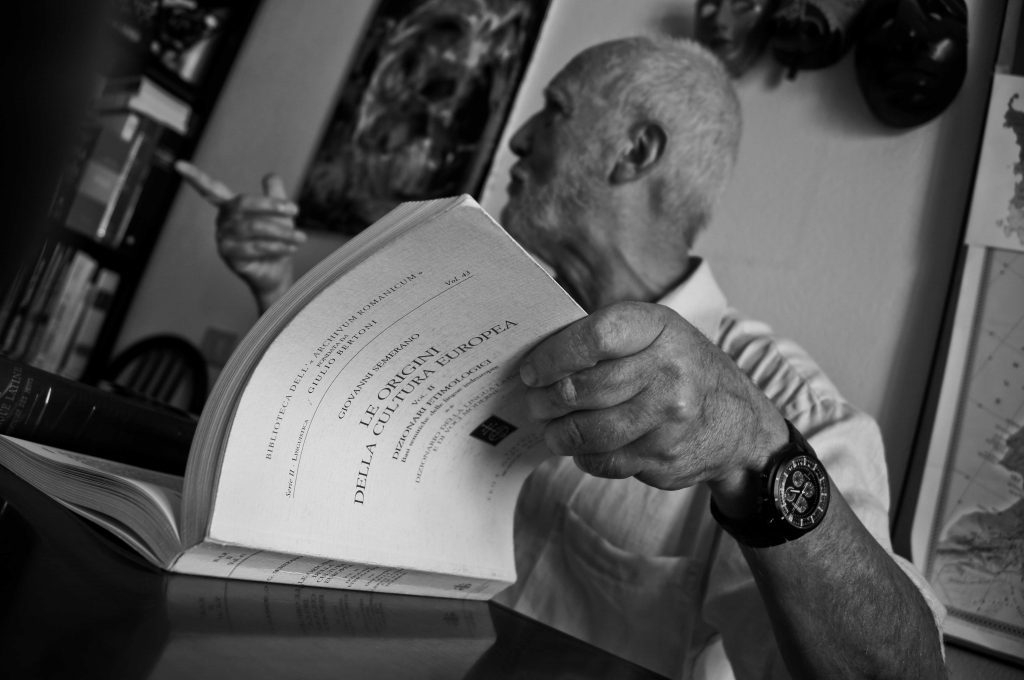ISTÉRRIDA METODOLÒGICA A SU “NOU FAEḌḌARZU ETIMOLÒGICU DESSA LIMBA SARDA” de Barore Dedola
I venticinquemila lemmi di quest’opera analizzano mediante la tecnica etimologica l’origine di altrettante parole. L’elenco arriva abbondantenente a un quarto dei 90.000 vocaboli inseriti nel più completo dizionario della lingua sarda, quello di Mario Puddu. Il mio scopo, evidentemente, non era di eguagliare i numeri del Puddu; invece ha inteso ricalcare uno per uno, e riesaminare ab imo, i lemmi trattati da Max Leopold Wagner nel “Dizionario Etimologico Sardo”, aggiungendone altri la cui analisi è già stata resa nota nella mia “Collana Semitica”.
Un’opera linguistica non si misura a numeri ma a contenuti. Peraltro l’opera del Puddu è diversa: egli ha ottimamente raggiunto lo scopo di ogni completo e buon “dizionario dell’uso” ed ovviamente non ha affrontato la questione etimologica; mentre il mio lavoro non solo dichiara nel titolo lo scopo etimologico ma lo assume a pivot dell’intera opera.
Sinora nessuno al mondo aveva studiato massivamente le etimologie del vocabolario sardo, salvo Max Leopold Wagner (stando almeno alle sue dichiarazioni). A parte sta l’impegno “classicista” di Giulio Paulis sulle voci pertinenti alla flora, al quale ha fatto seguire altri sporadici tentativi. Non metterebbe conto citare altri studiosi che ci hanno tentato, poiché i risultati sono stati assai discutibili (Massimo Pittau), o addirittura pessimi (Eduardo Blasco Ferrer); ovviamente non menziono certi altri appassionati, totalmente privi di formazione glottologica e pure di talento.
La revisione totale dei lemmi del Wagner è stata operata per la necessità d’illustrare con metodo più attuale e più incisivo la storia della lingua sarda, che lui aveva tracciato nelle sue opere. Applicarmi a questa impresa non è stato facile da nessun punto di vista, primamente perché si trattava di rimettere in discussione l’opera di un grande; non solo, ma nella discussione ho dovuto coinvolgere, direttamente o indirettamente, i lavori di numerosi professionisti colleghi o precursori del Wagner o che in lui hanno visto un maestro.
Il riesame dell’opera del Wagner non è stato intrapreso soltanto con questo Dizionario: è cominciato anni fa in alcune mie opere, ed ha raggiunto un punto di non-ritorno con la mia Grammatica Storica, intitolata “Grammatica della Lingua Sarda Prelatina”, la quale al cap. 3.1 (Fonologia) riesamina ab imo la Historische Lautlehre des Sardischen (edizione italiana proposta, con commento, da G. Paulis), confutandone uno ad uno tutti i risultati. Va da sé che la dimostrazione della vulnerabilità delle tesi wagneriane e delle stesse leggi fonetiche fondate sulla sua autorità non poteva rimanere isolata: aveva bisogno di quest’opera di completamento che – rivedendo tutti i lemmi proposti dal Wagner – li ricollocasse su un nuovo piano metodologico.
I miei predecessori nelle ricerche etimologiche hanno battuto una sola pista, la quale ha portato a collegare le parole sarde ad una presunta radice latina. Io invece apporto delle prove scientifiche che sconvolgono quel quadro, e dimostrano che il sardo, il latino e le altre lingue mediterranee hanno radici comuni, sono lingue sorelle, le quali vanno ancorate ad una matrice molto più antica, la quale ci è nota, è disponibile ed è facile da esaminare: si tratta del bacino sumero-accadico (con tutte le lingue strettamente legate a quell’ambito).
Penso non sia da addebitare del tutto al Wagner, tantomeno agli etimologisti che gli avevavo aperto la pista, il fatto che sinora nessuna pubblicazione sarda, italiana, straniera abbia raggiunto lo scopo di restituire correttamente l’etimo dei vocaboli sardi. I tempi trascorsi non erano perfettamente compiuti, non consentivano altissime percentuali di dimostrazioni. Invero, dopo oltre un secolo di sforzi e pubblicazioni, è soltanto da un decennio che l’élite dei ricercatori dell’intero orbe terracqueo ha terminato di contribuire al completamento di un’opera di base del linguaggio umano, che è il Chicago Assyrian Dictionary (CAD), un’opera in 25 volumi. Considerando i dizionari sumerici già completati grazie agli apporti di molte università di vari continenti, oggi possiamo dichiarare più agevole qualsiasi indagine storica sulle lingue mediterranee, nonostante che, purtroppo, oltre il 10% della lingua sumerica e di quella accadico-assiro-babilonese non risulti ancora tradotto; senza contare alcune opacità che rendono ancora insicuro financo il linguaggio biblico.
Per queste ragioni sino a un quindicennio fa anche l’etimologista più dotato – persino un sommo come Giovanni Semerano – ha lasciato qualche menda tra le proprie pagine, poiché le Università del mondo intero che già avevavo pubblicato dizionari sumerici o accadici palesavano più di una incertezza nell’interpretare varie voci.
La storia passata condiziona negativamente il metodo. Oggi possiamo ripartire sereni. E tale serenità può giocare finalmente un ruolo determinante, affrancando gli etimologisti da paure, limiti, sospetti e portandoli a riconsiderare più rettamente la complessa storia linguistica del Mediterraneo.
Però, oltre che dell’insicurezza dei dizionari del passato, occorrerebbe esser coscienti anche della futilità delle correnti filosofiche che hanno dominato negativamente sulle vicende degli studi linguistici. Volersene dichiarare immuni sarebbe ingenuo. Dopo la laurea in glottologia, io stesso mi sono dibattuto per 31 anni in un gigantesco garbuglio di problemi linguistici che non riuscivo a dipanare; e fu soltanto dopo aver deciso di “resettare” l’intera questione, riaggiustando i punti cardinali che orientavano il mio pensiero in relazione alla lingua sarda ed alle lingue mediterranee, che ho potuto riconoscere gli errori che bloccavano ogni iniziativa. Quegli errori avevano posto me e, beninteso, anche i miei maestri, in una condizione d’impasse. Mi accorgevo che il lavoro linguistico dei miei maestri, che da me furono seguiti disciplinatamente e senza discussione per 31 anni, era dominato dall’ideologia. Occorreva liberarsi da quella camicia di forza.
Si parla spesso delle correnti filosofiche, alcune delle quali passano nel breve trascorrere di una-due generazioni. Per converso, altre correnti filosofiche non hanno maestri conclamati, e tuttavia sono talmente imponenti da essere rimaste immobili e indiscusse da tanti millenni, divenendo i pilastri dell’intera storia umana. Non ha maestri, ed è immobile da tempo infinito, la “filosofia della superiorità” tra i popoli. Ad essa, come corollario, s’allacciano in modo indistricabile altre mode di pensiero le quali, tutte insieme, compongono una cultura che influisce negativamente persino sugli studi linguistici.
Posso citare, derivati dalla filosofia della “superiorità”, alcuni corollari storici che risultano negativi persino per gli studi etimologici: 1. le invasioni inaugurate dai musulmani “in nome di Dio”, che oggi sono rivitalizzate ad opera di due grandi Stati medio-orientali i quali dal 1945 stanno destabilizzando il Vicino Oriente, la Russia, l’Europa, l’Asia; 2. cito l’atrocità delle Crociate scatenate in nome di un “Dio superiore”; 3. cito le colonizzazioni post-colombiane dilagate negli oceani contro gli aborigeni ch’erano considerati “sub-umani” anzitutto in forza della pregiudiziale religiosa; 4. cito l’Inquisizione romano-ispanica, anzi le Inquisizioni condotte da ogni setta cristiana (e musulmana) nel proprio ambito, in nome dell’intangibile purezza della propria religione; 5. cito l’indegna appropriazione dell’Africa da parte di certi Stati europei, che la governarono “in nome della superiorità razziale”; 6. cito due apocalittiche guerre mondiali, generate ogni volta dall’unico Stato che si vantava del gene della “superiorità ariana”.
I corollari non si limitano a quelli indicati, e comunque sembrano tutti legati “a grappolo”. Nel grappolo rientra anche un tarlo incredibilmente vitale, che ha prodotto millenni di oscurità culturale nell’Occidente. È l’Aristotelismo. La sua scadenza è scritta nei manuali di filosofia, e viene fissata ingenuamente ai tempi di Dante Alighieri. Ma ancora oggi è tragicamente presente, producendo immani disastri ovunque vi sia una Università, ovunque il pensiero ambisca ad assurgere ad Accademia.
Purtroppo sono le Accademie a governare ogni e qualsiasi movimento di pensiero in relazione agli studi linguistici, e sono state soltanto esse ad avere voluto sinora la separatezza degli studi semitistici da quelli chiamati “indogermanici”. A me questa appare una pregiudiziale.
Ognuno di noi vive il proprio particulare subendo, spesso inconsciamente, la forza del pensiero impartito dalle Università. Tutto ciò è umano, è ovvio. Sarebbe assurdo il contrario, poiché le Università sono considerate le “forze armate” della ricerca e del libero pensiero.
Però osservo educatamente che negli studi linguistici oggi dovrebbe considerarsi inaccettabile che uno studioso di una lingua mediterranea ometta di consultare anche i dizionari e le grammatiche antiche della Sponda Sud, ivi compreso il dizionario e la grammatica egizia, poiché oggi dovrebbero essere caduti quei vincoli negativi che, sebbene surrettiziamente, sebbene non ravvisati e tantomeno conclamati, trattenevano ideologicamente gli studi entro le barriere concettuali di malintesi nazionalismi, e addirittura istigavano a negare ex silentio, o ignorare, gli apporti che ogni singolo popolo navigante o transumante ha reciprocamente dato al Mediterraneo fin dal più arcaico passato.
Oggi, finalmente, dovrebbesi dichiarare il declino della “pregiudiziale imperiale”, della “pregiudiziale di superiorità”. Oggi dovrebbe essere normale la condanna del mito “ariano” inventato durante il Romanticismo, che tante menti ha avvelenato, e ancora oggi avvelena sotto-traccia, financo nelle Università, financo tra gli eruditi che si millantano illuminati, quando non “di sinistra”.
Nel campo della glottologia il declino dell’arianismo, se fosse veramente avvenuto come bugiardamente si declama, avrebbe dovuto affievolire quel preconcetto accademico che induce a credere nella possibilità di cancellare una lingua in forza della sopraffazione armata o coloniale. Se veramente ci fosse stato il declino dell’arianismo, si sarebbe dovuto riconsiderare in toto quel monolitico pensiero accademico che, in nome di una “stirpe ariana” inventata dagli stessi intellettuali che architettarono il Nazismo, da 150 anni ha imposto nelle ricerche etimologiche la pregiudiziale di una immensa lingua ”indo-germanica” mai esistita, con al centro il popolo tedesco. Parimenti, si sarebbe dovuta riconsiderare in toto la bislacca teoria che l’Impero romano abbia soppresso le lingue mediterranee inaugurando la nuova era “neolatina”. Il declino di queste ascientifiche eredità tarda a cominciare, ed i conseguenti errori accademici non mostrano alcun cedimento.
Non ci fu mai catastrofe linguistica. Invero, nel Mediterraneo non ci furono mai rotture linguistiche traumatiche e le spinte imperialiste non poterono giammai decretare la morte di una lingua. Le dimostrazioni abbondano. Ad esempio:
1) Nel II-I sec. a.e.v., oltre un secolo dall’invasione romana, Cleone sente bisogno di scrivere un testo in greco-latino-punico (colonna bronzea di S.Nicolò Gerréi), per essere certo che i Sardi lo capissero almeno tramite la lingua punica.
2) Duecento anni dopo l’invasione, Cicerone denuncia (Pro Scauro) che la Sardegna non ha nemmeno una città amica del popolo romano. Se le città erano ancora ostili all’invasore, cosa dovremmo dire delle campagne e delle aspre montagne (che costuiscono il 70% del territorio sardo)?
3) I censimenti e la ripartizione dell’Italia ai tempi di Cesare Augusto mostrano una penisola composta da 32 popoli, che fino a prova contraria usavano 32 lingue. Numero che aumenta se sommiamo le lingue della Sicilia e quelle parlate in Sardegna dalle macro-ripartizioni tribali dei Balares, Corsi, Iliensens.
4) È famosa l’affermazione di Saulo di Tarso il quale, naufragando nell’isola di Malta, fu salvato dai residenti che parlavano una lingua barbara (ossia non greca né latina). Era una lingua semitica che tra quel migliaio di marinai e coltivatori durava in purezza nonostante che Malta fosse diventata romana da centinaia d’anni. I Melitesi si rifiutavano, forse persino inconsciamente, di adottare la lingua di Roma, nonostante che fossero così pochi e così esposti, che per i Romani sarebbe stato facilissimo imporglielo.
5) Altro episodio è quello del De Magia 98, in cui Apuleio, difendendosi dall’accusa di aver indotto con arti magiche la vedova Pudentilla di Oea (l’attuale Tripoli) a sposarlo, apre uno squarcio impressionante sulla società africana del tempo (siamo nel 159 e.v.). Infatti colloca da una parte Pudentilla, donna ricca e colta, che scrive e parla correntemente non solo la lingua latina ma pure quella greca; dall’altra mette il figlio di questa, Sicinio Pudente, che non solo non sa il greco pur essendo stato allevato nella cultura, ma che addirittura balbetta continuamente nel tentativo di esprimere, durante il processo, qualche frase in latino: non gli riesce per il semplice motivo che ha trascurato lo studio delle lettere latine, preferendo vivere come il resto della popolazione, la quale parla esclusivamente il punico. Dall’affermazione di Apuleio veniamo a sapere che nell’Africa latina, occupata da Roma nel 202 a.e.v. dopo la battaglia di Zama (Naraggara), ancora 360 anni dopo si parlava quasi esclusivamente il punico, nonostante che fosse stata romanizzata al massimo. Agostino, cittadino berbero, aveva imparato il suo ottimo latino, ma egli era uomo urbanizzato, apparteneva alla minoranza di cives cui era rivolta in esclusiva la predicazione cristiana, anch’essa espressa in latino.
6) Altra testimonianza: nel VI secolo e.v. i Barbaricìni adoravano ancora ligna et lapides (Lettere di papa Gregorio): solo le città avevano cominciato a recepire il verbo di Gesù, e tuttavia molti cittadini pagavano l’imposta per continuare ad adorare liberamente il Dio degli avi. Si badi, erano passati 3 secoli dalla liberalizzazione del cristianesimo, 5 secoli e mezzo dal suo esordio. Qualcuno dovrebbe riflettere sul fatto che i Barbaricini di Ospitone (ossia i ¾ dei Sardi, tutti residenti nell’immenso territorio montano), erano ancora pagani, e a maggior ragione non erano entrati stabilmente in contatto con i predicatori latini. Solo la religione è in grado di operare, con lento processo di secoli, dove non riesce il potere politico. La religione ha bisogno di essere predicata con somma circospezione, poiché i soggetti accettano il nuovo verbo soltanto se viene trasmesso nella lingua materna. Così fece Wulfila nel IV secolo e.v., il quale trascrisse la Bibbia ed i Vangeli greci nella lingua gotica, della quale inventò pure l’alfabeto. Così fecero Cirillo e Metodio, che per evangelizzare la Russia ebbero persino l’esigenza di creare un apposito alfabeto nazionale. Operò similmente Martin Lutero, che impose la propria Riforma traducendo la Bibbia in tedesco, previa correzione di numerosi passi.
Se questi episodi vengono traslati in un’isola grande ed aspra come la Sardegna, allora l’esempio di Malta, ancor più l’esempio dell’Africa romana, ma pure l’esempio di Ospitone, possono rendere bene i processi linguistici che s’instaurano presso un popolo di vinti. La chiave per comprendere il problema si trova proprio nella conquista delle città e nella netta frattura che nella storia del mondo si è sempre creata tra città e campagna, tra città e montagna. Infatti le montagne sarde rimasero libere dall’occupazione romana.
Beninteso, una religione può attecchire anche rapidamente: basta operare un genocidio (come fece Cortez). I sopravvissuti aderiscono, eccome! Ma i territori montuosi della Sardegna non furono mai conquistati con le armi, almeno fino al VI secolo, allorché l’esempio di Cortez ebbe un luminoso precedente nelle armi bizantine. Ospitone dovette salvare il proprio popolo: aderì al cristianesimo. In compenso la lingua sarda rimase indenne. Perché mai un popolo avrebbe dovuto cancellare la propria lingua a vantaggio di quella dell’invasore, un invasore che peraltro ai tempi di Ospitone cominciava ad esprimersi con la lingua greco-bizantina e non con quella latina?
È possibile sopraffare una lingua? Nel mondo abbiamo avuto varie prove di quanto fosse miope e incongrua la pretesa di un conquistatore di sopraffare persino la lingua del popolo soggetto. Ad esempio, lasciando da parte la famosa deportazione degli Ebrei a Babilonia (i quali conservarono in purezza la propria lingua), possiamo citare la politica dell’Impero assiro, le cui deportazioni avevano primamente lo scopo dell’unificazione linguistica. All’uopo, gli Assiri deportavano i vinti Cananei verso l’Assiria o verso altre province assire, e all’incontro deportavano gli Assiri, o i provinciali parlanti assiro, verso Canaan. «Scopo finale era l’assimilazione linguistica, culturale, politica, il più possibile completa, tale da trasformare i vinti in assiri. L’assimilazione completa la conquista, trasformando un regno ribelle e alieno in una nuova provincia del cosmo alle dirette dipendenze del re e del dio di Assur».1
«In questo contesto di rimodellamento demografico e territoriale al servizio degli interessi assiri, e sotto attento controllo di guarnigioni e funzionari assiri, la pratica della “deportazione incrociata”, che coinvolse qualcosa come 4,5 milioni di persone in un arco di tre secoli, svolse un ruolo essenziale. Il racconto biblico della conquista di Samaria narra dapprima la deportazione degli Israeliti:
il re d’Assiria prese Samaria e deportò Israele in Assiria, stabilendoli a Halah, sul Habur fiume di Gozan, e nelle città della Media. (2Re 17:6)
e poco dopo narra l’arrivo dei deportati alieni:
il re d’Assiria fece venire (gente) da Babilonia, da Kuta, da ‘Awwa, da Hamat e da Sefarwayim e li stabilì nelle città della Samaria al posto degli Israeliti. Costoro s’impossessarono di Samaria e si stabilirono nelle sue città. (2Re 17:24)
«Dai testi di Sargon II sappiamo che deportò in Samaria anche degli Arabi:
I Tamudi, Ibadidi, Marsimani, Khayapa, Arabi lontani abitanti del deserto, che non conoscono sorvegliante o funzionario, che a nessun re avevano mai portato tributo, per mandato di Assur mio signore io li abbattei, e il loro resto deportai e insediai in Samaria (ISK, p. 320).»2
Ma l’assimilazione non avvenne mai. Negli stessi passi della Bibbia è scritto che le nuove popolazioni di Samaria finirono per logorarsi e sfinirsi a vicenda. Non per altro, ma perché le guerre di conquista lasciavano delle scie d’odio e di revanche talmente grandi, da condizionare e trattenere per secoli o millenni i singoli popoli entro la propria lingua originaria, l’unico segno identitario salvabile. Il destino di Samaria è confrontabile – ma solo per farne risaltare le differenze di fondo – col destino della città sarda di Alghero. Ad Alghero nel 1353 era stato operato un innesto adamantino, un solo popolo e una sola lingua; ma quel popolo straniero rimase incastonato, “assediato” entro le mura cittadine come elemento spurio in un territorio parlante lingua sarda; e ancora oggi la situazione è invariata; la lingua catalana dopo 700 anni non ha mai varcato le mura di Alghero. A Samaria invece la questione fu pasticciata dal melting pot creato con la mescolanza di cinque popoli; e l’aggiunta del sesto popolo, gli Arabi parlanti una lingua più vicina a quella ebraica, non potè che esacerbare la situazione e mettere gli uni contro gli altri. Era questo il risultato che volevano gli Assiri? Non credo. Essi volevano mettere certamente gli uni contro gli altri, ma soltanto secondo la prassi del divide et impera. Invece quel seminare odio a piene mani fu foriero di declino economico.
Così andarono le cose nel Mediterraneo da quando Assiri e Babilonesi (poi Hittiti, Medi e Persiani, e infine Greci e Romani) tentarono di prevalere ed espandersi con la forza delle armi. Soltanto la libertà, la parità, la collaborazione pacifica, la dignità dei liberi commerci può fare integrare i linguaggi. È ciò ch’era accaduto per tanti millenni nel Mediterraneo, prima che gli Assiri e i Babilonesi inventassero la “persuasione” degli impalamenti di massa e quella delle deportazioni.
Il livello temporale. Le prospettive. L’Homo Sapiens. Tutto ciò acquisito, rimangono in piedi altre due fangosità da cui il pensiero accademico non riesce a depurarsi.
La prima fangosità colpisce nel vivo la tecnica dell’indagine etimologica condotta nell’ambito degli Istituti universitari di glottologia e di filologia romanza, nei quali si stabilisce a priori il livello temporale dove l’indagine debba cessare. Sinora la storia delle lingue tirreniche attuali e di quelle della costa nord-mediterranea è stata indagata a ritroso sino ad attingere al piano della lingua latina (salvo poi considerare l’apporto collaterale delle lingue germaniche, nonché una vaga citazione di “residui celtici” dei quali non si dice nulla sul piano scientifico). Ma ciò non è bene, poiché lo scavo etimologico è simile a quello archeologico, e non può eludere il proprio metodo, che è quello di toccare il livello più basso nel quale si ritrovino dei manufatti (per l’archeologo) nonché il livello più arcaico cui può condurre la manifestazione dei radicali di un vocabolo (per il glottologo). In linguistica occorre operare confronti lessicali e morfemici sino al più arcaico vocabolo che, in un’area indagata a raggio adeguato, possa credibilmente confrontarsi col vocabolo di oggi. Stabilire che il livello-base delle lingue tirreniche sia la lingua latina, significa rinunciare al criterio storicistico; equivale ad ammettere che prima di Roma la storia nel Mediterraneo non si sia mai svolta oppure (che è lo stesso) ch’essa sia obiettivamente inconoscibile. Invece la storia del Mediterraneo e dintorni è nota, con soddisfazione generale, fin dai millenni pre-greci. Mentre la conoscenza delle lingue ad essa correlate affonda ancora più lontano nel tempo e nello spazio.
Dalla prima fangosità deriva la seconda fangosità, concernente le prospettive. Affermare de imperio che la storia delle lingue tirreniche ed alto-mediterranee abbia una prospettiva di soli 2000 anni significa rinunciare a capire l’evoluzione del linguaggio mediterraneo, il quale è arcaico quanto può essere arcaica la presenza dell’Homo in questo bacino. I dati archeo-antropologici confermano la presenza del Neanderthal e poi del Cro-Magnon; e giacché quegli uomini lasciarono dei manufatti, è ovvio che parlassero, che scambiassero informazioni, che dessero i nomi alle cose, alle persone, al territorio, che usassero quindi la lingua, che avessero un vocabolario condiviso. L’idea nichilista ch’essi comunque parlassero lingue inconoscibili è generata dalle stesse pregiudiziali “latina” ed “ariana” su citate: pregiudiziali liquidatorie che bloccano ogni nuova spinta ad una seria indagine etimologica.
In verità, gli uomini mediterranei del Paleolitico parlavano. E parlavano una sola lingua: appunto la Lingua Mediterranea, per quanto essa fosse pluri-articolata secondo l’antichità e il radicamento degli stanziamenti nei singoli ambiti geografici. Questa lingua è perfettamente conoscibile mediante una semplice induzione, che è la seguente: la Scienza Glottologica ha sempre messo in evidenza un fatto elementare, intuitivo, cioè che le prime formazioni lessicali dell’Homo furono essenzialmente monosillabiche. Questa osservazione è così palmare, che tentarne una dimostrazione (peraltro facile) è ozioso. Ebbene, dalle età arcaiche è sopravvissuta, restituita a noi grazie alla riesumazione delle tavolette cuneiformi, una lingua che si articolava proprio a monosillabi: è la Lingua Sumerica, a tutti resa nota tramite vocabolari e grammatiche pubblicati da numerose Università. Quegli scavi, quelle scoperte hanno messo a disposizione dei glottologi odierni “l’altra metà del mondo”. Perseverare a non indagare quanta storia linguistica mediterranea sia ancorata alla lingua cosiddetta sumerica, non è più accettabile.
Infatti lo scrivente non accetta più di perpetuare la muta ostilità (ch’egli per 31 anni ha purtroppo condiviso) a conoscere l’altra “metà del mondo”. Lo scrivente da 15 anni ha cominciato ad indagare in ambo le sponde, ed ha scoperto che la Lingua Sarda è arcaica, aborigena, risale alle origini del linguaggio, e condivide con la Lingua Sumerica molto più della metà del proprio vocabolario. Come si noterà leggendo oltre nonché nel corpo dell’intero Dizionario, la mia scoperta è scientificamente dimostrata e rimane in attesa di prove contrarie. Come attende prove contrarie lo stesso dizionario egizio, il quale condivide metà della lingua sumerica.
Insomma, si perviene alla dimostrazione che la lingua (cosiddetta) sumerica era parlata ab origine in un’area molto vasta avente perno nel Mediterraneo centrale, ed entro l’ampia circonferenza roteavano già dai tempi arcaici la lingua egizia, le lingue che poi vengono riesumate in Mesopotamia, la lingua di Canaan compreso l’ugaritico, il fenicio, l’ebraico; inoltre quella araba, le lingue ad ovest del Nilo (es. il punico), la lingua che ancora oggi sopravvive in Sardegna, le lingue italiche compreso il latino, le lingue celtiche meridionali comprese quelle iberiche.
Questi vasti ambiti vanno considerati per difetto. Ma è uopo fermarsi per capire intanto la ragione di tale vastità. Per quanto in certi rami scientifici nulla possa considerarsi ultimativo, in relazione all’antropologia s’individua agevolmente un primitivo focus della Ursprache mediterranea. Che il focus possa essere l’Altopiano Etiopico o che altri lo pongano in Croazia (come qualcuno recentemente suggerirebbe), la questione non muta poiché si scopre che dal focus ci si è mossi lungo le coste per racchiudere a tenaglia l’intero Mare Nostrum.
Attenendoci alla corrente antropologica che narra della progenitrice Lucy, l’uomo (ed il linguaggio che ancora oggi ci appartiene) discese dall’Altopiano Etiopico lungo il Nilo, e da lì prese a tenaglia le coste Mediterranee, ad ovest verso la futura Cartagine ed alle Colonne d’Ercole, ed oltre in Andalusia, in Catalogna, in Linguadoca. Ad Est mosse verso Canaan e la Mezzaluna Fertile, e da lì lungo le coste anatoliche, ai Dardanelli, in Grecia, Dalmazia, Italia. Chiusa la tenaglia, toccò alle isole centrali del Mediterraneo. Erano tempi di glaciazioni, e l’arrivo in Corsica-Sardegna avvenne con mari bassi e molto transitabili nella direttrice dell’arcipelago toscano.
La remota antichità delle radici. Alcuni antropologi dichiarano la scoperta di un Neanderthal con osso o cartilagine glottale, anziano di 230.000 anni, ed ovviamente pensano che l’osso glottale favorì l’articolazione della lingua. Ma altri archeo-antropologi del Sud-Africa accampano la scoperta di una Dea-Madre vecchia di 700.000 anni: chiaramente, gli scultori di quella Dea-Madre parlavano ancor prima di questo Neanderthal citato. Comunque la mettiamo, l’Homo cominciò ad articolare parole e pensieri molto presto; e tentò di risalire sempre da sud a nord (verso l’enorme calotta glaciale che occupava l’Eurasia sino al livello delle Alpi, dei Carpazi, dei bassi-Urali, della Mongolia).
L’idea di un idioma “indo-germanico” sortito sulle pianure ghiacciate a nord dell’Ucraina e del Kazakistan, con improbabili rincalzi dal Pamir e dintorni, non tiene conto che l’Homo provenne sempre dalle zone non soggette a glaciazione. Quindi è forza immaginare soltanto pressioni da Sud, risalenti i vari corsi dei fiumi, lungo le antiche valli glaciali del Rodano, del Danubio, del Dnepr, del Don, del Volga, dell’Ural e forse – al dilà dell’Hindukush-Karakorum – del Brahmaputra, del Mekong.
Furono le genti che risalirono le valli glaciali a costituire poi – millennio dopo millennio – il fenomeno dei Popoli delle Steppe. E furono questi ultimi, a loro modo, che rifluirono a ondate verso Ovest nelle pianure centrali dell’Asia, nella Pianura Sarmatica, facendo capolino nella storia mediterranea col nome greco di Popoli Barbarici, quelli che affrontarono Mario, Giulio Cesare, l’Impero romano, ecc.
Financo la questione della Civiltà di Andronovo (the Indo-Iranians di Elena E. Kuz’mina) può ricevere ulteriori lumi se la inquadriamo in queste prospettive. Parimenti, si capovolge la prospettiva dei famigerati “popoli indoeuropei”, allorché andiamo a rivelare che pressoché ogni parola a loro attribuita è di origine sumero-accadica. Ad esempio, si pretende l’origine indoeuropea dei Persiani, ma intanto i loro nomi sono accadici, come Dario, nome d’imperatore persiano, dall’akk. dāriu(m), dārû(m) ‘lasting, eternal, eterno’ riferito agli déi, ai re (tipico appellativo di cui si dotavano i re delle origini, per marcare la propria forza e la nobiltà davanti al popolo).
Tornando al Mediterraneo, ci rendiamo conto che pure la questione delle lingue celtiche è fortemente zoppa, fintanto che non si tengono nel dovuto conto gli apporti millenari da sud. Se vogliamo, anche gli artisti contribuirono a dimostrare quanto sto affermando, come quell’uomo (ma immagino fosse una donna che attendeva il ritorno del marito dalla caccia) il quale (la quale) 32.000 anni fa dipinse la grotta di Chauvet con splendidi rinoceronti.
Sono migliaia le parole che noi consideriamo “nordiche” e invece provennero dal Bacino sumero-accadico. Di seguito, per ragioni di spazio, elenco poco più di venti lemmi.
Aggraviái camp. ‘ingiuriare, oltraggiare’; aggráviu ‘ingiuria, oltraggio’ = sp. agraviar, agravio. It. ant. aggravio ‘ingiuria, oltraggio’, che ritroviamo anche in Corsica. Base etimologica accadica, da garbu, garbānu ‘lebbroso’. Il termine penetrò tanto, da arrivare anche tra i Germani: cfr. ags. garbage ‘immondezza, porcheria’.
Alpi, ted. Alb. Il nome della catena montuosa che scompartisce mezza Europa ha lo stesso radicale di it. e lat. alba < akk. ḫalpû ‘frost, ice’, sd. alb-éskida, arb-éskida ‘alba’. Il nome più antico, conservato nelle due radici sarde, si ricava dal sum. ar ‘praise, preghiera’ + bar ‘to burn, bruciare’, anche ‘to open, aprire’. Il composto ar-bar in origine significò ‘preghiera al Folgorante’ (il Sole), o ‘preghiera dell’apertura (del giorno)’. È noto il “saluto al Sole” che molti popoli ancora oggi si tramandano, fin dal Paleolitico, al momento dell’aurora. Un tempo non era un “saluto” ma una preghiera, come vediamo al lemma Sud.
Bind (to bind) ingl. ‘legare’; cfr. log. bindellu ‘legaccio, nastro’, specialmente per legare i capelli; cfr. piem. bindel ‘nastro’. Base etimologica è l’akk. binītu ‘creation, structure’. A quanto pare il concetto è arcaico, proviene dall’Alto Paleolitico, allorché l’uomo, strappando le prime erbe tenaci, cominciò a intrecciarle facendone legacci, con i quali cominciò a fissare tra di loro i primi rami d’albero ed a costruirsi una capanna. Questa fu la prima barriera di difesa dai pericoli del mondo ferino, ed anche dalle intemperie.
Sud è il nome del punto più alto toccato dal sole nel suo spostamento est-ovest. Base etimologica è il sum. šud ‘preghiera’ (una preghiera con proscinesi, ovviamente rivolta al dio Sole, stavolta quando sta allo zenith). E ricordiamo il nome dell’Alba. Tale preghiera ci è noto tramite il cognome Sciùto, Sciuti, di area italica ma di sicura base tirrenica, con etimo anche nell’akk. šūtu, sūtu ‘sud’.
Ovest. Per indicare l’Ovest gli Šardana-Tirreni impiegarono addirittura due termini, l’uno e l’altro eternati, eccezionalmente, in due cognomi sardi. Il primo è Murru, con base nell’akk. amurru(m) ‘ovest’. Il secondo è il cogn. Erbì con la variante Erba, base nell’akk. erbu(m), erebu ‘tramonto, ovest’ (da cui poi il gr. Érebos, indicante il Regno delle Tenebre, il Mondo dei Morti, dove sprofonda il Sole). Del nome internazionale Ovest, West (creduto anglosassone) s’ignorò sempre l’origine, mentre la base è il sum. u ‘universo, universale’ + eš ‘shrine, sepolcro’ + de ‘creatore’ (ossia Dio Creatore dell’Umanità). Il composto u-eš-de, divenuto west tra gli Anglosassoni anche in virtù della nota Lautverschiebung germanica, in origine significò ‘sepolcro del Creatore dell’Universo’. La definizione si concilia con quella del Nord.
Est, altro nome del punto dove sorge il Sole, ha base etimologica nel sum. eš ‘shrine, sepolcro’ + tuk ‘to break off, rompere’. Il composto eš-tuk in origine significò ‘rottura del sepolcro’ (vedi le osservazioni per gli altri punti cardinali). In Italia certi popoli chiamarono altrimenti quel punto. Un indizio lo cogliamo dal cognome italico Zito, con base nell’akk. ṣītu(m) ‘uscita del sole’, ossia ‘Est’. Si può notare che i vari nomi per uno stesso punto d’orientamento mostrano l’autonomia dei vari linguaggi antichi.
Nord è il punto cardinale più citato, dal sum. nu-ra-du (nu ‘creatore’ + ra ‘limpido, chiaro, splendente, Dio’ + du ‘to hold, keep in custody, tener prigioniero’. Nura indicò il ‘Dio creatore’, quindi ‘Creatore della Luce, Sole’; Nura-du significò ‘prigione del Sole’ (perché negli antichi miti il Sole al tramonto veniva imprigionato dal Dio della Notte); cfr. sp. norte, ingl. north, norveg. nord, ted. Norden, della cui origine ogni etimologista ha sinora discusso invano.
Norge è il nome della lontana Norvègia, che non significa ‘terra del nord’ sibbene ‘Terra dei bagliori, delle aurore boreali’, da sum.-akk. nūru ‘bagliore’ + sum. ki, gr. gê ‘terra’ (in composto nurki). Cfr. il cognome sd. Nurki, che può sembrare un mistero finché non accettiamo che qualche Normanno tra quelli che raggiunsero la Sicilia dovette recarsi anche in Sardegna a fini di commercio trans-isolano. Con tutta evidenza, una bella vergine sarda lo ammaliò, ed egli s’insediò trapiantando un “cognome di origine”: ‘quello della Terra delle Aurore boreali’. Forse i Normanni arrivati in Sardegna per commercio furono numerosi. Un loro sia pur minimo contributo può senz’altro giustificare le molte teste bionde del centro-Barbagia, nonché gli occhi di certi barbaricini (es. ad Ovodda), spesso di un affascinante verde-smeraldo. Capisco l’imbarazzo di chi ragiona “a palmi”, ma questa etimologia s’affianca a molte altre della Sardegna acclaranti un fatto che sconcerta i più: in Sardegna ancora 500 anni fa si pensava in sumerico, come dimostrerò al paragrafo “La lingua arcaica compresa fino al Rinascimento”.
Mont Blank, noto in Italia come Monte Bianco, si dice abbia radice dal germ. blank ‘ripulito, lucente’; ma anche quella voce germanica proviene da sud, base etimologica è il sum. bar ‘bianco, libero’ + an-gal ‘cielo, cielo grande’ = ‘cielo limpido’. I cognomi sd. Barranca, Branca conservano ancora l’arcaico significato del bianco, che si espanse con fonetiche similari fino alla Mittel-Europa.
Monte Rosa è un oronimo italico persino banale. Ma tale banalità va spiegata, poiché quel magico colore rosa viene percepito soltanto dai Padani quando da Est il sole illumina di colpo l’altissima vetta, mentre il mondo se ne sta ancora avvolto dalle tenebre. È un momento di grande fascino, che riceve nome dall’akk. rûšum ‘rossore’, voce conosciuta bene dai Celti.
Monte Cervino è un altro oronimo italo-celtico, un aggettivale col suff. mediterraneo -ínu < akk. ḫerebū ‘torre’ (quindi ḫereb-inu). Nome antonomastico. Si badi che questo concetto riferito alla torre si ritrova esclusivamente nelle fonti accadiche relative agli scacchi (i quali testimoniano in tal guisa la loro arcaicità culturale, senza bisogno di coinvolgere nella loro invenzione gl’Indiani, e nemmeno gli Iranici).
Bàita è un’altra voce celtico-mediterranea abbarbicata sulle Alpi. Indica la ‘casa alpina’, specie quella isolata negli alpeggi, ma ritroviamo la voce nell’ebr. bait ‘casa, tenda’, akk. bītu ‘casa’, sd. bide ‘vite’, lat. vitis ‘idem’. Che provenga da sud, lo testimonia proprio il nome sardo della vitis. Infatti qualsiasi parola, sino a prova contraria, è arcaica, e l’ebr. bait ha un senso se lo leggiamo primamente come ‘tenda’; ha ulteriore senso se lo leggiamo anzitutto come ‘tenda’ (prodotta dalla vitis, dalla bide, che in certe zone mediterranee, crescendo nella foresta, crea un tendaggio enorme che fece concepire la primitiva idea della copertura).
Giorni della merla. Questo sintagma italo-celtico è legato ai giorni più freddi dell’anno nel nord-Italia, ed evoca le tempeste gelide da nord. Base etimologica il sum. mir-la ‘vento del nord’ (mir ‘chilly wind’ + la ‘to carry, portare, recare, apportare’). Dunque mirla significò ‘apportatore di tramontana, apportatore di tempeste’ (tutto un programma). Cfr. it. merletto ‘pizzo ricamato applicato a stoffe pregiate’, originato dall’osservazione dei fiabeschi ricami del gelo sulle superfici lisce. Da qui anche il merlo in quanto ‘sopraelevazione merlata delle mura difensive’, di cui i filologi hanno sempre ignorato le origini, confondendolo con i merli (uccelli) senza però riuscire a raccapezzarsi.
Hütte ted. ‘capanna’ ha il perfetto corrispettivo nel babibolese ḫuttu (a storage vessel, un recipiente per la conservazione). Va da sé che gli alimenti furono sempre ben protetti e immagazzinati contro le intemperie e contro gli animali. Dagli alimenti dipendeva la vita dell’uomo. Questa considerazione è sufficiente a capire la causa prima della creazione di robuste capanne presso i Germani.
Pò. Uno sguardo ai sistemi fluviali è d’obbligo, poiché il nome celtico del fiume più lungo d’Italia ha base nel sum. pû, akk. pû(m) ‘bocca’; cfr. akk. pāʼum ‘bocca’ da cui celtico Padum, altro nome del Pò. Il sum. pû, akk. pāʼum s’intese per antonomasia come ‘sorgente, scaturigine’. Cfr. poi il lat. Danubium, da akk. dannu ‘potente’ + bī’um ‘opening, outlet; apertura, fuoriuscita, sorgente’, col significato di ‘sorgente, fiume potente’.
Adda è nome di un grosso affluente del Pò, dal sum. adea ‘flooding’.
Arno è il nome del fiume toscano, idronimo celtico che però si ripete in Renania (Arnel), Svizzera (Orne), Catalogna (Arnon), Francia (Arnon, Arn), Transgiordania (Arnon).
Reno è nome di un grande fiume della Renania, da akk. reḫûm ‘versare, scaturire’ + ēnu ‘sorgente’.
Tina è nome di un fiume britannico = Tino, fiume sardo presso Tìana.
Normanni. Quanto ai popoli a nord delle Alpi, gli stessi Vikinghi erano detti Normanni, voce sumerica da nuru ‘luce’ + man ‘companion, compagno d’arme’. Il composto nur-man significò ‘guerrieri della Terra della luce’ (ossia ‘Quelli delle aurore boreali’). Pertanto dobbiamo smettere d’interpretare l’ags. man come ‘uomo’, poiché in origine indicava il ‘guerriero’, l’uomo ‘portatore di armi’.
Germani. Conosciamo benissimo questo popolo che diede filo da torcere ai Romani < akk. gērum ‘ostile’ + mānu ‘bosco’. Il composto gēr-mānu in origine nominava il ‘fiero popolo delle foreste’.
Danesi. Tutti i popoli del Nord erano conosciuti, prima ancora che apparissero le cosiddette “civiltà avanzate” del Mediterraneo. E non dobbiamo titubare anche se i primi a citare i Danesi furono Procopio di Cesarea e Giordane. Anche i Danesi, come i Normanni, come i Germani, erano noti per la forza temeraria. Infatti il nome ha origine dall’akk. daʼānu ‘potere, forza’.
Taurini. Non si può dire che tutti i popoli a nord dell’Italia non abbiano ricevuto il nome più appropriato, secondo la caratteristica più notevole. Ad esempio, i Taurini erano un popolo dimorante negli Alti Tauri, tra Austria e Italia. La paronomasia giocò il proprio ruolo, e gl’interpreti li collegarono al toro, lat. taurus, termine invero alquanto ostico da giustificare, per quanto esso provenisse da sud, dove il toro era adorato. Invero la base etimologica è l’aram. tur ‘monte’ (cfr. lat. turris ‘torre’). Con ciò dagli Alti Tauri passiamo al Monte Turu-séle il monte più alto del Supramonte di Baunéi, in Sardegna; questa pletora di nomi è mediterranea.
Per concludere, può essere utile uno sguardo agli oggetti preziosi, tenendoci sempre ancorati alle Origini, al Paleolitico, ai tempi in cui le lingue si formarono, allorché la meraviglia dell’Homo s’appuntava all’apparizione di pochi e rari reperti di superficie, ch’emergevano soltanto in qualche plaga.
Ambra. Facile immaginare che l’ambra del Nord fu il primo oggetto raro e prezioso dell’antichità, e se ne fece subito un proficuo commercio. Ci chiediamo donde sorse questo nome. Lo troviamo nell’ar. anbar, che però ha base nel sum. an-bar ‘cielo cotto’ (an ‘cielo’ + bar ‘cuocere alla fornace’ (pottery, vetro). Lo storico Tacito la indicò come “resina che trasuda dagli alberi”, mentre il nome latino dell’ambra fu glesum, anche questo dal sum. gilesi ‘tesoro d’albero’ (gil ‘tesoro’ + esi, eš ‘albero’). Ma ci accorgiamo che tale nome è uguale al germ. glass, Glas ‘vetro’. Con ciò intuiamo che questo fu il primo nome che i popoli nordici diedero all’ambra. Insomma, senza l’ambra oggi il nome del vetro non esisterebbe, sarebbe un nome diverso.
Vitrum. Ma com’è naturale, anche questo vocabolo latino, corrispondente al camp. bidri, ha origini arcaiche. Le scopriamo nell’akk. bitrûm ‘vedere attraverso, to see something through’.
Silk. Infine, chiudiamo con un nome nordico riferito alla ‘seta’. Essa, beninteso, fu conosciuta molto tardi. Non per questo i popoli germanici ed anglo-sassoni erano giunti impreparati all’impatto con le pregiate stoffe orientali. Disponevano già di un aggettivale appropriato derivante dal sumero: sikil ‘puro’.
La pregiudiziale della “barbarie” e l’intuizione del mondo arcaico. Il paragrafo appena chiuso dovrebbe far riflettere sulle civiltà arcaiche e sulle millenarie commistioni linguistiche impellenti da sud. Molti rifiutano a priori il parametro della remota antichità, perché applicano ad essa il giudizio negativo di una barbarie la cui indagine sarebbe infruttifera. Ma anche qui la questione è mal posta. I dipinti di Altamira pare stiano in Ispagna da 39.000 anni; essi indussero Pablo Picasso a sentenziare: “Dopo Altamira tutto è decadenza”. Figuriamoci s’egli avesse visto i dipinti della grotta di Chauvet (datati a 32.000 anni). Quei dipinti sfatano un altro luogo comune: che l’arte sia nata soltanto da 2,8 millenni in Grecia e che prima ci fosse solo barbarie. Francamente, soltanto Michelangelo e Rembrandt hanno posseduto la potenza espressiva dell’uomo (o della donna) di Chauvet. Basterebbe ciò per rifiutare la pregiudiziale della “barbarie”, che impedisce di capire serenamente le civiltà del passato e la formazione delle loro lingue.
Fu in quella remota fase arcaica, decine di migliaia d’anni fa, che nacque il toponimo Gibilterra, anzi due toponimi, com’è usuale nelle terre di confine. Da una parte fu Calpe, dall’altra Gibraltar. Chi s’attiene alla “pregiudiziale latina” (una pregiudiziale appena addolcita dal flirt con la civiltà greca) e crede alla inconoscibilità dei linguaggi precedenti, sostiene che Calpe è nome greco, e nemmeno lo traduce. Mentre la lingua sumerica agevola la comprensione, fornendo due monosillabi: ḫal ‘to divide; to open’ + pû ‘mouth’. Calpe, non meno di 40.000 anni fa, era nota come ‘opened mouth’. Dall’altra sponda, la tribù che l’aveva raggiunta la chiamò col tempo Gibraltar, che la “pregiudiziale latina” induce a interpretare come Jabal Tāriq ‘Mountain of Tariq’ (riferendola al conquistatore arabo ch’entrò in Andalusia, e tenendo in non cale quel fastidioso -iq). Ma è proprio il sovrabbondante -iq a far capire che la traduzione “araba” è forzata. Invero, anche questo nome è sumerico, da gi ‘to turn, return, change status’ + bar ‘to cut open, split’ + al ‘fencing’ + tar ‘to cut’: gi-bar-al-tar = ‘barrier cut, split, changing the destiny’. Si nota l’enfasi tautologica nella ripetizione concettuale bar ‘aprire‘ + tar ‘to cut’.
Dall’etimologia di Calpe/Gibraltar il lettore, i giovani glottologi cui mi rivolgo, avranno capito che spesso l’etimologia non può proporsi pianamente se non ci si riporta, quando possibile, ai tempi arcaici, assunti come parametro scientifico (non sempre necessario, beninteso, ma pur sempre scientifico) allato al parametro della identità o simiglianza fono-semantica tra i radicali attuali e quelli originari. Il bisogno di corrette intuizioni non è soltanto mio, beninteso. Fu lo stesso Wagner nel DES a dare sfogo alle più svariate intuizioni, che il lettore è gentilmente pregato di giudicare in questo Dizionario, e di confrontarle con le mie.
Faccio l’esempio di ammurrare, -ái che in log. e camp. significa ‘legare le vacche per mungerle’. L’intuizione del Wagner è la seguente: ammurrare = ‘legare il muso’ (murru). Una volta supposta tale equivalenza, Wagner crede appagata e conclusa la sua indagine etimologica. Ma a mio avviso essa non può ritenersi conclusa, e penso che nemmeno il lettore possa soddisfarsi appieno, se non altro perché manca una conferma: l’etimo di murru. E allora vediamo quest’etimo, che poggia sull’akk. murrûm ‘uno che scopre, che scoperchia’. Il riferimento originario è ai suini, che usano il grugno per grufolare, ossia per “arare” e “scoperchiare” in cerca di radici e insetti. Da quest’etimo comincia a balenare che la radice -mur- di ammurrare e di murru non parte dal Neolitico ma dal Paleolitico, da quando l’uomo cominciò ad osservare il meticoloso grufolio dei suini dopo le piogge, che scoperchiano la terra rendendola fertile, e per ciò stesso fornendo l’idea rivoluzionaria dell’aratro. Secondo la mia intuizione, quindi, l’operazione del Wagner con la sua lineare equivalenza non aiuta, poiché nel Paleolitico, allorché le vacche erano ancora poco domite, e non si era nemmeno in grado di confezionare corde, l’unico modo per nutrirsi del prezioso latte era accattivare la vacca fornendole abbondante foraggio, in modo che stesse ferma. La base etimologica che poi rinveniamo “incistata” nella lingua accadica proviene da lontano, dal sum. mur ‘fodder, foraggio’. Ovviamente il significato sumerico s’attagliò in origine non solo al foraggio dei bovini ma anche al cibo esumato dai suini grufolanti. Da ciò s’apprende che il radicale del sd. murru in quanto ‘muso’ è molto arcaico e fu capace, già da decine di millenni, di configurare concettualmente sia il ‘foraggio’ sia il ‘muso’ che lo procacciava. In tal guisa nacque la metonimia sarda murru, a quanto pare non condivisa nel restante Mediterraneo.
Beninteso, in certi casi è possibile che l’indagine etimologica non riesca a discendere al disotto dello strato romano (o greco). È il caso del camp. pantéus nella locuzione portái a unu in pantéus ‘portare uno di peso’ (Porru); vedi anche log. in pantéus ándias. Casu propone a ppantèa ‘di peso’: lu giughίan a pantèa ‘lo portavano di peso’, ed anche ‘in trionfo’. Wagner in questo caso rinunciò a indagare l’etimo, poiché non riuscì a trovare addentellati. Dal mio punto di vista, invece, l’etimologia di questo sintagma è chiara, ed offre due opzioni; la prima è l’akk. bāntiš ‘like a mother’, bāntu ‘mother’ (in tal caso il significato del sintagma sarebbe ‘portare come porta una madre’, ossia in braccio). Una seconda opzione può soddisfarsi discendendo soltanto al livello bizantino, a 1400 anni fa, allorché le antiche processioni pagane vennnero progressivamente sostituite con quelle cristiane. In tal caso s’arguisce facilmente che il sd. pantéus non è altro che il biz. πάν-θειος ‘affatto divino, augustissimo’ (epiteto rivolto alla statua di Dio, della Madonna, del Santo portati a braccio in processione). Quest’esempio mostra la possibilità di fermare l’indagine etimologica al solo livello latino (o greco, in questo caso), senza bisogno di discendere oltre. Ma tale possibilità si appalesa soltanto a posteriori, dopo avere indagato anche gli strati lessicali più arcaici. In ogni modo, il lettore noterà che Wagner non potè giungere all’etimo nemmeno quando gli si presentò l’occasione di accreditare con certezza l’opzione greca, della quale non seppe approfittare.
Ciascuno di noi glottologi è conscio delle obiettive difficoltà dell’indagine etimologica. Ci accorgiamo di muoverci in un ambiente indefinito con l’onere di renderlo finito; e troviamo nell’intuizione uno strumento che – a seconda di come lo indirizziamo – può essere un prezioso alleato, che però può rivoltarsi contro di noi al minimo errore di prospettiva, ad ogni insufficienza nelle opzioni.
Prendiamo il caso del log. Cammínu de Roma ‘Via Lattea’. Essa fu mitizzata anche come un immenso sentiero incendiato. Wagner s’appagò nell’interpretare la locuzione nel suo significato apparente: ‘Cammino di Roma’, senza avvertire che tale soluzione è insufficiente e gravida di contraddizioni. Non mi sento obbligato a riempire oziose pagine dimostrative, e invito direttamente ciascun lettore a spiegare che significhi, secondo lui, ‘Cammino di Roma’: Cammino verso Roma?, Cammino appartenente a Roma?, Cammino inventato dagli antichi romani?, Banda luminosa che forma un ponte apparente tra Logudoro e Roma? O cos’altro? E che c’entra Roma con la Via Lattea? Forse che fu Roma ad aver indicato ai Sardi l’esistenza della Via Lattea? Forse che i Sardi prima di Roma non avevano alcuna nozione di astronomia? Chi vuole intendere in questo modo l’antica civiltà della Sardegna, avvalla la credenza che i Sardi nel passato fossero una nullità antropologica, un buco-nero della storia. In ogni modo, da questa situazione di stallo bisogna uscire in qualche modo; il ricercatore deve decidersi e giungere ad una soluzione, stando attento alle interpretazioni che lo immergerebbero nel ridicolo. A mio avviso, si esce dall’impasse assumendo quell’idea generalizzata su citata, che la Via Lattea sembri un immenso sentiero incendiato, e confrontando tale visione con la base sum. rub ‘to go, andare’ + ma ‘to burn, bruciare, incendiare’. In tal caso rub-ma indicò proprio un ‘cammino incendiato’, e l’aggiunta di log. cammínu non è altro che una replica dell’arcaico rub. Questa soluzione è una spia eclatante di come il sumerico sia stato la base del linguaggio sardo.
Senza la giusta intuizione è spesso impossibile pervenire al concetto primitivo che dimostra la giusta etimologia. Lo vediamo nel lemma pèttene nuor. e log. ‘pettine’. È giusto planare sul lat. pecten, ma poi occorre procedere sino all’ultimo livello, che è l’akk. peḫû ‘to close up, seal; bloccare, sigillare’ + ṭênu ‘to grind, macinare’. Per capire appieno quest’etimo occorre risalire all’era in cui la macina fu una pietra mossa avanti-indietro sopra una pietra fissa (quasi come il pettine viene mosso sulla testa). Il composto peḫ-ṭênu in origine significò ‘macina che blocca, sblocca (un corpo estraneo)’. Anticamente infatti il pettine era il migliore ausilio per ripulire la testa dai pidocchi.
Non sono mai sprecate le raccomandazioni al massimo rigore ed alla massima acribia nell’indagine. Esempio, il sd. tzimitóriu, cimitóriu ‘terreno destinato ad inumare i morti’, nel tardo lat. si chiamò cimitērium e lo si volle derivare da gr. κοιμητήριον ‘luogo dove si va a dormire’. Ma questa è una paronomasia, poiché l’arcaica base lessicale si rintraccia ai tempi in cui in tante parti del Mediterraneo vigeva l’incinerazione. Vedi akk. ḫimṭum ‘burning, abbruciamento, incinerazione’. Quindi un tempo cimitóriu fu il luogo dove si portavano i morti per incinerirli. Cfr. log. tziminèa ‘camino, il posto dove si arrostisce la carne’.
Unità delle lingue mediterranee. Il metodo sinora suggerito vale per tutte le contrade mediterranee.
Prendiamo il log. ant. carrúgiu ‘viuzza stretta’ (Stat. Castels. 155). È un evidente accatto dal gen. carroggio, carùggiu. A sua volta però la voce genovese mostra un’origine antichissima e interessantissima, legata al fatto che l’antica Genova, molto prima dell’avvento dei Romani, non aveva alcun sito pianeggiante: era un villaggio di pescatori abbarbicato sulla scogliera. I successivi piani alluvionali che pavimentano l’attuale città si crearono nei millenni col trasporto di ghiaioni durante le piogge rovinanti dai monti incombenti. Furono i ghiaioni, che avanzarono nel mare con ripetuti apporti, a dare fisionomia alla striminzita piana attuale. Per ovvie ragioni le prime case dei Genovesi nacquero con file perpendicolari al mare, allungandosi al disopra dell’erta dei canaloni che recavano acqua dalla montagna. Anche le case allungate ai bordi dei torrenti minori e dei ruscelli dovettero avere fin dall’inizio questa ubicazione, una direzione finalizzata a convogliare al mare senza ostacoli ogni moto d’acqua, la quale spazzava anche le deiezioni rilasciate lungo i carruggi. Di qui il nome carrùggiu, avente base etimologica nell’akk. ḫarru ‘water channel, water canal’ + uggu ‘rage, fury’. Carrùggiu indicò quindi, dall’origine, la ‘furia dei canali d’acqua’, ossia i condotti che convogliavano senza danno la furia dell’acqua piovana. Fu questa intelligente topologia ch’evitò le devastazione di Genova, in quanto non ostacolava i torrenti. In seguito, la fame di spazio portò ad edificare dentro gli originari carruggi, entro la golena dei torrenti principali, strozzandoli, o coprendoli, e sottomettendo parte della città ai capricci del tempo.
Aḍḍurare (Planargia), atturai(sì) camp. ‘fermare, fermarsi, rimanere’ = cat. aturar(se). Voce mediterranea con base etimologica nell’akk. dūrum ‘permanenza, eternità’, ‘stato permanente’. Cfr. it. durare.
Ammattái camp. ‘guarnire una nave dei suoi alberi’. Wagner lo confronta col tosc. livorn. ammattare ‘alberare, attrezzare una nave’; còrso ammattà ‘alberare, alzare all’aria antenne e sim.’, di conseguenza ne suggerisce subliminalmente la derivazione da quei lemmi italici. Invero questi lemmi sono tutti mediterranei, con base etimologica nel sum. ma da ‘to sail a boat’.
Angiulottus m. pl. camp. ‘sorta di ravioli’, che sono anche specialità della cucina piemontese (añulot). A quanto pare il termine è mediterraneo, con base nel sum. an ‘cielo’, akk. Anu ‘Dio sommo del Cielo’ + ḫul ‘gioire’, col significato di ‘Gioia di Anu’.
Aspro antroponimo medievale, il quale fu autenticamente sardo, sardiano, senza contatti col lat. Asper, come vorrebbe invece Pittau (UNS 144), che ci vede il solito latifondista romano. Aspro aveva base etimol. nell’akk. ašpû ‘tizio, individuo’ + urû ‘di Ur, nativo di Ur’: composto ašp(u)rû, col significato di ‘individuo nativo di Ur’. A questo riguardo occorre precisare che in Sardegna la nostalgia per la città di Ur fu tale, che se ne fondò una con lo stesso nome, il quale è rimasto identico fino ad oggi: è Uri, nel Logudoro nord-occidentale, che riprende il nome della biblica Ur (detta Uri in sumerico), per quanto dell’antica Ur questo villaggio non abbia ripetuto le glorie e gli sfarzi. Sarebbe faticoso convincere i renitenti che in Sardegna, attraverso gli attuali cognomi (molti dei quali sono antichi epiteti), siamo in grado di fare la casistica di quanti furono i luoghi di origine di certa popolazione antica insediatasi alla chetichella nell’isola; più che altro furono dei commercianti che poi, insediandosi stabilmente, furono chiamati col nome della città o della regione d’origine. Esempio: il cgn Assóru, Soru, Soro, è relitto aggettivale che denotò qualche commerciante assiro che costituì un fondaco in Sardegna: da ass. aššurû ‘Assiro’; bab. surû ‘a foreigner, uno straniero’. Altro esempio è il cognome Catte, Catta, da akk. ḫattû ‘Hittita’: esso mostra che nel primo millennio a.e.v. il commercio inter-mediterraneo era intenso, che c’erano pure dei commercianti hittiti, e qualcuno di essi, com’è naturale, andò a dislocarsi nell’isola di Sardegna. Ma andiamo oltre nella nostra indagine mediterranea.
Assu, sd. e it. asso ‘figura nelle carte da gioco o punto sulla faccia di un dado corrispondente al valore uno’. DELI lo crede dal lat. ăsse(m) ‘persona che eccelle’, e comunque non produce l’etimologia. In realtà la base sta nel sum. aš ‘uno’, hitt. aš ‘uno’.
Assussèna log. ‘giglio bianco’ (Lilium). Wagner, nonché Paulis NPPS 207, ne pongono l’origine nello spagnolo azucena; nelle laudi della Vergine e dei santi, è applicato alle sante (senza che il popolo conosca il significato della parola), e vale ‘qualcosa di estremamente puro e bello’: Candidissima assussèna (per Santa Greca). Quest’epiteto è variante del più noto Susanna, nome muliebre.
L’epiteto iberico, lo stesso nome muliebre, sono originariamente anche sardiani, ed hanno base etimologica nella lingua ebraica. Il muliebre Susanna significa ‘donna originaria di Susa’ (la capitale dell’antica Persia). Lo ritroviamo nell’ebr. Šušan ( שׁוּשַׁנ ). Pure il noto frutto del susíno ha la stessa origine: ‘originario di Susa’. In Italia abbiamo due cognomi ebraici italiani: Susin e de Susen. Dante Alighieri usa già prima del 1321 il nome del frutto, da ant. ebr. שׁוּשִׁין (šušin ‘nativo di Susa’), e s’affianca a Šošannah שׁוֹשַׁנׇּה (‘(fiore) di Susa’: Susa שׁוּשַׁה ).
Astru sd. ‘stella’. Cfr. lat. āster, gr. ἀστήρ ‘stella’. Se ne ignorò l’origine. La base etimologica è l’aram. Aštar, fen. Aštart, bab. Ištar ‘paredra del Dio sole (Anu)’. L’astralismo della religione babilonese simboleggiava la dèa con la stella Venere, con la quale fu identificata sin da tempi preistorici (OCE II 40); v. akk. aštaru ‘goddes, dèa’ (per antonomasia).
Karallu. Questo è un altro vocabolo mediterraneo, detto in it. ‘corallo’, in lat. corăllum, corăllium, in gr. κοράλλιον. Se ne ignorò l’origine, e nessuno s’accorse ch’esso fu pure il nome arcaico della città di Càgliari, detta in lat. Karalis ma citata da Tolomeo come Καράλλι. Il babilonese karallu è anzitutto il ‘gioiello’ (per antonomasia), ma l’assoluta antichità fa capire che questo gioiello fu inizialmente proprio il corallo rosso, di cui la Sardegna era zeppa. Facile arguire perché Cagliari fu chiamata ‘Gioiello’: non solo perché era il porto d’imbarco dell’intenso commercio del corallo nell’antichità, ma perché Cagliari stessa era incastonata nel sito più incantevole del Mediterraneo.
Cabillu camp. è un termine oscuro e incompreso. Lo si è considerato, da parte di moltissimi, dalla gente comune e, a quanto vediamo col Pittau, pure da certi linguisti viventi, come un aggettivo etnico indicante ‘chi è del Capo di Sopra’ ossia chi è della Sardegna settentrionale. Ma i dizionari sardi non recepiscono il lemma; in più, non si è dato conto di quel tema in -íllu. Peraltro, se cabíllu significasse realmente ‘quello del Capo di Sopra’, ci aspetteremmo che quanti risiedono a nord dell’isola usino anch’essi un epiteto reciproco per indicare “quelli del Capo di Sotto”. Ma non c’è reciproco. È un dato reale che questo epiteto sia usato soltanto nel sud dell’isola. Si risolve il problema esclusivamente se mettiamo in campo il vocabolario semitico, dove abbiamo l’akk. ḫābilu, ḫabbilu ‘criminale, malfattore’. Il significato non ha bisogno di commenti. Ma si pone il problema di quando sia potuto nascere un tale epiteto. Poiché il lemma è arcaico, sembra di poter affermare che sia nato in epoca prelatina, addirittura prefenicia. Cfr. ad esempio i Cabìli, i ribelli che stavano sull’Atlante a fronteggiare l’avanzata romana, e poi l’avanzata araba.
La durata della parlata accadica in Sardegna non è ancora cessata, e si può supporre che questa sia stata usata – con piena e reciproca comprensione da parte dei residenti – almeno fino all’anno 1000 di questa Era, nonostante lo sforzo del clero orientale mirante a omologare la parlata sarda a quella di Bisanzio.
È verosimile che l’epiteto sia nato durante l’epoca buia dei quattro Giudicati, allorché i quattro regni si combatterono tra loro senza esclusione di colpi in vista della supremazia allo scopo di unificare l’isola. L’epiteto, viste le premesse, è nato sicuramente nel giudicato di Càlari. I Barbaricini, coloro che transumavano in pianura da Désulo, Villagrande, Gavoi etc., erano i classici Cabilli, intesi come “malfattori”. Ma nella storia mediterranea ogni popolo errante si meritò un simile epiteto dalla popolazione residente, che male li sopportava. Anche Gli Ebrei furono chiamati inizialmente Habiru (la /r/ al posto della /l/ è tipica della fonetica espressa dagli antichi Egizi e dai Cananei del Sinai); tale parola significava proprio “malfattori, banditi”, perché essi erano nomadi e perché davano assiduamente fastidio alle città cananee attorno alle quali essi, tornati dall’Egitto, portavano le greggi al pascolo e organizzavano azioni di disturbo. Dall’antico Habiru abbiamo in seguito Hebrew, Ebreo (la stessa pronuncia, appena modificata).
Cadalettu log. ‘pagliaio’. Stando al Baldacci, è un annesso relativamente recente delle case anglonesi, è sopraelevato e vi si accede da fuori mediante scala a mano. In altre case tipiche sarde esso, quando veniva creato, stava al difuori dell’abitazione. Questa parola sarda è una delle tante prove viventi dell’espansione e omologazione mediterranea degli antichi linguaggi. A dire del DELI, la parola cataletto (‘sostegno della bara durante il trasporto’), significherebbe… ‘sotto il letto’, poiché viene interpretata dal gr. katá ‘sotto’ + it. letto. Questo è il miserrimo livello delle ricerche etimologiche in Europa. In realtà, questa parola sarda ha base etimologica nell’akk. qâdu ‘to ignite, incendiare, accendere, dar fuoco’ + littum ‘stool, sgabello’; quindi qâdu-littum indicò in origine la funzione sacra – tipica del Mediterraneo, del mondo greco ma anche del mondo indiano – di dar fuoco alla pira sopra la quale veniva posto il morto. Da quella figura, abbiamo il termine sardo cadalettu, vista la somiglianza delle forme e la stessa sostanza di ciò che viene posto nel cataletto.
Cadíra camp., barb., nuor. ‘sedia’; cfr. cat. cadira. In log. si dice cadrèa (vedi), a Bitti catrèa. Base etimologica è il sum. kad ‘to tie, weave a mat, fabricate’ + ri ‘to lay down, place’. Il composto kad-ri (+ suff. aggettivale -ca) significò in origine ‘(oggetto) intrecciato per riposarsi’.
Castòne. Tanto per restare in argomento, notiamo che la voce it. indica la ‘sede della pietra preziosa’; cfr. germ. kasto ‘scatola’ < akk. kasû ‘legare, trattenere, incapsulare, imprigionare, afferrare’, e simili, il cui sostantivo kasû ‘captivus, trattenuto’ ha il femm. kastû. Il tutto deriva dal sum. kasu ‘calice’, ḫaštum ‘buco’.
Altra voce mediterranea è dòga (Fonni) dòva, dòa log. e camp. ‘doga’, = it. e lat.; base nel sum. dug ‘pot, vaso’, duggan ‘leather bag, borsa di pelle’. Per metonimia, col passare dei secoli in Italia e in Sardegna si passò a indicare soltanto il fasciame ligneo della botte (innovazione tecnologica), mentre agli inizi il contenitore era considerato per intero, quale che fosse la materia di cui era fatto, ivi compresi i sacchi di pelle, ossia gli otri.
Varie metonimie ha subìto anche il sd. fetta, vetta ‘nastro, nastrino, fettuccia ornamentale’. Base etimologica l’akk. betatu (plur. tantum di un *betu evidentemente sopravvissuto in Sardegna), che fu una ‘decorazione usata sui vestiti’; in accadico ha pure il significato di ‘oggetti di pelle’ (che sono opere d’artigianato). Con questa etimologia togliamo d’imbarazzo il Dizionario Etimologico della Lingua Italiana (in seguito DELI), che annaspa nell’impossibilità di offrire un etimo dignitoso alla parola italiana fetta ‘parte di cibo sottile separata di taglio dal corpo principale’. Infatti già da epoca arcaica le fette di cibo furono assimilate alle fette ottenute da altri oggetti, ad iniziare dalle pelli sottili, utilizzate per vestiti, scarpe, cosmesi.
Di metonimie è zeppo il Mediterraneo, ivi comprese tante metafore poetiche come Tirana, nome di città, dal sum. tir-an ‘arco del cielo, arcobaleno’. Per contro, nel Mediterraneo condividiamo anche voci ferali, come sd. buggínu aggettivale in -ínu < sum. ugu ‘morte’ (che nei millenni fece fiorire persino il cognome piemontese Bogino ‘carnefice’).
Il sd. Déu, Déus ‘Dio’ equivale al lat. dĕus ed al gr. Ζεῦς < sum. de ‘creare’ + u ‘totalità, universo’: de-u ‘Creatore dell’Universo’. Questa parola è fissa da almeno 100.000 anni, ed è sciocco pretendere che i Sardi l’abbiano importata.
Altra fissità si ritrova nel gr. δίκη ‘giudizio’ < sum. diku, dikud ‘giudice’; cfr. lat. dicō. L’appartenenza al campo sumerico è palmare, e dimostra l’arcaicità di questa parola, legata all’atto stesso del parlare, ai tempi in cui una parola equivaleva a un sasso, ogni parola era sacra, ogni parola era conferma di un fatto o di una cosa, era un giuramento inviolabile. Da lì questo venerando vocabolo mediterraneo.
Domu sd., lat. domus, gr. domos ‘casa’ è un’altra voce di estrema antichità mediterranea. Con tutta evidenza, nacque sul finire del Paleolitico, allorché l’uomo, che pure continuava a dimorare nelle caverne o nelle capanne di frasche, decise di erigere qualcosa di duraturo agli déi, facendo tesoro delle numerosissime fratture che notava nelle pareti rocciose, che gli diedero la prima idea delle sovrapposizioni litiche. Infatti la voce domu ha base etimologica nel sum. du ‘costruzione’ + mu ‘crescere’: du-mu = ‘costruzione in altezza’.
Il lat. niger, nigrum è parola mediterranea arcaica. Oggi il parlante occidentale, infatuato dalle mode americane, non vuole più usarla, allertato da una moda beghina secondo cui qualsiasi uomo “di colore” se ne deve adontare (guai a proporgli il contrario!). Ovviamente i negri appena sbarcati in Italia con provenienza centro-africana non accetterebbero mai un tale aggettivale, perché arrivano già imboniti dalla propaganda americana, rivolta al feticcio della parola in sé anziché a un rispetto democratico tutto ancora da condividere (anche in Italia!). Eppure in Italia questo aggettivale fu usato senza ipocrisia da sempre, persino in varie canzoni recenti (es. “Pittore ti voglio parlare”, “Mamma negra”, “Hully-Gully”). Ma oggi l’ipocrisia ci sta affogando, e finora – guarda caso – si è ignorata la base etimologica di negro, che è il sum. ni gur ‘che incute timore’.
Questo aggettivale latineggiante a sua volta ha un riscontro nell’it. nero, che – guarda un po’! – deriva dal sum. neru ‘nemico’.
Il discorso si chiude a triangolo col sd. nieḍḍu ‘nero’, la cui base non è un inesistente lat. *nigellus ‘nereggiante’, come invece qualsiasi latinista va proponendo senza criterio, ma è il sum. ni ‘fear’ + e ‘far entrare’ + dub ‘tremare’ = ‘paura che fa tremare’, ossia ‘paura tremenda’.
Il triangolo tirrenico niger/nigrum-nero-niéḍḍu, da qualsiasi parte lo assumiamo, sarebbe un affronto per i negri. E noi tirrenici, terrorizzati (resi niéḍḍi) dalla “dittatura dell’ignoranza”, non sappiamo più come trattare i nostri fratelli di pelle diversa, e ci lasciamo dominare dalle ideologie razziste, rendendole ancora più abiette da una catastrofica debolezza nell’uso del linguaggio degli avi.
È del tutto normale che moltissime parole sarde siano rimaste fisse dal primo remotissimo gemito sino ad oggi, quale può essere il log. pertúnghere, camp. pertúngiri ‘bucare, forare’: indubbia corruzione dal lat. pertŭndere ‘forare, bucare’, da cui anche sd. pertuntare ‘traforare, corrodere’, infine pertusare, -ái ‘bucare, forare, pertugiare’. Il pref. mediterraneo per- indica il passaggio da parte a parte, e la base etimologica passa per il lat. tundō ‘batto, pesto’, planando sul sum. tud ‘to beat, hit; colpire, battere’.
Territorialmente più percepibili sono certe sopravvivenze come pilótu camp. ‘palo da palafitta’ = sp. pilote ‘madero rollizo armado frecuentemente de una punta de hierro, que se hinca en tierra para consolidar los cimientos’ (cfr. it. mod. pilotis ‘colonna in cemento armato dei moderni palazzi’ < fr. pilot ‘palo’, pile ‘pilastro’). Wagner si soddisfa nel proporre la discendenza della parola sarda da quella iberica, e lì si placa, senza ulteriore indagine. Eppure queste voci sono di estremo interesse. Per quanto a qualcuno possa apparire astruso, la circolazione culturale che rinsaldò la Koiné Mediterranea fece viaggiare anche i termini che un popolano non avrebbe mai potuto formare direttamente ma soltanto accettare in virtù degli approci reciproci. Un sardo non conobbe mai la proboscide e nemmeno l’elefante, ma quel nome circolava culturalmente nel Mediterraneo. Pertanto gli fu facile condividere con iberici e provenzali la voce pilótu, pilote, dall’akk. pīlu, pīru ‘elephant’ (metonimia: ‘proboscide’) + ūttu-, āttu- ‘belonging to, relativo a’. Che la formazione pil-ótu, pil-ote sia stata formalizzata nell’ambito del Mar di Sardegna, lo si capisce dal fatto che ūttu- in accadico veniva prefisso, mentre in Sardegna ed in Ispagna venne suffisso.
La Koiné Mediterranea, a bene intenderla, fa capolino con decine di migliaia di parole sparse qua e là, che nessuno però accetta di percepire come fenomeno unitario. Purtroppo, senza questa percezione non si arriverà mai a padroneggiare questa Koiné, e sfuggirà un fenomeno come pitarra (Oristano), nome della ‘gallina prataiola’ altrimenti detta ‘otarda minore’ (Otis tetrax Cetti). Cfr. salent. pitarra, sic. pitarra ‘idem’; it. sett. pita ‘gallina’. Premetto che il nome sd. più usuale dell’otarda è pidráxu, che però ha la stessa forma basica di pitarra (pidr-). Wagner si limitò a segnalare le coeve presenze di pitarra ad Oristano, nel Salento, in Sicilia, in alta Italia, e suppose che pitarra in Sardegna fosse un accatto, cadendo nel deviante preconcetto del colonialismo. Tale preconcetto, proprio perché deviante, gli tarpò le capacità critiche, come ora vado a evidenziare. Infatti Wagner (DES II 284) si era meravigliato del fatto che pure in Italia sopravvivesse il suffisso -àrra da lui considerato di “origine preromana”. Tale fantasma era emerso in luoghi per lui insospettabili, poiché Roma, secondo lui, aveva latinizzato gl’Italici fino al midollo. Se solo avesse percepito la superiore presenza della Koiné Mediterranea, si sarebbe rilassato, riuscendo persino a scindere meglio la voce pitarra. Infatti l’etimologia deve partire dal prototipo sd. pieppìa ‘gallina’ (dove ritroviamo la base pi- < akk. pīum ‘becco’, opportunamente raddoppiata ad indicare il frenetico uso del becco fatto dalla gallina nel razzolare). Il secondo membro di pitarra non è quindi -arra (immaginato come suffisso) ma -tarra < akk. tarru (a bird); e pitarra in origine significò ‘uccello che razzola’, indicando genericamente vari tipi di gallinaceo.
Ragùsa toponimo italico e dalmata (anche cognome italico: Ragosa). Termine sacro mediterraneo, con base nel sum. ra ‘luce, splendore (riferito al Dio Sole)’ + guza ‘trono’, col significato di ‘trono di Ra’: segno che nell’area sorgeva il tempio al dio Sole.
Occorre ammettere che noi, figli di un Mare chiuso, siamo eredi di lingue fortemente innervate dalla potente Koiné Mediterranea. Ammettere ciò comporta la dissoluzione istantanea della pregiudiziale “latina” e di quella “ariana” (sia pure quando quest’ultima è camuffata da indogermanica), tenute in vita nelle orangeries delle varie Università. Se non dissolviamo quei preconcetti non riusciremo mai a capire perché Sirèna sia un antichissimo cognome sardo, mentre lo si riteneva nome prettamente greco poi emigrato a Roma. Omero (Od. XII) ci fa conoscere quelle creature marine che affascinavano col canto. Infatti Sirena (gr. Σειρήν) significa ‘Colei che affascina col canto’ < sum. šir ‘cantare’ + en ‘incantesimo, fascinazione, opera di magia’. Il dover ammettere che il nome sia sumerico equivale a riconoscerlo come mediterraneo.
Scampiái camp. ‘cessare di piovere’, ‘schiarire’ (del cielo) = cat. escampiar ‘asserenar-se, aclarir-se el temps’; sp. escampar ‘dejar de llover’; anche in tutta Italia meridionale scampare ‘idem’. Wagner con questi raffronti da lui fatti (e miranti a validare l’idea dello ‘scampare, salvarsi da un male’) non ha indicato un’etimologia di appoggio alle sue proposte, che pertanto appaiono surrettizie.
Indubbiamente, il verbo scampare in quanto ‘salvarsi da un male’ ha base nell’akk. kappum ‘wing, ala’, ‘hand, mano’, dove il suff. s-, es- ha la funzione di far percepire l’apertura della mano che libera la cosa afferrata (questa figura etimologica, a ben vedere, rende perfettamente lo scampare). Ma nel caso sardo ed iberico il campo semantico si allarga notevolmente e mira anzitutto all’akk. kappum ‘harness, finimenti, bardature’, dove il suffisso s-, es- offre il concetto della privazione, liberazione. Vedi anche akk. kapārum ‘to wipe clean, ripulir bene’. Quindi è grazie a queste tre voci accadiche che il sd. scampiái ed i due verbi iberici tessono il proprio campo semantico.
Di questo passo nella lista dei nomi mediterranei potremmo annoverare centinaia di migliaia di voci, e non è utile proporli in questa sede. Serve però qualche esempio affinché il lettore capisca la situazione linguistica entro cui ci muoviamo. Quindi gli propongo anche il sd. seḍḍa = it. ‘sella’ < sum. šed ‘to rest, poggiare, riposare’: si può notare l’appartenenza della voce sarda al vocabolario sumerico nonché la differenza grafico-fonetica di quelle italica e latina. Il lat. sĕlla valorizza il significato di ‘sedia’ < akk. sellu ‘archivolto’ (an architecture feature: tutto un programma), ma per il resto la voce latina è precisa alla parola italica. La differenza fono-grafica tra seḍḍa-sedia-sella nonostante l’unità del campo semantico, deve far meditare sulle sottili differenze tra le lingue tirreniche, sulle minime convergenze-divergenze dovute all’autonomo maturare dei processi linguistici, senza che ciò richiami l’assurdo principio della “origine” o della “derivazione”. Questa opposizione fono-grafemica deve far meditare pure sull’inaccettabile modo di affrontare il problema della cacuminale sarda -ḍḍ- (presente anche in sud-Italia), la quale si differenzia dalle liquide -ll- del centro-nord Italia. Non è questa la sede per discuterne, anche perché questo problema è stato illustrato e risolto nel cap. 3.1.5 della mia Grammatica Storica (intitolata Grammatica della Lingua Sarda Prelatina).
Eccoci giunti all’avverbio si log. e camp. ‘se’, ‘nel caso che’, ‘nell’eventualità che’: indica esitazione, incertezza, dubbio, condizione. Di questa voce mediterranea s’ignorò l’origine. Ha base nell’akk. Sê’, Sîn ‘Dea Luna’. Nel lontano passato entrò in qualsiasi invocazione rivolta alla Luna. Si deve assumere per certo che questo onnipresente Se, Si fosse a capo di quasi ogni frase, così come ancora oggi Insciallah tra gli Arabi. Nella lingua italica medievale il se era usatissimo nel senso di ‘se, voglia il Cielo che…’, e ciò è una spia di quanto vado affermando.
L’esempio del monosillabo si, se rintuzza anche un’altra illusione pollonata assieme a quelle già esaminate: è l’illusione (o la scorretta prospettiva) della “evoluzione” delle lingue. Certamente l’evoluzione avviene, è innegabile, ma il lettore deve capire una volta per tutte ch’essa è molto più lenta di quanto s’immagini, e per moltissimi vocaboli è più apparente che reale. Diciamo pure che moltissimi vocaboli non si sono mai evoluti sin dal momento in cui (40.000?, 100.000 anni fa?) furono formulati. Rifacendoci all’agglutinazione prediletta dalla lingua sumerica (ma non solo da essa), possiamo affermare che moltissimi vocaboli mediterranei non sono altro che agglutinazioni di monosillabi sumerici. Prendiamo l’it. singulto ‘singhiozzo’, lat. singūltum ‘idem’. Base etimologica è il sum. sim ‘to swallow, inghiottire’, ‘deglutizione’ + gul ‘to destroy’ + tu ‘incantation, incantesimo’. L’agglutinazione sim-gul-tu in origine significò ‘incantesimo che distrugge la deglutizione’.
Lo stesso processo vediamo nel sd. tambùru, it. ‘tamburo’. Nel Mediterraneo il termine esiste da tempi arcaici; il nome dello strumento primordiale che rimbomba con la percossa ha origine primitiva, ed è facile ricavarlo dal sum. tun ‘contenitore, cassa, sacco, stomaco’ + bur ‘albero’ (tun-bur), col significato originario di ‘cassa d’albero’ ossia ‘albero cavo’.
Medesima fissità ritroviamo nel sd. zéru, it. zèro, fr. zéro, sp. cero. Rinvio al Dizionario per leggere le lambiccate e scorrette etimologie proposte dai più illustri etimologisti per una parola mai compresa. In realtà zero deriva dall’akk. zēru ‘seme’, ant. ebr. zeraʽ (זֶ֫רַע). Con ciò gli Accadici (Babilonesi), grandi cultori di matematica, volevano intendere che dallo zero, come da un ‘seme’, origina la sequenza dei numeri.
Altra parola inalterata è il sd. tzilléri ‘bettola, taverna’, sp. cillero, cat. celler ‘bodega’. Base etimologica di questo aggettivale in -éri è il sum. zil ‘to boil, peel; bollire, sbucciare’. Questa voce sardo-iberica ancora oggi indica il posto dove si cuoce (il cibo), ossia la taverna dove un viandante o un pellegrino poteva fermarsi a mangiare.
Molte voci sarde sono presenti sia in sumerico sia in accadico, com’è per toróju log. ‘urlo, grido, pianto scapigliato, mortorio, piagnisteo’; pránghere a toróju ‘piangere dirottamente’. Base etimologica l’akk. turu’u ‘a cry’ da sum. tur ‘to be ill, star male’. Cfr. gallego aturujar ‘ulular, berrear’ e altre voci simili.
Altre voci sarde si riesumano soltanto dall’accadico (e dall’assiro-babilonese), come il citato zéru. Consideriamo all’uopo vánuva, fánuva camp.; fánua, fáuna log. ‘coperta da letto imbottita’; cat. vànova ‘frazada’; è un aggettivale s’ignorò l’origine. Base etimologica è l’akk. banû ‘make good (object); look after s.o. kindly; render buono (un oggetto), prendersi cura di qualcuno delicatamente’. La presenza e consistenza di rarissimi oggetti di lusso tra le popolazioni del Neolitico rendeva una coperta imbottita (di lana di pecora) assai confortevole. Le pretese del Wagner che questa voce sia nata in Catalogna e poi esportata in Sardegna sono miopi e fallaci. Se fossero state scientifiche, egli avrebbe dovuto indicare la base etimologica della voce catalana.
Con l’ausilio dell’intuizione (dell’intuizione utile…) possiamo chiarire il mistero del sintagma italiano “sbarcare il lunario” ossia ‘riuscire a campare sia pure stentatamente’. Si crede il sintagma esclusivamente italiano, senza considerare i radicali sottesi alle due parole, che sono mediterranei, in uso quasi ovunque, anche in Sardegna. I radicali indicano lo stesso concetto, uno accadico e l’altro sumerico: s-barcare < akk. warḫu ‘moon’; lunario < luna (agglutinazione sum. lu ‘to flare up, divampare’ + nu ‘creator’: lu-nu ‘Creatrice divampante’, ossia ‘Dea Luna’, ‘Dea Madre’). Quindi “sbarcare il lunario”, con s- che precisa il valicare, l’andare oltre, indicò l’azione di “superare il mese” (quello lunare, ovviamente). La barca non c’entra nulla.
Altra voce mediterranea incompresa è il sd. casu ‘formaggio’. Perché gli dò importanza? I fautori della “pregiudiziale latina” lo derivano dal lat. căsĕus e non s’accorgono che căsĕus è aggettivo, quindi seriore rispetto al vocabolo sardo. La base etimologica è l’akk. kasû ‘rappreso, legato’ (e siamo al formaggio). Vedi anche akk. kāsu ‘cup, bowl’, ‘misura di capacità’ < sum. kasu ‘calice’ (e siamo alla ‘scodella che dà forma’, quindi nuovamente al formaggio, ‘quello che prende forma’). Però il cognome sd. Casu non significa ‘formaggio’ ma ha base nell’akk. ḫašû astron. ‘scuro’, gr. Χάος ‘immensa buia cavità che accoglie le acque primordiali’. Ebbene, sì, il Χάος greco in Sardegna si chiamava Casu, in virtù dell’autonoma elaborazione delle radici e dei suffissi mediterranei.
Buon penultimo è il sd. pilla ‘denaro, soldi’ (parola che riemerge anche in sud-Italia: vedi la mia Grammatica Storica). I cosiddetti “puristi” la considerano voce di slang, ed ignorano che la base è il sum. pil-la = ‘unità di pagamento’: pi ‘unità di misura’ + la ‘pagamento’.
Conscio d’essermi concesso molto spazio (ma la situazione lo reclamava, essendoci innumerevoli casi), chiudo l’elenco, illustrando brevemente la questione del sardónios ghélōs o sardánion ghélōn, ossia del ‘riso sardònico’. Non intendo affatto inserire l’argomento nel paragrafo seguente relativo alle voci autoctone del vocabolario sardo, poiché questa voce non è autoctona: è solo martoriata. La prima apparizione scritta collegabile a questa espressione è in Omero Od. XX 301-302, allorché Odisseo schiva la zampa di bue lanciata da Ctesippo e “ride sardonicamente” (μείδησε δε θυμῷ σαρδάνιον μάλα τοῖον ‘sorrise in cuor suo, però dolorosamente’). L’unica ricostruzione arcaica cui è possibile agganciare l’aggettivo avverbiale greco è il composto sum. sa ‘to burn’, ‘to sting, pungere’ + raḫ ‘disease’, ‘to beat, break, crush’ + du ‘to push, thrust, gore; spingere, attaccare, incornare’ + niḫuš ‘terrifying appearance’, che agglutinandosi (sa-raḫ-dú-niḫuš, poi contratto in sardúniḫuš) porta al significato compatto di ‘dolorosissimo, sconvolgente’.
Ma tanti seriori autori greci e latini, nel tramandarsi a vicenda un’incompetenza culturale sull’omerico σαρδάνιον, sono andati a parare su altri significati, a loro parere legati a un’erba speciale che fa morire tra spasmi di labbra e digrignar di denti; senza peraltro aver mai pensato che Omero con l’aggettivo σαρδάνιον volle descrivere lapidariamente un Odisseo muto e serio, che non aveva sorriso apertamente per la provocazione di quel prepotente ma aveva soltanto rimuginato nel proprio animo la vendetta.
Sul riso sardònico si potrebbe scrivere un libro, ma sarebbe sprecato, perché parlare dell’erba sardònia o del riso sardónio è come parlare del sesso degli angeli. Nella storia di questo appellativo ognuno degli autori è stato coinvolto in un vortice di traviamento collettivo, condito da ignoranza, da presunzione e dalla fiabesca distanza tra Grecia e Sardegna, un’isola che i Greci non avevano mai visto ed alla quale, considerata la sua dislocazione nel mitico Occāsŭs Sōlis, potevano conferire a man salva tutti i misteri mediterranei covati dalle civiltà dell’epoca. Tutto ciò portò poeti e pensatori a girare su se stessi sino a parare in una messe di paronomàsie che si stratificò ed ammuffì col passare dei secoli. Il riso sardónio puzza di stantio.
In ogni modo, il gr. sardónio può anche essere inquadrato nel sum. šar ‘vacca’ + du ‘imprigionare’: šar-du ‘imprigionare entro la vacca’. Era l’urlo lacerante emesso dai moribondi nel ventre metallico di questo arnese inventato dai Cretesi e surriscaldato. Altri lo chiamano Toro di Faláride, perché donato al tiranno Falaride di Agrigento da Perillo ateniese. Il sardónikos ghélōs fu una cosa orribile che oggi, con cinica metonimia, possiamo intendere come ‘risata smodata, plebea, esagerata, chiassosa, urlante’.
Se invece vogliamo mutare il gr. sardónios in gr. sardonicós, la voce sarebbe un po’ seriore, essendo da inquadrare in un composto sumero-accadico cui sarebbe da aggiungere l’akk. niqû ‘sacrificio’. A sua volta ghélos < sum. gi ‘giudizio’ + lu ‘divampare’, ossia ‘giudizio del fuoco’. Pertanto sardonicós ghélos, nella sua commistione di sumero-accadico, presenta una pari sovrapposizione di concetti, e andrebbe a significare nel complesso ‘sacrificio dell’imprigionamento entro la vacca’ o ‘giudizio del fuoco entro la vacca’.
Arcaicità della lingua sarda. Il breve saggio sui vocaboli mediterranei non deve far pensare che ai singoli popoli rivieraschi mancasse la possibilità e l’estro per invenzioni autonome (vedi il già citato Karallu). Ogni popolo ha sempre usato la lingua secondo il proprio genio, ed i fenomeni d’isolamento – macroscopici in Sardegna – impulsero a “far da sé”, senza per questo che si smettesse di collaborare al proficuo scambio culturale al quale la Sardegna non si è mai sottratta. L’enorme massa di radicali sumerici (ed in seguito accadici) fu la banca-dati da cui attingere sia per usare il vocabolo nella sua purezza sia per elaborare filiazioni, o “ricamare” concetti autonomi. Quindi non deve far meraviglia che la stessa radice sumerica o sumero-accadica abbia dato corso a voci diverse nei singoli popoli rivieraschi. I suffissi, i prefissi – eredità del plancher sumerico – sono l’ingrediente che arricchisce i processi della fantasia individuale; cui si somma l’abitudine alla metatesi (es. craba anziché capra), alla diversa accentazione (es. càmpana anziché campàna), all’apofonesi (citerò più oltre qualche sporadico esempio latino, italico, sardo, accadico, sumerico di mutamenti -a- > -i- oppure -a- > -u-). Questi processi sono stati da me studiati e illustrati nella Grammatica Storica, e qui non m’attardo.
Sta di fatto che, per ovvie ragioni, i singoli popoli hanno elaborato i propri vocabolari secondo esigenze peculiari, e pertanto non tutti i vocaboli rintracciati per l’ampio bacino costiero sono identici tra i popoli. Molte voci appartengono ad un solo popolo.
Di seguito propongo un breve elenco di vocaboli (tra le migliaia) che appaiono formati unicamente dal genio sardo.
Áere log. ‘avere’; camp. ái; sass. abe’. In sardo antico si usava come verbo transitivo. Oggi s’usa più che altro ténnere, ténniri, jùkere, al di fuori del centro-isola dove invece prevale ancora áere. Il sd. áere, ái ha sempre vissuto in autonomia senza ricevere influssi diretti dal lat. habēre, it. avère. La spia di tale separatezza è l’assenza nel verbo sardo di h-, la cui presenza avrebbe postulato tutt’altra radice di formazione, come ora vedremo.
A mio avviso, il sardo áere, ái ha base etimologica nel sum. ab ‘cow’, mentre il lat. habeo ha base nel sum. ḫabum ‘animal’. Ambedue le basi fanno riferimento ad animali (si presume d’allevamento), specialmente alla vacca, da sempre considerata il peculium per antonomasia. Così come ancora oggi accade presso i popoli pastori del centro-Africa, considerati “possidenti”, “benestanti”, contrapposti a coloro che non posseggono bestie, anche per gli antichi Sardi e Latini il destino dovette essere uguale: il possesso di bestiame li rendeva liberi e ricchi. Di qui la nascita del verbo avere, riferito alle vacche o agli animali in genere.
Agarrutu in una pergamena arborense del sec. XII, pubblicata secondo l’originale in AStSa II 426 dal Besta, che interpreta ‘qualità di terra, forse brughiera’ (p. 429). Il passo suona: Et ego donna Nibata ponioiue saltu de Suberiu et pauli de Figu e fenu e pastu e perra de bilbicesos e bau de bodes e agarrutu. (Nell’apografo pubblicato nl CDS I, 164, che formicola di errori, si legge: e pezza de bilbiusos, abandecodes e agarratu). Niente giustifica l’interpretazione del Besta e il passo non permette di dire niente di sicuro.
Tutto quanto precede è stato scritto dal Wagner nel DES. Posso sollevare Wagner dall’angoscia facendo notare che agarrutu ha il perfetto corrispettivo in accadico: agarrūtu ‘bracciante salariato a giornata’.
Alguatzíle, -i log. e camp. ‘usciere, sbirro’; Wagner lo considera ormai fuori uso, ed in ogni modo non evidenzia l’etimo. Base etimologica è l’akk. āliku ‘goer, traveller, messenger’ + aširi (person of a special status). Pare evidente che ālik-aširi nell’alta antichità in Sardegna fosse un messo con poteri ispettivi.
Allegare, -ái log. e camp. ‘discorrere, parlare’; allèga ‘diceria, discorso’. Wagner lo crede verbo dell’uso giuridico, da it. ‘allegare, addurre ragioni, argomentare’. Ma la forma-base del lemma sardo è composta da ad (particella sardo-mediterranea di moto a luogo) + sum. ligin ‘tavoletta d’argilla con excerpta scolastici da imparare’, ligtum ‘selezione, raccolta di materiale’. Va da sé che allegáre è verbo sardiano risalente alle antichità sumeriche, indicante l’azione del “trasmettere nozioni per l’apprendimento; parlare insegnando”.
Allégru log., allirgu camp. Questo termine sembra derivare dall’it. allegro ‘lieto, giocondo’, per il quale si accampano strane e incomprensibili etimologie: fr. allegre (1130) dal lat. alacrem (DELI). Quella voce francese va bene, fa parte dell’uso mediterraneo, mentre è la voce latina ad essere discorde. Penso che la base etimologica dei lemmi sardo, italico, francese sia il sum. lugura ‘reaper, mietitore’. Si può rendere giustizia a questo termine soltanto se ci mettiamo nella condizione di capire gli antichissimi mietitori, i quali entravano nei campi cantando le lodi dell’Altissimo, felici perché stavano partecipando al rinnovo annuale del dono della vita.
Alòre log. ‘caldo lento’ (Spano). Secondo Wagner è probabile derivazione dall’it. alidore ‘siccità, stagione alida’. Invero, base etimologica è il sum. alur ‘to bake, cuocere al forno’.
Attonare, -ái log. e camp. ‘ristorare, mettere in sesto’; attonare su stόgumu ‘ristorare, rifocillare’. Anche in Italia si dice attonare lo stomaco. Ma non siamo di fronte a un cultismo, come purtroppo crede Wagner, poiché la parola è mediterranea, avendo per base il sum. tun ‘stomaco’, ‘sacca’, ‘contenitore’.
Aúra log. ‘spirito misterioso, spettro’, ‘paura’; bonaúra ‘fortuna’, disaúra ‘disgrazia, sciagura’; auradu log. ‘spaventato, atterrito’; anche ura ‘evento cattivo’ (nel senso di ura mala). Wagner non sa trovare l’etimo. Invero la base etimologica è il sum. ur ‘liver, fegato’, quello che nell’alta antichità veniva sezionato per ricavarne gli auspici (buoni o cattivi).
Aúrghere log. ‘muoversi, sforzarsi, piegarsi’ (Sanna, StaSa XII-XIII parte II, p. 441); aúlghere ‘muoversi, sgranchirsi’ (Casu). L’etimo ha base nell’akk. urḫum ‘via, sentiero’. Wagner ne indica insensatamente la dipendenza dal lat. indulgeō ‘sono ben disposto’.
Avra log. indica la ‘brezza fredda nociva alla frutta’. La sua base arcaica sta nel sum. a ‘acqua’ + bar ‘to burn’: a-bar, per metatesi avra, indicò in origine l’acqua che brucia. Evidentemente siamo in quelle rare giornate di pieno inverno quando piove acqua sopraffusa, pressoché invisibile ma capace di lasciare un millimetrico strato di gelo dappertutto, distruggendo le piantagioni.
Bi, be sd. avverbio di luogo. Cfr. ug. b ‘in’, ebr. be- ‘in’; l’avverbio di luogo cananeo è sempre agglutinato alla parola retta (es. B-ŠRDN ‘in Sardegna’, dalla Stele di Nora). L’avverbio di luogo ugaritico-fenicio-ebraico b (be) è anche sardiano. Si ritrova in molte indicazioni di luogo nelle forme be, bei, bi; indica sempre un luogo, non sempre preciso, lontano dal parlante: ‘lì’, ‘in quel luogo’, ‘a quel luogo’: siéntzia bei keret, no bestire!; a contos male fatos si bi torrada; ite b’ada?; in s’isterzu de s’ozu non be podiat aer ke murca; de listincu be nḍ’aìat prus de una molinàda; a campu bi anḍo déo; bazibbéi a domo sua; a bi sezis, si benzo a domo bostra?; in su putu bi at abba; no bi creo!
Biscaccàda ‘lentiggini’. Zonchello ignora l’etimo ma azzarda derivi da biscaccu ‘conchiglia, patella’. Sbaglia. Base etimologica è l’akk. biṣu, biṣṣu(m) gocciolina’ + kakkû(m) ‘lenticchia’. Lo stato-costrutto significa, letteralmente, ‘pioggia di lenticchie’.
Cambiare, -ái log. e camp. ‘cambiare’. Verbo presente già nei condaghes, che secondo Wagner sarebbe un evidente apporto dal tardo lat. cambiāre, di origine gallica secondo DELI. Non sono d’accordo né con l’uno né con l’altro. Base etimologica è il sum. kam ‘to alter, modificare, cambiare, mutare’ + ba ‘to distribute, ripartire’. Queste sono le stesse radici sumeriche che determinarono la nascita della parola sd. camba, da cui l’it. gamba, la quale è l’arto degli animali e dell’uomo che ha la funzione di ripartire e mutare continuamente il peso durante il movimento.
Catóiba sass. ‘prigione’. Base etimologica è l’ant. akk. ḫaṭû, ḫaṭṭû, ḫaṭ’um ‘criminal, criminale; to do wrong, commit crime, agir male, commettere crimine’ (towards someone) + ewûm ‘to impose on, imporre’. Quindi il composto ḫaṭṭû-ewûm significò in origine ‘imposizione, pena per il criminale’. Col tempo ewûm fu pronunciato -ebu, -ibu, per legge fonetica tirrenica. Questo vocabolo non esiste in nessun altro dizionario sardo, tantomeno italico.
Cùa è voce assente nei dizionari mediterranei. Dovette essere l’antico nome sardo della ‘civetta’ e del ‘gufo’, sopravvissuto grazie al cognome Còa, registrato nel condaghe di Bonarcado 57. La locuzione log. fàghere assa cùa significa ‘agire di nascosto’. Cùa, cuba è l‘atto del nascondere. L’infinito cuare ‘nascondere’ è un chiaro denominale, essendo cùa il sostantivo originario, da akk. ḫū’a ‘civetta, gufo’.
Débile, débili log. e camp. ‘debole’; cfr. lat. dēbilis ‘che manca di forza’. In Sardegna sarebbe arrivata dalla Spagna (débil) secondo Wagner. Invece la voce è decisamente sardiana, prima ancora che latina e spagnola: esattamente è l’opposto di ábile, che ha base nell’akk. ābilu ‘trascinatore’ (detto della professione di chi trascinava le navi lungo i canali o i fiumi, e detto anche dell’aquila in Logudoro).
Ábile log., ákila, ákili camp. ‘aquila’; áe (Nuorese). È proprio questa serie di vocaboli sardi (uno per ogni macro-tribù preromana) a testimoniare la scaturigine autoctona del su citato débile. L’etimologia di ákila ha base nell’akk. ākilu ‘divoratore’ (cfr. lat. aquila). Ma in Sardegna un’altra tribù utilizzava un secondo (e doppio) registro, che è āgilu, ābilu ‘trascinatore’ (detto della professione di chi trascinava le navi lungo i canali o i fiumi). Infatti destò sempre ammirazione il fatto che l’aquila con la sua forza poderosa sia in grado di sollevare e portar via persino un animale di media stazza come una pecora o un muflone. La controprova dell’autoctonia di ábile si ha in barbaricino col terzo vocabolo áe, indicante l’Aquila del Bonelli, il cui nome si riferisce parimenti al “trascinatore di navi” (dal sum. aʼu ‘towman’). Non fa meraviglia che il nome dell’aquila abbia migrato dalla Sardegna a Roma, e non viceversa: la Sardegna è fortemente montuosa e selvaggia, mentre il Lazio è fortemente pianeggiante, o leggermente collinoso, quindi totalmente arabile: luogo difficile per la dimora delle aquile.
Dogare centr., doare, addoare log. ‘scavare un fosso intorno ai terreni da debbiare’: fákere sa doga (Nuoro) ‘dissodare la terra in modo che il fuoco non passi’. Base etimologica è il sum. dub ‘to go around, encircle, turn, surround’. Col tempo, evidentemente, il termine sumerico fu omologato foneticamente al radicale sum. dug ‘pot, vaso’. Notiamo anche l’evoluzione di dogare nel significato di ‘ripararsi dal fuoco’ (fattende dogas), poi in generale ‘ripararsi’, ‘scansare’, anche ‘ripararsi (dalla pioggia)’.
Forru log. e camp. ‘forno’; cfr. lat. furnus. Base etimologica il sum. bur ‘to glow, abbagliare; to light, accendere, infiammare; to shine, risplendere, brillare’ + ru ‘architecture, costruzione’. Il composto bur-ru significò in origine ‘costruzione per accendere (il fuoco)’. La sardità della voce si percepisce per l’assenza del riempitivo -n- esistente invece nel lat. furnus. Mio malgrado, debbo segnalare DES I 536 affinché il lettore conosca le prolisse e allucinate elucubrazioni scritte su forru, ammannite come fossero ragionamenti scientifici.
Francusìna orist. ‘colica’, ‘mal di pancia’. Cossu 151 ricorda che quando uno restava a lungo col broncio gli dicevano: Pigáu sa francusina t’esti? ‘t’ha preso la colica?’; e per una persona che s’intristiva alquanto (s’affringillonàḍḍa) e non aveva voglia e forza di fare dicevano: Paris cun sa francusìna ‘Sembri con la colica’. Ma è veramente strano che per francusìna s’intenda proprio la colica, considerata la sua etimologia.
Per Wagner sa francusìna è una formazione scherzosa. Replico di no, poiché francusìna ha un proprio etimo, l’akk. parāku(m) ‘giacere di traverso, ostruire’, ‘impedire, ostacolare’ + sînu ‘luna’ col significato di ‘avere la Luna (il dio Luna) di traverso, ossia contrario’. Ora sappiamo quale è la locuzione più antica, e da dove ha origine la frase italiana tanto nota, relativa a una persona (donna prevalentemente), momentaneamente asociale, che appunto “ha la luna di traverso”, da parāku(m) > p(a)raku > franku + sînu.
Fruttòsa (Bitti) ‘piccola spazzola per pulire l’aia’. Wagner dichiarò d’ignorare l’etimo, essendo rimasto sconcertato da questo vocabolo evocante un frutto. Invero, la base etimologica è la stessa di bruttu ‘sporco’, bruttèsa ‘immondezza’; centr. bruttáre, log. imbruttáre, camp. imbruttái ‘sporcare, lordare, imbrattare’. Per la discussione e l’etimo vai a bruttu.
Gangorra ‘svasso maggiore’ (Podiceps cristatus) (Campidano); in camp. indica anche la ‘strolaga minore’ (Colymbus septemtrionalis). Base etimologica è il sum. gan ‘child-bearing, to bear young’ (infatti lo svasso maggiore porta i neonati sul dorso) + gur ‘bearer’: gan-gur ‘colei che porta i bimbi sul dorso’. L’analisi di questa voce portò Wagner fuori pista inducendolo ad associarla a gangas ‘tonsille’ (sic), e proponendola addirittura come onomatopea (sic).
Génti arrùbia ‘fenicotteri’ < sum.-akk. enti rubû ‘uccello re’ (v. akk. rubû ‘re’).
Grillu camp. ‘germoglio delle patate invecchiate, di semi, frutta, cipolle, aglio’ < sum. gir ‘erbaccia’ + lu ‘spuntare’: gir-lu > met. grillu = ‘germoglio che spunta, che fiorisce’.
Gutta1 camp. ‘goccia, gocciola’; cfr. lat. gutta ‘goccia’; centr. gúttiu ‘goccia’; log. búttiu, úttiu ‘idem’. Base etim. nel sum. gu ‘pulse, polso, vibrazione; bean, chicco, grano’ + tar ‘to untie, scatter, disperse, decide; disfare, sciogliere, slegare, spargere, sparpagliare; disperdere; staccare’. Quindi il legame gut-tar in origine indicò il ‘chicco che si stacca (dalla massa idrica)’. Da qui l’it. goccia.
Ibi, ibe barb. ‘costà, colà’ (Oliena: a ibe ‘là’; CSP 62: iui iumpat ribu; 63: aue sa foke a derettu ad iui; 220: e ccun sa uinia ki est iui; CSP 30: ki ui fuit curatore; ecc.). Si badi che questa voce è latina, e fu portata in Sardegna dai preti che scrissero le pagine dei condaghes (vedi più oltre). La propongo soltanto perché si capisca ch’essa a sua volta fu una rielaborazione latina della seguente voce autenticamente sarda.
Ingòlliri camp. ‘cogliere, incogliere’: questa traduzione è del Wagner, ed è riferita a una voce italiana alquanto omofonica ma non omosemantica. Ingòlliri indica invece il ‘colpire, ferire’: si podit ingolli ‘si può ferire’ (Villacidro). Base etimologica è il sum. gul ‘to destroy, break, flatten; distruggere, rompere, abbattere’. Il verbo è autoctono. Purtroppo quel significato di ‘cogliere, incogliere’ è messo in primo piano dal Wagner (DES 583) per evidente incapacità di comprendere il fenomeno sardiano. Il nostro filologo insiste nell’indicare la base italica di tale voce, anche a costo del ridicolo, nel centr. goḍḍìre ‘cogliere, raccogliere’, un significato che va in rotta di collisione con quello di ‘colpire, ferire, distruggere, abbattere’. La procedura d’inventarsi dei significati inesistenti e (ciò che è peggio) legarli d’autorità al campo italiano (o iberico) è frequente in Wagner.
Ísola cognome sd. < bab. is lê, iš lê ‘le fauci del Toro’ (ossia costell. delle Hyadi). Alìsa è lo stesso cognome Ísola ma rovesciato. Notisi che l’akk. is lê, iš lê in sd. è usato pari pari oppure è capovolto in al isu, ma il composto si traduce ancor sempre ‘le fauci del Toro’ (Hyadi) < alû ‘Toro del Cielo’ [ossia costell.] + isu ‘fauci’. Quanto precede è un luminoso esempio di come tra i Mesopotamici ed i Sardi in quel periodo, pur usufruendosi di una stessa Koiné linguistica, si aveva agio di “personalizzare” la combinazione degli elementi.
Kenábura, cenábura, cenábara. La Sardegna è l’unica regione mediterranea dove il ‘venerdì’ ha nome kenábura, sd. ant. kenápura.
Wagner (La lingua sarda p. 72) ricorda che già S.Agostino afferma la presenza della locuzione cena pura nella Bibbia precedente la Vulgata (locuzione sparita poi, stranamente, proprio dalla Vulgata): e qua notiamo la prima confusione del Wagner. Egli non spiega perché la “locuzione latina” fosse già presente nella Bibbia (ebraica o greca?) prima ancora della sua traduzione in latino; dice soltanto – senza dimostrarlo – che corrispondeva al gr. δεῖπνον καθαρόν ‘cena pura’. «Gli Ebrei lo adottarono per designare la vigilia di Pasqua, durante la quale ogni traccia di lievito doveva essere rimossa dalle case». La denominazione cena pura indicava, insomma, per Wagner, la vigilia della Pasqua ebraica, ed oltre a ritenerla locuzione del rituale pagano (sic!) egli confonde ancora il discorso, introducendo παρασκευή (parascève) come corrispondente alla voce cena pura (sic!), mentre noi sappiamo che παρασκευή significò ‘preparazione’ (preparazione al sabato, shabbat)’, e solo in seguito giunse a significare tout court ‘venerdì’. A Wagner sfuggì che il sd. kenàbura, kenàpura non deriva dal lat. cena pura ma da un composto sd.-ebr. kena-pura, forma cananea indicante la ‘cena di Purim’, che è la grande cena che il popolo ebraico fa il 14 ed il 15 del mese di Adar in commemorazione della propria salvezza dallo sterminio rischiato in terra babilonese prima della definitiva liberazione (la celebre congiura di Amàn); essa cade per caso abbastanza vicina alla Pesah. In tal guisa si è confusa Purim con la purificazione dai lieviti attuata prima della Pasqua. Ma tale confusione fu introdotta nel medioevo dai preti bizantini. Fatto sta che kenábura in terra sarda è un lascito ebraico precristiano. Non esiste né in Israele né altrove. Si può calcolare che la parola sia nata in Sardegna dopo il 500 a.e.v., ossia dopo la liberazione degli Ebrei, la cui strabiliante fama si espanse immantinente presso gli Ebrei che avevano già operato le prime diaspore mediterranee durante le grandi persecuzioni degli Assiri e dei Babilonesi. A meno che la parola non sia nata tra i 4000 ebrei trasferiti in Sardegna da Tiberio nel 19 e.v. Sta di fatto che la parola nacque in terra sarda, tra ebrei che si erano perfettamente fusi con la popolazione sarda. Quindi kenábura è la testimone più recente della produzione lessicale dei Sardi prima o a ridosso dell’Impero romano.
Kida, kita, kèḍḍa, ceḍḍa, cida ‘settimana’< sum. kid ‘staccare, spezzare, rompere; tagliare’. Con tutta evidenza, già dal Paleolitico i Sardi avevano capito il vantaggio di sezionare in quattro settimane il ciclo lunare, per scopi non solo astronomici ma anche calendariali. Questa parola sarda non ha alcun riscontro nel bacino, ma l’arcaica Koiné Mediterranea rispunta prepotentemente nell’anglosass. cut (to cut) ‘tagliare’ < sum. kud ‘tagliare’. E si noterà in kid/kud l’apofonesi i/u (poi vedremo quella a/i) da me citata nell’incipit, che operava nella grammatica sumerica e dilagò per tutti i popoli mediterranei (cfr. lat. faciō-efficiō, it. faccio-feci).
Miále, Miáli log. e camp. ‘Michele’; nei documenti antichi Mical, Michali, Migali, Miali = gr. biz. Μιχάλη(ς). Si può notare la caduta della velare già nel Medioevo. Poi questo processo ha preso il sopravvento in base alla legge fonetica sardiana che fa cadere le velari, specialmente nelle sillabe accentate. Questo processo infine contagiò l’altra sponda tirrenica.
Nuráki sd. ‘nuraghe’ < sum. nu ‘creatore’, ‘sperma (divino)’ + ra ‘puro’, ‘ fulgido’, ‘splendente’ (v. eg. Ra ‘Sole che splende’) + ki ‘place, earth’ = ‘sito di Ra Creatore’. Questo vocabolo è autoctono della Sardegna, al pari di log. nuraghe dove si sostituisce -ki con -ghe, evidenziando così il radicale sum. ĝa ‘house’, ge ‘shape’ (leggi ghe; ‘an architectural term’); quindi nel caso del Logudoro il significato fu ‘forma, edificio di Ra Creatore’. Insomma, i nuraghes erano dei monumenti al Dio Sole, epifania di Ra (egizio), di Eli (semitico), che rappresentavano il Dio Sommo.
Parissùos log. ‘Diavolo, Satana’. Base nell’akk. parriṣu ‘criminale’ o parīsu ‘colui che divide’. Wagner gli dà il significato di ‘(da) pari suo’, al medesimo livello’ «perché il diavolo vuol farsi pari a Dio» (sic!). La sua forzatura è suggerita dalla “pregiudiziale latina”, poiché Wagner non si volle mai misurare con le lingue semitiche. Invero, questo vocabolo è strettamente sardiano.
Piréḍḍu (Siniscola) ‘ugola’. Può essere diminutivo di pira ‘pera’ o di piru ‘cavicchio di legno’ (vedi). Però debbo rimarcare un fenomeno già chiarito nel paragrafo precedente (alla voce pilótu). In akk. pīru significa ‘elefante’ (questa è la traduzione del CAD e del CDA), mentre nelle attestazioni sarde il vocabolo prende l’inequivocabile significato di ‘proboscide’ (metonimia). Se sono nel giusto, traduco il sd. piréḍḍu come ‘piccola proboscide’ (per il modo come l’ugola si muove). Quella di piréḍḍu è una delle tante prove dell’autonomo svolgimento della lingua sarda rispetto al sumerico e all’accadico, al dilà della vasta condivisione dei radicali.
Reusare log.; arreusái camp. ‘rifiutare’: sa morti ki no podéis reusari (A. M. di Esterzili); arreúsa ‘rifiuto’; (Nuoro) su mare no rebusat abba (con -b- estirpatore di iato). Cfr. it. ricusare, sp. rehusar. Si cita come fonte il lat. recusāre voce dotta col senso di ‘fare opposizione (contro una causa giudiziaria)’, considerata dai latinisti (e da Wagner) derivante da re- + cāusa. Ma le cose non stanno così. In ogni modo, la voce sarda è autoctona, la sua base etimologica è il sum. ri- (vedi: con valore di contrarietà) + uš ‘to shut off, block up; rinchiudere, bloccare’. Chiaro quindi il significato d’origine: ‘chiudere contro’, ‘non accettare qualcosa’.
Sinnare, -ái log. e. camp. ‘segnare’, anche nel senso di ‘marchiare’ il bestiame; sinnu ‘segno, marca’; sinnadorzu log., sinnadróxu camp. ‘sito dove si marcano le bestie’, e siccome ciò si suole fare nel giorno dell’Ascensione, si chiama così anche l’Ascensione.
Base etimologica di sinnare, sinnu è l’akk. šiknum (lat. signum) ‘figura, immagine’, gr. ἴχνος ‘orma, traccia’, originariamente ‘segno, figura’. Si può notare l’evidenza della legge fonetica sarda, che fin dalle origini assimila in -nn- le consonanti estere -kn-, -gn-.
Talu cognome sardo che pare riprodurre il gr. Talos (Simonide), mostro metallico che abitò in Sardegna e traslocò a Creta. S’immergeva nel fuoco prima d’abbracciare i nemici < sum. tal ‘cry, clamor; battle cry’.
Trattalía camp. ‘frattaglie, busecca’; tartalía (Nuoro) ‘idem’; tattaréu sass. ‘coratella, vivanda preparata con interiora di agnello o di capretto infilzate allo spiedo e avvolte dalle budella dello stesso animale’. Secondo Wagner queste voci sono deformazione dell’it. frattàglia ‘interiora degli animali macellati’ < fratto ‘spezzato, frazionario’. Ma la situazione non sta in questi termini, derivando fratto dal lat. frangō ‘rompo’, mentre le voci sarde hanno base etimologica nel sum. tar ‘to cut, tagliare a pezzi, resecare’, ripetuta (tar-ta-) a indicare la molteplicità dei pezzi. Anche questa è una parola sarda in purezza.
Arcaicità del linguaggio del centro-Sardegna. L’ultimo lemma su citato coinvolge anche il Nuorese. Invero, sono una caterva le voci nuoresi conservate anche in log. e camp., per quanto poi ogni sub-regione abbia le proprie varianti fonetiche. Non mette conto osservare che il linguaggio del centro-Sardegna è né più né meno arcaico degli altri linguaggi sardi, ma è un po’ più conservativo (quasi un’isola nell’isola) – considerate le più difficili comunicazioni nel passato –. Questa osservazione va ovviamente sostanziata, poiché sui linguaggi nuoresi (e in buona quota barbaricini) si sono affermate delle idee contraddittorie che nella diffusione della cultura hanno arrecato confusione e sconcerto. Tutto nacque quando un primo intellettuale dei secoli recenti osservò che il Nuorese, tenendo Bitti come pivot, manteneva in purezza la lingua latina, al punto tale che si ritenne più conveniente prendere a misura il linguaggio bittichese per svelare alcune leggi fonetiche del latino. L’esistenza esclusiva di molti vocaboli latineggianti nelle inaccessibili aree centrali suscita indubbiamente dei problemi, ma a ben vedere sono problemi creati dagli stessi intellettuali, i quali contro ogni logica hanno imposto la falsa teoria dell’integrale colonizzazione latina delle Barbagie e del Nuorese; ne sarebbe corollario la teoria della tenace sopravvivenza del lessico e della fonetica latini in virtù dell’isolamento. Non intendo destare il riso del lettore, ma la questione suscita l’idea di un temerario generale il quale penetra profondamente in territorio nemico, rimanendone intrappolato. Mutatis mutandis, sarebbe come la situazione di Alghero: una parlata nemica incistata entro la parlata sarda.
Ma la Barbagia non fu mai colonizzata dai Romani (l’ho dimostrato nel mio “Toponomastica in Sardegna”); l’ampio territorio montano fruì (tacitamente?) di uno statuto di “libero-scambio” con le aree granarie, minerarie, portuali dell’isola, ed i montagnini continuarono imperterriti le loro millenarie transumanze tra monte e piano, senza disturbo alcuno per il collaterale commercio dei loro prodotti, a cominciare dai formaggi, dal bestiame, dai prosciutti, dalla lana, dalle pelli, dal miele, dal legno delle foreste.
Prendiamo l’esempio del verbo bittichese verberare, (Nuoro) berberare ‘percuotere, picchiare’. Cfr. pis. berberà ‘idem’. Il prototipo sembrerebbe a tutta prima il lat. verberāre ‘battere, percuotere’ < verbera ‘verghe, frusta, colpi di verga’. Ma attenzione!: la base etimologica è il sum. bir ‘to shred, strappare, trinciare’ (ripetizione icastica: bir-bir-). Si può notare che è proprio Nuoro a mantenere in purezza l’eredità sumerica, e nessuna ragione dimostra la nascita di questa parola nelle contrade laziali. La forma pisana può essere anch’essa, con tutta tranquillità, un accatto dalla Sardegna, visti i rapporti tenaci (non solo nel Medioevo) tra Sardegna e Pisa.
Occorre accettare un’evidenza scomoda per alcuni, e cioè: la sopravvivenza di sd. verberare è la dimostrazione che nella conservativa Barbagia l’arcaica Koiné Mediterranea dei tempi preromani ha mantenuto sinora più saldi caratteri, proprio in virtù dell’isolamento montano. Quindi occorre accettare che il lat. verberāre sia verbo seriore, un imprestito dal sardo.
Ci sono inoltre dei vocaboli nuoresi la cui unicità è lampante. Prendiamo bisenda ‘settimana’ (Bitti). Wagner, fisso nella pregiudiziale latina ed italica, lo volle derivare dall’it. vicenda ‘serie di fatti che si succedono alternandosi’, ed aggiunse, a rafforzo della propria intuizione: «Campus crede che si tratti di un termine pastorale, che in origine doveva indicare quel periodo di tempo in cui una persona doveva badare al bestiame in campagna in attesa che un’altra la sostituisse; ma forse si riferiva al turno settimanale per fare il cacio». Ma tutto ciò è assurdo. Wagner non sa che i pastori un tempo (e sino a ieri) facevano il formaggio ogni giorno per impedire il deterioramento del latte. Inoltre si noti il fatto imbarazzante che, mentre i due linguisti derivano la voce sarda dall’italiano, gli studiosi della lingua italiana non si sono ancora raccapezzati sulle vere origini dell’it. vicenda (DELI). In tal guisa, tutti questi linguisti non si sono accorti che è il sd. bisenda ad essere stato il prototipo dell’it. vicenda, e non viceversa.
Ciò si capisce bene osservando la base etimologica di bisenda (poi di vicenda), che è l’akk. wīṣum ‘alcuni, few’ (giorni) + emdu ‘sovrapposto’ < emēdum ‘to lie on each other, add; adjoins’. Il composto wīṣ-emdu significò in origine ‘pochi giorni affastellati; gruppo di pochi giorni’. Era un modo primitivo ma efficace per indicare i giorni della settimana, che si affastellano in gruppo per servire come base di conto dei quarti di luna. La settimana sarda chiamata bisenda è l’eredità accadica ancora conservata in rari recetti della Sardegna montana. Ma sappiamo, e vedremo oltre, che la lingua accadica è seriore rispetto a quella sumerica: penetrò in Sardegna meno di 5000 anni fa, promuovendo parole nuove, formazioni nuove, ivi compreso lo stato-costrutto. Il fatto che bisenda sia conservata proprio nel Nuorese ripropone l’idea da me evocata, quella del condottiero temerario che poi rimane intrappolato. Oggi bisenda è trattenuta soltanto sull’area montuosa, mentre dappertutto nell’isola è conservata l’arcaica voce sum. kida, cida (già citata), ch’ebbe il vigore di tenere segregata ed isolata nel Nuorese la sopravvenuta voce accadica.
È sempre dall’accadico che riceviamo la chiave del misterioso pilósu, piloséḍḍu (Fonni) ‘bimbo in età tenerissima’. Per Wagner l’origine è dal lat. pilōsus poiché, scrive, fino all’adolescenza i bimbi non si tagliavano i capelli. Ciò è ridicolo. Invece la base etimologica è il bab. pelû(m) ‘uovo’. Questo aggettivale è veramente arcaico, risale al Paleolitico o comunque al primo Neolitico, allorché s’affermo l’idea dell’Uovo Cosmico Primordiale nella mitologia di numerose civiltà, la cui forma ritroviamo in vasi elladici, in crateri minoici, in piatti moldavi (3700-3500 a.C.), nella religione egizia, ecc.
Aímu (Posada) ‘vicino’ (Spano). Wagner lo considerò lemma sospetto, inaffidabile, ma sbagliò. La dimostrazione proviene in linea indiretta dala lingua italiana, dove s’usa la parola vicìno < lat. vicῑnus < vῑcus, indicante ‘quello che vive nello stesso gruppo di capanne’, da cui it. vìcolo ‘stradetta stretta’ (luogo dove tutti fanno vita in comune). Parimenti, a Posada scopriamo la più antica parola mediterranea indicante ‘colui che vive sull’altra sponda del fiume’. Ricordo che Posada sorge sulla foce di un fiume ad estuario. Con tutta probabilità, in origine su ambo le rive c’erano due villaggi, due gruppi di capanne, onde si formò un epiteto riconducibile ad akk. aḫû ‘to fraternize, diventare fratelli’ + mû ‘acqua’ (del fiume): il composto di stato costrutto aḫῑ-mû significò in origine ‘fratello del fiume’, ‘dirimpettaio del fiume’.
Ammadeskinzu (Dorgali) ‘un cibo che si ferma nella gola e vorrebbe tornare su’. Base etimologica è l’akk. ma’dû ‘large quantity’ + ešqu ‘solid, massive’.
Azírima nella frase sunt azírima ‘sono opposti’ (Orotelli: Spano); éssere azìrima ‘essere in discordia’ (Casu). Wagner ignora l’etimo. Base etimologica è l’akk. zīru ‘hate, odio’ + emmu ‘hot, bollente’. Quindi a zírima in origine significò ‘’(essere) in odio al calor bianco’.
Tornerò più volte e in altro modo sui “latinismi” del Nuorese e della Sardegna, poiché serve riproporre su basi nuove l’intera questione.
Le prevaricazioni dei preti nel Medioevo. La storia è feconda di notizie sugli scontri religiosi, ma non riesce a narrare minutamente gli avvenimenti a causa delle lacune prodotte dall’uso perverso della damnatio memoriae. Si conoscono pure altri tipi di silenzi plumbei. Siamo indotti ad intuire che molti silenzi della storia celino, in quanto tali, delle trame significative; l’assenza di documenti dovrebbe costringere lo studioso a un supplemento di sforzo per individuare un metodo capace d’interpretare le verità che non ebbero cronisti.
La procedura da me suggerita è normale tra gli archeologi. Purtroppo i tempi in cui il clero cristiano prevaricò le culture precristiane e cancellò le religioni patrie hanno focalizzato gli storici soltanto sulla documentazione emersa: edicta, historiae, epistulae, anecdota; però è mancata la curiosità per le modifiche forzose del vocabolario, non foss’altro: perché mancano le fonti scritte, e laddove scripta deficiunt lo studioso spegne le luci, venendo meno alla propria funzione. Per fortuna, la lingua (il vocabolario di un popolo) è capace, per sua natura, di superare d’un balzo millenni di silenzi. E qui subentra il glottologo. Per fare il balzo, però, egli deve operare col massimo rigore, con metodo etimologico indiscutibile, che sia veramente capace di riesumare le verità del passato. Basta un passo falso, e l’oggetto della ricerca, anziché ricomporsi, si frantuma.
Si può immaginare che durante i “secoli bui” del Medioevo sardo i preti cristiani operassero di gran lena per capovolgere la situazione religiosa a loro vantaggio, e lavorassero decennio dopo decennio per imporre al popolo analfabeta, abitatore dei villaggi, vari giochini di parole i quali travisavano, distorcevano, capovolgevano i significati originari, lasciando quasi intatte le fonetiche. Dopo lo tsunami di Saulo che aveva stravolto i vocaboli greco-romani facendogli maturare nuovi concetti universali, era il tempo del lessico dei singoli popoli. Quello fu l’unico aspetto incruento della rivoluzione cristiana, che avanzò lungo il sentiero dell’evoluzione semantica, coniata a tavolino da chierici dotti, impartita dai pulpiti e accettata lentamente e supinamente dai fedeli. Un metodo anch’esso combattivo ma subdolo, che sovvertì parte del patrimonio lessicale dei popoli.
Tutti questi aspetti sono stati da me trattati scientificamente nel 2° volume della Enciclopedia della Civiltà Shardana, oltreché nel libro Monoteismo Precristiano in Sardegna. Qui non m’attardo.
Latinismi veri e latinismi degli amanuensi. I preti che hanno travolto l’universo religioso dei Sardi erano di origine e formazione bizantina, e tra di loro usavano la lingua greca. Guarda caso, di grecismi la lingua sarda è totalmente e paradossalmente scevra, nonostante che quei preti si siano avvicendati (o siano rimasti) nell’isola per cinque secoli. I famigerati “latinismi” del vocabolario sardo, che tutti suppongono nati ad opera dei preti bizantini nell’Alto e nel Basso Medioevo, sono invece di epoca pregressa, non appartengono affatto al periodo medioevale (tantomeno al periodo romano), e quindi vanno ben spiegati. Di essi s’era già accorto Dante Alighieri, il quale nel De Vulgari Eloquentia I, XI scrive: Sardos etiam, qui non Latii sunt sed Latiis associandi videntur, eiciamus, quoniam soli sine proprio vulgari esse videntur, gramaticam, tamquam simie homines imitantes: nam domus nova et dominus meus locuntur ‘…e rigettiamo anche i Sardi, i quali non sono italici ma agli italici sembrano doversi associare, perocché questi soli ci appaiono privi di un loro proprio volgare, e imitano la grammatica [ossia il latino] come le scimmie imitano gli uomini; essi dicono infatti: Domus nova e Dominus meus’.
Ma i Sardi non hanno mai scimmiottato i Latini. Sulla questione, non c’è stato un solo dotto che non abbia preso un abbaglio. Il lettore appassionato che abbia la possa di leggere tutto intero questo Dizionario Etimologico, apprenderà che i vocaboli sardi derivanti direttamente dal latino sono molto meno del 10%. A chi vuol dichiarare tale residuo un’eredità della colonizzazione romana, glielo concedo, ma stupirei se dicessi che i Romani a loro volta hanno ereditato dalla Sardegna molto più del 10% di vocaboli.
Sino a che non cambierà il punto di vista dei dotti sulla questione, sino a che non si accetterà che la lingua latina e la lingua sarda fecero parte della grande Koiné Mediterranea, non potrà mai cadere la funesta “pregiudiziale latina”. Essa deve cadere a maggior ragione, se si considera che migliaia di parole che i più considerano latine erano parlate dai Sardi in piena età nuragica, ossia almeno 1000 anni prima che sul Palatino sorgesse la prima capanna di frasche. Com’è che il popolo laziale era riuscito a saturare di latino la lingua dei Sardi, se a quei tempi Roma stava ancora “in mente Dei”?
Questo fenomeno apre un ulteriore spiraglio che aiuta a capire la conservativa parlata nuorese e la conservativa parlata barbaricina del nord, che somigliano molto più al latino rispetto alle parole consorelle parlate nel resto della Sardegna. Beninteso, con ciò non sto concludendo il discorso accennato al paragrafo “Arcaicità del linguaggio del centro-Sardegna”. Anzi, sto allargando la visuale; ma preferisco rivelare gradualmente, lungo tutta questa premessa metologica, come dev’essere considerata l’intera questione.
In questo paragrafo mi preme affrontare i latinismi profusi a piene mani nei più antichi documenti sardi, ossia nei condaghes e nelle carte coeve. Non ho mai letto alcuna indagine da parte di nessun linguista, che illuminasse tutti quei latinismi con l’unica ragione che può giustificarli: a quei tempi nei quattro Regni sardi c’era un altissimo tasso di analfabetismo che coinvolgeva anche parte dei nobili (i quali furono per lo più i dettatori dei documenti dell’epoca). Non intendo dire che i majorales fossero una massa di analfabeti. Però posso affermare che non erano fior di letterati. Al punto che s’affidarono docilmente agli amanuensi che registravano ufficialmente le loro dettature. Ma chi erano quegli amanuensi? Presto detto: erano gli stessi preti di formazione latina che periodicamente andavano e venivano tra i monasteri, abitando ora in cenobî del Continente, ora in quelli sardi, e viceversa. Non era gente stabile (esclusi pochi), tantomeno nativa della Sardegna; in più, il latino era la loro lingua principale, anche per capirsi reciprocamente, visto che ai monasteri convergevano preti di varia origine, del profondo Sud e del profondo Nord italiano. In certi monasteri dimoravano i preti francesi. Qualcuno sa dire con quanta facilità quei preti dominassero la lingua sarda, anzi i vari dialetti esistenti nell’isola?
Non mette conto allungare la spiegazione: quei preti scrivevano sotto dettatura o sulla traccia di un papier scritto rozzamente dal proponente; e nell’esigenza di rendere nel modo più perspicuo il pensiero del proponente, spesso e volentieri innestavano qua e là i propri latinismi. Di latinismi arbitrari sono zeppi i condaghes. Ciò che fa male in questa vicenda è che i filologi votatisi a tradurre le antiche carte della Sardegna abbiano creduto che i latinismi appartenessero alla parlata sarda.
Di seguito faccio qualche esempio, tra le migliaia che impellerebbero (ma si vedano per questo i lemmi nel Dizionario). In ogni modo, approfondirò la questione nei due paragrafi successivi oltreché, passim, in tutti gli altri paragrafi.
Auinde log. ant. (CSP 5: et falat su ualliclu derectu ad riuu, auinde riuu falat isc’a badu de preuiteru et cludet; CSNT 290: auinde toctuve via a derectu ad rivum de gulpe). Cfr. lat. ăb-inde ‘di là’ (moto da luogo). Questa voce antica è tratta di peso dal vocabolario latino ad opera dell’amanuense che scrisse il documento sardo. Di questo procedere “disattento” sono colmi i testi antichi della Sardegna (nota, qua stesso, ad rivum, costruzione inequivocabilmente latina). Per ulteriore nota, faccio seguire il lemma-base inde.
Inde log., indi camp. avv. ‘ne’ (traduzione del Wagner). Questa è una delle tante voci sarde discutibili. Esiste anzitutto nelle carte antiche. Sono troppi gli indizi che denunciano una certa “scioltezza” nelle redazioni dei testi antichi, i quali quasi certamente, o quasi sempre, erano scritti sotto dettatura, e venivano arrangiati secondo la dottrina linguistica dell’amanuense, al fine di evitare le oscurità o le asperità del linguaggio sardo, percepite come tali dall’amanuense stesso.
L’avv. di luogo lat. in-dě (ant. im-dě) significa ‘di là, di lì, da quel luogo’ (moto da luogo): inde reversus ‘tornato di là’; provenienza sociale: ‘da lui, da loro’: inde oriundus erat ‘derivava da lui’; fig. ‘da ciò, quindi, per conseguenza’. Questa voce latina ha per base il sum. im ‘to run, uscire di corsa’ (moto da luogo) + de ‘to bring’. Il composto im-de significò in origine ‘uscire portando, recando’.
Riporto al riguardo le citazioni antiche prodotte dal Wagner: CSP 207: derun inde su saltu de Ualle de Cucke; CV XV 4: pro su ki apat indi proi sanctu Antiogu. Spesso indě si esprime encliticamente: ‘nde, ‘de (CSP 204: non tinde do; ca ui andai e ‘nde la leuai; CSMB 48: Comporeilli a Petru Zote terra in Pubusone et fegindelli sollu).
Carnattu (St. Sass. I, 69) è un altro tra le migliaia di testimoni: dessos qui fachen carnattu et dessa bructura de cussu. A quanto pare la frase si riferisce ai macellai che manipolano la carne per fare salsicce e altro, producendo inquinamento. In Sardegna, oltre a petza, l’altro vocabolo indicante la ‘carne’ è carre (vedi per l’etimo); in Sardegna manca la parola-base carne. In questi documenti medievali, inevitabilmente composti da scribi di estrazione pretesca e formazione latina, sono molte le parole influenzate dalla cultura latina e italiana.
Famígiu Stat. Castels. 179: gasi su iuuargiu, famigiu i ouer figiu dessu pupidu; 232: ouer roba de alcunu famigiu ‘servo’. Cfr. it. ant. famiglio. Questa voce è un esito eclatante della libertà con cui i preti di formazione latina, arrivati in Sardegna nel Medioevo dall’Italia o dalla Francia, maneggiarono le parole autenticamente sarde che gli venivano dettate per i testi ufficiali.
Fizzastru log., fillastu camp. ‘figliastro’ (CSP 31: cun sos fiastros; CSNT 29, 200, etc.: filiastru, filastru). Questa voce è influenzata dal suffisso italico di figliastro < lat. filiaster (REW 3297).
Gotantu, gatantu log. ant. = it. antiq. cotanto. Il vocabolo è l’ennesima spia del fatto che i preti e gli altri amanuensi scrivevano la lingua sarda con una certa disinvoltura, impaniati dalla propria formazione di base.
Infra log. e camp. ‘fra, infra’ (Stat. Sass. I, 27: infra dies XX; infra de otto dies; Liber Jud. Turrit., cap. 8: infra sa ottova de Pascha Manna; Cod. Sorres, cap. 20: infra dies XV). Questa voce in Sardegna si usa ancora; ma è italianismo dotto dal lat. infra. Anzi, qui siamo al latinismo puro.
Patre log. ant. ‘padre, babbo’ (CSP 15, 38, 262); patri (CV V, 3); padri (CV III, 3; V, 3; XIV, 9; XIX, 5). Accatto dall’italiano padre < lat. pāter. Questa parola non è mai stata usata in sardo (del Monte Santu Padre discuterò oltre). Questo è uno dei segni macroscopici che gli amanuensi latini dell’epoca rimaneggiarono ad libitum il linguaggio sardo nella registrazione delle carte; lo fecero, a quanto pare, persino sotto dettatura diretta.
Pecuiu sd. ant. CSP 231: II sollos de pecuiu; CSMB 43: in tremisse de pecuiu), scritto anche peculiu (CSMB 41: et sollu de peculiu) ‘sostanza, peculio’. Nelle CV XX, 2 figura nell’antico significato di ‘animali’ (bollant pasquiri cum peguliu issoru, bollant arari…). Chiarissimo esempio del fatto che molto spesso gli amanuensi (preti) di formazione latina acquisiti ai vari monasteri dei giudicati si esprimevano, quand’era possibile o necessario, con vocaboli estratti dal proprio bagaglio culturale, per quanto il vocabolo fosse estraneo alla tradizione sarda. Vedi anche pecuiare e pegugiare.
Termen log. ant. (CSP 187; CSNT 43) ‘confine’; pl. termenes. Per l’etimo vai a tremma. Questa voce è palesemente raccordata al lat. termen. Attualmente si preferisce trèmene.
Turpe log. ant. in faker turpe ‘fare un torto, offendere’ (CSP 43: ca minde aueat fattu turpe duas uias; 73: e cca ui li feki turpe). La voce è un classico accatto dal latino.
Uske a, log. e camp. ant.; usca a (CV, IX, 2) = lat. usque ad. Voce dotta latina.
La pregiudiziale latina. A mio avviso i latinismi delle antiche carte sarde sono stati sottovalutati a causa dei pregiudizi, perlomeno a causa degli equivoci che da sempre hanno covato sulla questione. A quanto pare gli equivoci sono sorti persino prima che Dante prendesse la celebre posizione nel De Vulgari Eloquentia, considerando i Sardi scimmiottatori dei Latini. Forse gli equivoci risalgono addirittura agli antichi Romani. Non ci possiamo meravigliare più di tanto. Si dice che Giulio Cesare fosse poliglotta, e fosse tanto geniale da saper dettare in una sola seduta più lettere in diverse lingue straniere. Io ho grande ammirazione per il genio di Cesare, ma penso che le dettature parallele e simultanee gli riuscissero facili per il fatto che i popoli celtici ai quali scriveva parlavano lingue molto simili a quella latina (ed a quella sarda), ancora prima di essere colonizzati da Roma. Io sono convinto di questa asserzione, la quale va a ribadire la verità di quanto ho asserito nel primi paragrafi di questa premessa.
Insomma, la Koiné Mediterranea era tanto forte proprio perché univa molte lingue tra loro simillime. Wagner ai suoi tempi non potè restare immune da tali equivoci oramai cristallizzati da millenni. Peraltro l’educazione da lui ricevuta nella natia Germania non era in grado – in quei tempi di odio e di revanche – di ribaltare quella poderosa corrente di pensiero che proprio partendo dal focus germanico stabiliva “scientificamente” che ogni lingua del Mediterraneo fosse stata cancellata dal poderoso intervento romano e poi dalla “tabula rasa” operata dai popoli germanici con le Invasioni barbariche.
Wagner credette in buona fede ed acriticamente a questi millenari pregiudizi, incancreniti con l’avvento del Romanticismo, assumendoli come verità, e non è un caso che quasi ogni lemma del DES evidenzi in primo piano le voci bittichesi, o quelle nuoresi, rispetto a quelle logudoresi e campidanesi. Egli era convinto – e lo ribadì apertamente nella “Fonetica Storica del Sardo” – che le voci bittichesi e nuoresi fossero i prototipi (latini) del vocabolario sardo, e che le voci consimili del Logudoro e del Campidano fossero semplici derivati adattati foneticamente secondo il genio delle singole parlate sarde.
Anche i vari linguisti che avevano preceduto Wagner erano stati abbagliati dai “latinismi” del Nuorese, e Wagner, ereditando il pensiero dell’accademia, ne fu corifeo entusiasta. I tentativi del Wagner di formalizzare le sue credenze entro la “Fonetica Storica del Sardo” sono stati da me denunciati, come spiego nel cap. 3.1 della mia Grammatica Storica. Fu tale l’arbitrio dei linguisti del passato, che hanno addirittura inventato delle “leggi fonetiche” le quali dovrebbero dimostrare la derivazione del sardo dal latino.
Ad esempio, Wagner sostenne che il log. abba deriverebbe dal lat. aqua, in virtù dell’esito lat. -q- > sardo -b-. Nella mia Grammatica io dimostro che -q- = -b- non è prova di alcun processo derivativo; non siamo di fronte ad un fonema derivato diacronicamente dall’altro, bensì di fronte a due fonemi sincronici, operanti ognuno per proprio conto prima dell’invasione romana. Abba esisteva già nel vocabolario accadico: abbu ‘palude, pantano’; abbû ‘fauna acquatica’; bā ‘acqua’; sum. a’abak ‘(acqua del) mare; sea (water)’, a-ab-ba ‘idem’ (< a ‘water’ + ab ‘sea’ + ba ‘marine creature’). Il sd. abba, in tal guisa, non ha concesso niente alla lingua latina, rimanendo inalterato fino ad oggi ed ignorando il lat. aqua, il quale invece riuscì ad insinuarsi nel dialetto campidanese (áqua). In origine la Sardegna aveva un doppio registro, che poi lasciò in eredità due lemmi: abba a nord, áqua a sud. Al secondo registro appartiene l’akk. agû, egû ‘onda, corrente, flutto’. Fenomeno di Lautverschiebung nord ≠ sud, come spiegherò nel successivo paragrafo.
Stesso discorso vale per il suffisso sardo -u, che Wagner fa derivare dal lat. -us, mentre esistevano entrambi nella stessa epoca, ognuno operante nel proprio campo linguistico prima dell’invasione romana. Per il sardo -u non c’è da accampare un supposto influsso romano, poiché già le lingue mesopotamiche (sumero-accadico-assiro-babilonese-cananeo) mantennero per migliaia d’anni il proprio suffisso -u al quale possiamo e dobbiamo riferire una -u sarda originaria.
Percepiamo ancora le arcaiche desinenze cananee in -ū per il nominativo anche nell’antico ebraico (1Sam 2,10 ‘ālū “l’Altissimo”, corrispondente a Yahweh del primo stico; Sal 140,9 yārūmū “l’Eccelso”, anche esso in parallelo con Yahweh del primo stico). Parimenti percepiamo ancora nell’antico ebraico le arcaiche desinenze cananee in -ī per il genitivo (Sam 22,44; Ez 5,3; Os 11,4; Sal 26,10). Altro che genitivo di formazione latina! Il genitivo latino non è altro che un genitivo mediterraneo con basi etimologiche semitiche!
Tornando alla Sardegna, era tipicamente sardiano, quindi originario, pure il suffisso femminile -a, per il quale non c’è da accampare la colonizzazione romana, come pretende Wagner, essendo tale forma, di per sé, latamente presente nel Mediterraneo, comune, ad esempio, ai Latini, agli Šardana, agli Aramei. Ed è proprio l’identità o similitudine di certe leggi fonetiche tra Sardiano ed Aramaico che lascia capire l’autoctonia di molte forme della lingua šardana, preesistite all’invasione romana e coeve alla celebre Koiné aramaica esistita prima delle falangi di Alessandro e prima dei Cesari.
Pari discorso riguarda le velari sarde k, ĝ, che Wagner crede derivati dal lat. c, g, mentre esse preesistevano nella lingua sardiana, con un impianto confrontabile alle velari accadiche k, g, ḫ.
Questa certezza scientifica è corroborata da un fatto celebre ancorché strambo, che è il seguente: dalle leggi fonetiche del sardo attuale (e del sardo medievale) i cattedratici hanno derivato le loro certezze sulle leggi fonetiche latine, non viceversa! Infatti per dimostrare che il latino ciceroniano aveva le velari non si è fatto di meglio che supporne l’esistenza (altrimenti indimostrabile) attraverso l’attuale parlata di Bitti, in Sardegna. Ma quei “linguisti” non sono gli stessi che pontificano l’origine del sardo dal latino?
Insomma, quei cattedratici hanno preso al guinzaglio la lingua sarda per andare in soccorso della lingua latina intesa come Ursprache mediterranea. Si badi, è stata soccorsa la lingua latina: nessun’altra! Come dire che la “trasfusione di sangue” è andata ad una sola lingua da loro prescelta. Mentre tutte le altre lingue italiche e quelle mediterranee lato sensu non hanno meritato le loro attenzioni. Perchè? Ovvio: essi sono partiti dall’ideologia secondo cui tutta la civiltà mediterranea oggi percepibile avrebbe l’incipit nell’Urbe. Da qui il “soccorso” della lingua sarda nei confronti della propria… “madre”! Ma vediamo di seguito qualche esempio che meglio illustri la questione.
Accásu log. ‘per caso, forse’; cfr. sp. acaso. Wagner deriva accásu dal sardo casu, e questo direttamente dall’it. caso ‘avvenimento fortuito, imprevisto’, considerandolo dunque non solo un prestito ma anche un cultismo italianizzante. A sua volta, occorre badare che tutti i linguisti sinora hanno considerato la base di it. caso, ossia il lat. cāsus, come cultismo che fu tale già nella fase latina. Non hanno saputo fare altra considerazione davanti al verbo da loro considerato come incipit, che è cădere ‘cadere, cascare’. Il cultismo sortirebbe – secondo loro – dalla fusione (o confusione) della semantica del “cadere” con quella dell’ “accadere”. Questa confusione dura da oltre 2500 anni, ma è confusione confezionata “a tavolino”, freddamente, senza meditazione, quindi idealistica, ed è ora di dare un colpo a tale nodo gordiano. La vera base etimologica del lat. cāsus, it. caso, sd. casu è l’akk. ḫašû ‘frantumare’, anche ‘to become dark, diventar buio’, ‘suffer darkness, essere cieco’. Insomma, tutto rinvia alle origini dell’Universo e all’arcaico cognome sardo Casu, identico al gr. Χάος, che identificano l’immensa buia cavità che accolse le acque primordiali. Pertanto il riferimento non è alla caduta ma al caos.
Avu it. ‘nonno’, apparso in Italia prima del 1374 col Petrarca; al pl. ‘antenati’ (1581, T. Tasso); vocabolo ritenuto dotto dal DELI, originario dal lat. āvu(m), a sua volta considerato di origine indoeuropea col sign. di ‘anziano’. Non discuto, per spirito di carità, che l’origine possa essere quella, ma la voce è condivisa anche nel campo semitico, dall’ebr. āv ‘padre’ ( אׇב ).
Cartu log. ‘misura di grano, di fave, ecc.’. Cfr. it. quarto ‘idem’ (che soltanto foneticamente corrisponde al lat. quartum ‘quarta parte’ aggettivale di quattru: vedi). Wagner non dà l’etimo, sembrandogli ovvia e bastante la derivazione latina. Invero, base etimologica è l’akk. kārtum ‘prezzo corrente’. Cfr. akk. qa ‘misura di circa 1 litro’; karāṭum ‘(merce vendibile), da cui it. carato (misura per pietre e metalli preziosi).
Para camp. ‘frate’. Wagner lo deriva dal cat. parə ‘padre’ (padre in ogni senso, anche come sarcerdote o mestierante del sacro). Anche in altri dialetti italiani abbiamo gli stessi esiti. Ma in ciò Wagner è generoso, perché ogni volta che cita l’origine catalana vuole sempre intendere che il catalano stesso a sua volta ha origini latine, quindi le parentele con analoghe voci italiane sono già messe nel conto. Ovviamente questo modo di andare per etimologie è incongruo, quindi mi tocca subentrare precisando che para potrebbe forse allinearsi con l’uso akk. di pāru, accus. pāram (un ufficiale). Ma ci viene incontro una migliore opzione, l’akk. pâru(m) ‘cercare, andare a cercare’. Per decidere quale delle due opzioni s’attagli alla voce sarda, dobbiamo osservare che i primi monaci che diedero impulso alla costruzione della Cristianità (non parliamo poi dei frati minori francescani) erano anzitutto frati “cercatori”, per aver fatto voto di assoluta povertà. Nonostante tale vocazione, i frati non sono mai stati indicati come “pitocchi” ma in altro modo, almeno in Sardegna; il Sardo aveva un tale rispetto della povertà, che anche il classico mendicante non veniva chiamato così, sibbene mazináiu ‘venditore d’immaginette sacre’, con riferimento a ciò che lo caratterizzava. Così fu per i primi frati cristiani, che vennero catalogati come ‘cercatori’, dall’akk. pâru(m).
Párdula. In Campidano è il corrispettivo della casatìna del nord Sardegna, ma al posto del formaggio si preferisce la ricotta. La base etimologica è l’akk. parû ‘base’ + dulû ‘secchiello’ (stato costrutto par-dulû > párdula), col significato di ‘(dolce sostenuto da una) base a secchiello’. Secondo Wagner questa voce può risalire a lat. quadrula «siccome le pardulas sono di forma quadra». Invece le pardulas sono tutte di forma tonda. Sale a galla l’ennesimo intento ideologico d’indovinare anzitutto la fonetica latina più consona, proporla come fosse una base etimologica cogente, e ricondurre ad essa il significato della parola sarda, con plateali stravolgimenti della realtà.
Pesáre1 log., pesái camp. ‘pesare, bilanciare’ (Stat. Sass. I, 30 (13r): Sa mercatantia et issas cosas qui si aen uender sas quales se pesan, neuna persone uendat ouer peset ultra libras .X. si non cum sa istatea dessu cumone); fig. ‘apprezzare, giudicare il carattere, l’indole di una persona, ponderare’: l’appo pesadu bene. Cfr. lat. pendere ‘appendere, pesare, pagare’. Se ne ignorò l’origine, che è dall’akk. pedû, padûm ‘to set free, absolve, be merciful; liberare, assolvere, esser pio’. Questi concetti sono strettamente legati alle pratiche dei dazi reali ed anche alla pratica della decima data al tempio: da una parte il concetto della assoluzione, affrancamento del cittadino che ha fatto verificare la produzione, cedendo una parte come tributo al re; dall’altra, parimenti, la giustezza del tributo dovuto al tempio, dimostrazione di pìetas, di correttezza nel rapporto con Dio.
Piatza sass. (nell’agglomerato urbano è il luogo alquanto largo creato per ampiamento d’una via, d’un sito). Termine paneuropeo ed eurasiatico, del quale uno dei riferimenti sta nel gr. πλατύς ‘largo, ampio’, fem. πλατεῖα ‘via ampia nella città’; cfr. lat. plătēa ‘via ampia, cortile’. Pompeo Calvia: Li Candaléri fàrani in piàtza / cu li vétti di rasu trimuréndi… ‘I Candelieri scendono in piazza (ossia nella via più larga di Sàssari), con i nastri di raso tremolanti…’. Vedi anche sp. plaza ‘piazza’, fr. place ‘piazza’ ma anche ‘posto, sito’ = ingl. place ‘luogo, sito’ (le ultime tre voci sono latinismi da plătēa).
Il lemma sardo piatza, pratza, paltza e simili, così semplice e così complesso, ha numerose parentele semantiche oltre a quelle viste, ad iniziare da it. pertùgio ‘stretta apertura naturale o artificiale’, sd. paltùsu, partùsu ‘foro’, per estensione ‘ano’; camp. pratzìri, log. paltìre ‘dividere, staccare’, lat. partior ‘divido’; it. partìre ‘dare origine al moto di allontanamento’.
Il termine sardo non è un latinismo, non lo è nemmeno il termine italico, e nemmeno lo sono i derivati sardi come pratzìri, paltzìri ecc. Il termine è arcaico, mediterraneo, primamente sumerico: appunto da sum. pad, padr, par ‘rompere, spaccare, dividere’ + zu ‘lama o punta dell’aratro’: par-zu ‘spaccare con l’aratro’, oppure par + tab ‘compartire in due, suddividere’: par-tab ‘rompere in due’.
Pilu1, filu. In log. e camp. significa ‘pelo, capello’. Viene proposto dal lat. pĭlus. Ma se ne ignorò l’origine. In analogia con pūbēs ‘peluria’ dei giovanetti, la -l- è una originaria -r- mediterranea: cfr. ebr. pera ‘pelo’, akk. per’u ‘bud, shoot’; vedi sass. péru ‘pelo’.
Pisciòni camp. ‘polpaccio’. Ancorato alla pregiudiziale latina, Wagner segnala come base il lat. piscis ‘pesce’, senza badare all’assurdità dell’accostamento. Invece la base etimologica è il sum. peš ‘topo’ + unu ‘(animale) selvaggio’, col significato di ‘topo selvaggio’ (ossia Rattus). Questa voce è autoctona della Sardegna. Ma la circolazione culturale nel Mediterraneo non è mai cessata; pertanto anche i Latini vollero comparare il muscolo (ad esempio, quello del braccio) a musculus ‘topolino’, causa l’atteggiamento tipico dei topi d’ingobbire la schiena quando stanno fermi.
Ragno (voce italiana). Ma vedi sd. ranzόlu, aranzόlu, arranzόlu ‘ragno’ (Araneum species). Cfr. lat. arāneum, gr. αράχνη ‘ragno’. Base etimologica il sum. raḫ ‘to kill, uccidere’ + nu ‘to spin (thread), tessere (fili)’. Il composto raḫ-nu (> it. ragno) significò ‘assassino che tesse’. In Sardegna ritroviamo la stessa base mediterranea ma col suffisso aggettivale -lu. Questo è uno dei tanti esempi di false origini latine.
Siḍḍu2 (Bitti) ‘moneta antica’; (Desulo) ‘occhio di pernice’ (callo); (Cagliari ‘stella di mare’ (echinoderma), ‘cerniera, cardine delle ostriche e delle arselle’ (Marcialis); ‘coppetta, ventosa del polpo’. Nel CSNT figura col senso di ‘sigillo’; armentariu de sigillu (88, 115, 240); maiore de siillu (129). Wagner propone sbrigativamente per tutte queste voci l’origine dal lat. sigillum. Ma quest’operazione è ametodica, poiché le semantiche sono molto diverse e vanno spiegate una a una.
La prima voce, relativa alla ‘moneta antica’, ha base etimologica nel sum. šid ‘to count’. Quella relativa alla ‘ventosa’ del polpo può avere base nel sum. sidug ‘cavity, cavità’. Il significato di ‘stella marina’ può corrispondere al sum. si ‘horn, corno’ + du ‘to go, andare’ (col significato di ‘corni che camminano’. Il significato di ‘occhio di pernice’ può essere dal sum. si ‘horn, corno’ + dun ‘to dig, scavare’ (col significato di ‘corno che scava, che infilza’).
Sitzillu camp. ‘quarzo, silice’; sa pedra sitzía ‘pietra focaia’ (Mogoro). Base etimologica il sum. zi ‘life, vita, soffio’ + zu ‘flint, pietra focaia’ + illu ‘source, sorgente’. Il composto ziz-z-illu significò ‘pietra (focaia) sorgente di vita’. Tale fu il grande significato iniziale. Voler derivare questa voce dal lat. siliceus ‘di silice’ (come propone Wagner) significa storpiarne la vocalità e dare alla voce sarda un marchio d’accatto immeritato.
Suspirare log. ‘separare il siero dal latte’ (Spano). Base etimologica il sum. peš ‘to be thick, essere spesso’. Il latte nella cagliata s’ispessisce. La definizione dello Spano è infelice, poiché il siero non è un bi-componente separabile dal latte ma è un prodotto di trasformazione, diventato tale dopo l’inserimento del caglio. Wagner a sua volta s’intromette aggravando la situazione (DES II 252), poiché origina suspisare da un inesistente lat. *suspe(n)sare, quasi un ‘sospendere’, ignorando peraltro il contesto della caseificazione e rinunciando a interpretarlo.
Lautverschiebung. L’Accademia degli indogermanisti presenta la Lautverschiebung come problema esclusivamente germanico, mentre invece essa pervase (in parte ancora pervade) mezzo mondo, ed è vivissima anche in Sardegna. La Lautverschiebung (“rotazione consonantica”) divide la Sardegna metà per metà. Quindi a sud égua, a nord ebba. Se si chiedono lumi all’accademia, la risposta è che la /b/ del nord è fenomeno indotto dal latino (Wagner e Paulis), e non si va oltre: si legga per intero la Fonetica Storica del Wagner, con annesso l’ampio commento del Paulis.
In realtà, la “Rotazione consonantica” sarda è fenomeno arcaico, che vige nell’isola da almeno 40.000 anni (dai tempi Cro-Magnon), se non da prima, in ogni modo da quando si parla la lingua sumero-sarda. Il tutto è collegato strettamente a un fatto non considerato, ossia che in Sardegna sin da allora si svilupparono due fortissime tribù e, come accade in ogni divisione tribale, esse sono vissute sino a pochi millenni fa combattendosi (quando necessario) o almeno separandosi. Peraltro il 70% dell’isola è montagnoso, e già il Lamarmora indicava nei vertiginosi sprofondamenti tra le montagne un problema immenso che favorisce le reciproche separazioni.
Le separazioni tribali, e la scelta di starsene l’uno separato dall’altro, determinò anche la perdita dell’indipendenza sarda, a ben notare. La libertà delle tribù sarde finì con Josto, nel pessimo indimenticabile momento in cui Amsicora tentava disperatamente di far scendere a valle contro i Romani qualche squadrone di Barbaricini. Ebbene, non ci riuscì perché i Barbaricini si sono sempre sentiti un corpo separato. La disfatta portò Amsicora al suicidio. L’unità linguistica della Sardegna non si era mai potuta fare, ed ancora oggi si parlano vari dialetti. Problema immenso. Ma la lingua mediterranea parlata dalle genti sarde (il sumero dapprima, poi il sistema accadico, che si sovrappose e finì per convivere e imbozzolarsi entro il sumerico) avevano già determinato anche la scelta di vocaboli diversi per uno stesso concetto. Questo è evidente con abile “aquila” contrapposto ad ákili (fenomeno discusso più su).
Modelli del genere sono centinaia in Sardegna. Ed è da questi modelli, non da altro, che prese avvio la Lautverschiebung, in modo che la /b/ del nord fu letta /k/ o /g/ nel sud (o viceversa), persino in assenza di parole sumero-accadiche che consentissero di operare in tal senso, distinguendone i significati-base.
Égua/Ebba. Sul modello di ábile, l’originario égua (corrispondente al femminile lat. di equus) produsse al nord ebba (ma ciò accadde millenni prima dei Romani). Ebba non corrisponde ad alcun vocabolo originario del campo sumero-accadico (come invece abbiamo visto per abile/akili): è pertanto un perfetto esempio della Lautverschiebung, che opera a prescindere, essendo una legge fonetica.
(Tra parentesi, se qualcuno osasse dire che i cavalli arrivarono in Sardegna soltanto con i Punici, è pregato fraternamente di andare a vedersi i cavalli dipinti nelle Grotte di Lascaux, 32.000 avanti Era volgare, dimostrazione che i cavalli erano di casa anche con l’Homo Cro-Magnon). Ma vediamo di seguito alcuni altri esempi di Lautverschiebung.
Abbattare log. ‘schiacciare’; anche ‘sbattere le uova’; nasigattâdu ‘che ha il naso schiacciato, camuso’. Osserva anche il frequentativo abbattigáre ‘calcare, premere, pigiare (l’uva)’. Base etimologica è, per il significato ‘schiacciare’, l’akk. watārum ‘to be outsize, surplus, in excess, greater’. Respingo l’etimologia del Wagner (da lat. coactāre) perché foneticamente distante e priva di metodo. Wagner nella presentazione di abbattáre ripropone la falsa teoria secondo cui il sardo /b/ deriverebbe dal lat. /c/, pertanto sbaglia l’etimo di abbattáre, proponendo un analogo cattáre da catta, e da catta arbitrariamente egli fa risalire l’infinito abbattáre. In realtà, abbattáre e cattáre sono due verbi distinti nella forma e nell’etimo, ed è un puro caso che abbiano significati convergenti. Per l’etimo di cattáre e catta vai a cattigáre (ma catta significa pure ‘frittella’, e in quanto tale ha un terzo etimo: l’akk. kattu ‘che corrobora’).
Abbentinnare, abbintinnare log., agghentinnare nuor. ‘contrassegnare il manto del bue o del cavallo’; a Nuoro anche ‘rassomigliare’ (parlando delle bestie): processo di Lautverschiebung. Base etimologica l’akk. binītu ‘shape, appearence; forma, apparenza’.
Abbénzu log. ‘difetto fisico o morale, debolezza, macchia’. Per l’etimo vai ad irghenzu.
Abbuttinare log. ‘calpestare, investire, travolgere’ (detto specialmente dei cavalli e dei buoi); fig. ‘danneggiare, rovinare, disonorare’. Wagner propone l’etimo dal lat. coactare ‘schiacciare’. Ma tra le due parole c’è un abisso fonetico. La vera base è il sardo botta ‘scarpa’. La voce sarda indicante la ‘scarpa’ corrisponde all’ingl. boot ‘stivale, stivaletto, scarpetta’ < ant. fr. bote, ed ha base etimologica nell’akk. uttû(m) ‘ghirba di pelle, otre’, per estensione ‘scarpa’ (in origine la scarpa non fu altro che un rifascio di pelle, poi rafforzato dal cuoio).
Fitiánu, vitánu ‘comune, di ogni giorno’: bestíres fitiános ‘vestiti di ogni giorno’, dìes fitiánas ‘giornate di lavoro’ (non festive); ‘necessario, regolare’: sa proènda fitiána ‘la razione di biada’; ‘avventore assiduo’: fitiános dessu tsilléri ‘frequentatori della bettola’; a fitiánu ‘nei giorni di lavoro’: custa beste mi la ponzo a fitiánu ‘questa veste la indosso nei giorni di lavoro’, filende fitiánu ‘filando assiduamente’. Wagner, convinto che la p (f) sarda non sia altro che un derivato automatico dal lat. q, c, non trovò di meglio che far derivare il lemma sardo dal lat. cotīdiānus, quotīdiānus ‘di ogni giorno’, per quanto ammettesse poi, prudentemente, che lo sbocco sarebbe dovuto essere b- anziché p- o f- (bontà sua!). L’inadeguatezza degli studi passati ed attuali è dimostrata dalla vera etimologia di fitiánu (di cui il camp. vitánu è normale lenizione): sta nell’akk. bītu ‘casa’, bītānu ‘di casa, interno, familiare, casareccio’, bītānû ‘intimo, personale’. Da questa b- semitica ebbe origine la lenizione /v-/ del campidanese.
Báttica (Orosei) ‘la parte di un orto riservata alla coltivazione dei cocomeri e dei poponi’. Pittau (Studi Sardi di Linguistica e Storia, Pisa 1958, p. 98), approvato dal Wagner, sostiene che la voce derivi da un lat. aquatica, che produrrebbe la famigerata trasformazione q > b. Invece la base etimologica sta nell’akk. batqu ‘cut (off), tagliar via’. Infatti, poiché báttica è parola arcaica, vecchia di parecchi millenni, non occorre fantasia per capire che le antiche coltivazioni irrigue venivano fatte separando rigorosamente il terreno dagli spazi liberi, dal tradizionale regno degli armenti.
Bènnere log., bènniri camp. ‘venire’; p.p. bénnidu, bénniu ‘venuto’. Base etimologica è l’akk. bā’um ‘andare, venire’. La forma sarda sembra la più vicina all’originale, mentre il lat. ueniō è un derivato. Questo è uno dei tanti verbi su cui gli indoeuropeisti si sono infervorati a “dimostrare” origini indimostrabili da un (inventato) indoeuropeo *guen (Benveniste, Origines 156).
Bodále log. ‘coso, cosa o persona indefinita’. Non è dall’it. cotale (come pensa Wagner) ma dall’akk. wuddi, uddi ‘certainly, probably’, poi aggettivalizzato in -le. Nel CSP 356 e 358: in gotale tenore. Ovvia la voluta corruzione dell’amanuense sulla falsariga dell’it. cotale.
Gustare, -ái log. e camp.; secondo Wagner, questa voce è identica all’it. gustare, di cui sarebbe un accatto. Ma Wagner ha preso un abbaglio, anzi ha volutamente forzato il suo lemma (illustrerò più oltre la strana tendenza del Wagner alle forzature). In realtà la voce sarda non è gustare ma bustare ‘desinare, mangiare’, anche ‘far colazione’; bustu ‘pranzo’. È l’equivalente di ismurzáre, immurzáre, smurzái. Wagner quindi erra a dare il significato di ‘gustare’ < lat. gustare ‘provare il sapore, assaggiare’. Infatti il termine bustare è autoctono, sardiano, con base nel sum. bur ‘tempo del pasto, ora del pasto’ > akk. būru(m) ‘fame’ + uštu, ištu ‘fuori da’ (stato costrutto būr-uštu > bū(r-u)štu nel nord Sardegna e b(ū)r-uštu nel sud), col significato di ‘fuori dalla fame’.
Isbattulare log. (Bonorva) ‘colpire violentemente’. Base etimologica l’akk. bâṭu ‘to show contempt, mostrare disprezzo, disdegno; oltraggiare’. Respingo la proposta del Wagner dell’origine dal lat. coactare ‘schiacciare’. Wagner anche in questo caso volle imporre la “legge fonetica” da lui inventata.
Patatas. Il toponimo Sas Patàtas nel monte Albo di Lula, territorio carsico, deriverebbe da un lat. *coactiare ‘schiacciare’ (secondo Giulio Paulis NLS 522), causa la forma “schiacciata” del sito rispetto al restante rilievo montano (ma è una falsità), e significherebbe ‘grande avvallamento’. Posta così, la questione appare già traballante, poiché il toponimo convive nello stesso sito con l’altro toponimo Janna e Nurái ‘il passo della voragine’ (perché presso l’angusto passo che introduce nel selvaggio Monte Albo c’è una grotta verticale molto profonda, a campana), ed il toponimo convive anche col contiguo Sos kilívros ‘i crivelli’ (termine che è tutto un programma, poiché quel suolo è fortemente carsicizzato e presenta vari buchi pericolosi). In realtà patàtas non attiene a *coactiare (verbo inventato tanto per giustificare un’assurda trasformazione da lat. c- a sd. p-) ma attiene all’akk. pattu, pātu, puttû ‘aperto’, termini che indicano i vari sprofondamenti del terreno (quelli che in sardo si chiamano normalmente putzos ‘pozzi’,da puttû ‘aperto’). Cfr. sum. pa ‘pouch, tasca’ + taḫ ‘to add, increase; addizionare, ingrandire’, il cui composto (pa-taḫ, raddoppiato per resa icastica: pa-taḫ-taḫ) potè significare in origine ‘pozzi profondi’; akk. patāḫu ‘bore through, perforato’.
Pazzare log. ‘mettere il caglio nel latte’; rifl. ‘coagularsi, accagliarsi’; anche di altre sostanze ‘aggrumarsi’ (su sàmbene); sost. pazzu ‘caglio’; anche ‘malattia infantile con vomiti’ (Casu). Ma quest’ultima voce, inserita arbitrariamente dal Wagner nel contesto del lemma, rientra in un campo semantico diverso, quindi per essa rinvio a pazzu. Quanto a pazzare, base etimologica è l’akk. pazārum ‘to hide o.s., conceal o.s., be hidden; nascondersi, celarsi, stare nascosto’. A quanto pare, alle origini l’uomo osservò anzitutto la capacità delle ferite di “metter crosta”, di celarsi. In un secondo tempo al verbo pazārum associò anche l’idea del coagulo del latte, il quale avviene appunto nascostamente. Wagner invece fa derivare pazzare da it. e lat. coagulare, riproponendo l’assurda “legge fonetica” che forza il lat. K, G a diventare sd. P, B. Qui debbo sottolineare un fatto incredibile, che Wagner inventò la sua “legge fonetica” per soddisfare una manciata di vocaboli (non più di 15 citati nel DES) per i quali egli non riusciva a far quadrare l’etimologia. Ammesso e non concesso che fosse mai esistita una tale legge fonetica per una irrisoria manciata di vocaboli, Wagner avrebbe dovuto rendersi conto che il lat. coagulāre è composto da un primitivo cum + agō ‘faccio convergere’. E allora avrebbe dovuto capire l’insormontabilità di ridurre il lat. cum al sd. pa-. Chi pretende di accreditare l’esistenza di questa assurda trasformazione mostra la risolutezza di chi si lancia senza paracadute sperando d’atterrare incolume.
Altri latinismi supposti da Wagner. La falsa “legge fonetica” appena discussa, inventata per soli 15-20 vocaboli al solo scopo di dare più lustro alla forzosa idea che la lingua sarda derivasse dal latino, è stata soltanto uno degli escamotage inventati dal Wagner per ancorare la propria teoria alla romantica “ossessione imperiale”. Per non tediare, scelgo soltanto due lemmi tra le migliaia disponibili. Ma si notino i molti altri “latinismi” già discussi o che discuterò nel corpo della presente premessa metodologica.
Murru2 log. e camp. ‘grigio’ (CSNT 282: I caballu murru). Per Wagner questo aggettivo è contrazione da lat. murīnus ‘color del topo’. Il termine è usato anche dagli antichi scrittori di veterinaria proprio ad indicare il manto del cavallo. Ma invero, Wagner non sa quale concetto avessero in mente gli antichi romani. Altro esempio sd.: braba murra ‘barba grigia’ ecc.
Per tutte le altre occorrenze citate dal Wagner in relazione a questo aggettivo (tipo ispiga múrina, etc.), rinvio alle voci múrina, múrinu, poiché le loro basi etimologiche sono assai diverse da quelle suggerite dal Wagner. Quanto a murru2, anche qui Wagner cade male, poiché pretende di accostare la barba di un vecchio nonché uno dei colori del nobilissimo cavallo al colore del ratto, un essere che l’uomo ha sempre tenuto in gran dispregio. Basterebbe ciò a mettere in allarme un ricercatore. Infatti la base etimologica di murru2 è il sum. muru ‘rainstorm, mist, drizzle; tempesta di pioggia, foschia, pioggerella’. Da qui quel meraviglioso colore picchiettato del cavallo.
Paríga è il termine col quale nel Campidano s’indica ‘un certo numero’, ‘una dozzina’; impropriamente pure il ‘paio’. Con incredibile insufficienza e nonchalance, Wagner scrive quattro-parole-quattro: «parίga camp. ’paio’, = *PARIC(Ŭ)LA». Nient’altro. Egli era uomo accorto, e sapeva che l’origine da lui proposta è inesistente: viene da lui supposta per riempire un vuoto cognitivo. E lascia il lettore impiccato a questo laconico ‘paio’, senza nemmeno un seguito esplicativo.
Peraltro non è che lo stesso Porru, dal quale Wagner attinse il vocabolo, abbia avuto incertezze a registrare la seguente frase contraddittoria: «Parìga s.f. pajo, paro, coppia. Ses parigas di ous, de pira ec. Su propriu de una duzzina, una serqua d’ova, di pere ecc.». Egli però trattò la materia con più sufficienza, lasciandoci una vaga traccia del concetto di dozzina. Questo è un progresso, che però non bastò a mettere sull’avviso Wagner. Inoltre il modello italiano ha il suo peso, e il DELI, nel registrare il lemma paio ‘coppia di cose, persone, animali’, attinge direttamente da it. paia, fondato sul lat. pāria, neutro plurale di pār ‘pari’.
Riconosco al Wagner la poca disponibilità di materiale alternativo, stante il fatto che si auto-condannò a frugare soltanto nella lingua latina. Ed avendo davanti agli occhi il modello pār, va da sé che lo vide come archetipo. Gli riconosco pure che in Sardegna sul tema ebbe pochi altri modelli, visto che in sardo per indicare il paio abbiamo soltanto dei lemmi italo-latineggianti concorrenti, quale l’italianismo coppia (con metatesi e rotacizzazione camp. croppa, dal lat. cŏpula), nonché páya (italianismo) e, appunto, parìga, che viene considerato una sopravvivenza medievale originata da un (inesistente) *paricŭla.
A nessuno è sembrato importante indagare perché il popolo sardo tende a misurare tutto in dozzine. Da quando sono nato non ho mai visto gente acquistare a decine ma soltanto a dozzine: una dozzina di paste, una dozzina di uova, una dozzina di piatti, e così via. E quando un campidanese va a far la spesa e vuole comprare una quantità di merce numerabile, ne chiede sempre una barίga, che non interpreta come paio ma proprio come ‘una dozzina’ (così è per le mele, le pere, le arance, e così via). Quando egli vuole andare oltre il numero uno o due, parla sempre di parίga. Il termine è usato estensivamente anche per la merce non numerabile, con procedimento generalizzante: così è per le ciliegie e tutta la merce minuta, ivi compresa, ovviamente, quella non edule. Cantu? Una parìga «Quanto? Un po’» (a indicare una quantità non misurabile ma già cospicua). Parìga è termine sardiano con base nel sum. bariga ‘unità di misura, di capacità’, ‘un contenitore per misurare’, da bar ‘forma esterna’ + iku ‘unità di misura’.
Italianismi. Una sotto-classe della “pregiudiziale latina” è la “pregiudiziale italiana”, cui Wagner ed i suoi epigoni si àncorano per giustificare l’origine di circa il 10% del vocabolario sardo. La riserva mentale dei ricercatori è che, intanto, anche gli italianismi sono di origine latina. In ogni modo Wagner, quando potè, volle distinguere e parlare propriamente di “italianismo”. E non lo sfiorò nemmeno l’idea che l’Italia romana era suddivisa in 32 popoli, con relative lingue, e che quelle lingue hanno prodotto i dialetti italici attuali. Talché io stesso, nel trattare le voci della Penisola, preferisco parlare spesso e volentieri d’italico anziché d’italiano, affinché si percepiscano le autonomie dell’antichità rispetto al latino.
Peraltro, il sud Italia formò per oltre 500 anni la Magna Grecia, e non è che dopo la conquista romana il greco delle coste sia decaduto nel giro di decenni. Ma sarebbe lungo rivangare questa problematica. A me compete in questa sede proporre alcuni esempi del tema prefissatomi.
Abbolicósu log. ‘diabolico’. Wagner ne propone l’origine dall’it. diabòlico, con perdita della prima sillaba. Ma in realtà la base etimologica è il composto akk. bu’’uru ‘catturato, prigioniero’ + leqû ‘prendere il potere’. Il composto bu’’uru-leqû significò in origine che è ‘succubo, preda di un potere (diabolico)’.
Accasare1 log. ‘maritare’; cfr. it. accasar(si). Wagner e chiunque altro pongono l’origine del termine sardo dall’it. casa ‘costruzione abitativa’ < lat. casa ‘capanna’. In realtà il termine accasáre è parimenti antico anche in Sardegna, ed ha base etimologica nell’accadico: v. kasû ‘legare, legare assieme’, ḫâsu ‘installare’, ḫuṣṣu (a kind of reed hut). Con ogni probabilità, la base più appropriata del lemma sardo relativo al matrimonio è l’akk. kasû ‘legare, legare assieme’.
Accássu log. ‘bisognoso’; accassu de sidis, de fámene ‘mezzo morto di sete, di fame’ (Spano). Wagner deriva il termine sardo dal sic. e it. casso ‘stanco, lasso’. In realtà il termine sardo è arcaico: vedi il verbo acansáre, accassáre, cansìre ‘star male, soffrire’; cansìdu p.p.; acassu, acansu, akensu ‘che sta male, che soffre’, ‘esausto, bisognoso’; camp. accasiòni ‘sofferenza, fastidio, malessere’; camp. acasionéri ‘chi produce un male, chi crea sofferenza’. Per traslato: cansàda ‘digressione, deviazione’. Base comune a tutti questi lemmi è l’ass.-bab. kanšu, kaššu, kansu ‘sottomesso, remissivo’ < kanāšu ‘sottomettere, assoggettare’.
Cascavallu camp. ‘caciocavallo’. Italianismo. DELI non sa trovare l’etimo, non riuscendo a individuare addentellati per il secondo membro -cavallo. La base etimologica può essere individuata soltanto dopo aver capito la tecnica di produzione del caciocavallo, il quale è un formaggio stagionato a pasta filante dell’Italia meridionale (specie della Campania), ottenuto da latte di vacca podolica. La forma è quella di una grossa pera (infatti in Sardegna è detto pireḍḍa ‘peretta’), il cui tozzo “picciolo” serve per legarlo ed appenderlo ad asciugare e stagionare. Talora il caciocavallo viene appeso entro una rete di rafia. Per il primo membro cacio- rinvio a casu; il secondo membro -cavallo ha base etimologica nell’akk. ḫabālum ‘to bind, harness; legare, imbrigliare’.
Incocciare, incocciái log. e camp. ‘incontrare, trovare, sorprendere’, come it. merid.: sic. ncucciari ‘ghermire, cogliere, soprendere’ (Traina); cal. ncucciari ‘accostare, avvicinare’; irp. nguttsà ‘indovinare’ e ‘colpire’ (Urciolo). Base etimologica è l’akk. ḫuḫārum ‘bird-snare, trappola per uccelli’. Il significato originario è chiaro, ed è chiara la sua evoluzione semantica nel bacino tirrenico.
Invece Wagner pretende che – siccome il vocabolo esiste anche nell’Italia meridionale – in Sardegna esso sia importato dal sud. Non lo sfiora nemmeno il sospetto che già dal Paleolitico sia esistita una Koiné tirrenica, alla quale la Sardegna partecipava da signora.
Ovviamente, il danno maggiore Wagner lo fa nel raffrontare fra loro sincronicamente queste voci, senza tentare la ricerca etimologica che ne avrebbe stabilito la loro origine prima, e se possibile la loro diacronicità.
Insólica in erba insólica (Cagliari); arbasólica (Cuglieri) ‘varietà di vite a frutto bianco’; corrisponde al nap. uva ‘nzoleca (Sarnelli); Isola del Giglio anzónaca; Elba: ansónico (Merlo); Pitigliano anzónica (Longo); cal. ansólia, insólia (DTC); sic. nzólia (Traina). A quanto pare, la voce sarda è d’accatto. Lascio al lettore l’impegno di controllare l’irresolutezza del Wagner (DES I 637) sull’etimo di queste voci italiche. Un indizio linguistico (il suffisso -ik-) fa pensare che tale vite sia entrata in Magna Grecia provenendo dalla Grecia. Lascio ai grecisti l’indagine, che sicuramente porta molto lontano, quasi certamente fuori dal loro mondo, esattamente al mondo semitico (vedi bab. īnu ‘vino’ + ṣulû ‘supplication, prayer; supplica, preghiera’). Secondo la mia interpretazione – la quale è in linea con tutti i nomi delle viti da me analizzati – insólica (īn-ṣul-ikos) in origine significò ‘vino da messa’, ‘vino per le suppliche nel Tempio’, e simili.
Pirone2 m. log. sett. ‘romano (contrappeso) della stadera’. Base etimologica è l’akk. pirru, perrum ‘payment collection, tax delivery; raccolta dei pagamenti, consegna delle tasse’. Nella prospettiva della nascita del linguaggio, questo vocabolo nitidamente sardiano acclara come si svolgeva il pagamento delle imposte allorché mancava ancora la moneta. Su una grande bilancia si poneva da una parte il peso accertato, e dall’altra il contribuente caricava grano od altro tributo, sino a che il peso si equivaleva.
Duole notare la superficialità con cui Wagner liquida la questione etimologica, scrivendo (DES II 276): « = ital. pirone (la limitazione al solo log. sett. e l’assenza del vocabolo negli altri dialetti esclude l’indigenato e più ancora l’etimo ‘pedone’ del Salvioni, RIL XLIX, 724, n.). Cfr. REW 6366». Si possono notare nella nota del Wagner due atteggiamenti culturali ancora oggi tipici dell’accademia: 1) quello di annotare comunque le soluzioni proposte dai suoi colleghi accademici, anche quando sono impresentabili e grondano mistificazione; 2) quello di sentenziare categoricamente la non-sardità dei vocaboli logudoresi allorché manchino delle controprove campidanesi.
Rata log. e camp. ‘rata, parte, quota in cui viene frazionato un pagamento’. Per Wagner è italianismo. DELI lo deriva dal lat. răta p. p. di rēri ‘pensare, opinare’ ma senza convinzione: infatti s’ignora persino l’etimo del verbo latino. Invero, base etimologica del tirrenico rata è il sum. raḫ ‘to break’ + taḫ ‘to add’. Il composto originario raḫ-taḫ significò ‘frazione (di un insieme) da addizionare’.
Reghentiare, arreghentiare log. ‘inasprire, inciprignire’ (di ferite, tumori); rifl. ‘inasprirsi, incocciarsi’; regentίa ‘collera, rabbia, ostinazione, cocciutaggine’. Base etimologica è il sum. raḫ ‘to beat, kill; picchiare, battere, uccidere’ + ti ‘arrow, freccia’. Il composto raḫ-ti- in origine indicò il ‘colpire di freccia’. Ovviamente è da espungere la proposta del Wagner di derivare questa voce da un it. recente (lat. recens, recentis) ‘avvenuto da poco tempo’ (sic).
Sinnu log. ‘senno, criterio’, parola usata anche nel Medioevo (CSP 348). Base etimologica il sum. šennu ‘priest, sacerdote’ (tutto un programma). Cfr. ant. fr. sen ‘intelligenza, ragione’ (DELI), evidente segno dell’arcaica Koiné Mediterranea. Wagner lo deriva dall’italiano, DELI dal francese, ma essi rimangono sempre nell’angusto cortile della filologia romanza.
Vária (Bitti), oggi válgia (s’álgia); sa várgia (Fonni); barza (s’arza) log.; bárgia, braxa camp.; viene definito dallo Spano ‘falangio, sorta di ragno velenoso, il solo che abbiamo nell’isola, dal Berni si chiama tarantola, ma meglio solìfuga’. Difatti non è la vera tarantola (Lycosa tarantula) e neanche il malmignatta (solifuga, che si chiama in Sardegna soloίga, suίga), ma una specie di Mutilla, un imenottero vespiforme “le cui femmine rassomigliano a formiche graziosamente screziate di giallo e di rosso” (Marcialis, Pregiudizi 59).
Base etimologica di vária è l’akk. bārû(m) ‘to catch, trap (with a net), wicked people; hunt, go hunting; catturare, intrappolare, gente cattiva; cacciare, andare a caccia’. Questa è l’esatta descrizione dei ragni in generale. Nel caso specifico, bária è aggettivale del verbo accadico qui indicato. Va da sé che le etimologie del Wagner sono fuori posto, poiché non si può sostenere che la denominazione provenga dal colore variegato (vária).
Caḍḍémis, caḍḍémini ‘persona miserabile, vestita di stracci o comunque male vestita, sporca’ (Puddu); kaḍḍémis cagl. plebeo ‘straccione, sporco, malvestito’ (Wagner); bestίu a caḍḍémis; Wagner lo presenta come equivalente del sic. gaddémi ‘chi somministra legna alla caldaia, abietto, dappoco’ allato a gaddìmi ‘idem’ e lo ritiene una probabile derivazione dall’ar. ḥadîm ‘servo’. L’ipotesi del Wagner va bene per la Sicilia. Per la Sardegna propendo a vederci l’influsso dell’akk. qaddu(m) ‘piegato’ da miseria, preoccupazioni, malattie + emû, ewûm ‘diventare’, ‘essere come’; questo verbo si usa spesso col suffisso modale -iš ‘come, like’. Il significato è ‘diventare come uno schiavo, un servo’. Alcuni sardi, influenzati in buona fede dal fatto che certe parole della Sardegna somigliano stranamente a lemmi inglesi con significato similare, giurerebbero che il termine sia stato creato da emigranti sardo-americani di un secolo fa, dalla locuzione God damned ‘che Dio sia maledetto’. Registro questa curiosità per far capire quanto forte sia la legge della paronomasia (della quale tratterò in seguito), la quale esercita la sua tirannia sia nel popolo sia tra gli intellettuali.
Caḍḍótzu camp., specialmente cagl. ‘sudicio’ (di persone). Il termine si ha pure ad Escalaplano, ossia sulle montagne degli antichi Galilla. Wagner propone una probabile etimologia da kaḍḍu ‘cotenna, pelle del maiale o del cinghiale’ < lat. callum. Ma è difficile accostarsi alla proposta wagneriana. Era nota nell’antichità l’abitudine all’igiene del maiale (a maggior ragione del cinghiale), che non è nè più sporco nè più pulito di altri animali, ed appare “sporco” solo allorché viene chiuso nell’abiezione del brago. Ma il brago, si sa, viene cercato naturalmente dal maiale (e pure da molti animali della savana) per crearsi addosso un impasto che, seccando, racchiude e uccide le zecche e tutti i parassiti della pelle. Nella stagione calda è usuale vedere branchi di maiali (quelli liberi in natura) immersi per lungo tempo nei fiumi d’acqua pura, col solo muso fuori (proprio come i bufali o gli ippopotami) allo scopo precipuo di annegare i parassiti. Il termine ‘sozzo, sudicio’ non poteva dunque richiamare il maiale, nonostante che gli Ebrei lo avessero considerato un essere immondo (ciò riguarda soltanto la loro religione, per la quale era immondo persino il cammello).
Suppongo che il termine caḍḍotzu col semantema attuale sia nato nell’alto medioevo ad opera dei preti cristiani, decisi a far tabula rasa di ogni forma di religione anteriore, della quale bersagliavano i termini sacri distorcendoli nella forma e molto più nel significato, che veniva capovolto, umiliato, lordato e quindi demonizzato. Nelle città sarde – giusta la (relativa) tolleranza degli imperatori – le religioni attestate erano le stesse professate a Roma: quella ufficiale dello Stato, ma pure quelle orientali (ebraica, egiziana, persiana, etc.). Era forte specialmente la religione ebraica, non solo per la forte presenza della diaspora ma anche perché gli Ebrei, dovunque stessero, erano gli unici a saper leggere e scrivere. Erano pertanto rispettati ed apprezzati.
L’unico termine antico accostabile a caḍḍotzu è il fen. qdš (qodeš) ‘santo, santuario’, ‘consacrare, consacrato’, riferito a tutto: sacerdoti, offerte, tempio e divinità. È principalmente accostabile l’ebr. qadòš ‘martire, santo’ (SLE 85). Ma può esserlo pure qaddiš, ch’era la preghiera ebraica ripetuta varie volte al giorno (SLE 73), o il kidduš, la benedizione a Dio espressa la mattina del sabato, recitata accanto a due candele, su una coppa di vino.
Somiglianza originaria tra sardo, catalano, spagnolo. Nonostante le obiezioni che fin qui ho mosso a M.L. Wagner, riconosco che per il passato egli fu il maestro indiscusso e insuperabile degli studi di linguistica sarda. Nato nel 1880 e morto nel 1962, compì gli studi al regio Humanistiches Gymnasium bavarese di Neuburg a. d. Donau e alle Università di Monaco, Würzburg, Parigi e Firenze. Dal 1905, su borsa di studio dell’Università di Monaco, cominciarono i numerosi soggiorni in Sardegna. Nel mentre dal 1907 fu nominato professore di lingue moderne alla Deutsche Realschule di Costantinopoli. Wagner conosceva, oltre al tedesco, il sardo, l’italiano, il francese e lo spagnolo, e seppe approfondire anche la conoscenza del rumeno. Essendo di casa in Turchia, è pensabile che sapesse gestire anche la lingua turca. Era indubbiamente poliglotta, e in quanto tale si potè concedere impegni di studio anche nell’ambito dei gerghi e delle lingue popolari, del giudeo-spagnolo, del portoghese, dello spagnolo, del catalano. Ovviamente alla base dei suoi studi doveva esserci la lingua latina e quella greca antica. Caballero andante [y ingenioso hidalgo] della filologia lo definì Karl Vossler, e ancora oggi ogni linguista s’inchina davanti alla vastità dei suoi excursus.
Nell’approfondire le lingue iberiche, Wagner si era reso conto dell’identità pressoché totale della lingua sarda col catalano e con lo spagnolo. Leggendo estesamente il suo capolavoro, il Dizionario Etimologico del Sardo, si evince che lo studioso tedesco agganciò quasi il 90% della lingua sarda a quelle iberiche. Ovviamente egli aveva approfondito anche gli studi sulla storia sarda, e dagli storici del suo tempo apprese che le vicende sarde avevano portato nei secoli anzitutto all’occupazione romana, poi all’occupazione pisana, genovese, catalana, dopo la quale la Spagna intera subentrò estesamente nell’isola. Infine, furono i Savoia a dominare la Sardegna.
Wagner tenne conto di questo fenomeno, ma con tutta evidenza lo interpretò mediante la cultura da lui assorbita nei luoghi di origine in gioventù, quando la pregiudiziale nazista pervadeva ogni poro del pensiero germanico. Di conseguenza egli ammantò i propri libri di una visione poco meditata, che proponeva una lingua sarda derivata quasi per intero dalle lingue iberiche. Wagner, per ragioni di stile scrittorio, non scrisse espressamente di derivazione né di origine delle decine di migliaia di lemmi da lui affrontati. Gli bastò esplicitare i due concetti di tanto in tanto, su poche centinaia di voci, conseguendo l’effetto che il lettore se ne convincesse per proprio conto. Fu un processo pressoché surrettizio, come tale poco adatto a risvegliare nel lettore il senso critico, inducendolo ad accettare le sentenze palesi o silenti del Wagner. Nelle altre migliaia di lemmi egli affianca semplicemente la voce iberica a quella sarda, suggerendo ex silentio la prima come origine della seconda.
Da me in quanto glottologo tali sentenze del Wagner sono state percepite da decenni come ingannevoli, ma è da quindici anni che ho rotto gli indugi col mio maestro Wagner, decidendo di contrapporre a mia volta una visione e una procedura metodologica diverse nello studio della lingua sarda. Il lettore sarà mio giudice. Sorge spontanea un’obiezione: se Wagner era convinto che il 90% della lingua sarda deriverebbe dalle parlate iberiche, come conseguenza si deve assumere che il popolo sardo, prima dell’invasione iberica del 1323, parlasse soltanto un 10% di vocaboli. Un glottologo sa che un popolo con tale penuria non può mai esprimere la propria cultura. Ci vuol poco a capire che la “pregiudiziale iberica” del Wagner è sorella della “pregiudiziale latina”: porta alle stesse conclusioni nichiliste, ossia ad ammettere che prima di Roma (in questo caso, prima di Barcellona) il popolo sardo si esprimesse mediante un plancher così misero, che può benissimo essere tralasciato, perché ininfluente nello studio del sardo attuale. Come corollario, va da sé che la lingua sarda attuale dovrebbe considerarsi accattata di recente, quasi al 100%, dai popoli viciniori. Come secondo corollario, si dovrebbe ammettere che la lingua sarda nella sua lunga storia sia stata di una gracilità così eclatante, da infrangersi e sparire ad ogni minimo urto colonizzatore. Si può notare che i filologi che sinora hanno condotto gli studi linguistici in Sardegna hanno tutti la stessa mentalità: credono che i Sardi abbiano una tale disaffezione per la propria lingua da barattarla con la prima lingua che s’affacci alle coste isolane.
Ciò equivale a dire che il popolo sardo, dopo aver vissuto con la propria lingua da 100.000 anni (o da almeno 40.000 anni) e fino al 238 a.e.v., di colpo vi rinunciò. Una volta latinizzati al 100%, i Sardi giunsero al 1323 della nostra Era, ed eccoli di nuovo abiurare alla propria parlata, calpestandola ed assumendo in breve tempo altre parole, altre visioni del mondo.
Invero, i fatti non sono mai andati per quel verso. I Sardi hanno sempre mantenuto la lingua delle origini, salvo le poche contaminazioni che in ogni paragrafo vado dimostrando. Quindi è ovvio che la visione del Wagner va rivisitata con occhio disincantato. La mia visione è semplice: se i Sardi condividono con gl’Iberici il 90% del proprio vocabolario, vuol dire che Sardi ed Iberici lo condividono già da 100.000 anni, o giù di lì. Insomma, rammentando la “presa a tenaglia” che l’Homo, disceso fino al Delta, operò lungo le coste mediterranee, va da sé ch’Egli prima sbarcò a Gibilterra su otri gonfi di paglia, poi dilagò sino alla Linguadoca, alla Liguria, all’Etruria, e di là per la Corsica arrivò in Sardegna. Per questa ragione gl’Iberici sono stati i primi, nel Paleolitico, a parlare il linguaggio nilotico, poi sbarcato in Sardegna; ma tutto ciò avvenne sempre in epoca arcaica, non nel 1323.
Ecco di seguito qualche vocabolo indissolubilmente e pariteticamente iberico-sardo (o sardo-iberico).
Altanèra camp. ‘aquila grande’ (Spano). Wagner deriva il lemma da sp. altanero ‘aplícase a les aves de rapiña de alto vuelo’. In realtà i lemmi sardo e spagnolo hanno base etimologica nell’akk. alītu, elītu ‘altezza, parte alta’ + erûm ‘eagle’, e significò in origine ‘aquila dei luoghi eccelsi’.
Amistáde, amistádi log. e camp. ‘amicizia’; uguale a sp. amistad. L’uno e l’altro vocabolo hanno basi etimologiche comuni nell’akk. a, an, ana ‘per’ (finale) + misu, mēsu ‘washing, purification’ + ṭabtu ‘pace’. Il composto a-mis-ṭabtu significò in origine ‘purificazione della pace’. Questa parola è arcaica. Non può essere vero che derivi dalla Spagna. L’una e l’altra parola sono mediterranee ma autonome, in quanto facenti parte di unica Koiné. L’arcaicità di questa parola si nota dalla combinazione delle tre componenti e indica il momento in cui le famiglie nemiche facevano solennemente la pace, purificandosi con l’acqua (rito uguale a quello dell’ingresso nel Tempio) e tenendosi pubblicamente e reciprocamente la mano.
Arraccáda nuor. e camp., meno frequente nel log.; spesso arreccadas (Cagliari, Villacidro, Iglesias, Sarrok) ‘orecchini pesanti’ = cat. arracada, arrecada; sp. arracada; sass. raccára ‘idem’ (Muzzo): un pággiu di raccári ‘un paio di orecchini pesanti’ (Calvia). Base etimologica è l’akk. raqādum ‘to dance, skip; danzare, saltellare’ (infatti gli orecchini sono l’unico ornamento muliebre che ballonzola liberamente).
Carrogna (carroña) log. e camp. ‘donna di facili costumi’; cfr. cat. carronya, it. carogna (ambedue con identici significati spregiativi, relativi a persona infame raffigurata come carcassa puzzolente). Wagner propende a vedere l’origine della voce sarda dal catalano (e ciò soltanto perché essa contiene …due -rr- come in Sardegna!). L’atto del Wagner, oltre ad essere superficiale per il fatto che confronta lemmi coevi la cui storia non viene approfondita, non si pone nemmeno il problema delle cause che portarono in Italia ad una -r-, e in Catalogna a due -rr-. A lui basta l’evidenza della doppia -rr- per decretare che la Sardegna è debitrice di un ennesimo vocabolo dalla Catalogna. Questo metodo… “audio-visivo” è ascientifico e antistorico, perché, non tenendo conto della pronuncia italiana, si priva dell’opportunità di scendere al fondo dei millenni per individuare il prototipo di tutte queste voci mediterranee.
Soltanto andando alle origini arcaiche siamo in grado di capire il fenomeno, il quale va scomposto in due rami d’indagine per essere meglio inquadrato. Il primo ramo conduce forzatamente alla situazione storica del Mediterraneo nei millenni precristiani, allorché le continue guerre che recavano ad alte perdite tra i maschi, nonché la disuguale organizzazione del lavoro e la disuguale struttura ereditaria, portava a un quadro socio-economico nel quale la vedova o l’orfana – nonostante le ipocrite leggi morali e religiose che suggerivano l’elemosina e la protezione delle vedove e dei bimbi – riuscivano a sopravvivere soltanto prostituendosi. Il secondo ramo d’indagine è quello meramente linguistico, in base al quale scopriamo che la lingua accadica offre la voce karru, kāru(m) ‘quay, port, (river) quay; molo, porto, porto fluviale’. Unire questi due risultati è facile, considerando che le prostitute s’ammassavano principalmente lungo i porti dei grandi fiumi o sui moli dei porti marini. Ragioni ovvie: era lì che convergevano i marinai ed i commercianti di passaggio, era lì che alle donne era consentito di esercitare la prostituzione sacra senza pagare nemmeno il fio della condanna morale.
Quindi carrogna non è un inasprimento morale e linguistico (le due -rr-!) mirante ad equiparare la prostituta alla carcassa puzzolente d’una bestia (ciò sarebbe stato il colmo della contraddizione in bocca a un maschio che prima del matrimonio era invitato dal padre a “farsi esperto”), ma è semplicemente un aggettivo professionale in -nia indicante ‘quella dei porti, quella dei moli’. Si può constatare che in Sardegna e in Catalogna prevalse l’akk. karru, mentre in Italia prevalse l’akk. kāru, da cui le due voci carrogna e carogna. Invece l’it. carogna intesa come bestia in decomposizione ha altro etimo, infatti è lemma precipuamente italico (è aggettivale spregiativo da lat. carō, carnis ‘carne’), mentre in Sardegna s’usa precipuamente mortorzu o ispéigu (vedi).
Ditta2 camp. ‘prétziu crésciu in is compras a s’incantu’: crèsciri ditta ‘aumentare l’offerta o il prezzo’; béndiri a ditta ‘vendere per la maggiore offerta’; cfr. cat. dita ‘lo preu que’l comprador posa a lo qu’es ven y arrenda: postura’. Base etimologica è l’akk. diktum ‘fighting, combattimento’ (tutto un programma).
Inconaresì log. ‘essere di malumore, stizzirsi, affliggersi’; cfr. sp. enconarse ‘irritarse’; (Spano) inconadu ‘adirato, disgustato, sorpreso’. Base etimologica è l’akk. inḫum ‘hardship, trouble; sofferenze, guai’.
Puḍḍu (Missa de Puḍḍu, de Buḍḍu, de is Puḍḍas) in tutta la Sardegna è la ‘Messa di Natale’, celebrata la sera del 24 dicembre in ora tale che il momento della nascita di Gesù corrisponda con la mezzanotte.
Wagner è convinto che tale Messa abbia a che fare con i polli, e cita a rinforzo la corrispettiva misa del gallo spagnola. Ma si sa che i polli (galli, galline) vanno a dormire al calar del sole, e si svegliano all’alba. Orari che non corrispondono a quello della Messa celebrata dai Cattolici. In questo contesto, sembra chiaro che gli Spagnoli si ritrovino il modo di dire moderno come traduzione paretimologica (e omologazione al semantema del lat. pullus) di un termine mediterraneo non più compreso. Così è per il sardo puḍḍu.
L’enigma del sardo puḍḍu inteso come ‘pollo’, e parimenti dello sp. gallo inteso come ‘pollo’, è svelato dall’etimologia, che ha base nell’akk. pūdu, būdu (un genere di festa). Il fatto che il sardo (e sardiano, oltreché mediterraneo) puḍḍu, buḍḍu abbia in origine significato, per antonomasia, una festa, la dice lunga sull’importanza di tale festa, la quale, cadendo al solstizio d’inverno e quindi al Capodanno solstiziale, doveva essere la più importante dell’anno. Infatti tale festa dava avvio ai riti della morte e resurrezione del Dio della Natura, rito che poi dalla nuova religione fu incanalato nel Carnevale. La tradizione cristiana del Natale, sovrapponendosi alla tradizione pagana, non riuscì ad estinguere il termine mediterraneo, che ancora sopravvive in Sardegna.
Tamagnu (Nuoro, Osidda, Goceano) ‘statura, grandezza naturale’ = sp. tamaño. Nel log. sett. occorre come f. temagna ‘qualità, proporzione, dimensione’: Sun totos duos dessa matessi temagna ‘sono della stessa misura’; ladros dessa matessi temagna ‘della stessa specie’ (Casu). Base etimologica il sum. tam ‘to trust, believe; dar fiducia, credito’ + aĝ ‘to measure’. Il composto tam-aĝ (pronuncia: tamagn) significa da sempre ‘misura fiduciaria, standard, ufficiale’. Non varebbe la pena osservare che Wagner opera una doppia operazione subliminale: 1. la prima è di accreditare ex silentio l’origine spagnola della parola sarda anziché assentire sull’origine mediterranea; 2. la seconda è di non proporre l’etimologia, accreditando tale obbligo come superfluo.
Valentía log. e camp. ‘prodezza’. Wagner ha registrato questo vocabolo, prendendolo da due scrittori sardi, ma lo ha corrotto ad libitum soltanto per poterlo accreditare come derivazione da sp. valentía ‘echo o azaña heróica’. In realtà, la voce sarda autentica è balentía, per il cui etimo vai a balente.
Zira log. sett. ‘striscia’ (di tela, di carta, di terreno): Casu = sp. jira ‘tira de tela o jirón’. Base etimologica il sum. zir ‘to break, tear out; rompere, strappare’: esempio tipico della stretta parentela sardo-iberica fin dal Paleolitico.
La pregiudiziale iberica. Nel paragrafo precedente abbiamo riconosciuto che Sardegna ed Iberia condividono fin dal Paleolitico parecchie migliaia di vocaboli, ancora vivi nelle rispettive parlate. Si spiegano anche per questa via i rapporti sempre esistiti tra il popolo catalano e quello sardo, come c’insegna la storia dei giudici d’Arborea e la stessa vita di Eleonora d’Arborea. Ma la visione dei filologi romanzi è diversa: essi pretendono che le voci iberiche in Sardegna siano state importate, cancellando le precedenti voci sarde (…ammesso che ne esistessero…). Questa visione è palesemente miope, ascientifica, indimostrabile. Lo scopriremo discutendo qualche lemma.
Cannutígliu log., canotίgliu camp. è la ‘canutiglia, filo d’argento o d’oro per ricamo’. Wagner sostiene che il termine deriva da sp. cannutillo, cañutillo ‘hilo de oro o plata rizado para bordar’. In realtà, base etimologica è l’akk. ḫanû (proveniente da Hana, città della Mezzaluna Fertile celebre per le stoffe di pregio) + tillu ‘bardatura, bordatura, segno esteriore, applicazione a stoffe cerimoniali’. Quindi ḫanû-tillu in origine indicò la ‘bordatura proveniente da Hana’. Se dovessimo immaginare che le pregiate stoffe di Hana, celeberrime in tutto il Mediterraneo, arrivassero in Iberia by-passando la Sardegna, dovremmo accettare che la Sardegna fu tagliata fuori da ogni commercio, in andata e in ritorno. E ciò non è vero.
Carignátula (cariñátula) ‘tignola, tarma’ (Spano); anche caragnada; voce gallurese; cfr. còrso caragnattu, caragnáttulu ‘specie di ragno’, caragnattula ‘scolopendra’. Per Wagner l’origine è iberica. Invero, la base etimologica è l’akk. kâru ‘to rub’ ‘sfregare’ + naʼdu ‘attento, riverente’: il composto si riferisce all’attento “sfregare”, ‘rosicchiare’ del tarlo.
Immurzare log., ismurzáre centr., immurgiáre centr., smurzái camp. ‘far colazione’, ‘far siesta per mangiare’; immurzu ‘merenda’, sass. immùzzu. Secondo Wagner, che s’accoda al Corominas, dovrebbe essere una forma iberica recente, del XIX secolo, vedi sp. almorzar, cat. esmorzar. Wagner avrebbe dovuto farci capire perché gli Spagnoli, che in Sardegna cessarono la propria dominazione tre secoli fa, abbiano inventato un termine così tardo, lasciandolo poi in eredità ai Sardi dopo aver cessato il dominio, che peraltro negli ultimi secoli fu oltremodo indiretto, poiché i possidenti e feudatari spagnoli amministravano con missive dalla Spagna (o comunque dalle città sarde, non dalle campagne) attraverso i propri fattori. Ancora più arduo è pensare che il termine sia stato lasciato in Sardegna dai Catalani, che governarono l’isola soltanto nel 1300-1400.
È strano che Wagner non si sia accorto che il termine è pansardo, ed è molto utilizzato in ogni paese della Sardegna (non nelle città). Viene usato non tanto per indicare la ‘colazione’ (concetto ignoto ai sardi), ma per indicare una “rottura” dell’attività giornaliera al fine di ricaricarsi d’energia. Semanticamente equivale all’ingl. breakfast ‘rottura del digiuno’, ed indica in particolare il pasto della siesta meridiana. Debbo quindi ammettere che il termine sia molto antico. Infatti è sardiano, con base nell’akk. emṣum ‘affamato’ > *em(u)ṣum (anaptissi eufonica) > immùzzu (forma sassarese). Da qui le numerose varianti di immuzzu, comprese quelle con la classica epentesi di -r- dovuta a una legge fonetica sarda, e comprese le semplificazioni tipo murzu.
Disvelare log. ‘vigilare’; cfr. sp.-cat. desvelar; sost. disvélu, desvélu log. ‘sveglia’ = sp. desvelo. Wagner presenta la dipendenza della voce sarda da quella iberica, ma la verità è diversa, e lo dimostra ad esempio il camp. billái ‘vegliare, custodire, far la guardia’: billai su mortu; billai bona parte de sa notti studiendu (Porru). Bil-lai, privo del prefisso dis-, mostra chiaramente il radicale del verbo dis-vel-are ed acclara la sua origine dall’akk. bêlu ‘detenere (qualcuno), dominare, governare; to rule, take possession of’. In questo caso si evidenzia l’esatta funzione del pref. dis-, che non è privativo ma confermativo. Quindi disvelare significò anzitutto ‘vegliare, dominare, governare con determinazione’.
Irrobbare log., sdorrobái camp. ‘derubare’. Da rifiutare l’origine del verbo da sp. robar ‘idem’, proposta dal Wagner il quale propende per quell’origine anche quando l’evidenza è contraria. Tale voce è denominale da sd. robba ‘gregge, peculio, ‘bestiame’, ‘tutto ciò che uno possiede’. Wagner sostiene che robba derivi dall’it. roba (notisi la contraddizione, visto che prima indica l’origine iberica di irrobbare ‘portar via la robba’). A sua volta DELI registra roba come ‘ciò che di materiale si possiede o che serve in genere alle necessità del vivere’, derivandolo dal francone rauba ‘armatura’, ‘veste’: ma anche qui si cade in errore. Si vede che il termine si è espanso in Europa, ma nessun ha messo in evidenza la base etimologica, che è l’akk. rubbû ‘portato a piena crescita’, ‘incrementare, migliorare’, ‘avere interessi su’. Cfr. ingl. robbery ‘beni acquisiti con la grassazione’, to rob ‘derubare’, robber ‘ladro’; it. rubare.
Madéra-Linna. In camp. sa madèra o marèa (term. de maistu de barcas) funti ‘pezzus de linnámini de barca fattus a guidu po sustegnu de is taulus’ (Porru), = sp. madera ‘legno’. Questo è uno fra mille esempi che Wagner propone, relativo a voci che invece agonizzano o sono morte in Sardegna dopo l’epoca del colonialismo. Il termine largamente più usato in Sardegna non è certo madéra ma linna; ma anche linna per Wagner è coloniale, dal latino, mentre ha la base akk. liginnu (un tipo di tavoletta).
Magalléri camp.; mragalléri (Muravera) ‘giovane dell’anguilla latirostro e del grongo’ (Marcialis). Possibile base etimologica è l’akk. magallum (a big boat, una grossa barca). Se l’intuizione è giusta, qui assistiamo ad un processo in cui dalla barca da pesca si addivenne a nominare un tipo di pesce. Wagner dichiara la sua impressione che la voce sia catalana, “ma che non si trova nei dizionari”. A tanto giunge la pregiudiziale iberica in quello studioso.
Pansíri, pantzíri camp. ‘appassire’; mela pantzída ‘mela aggrinzita’ = cat. pansir-se ‘dessecar per l’acció del sol, per la calor excessiva’. Indubbiamente la voce sarda ha subìto l’influsso fonetico catalano, ma la voce è anche italiana: appassìre ‘idem’, dall’antico participiale passo ‘appassito’ (di erbe, frutta, per mancanza di umore). Base etimologica è l’akk. pa’ṣum, pāṣu ‘disbanded, off-duty; fuori servizio’ (truppa e altro), ‘crushed, broken up; schiacciato, rotto’. Questa è uno dei tanti lemmi da me elaborati nel Dizionario Etimologico senza citare il testo del Wagner (per non appesantire la narrazione), il quale traccia la vita di questa voce traendo gli esempi catalani (parecchi esempi) e quindi inducendo subliminalmente il lettore a credere alle origini catalane o spagnole.
Patranga (Bonorva) ‘finteria’, ‘fatto, cosa inventata’ = sp. patraña ‘mentira o noticia fabulosa’. Possibile base etimologica l’akk. patḫu ‘holed, bucato’ of discarded shoes, di scarpe abbandonate. Ma è più congruo l’akk. paṭārum ‘to loosen, release; allentare, rilassare’, paṭru ‘released’ + anḫu ‘tired, dilapidated; sfinito, dilapidato’ (in composto paṭr-anḫu). Wagner, disdegnando l’analisi etimologica, s’assicura in primis di ricondurre tutto all’iberico, lasciando però la sua proposta senza spiegazioni.
Pedríscia log. sett. ‘soglia, limitare’; pedríscia dessu balcone ‘davanzale della finestra’ (Casu); pedrissa, predissa log.; pedritza (Sennori); pidrissa sass. ‘sedile di pietra addossato al muro, da cui si monta a cavallo’. Per l’etimo vai a préḍḍa, pedra.
Wagner, oltre a considerare la base pedr- di origine greco-latina anziché, più correttamente, di origine mediterraneo-semitica, considera anche il suff. -íscia come non-sardo. E insiste: «probm. dal cat. pedrissa ‘massa de pedra’; pedrís ‘lloc abundant de pedres’; ‘seti de pedra’, ‘banc de pedra al peu de la porta, al pati, etc. per a seure’». Se escludiamo la foglia di fico espressa con “probm.”, da lui (e da altri imitatori) largamente usata per non apparire partigiano, egli non riesce a nascondere il suo filo-catalanismo, e non sa dove altro parare con la sua erudizione “di galleggiamento”. Invero, -íssa, -íscia è formazione tematica molto usata in Sardegna ad indicare un’attività o professione al femminile: crabarìssa ‘caprara’, abbatissa ‘abbatessa’, priorissa ‘prioressa’ e così via. La sua origine sta nell’ass. issu ‘woman, wife’, ebr. iššāʼ ‘donna’ ( אִׅשָּׁה ), bab. iššī ‘ella, she’. In Sardegna la pietra lineare della soglia e del davanzale, nonché il sedile spartano posto a lato della soglia, ricevettero suffisso femminile per il rispetto dovuto alla donna, Poiché la soglia, il davanzale, il sedile laterale alla soglia delle case antiche erano funzionali esclusivamente alle donne, anche perché erano anzitutto esse ad aver bisogno della predella per montare a cavallo. Stessero le case in mezzo alla foresta (come in Gallura) o nella viuzza paesana, questi tre “posatoi” erano destinati alle donne: per parlare a lungo sulla soglia con la vicina, per stare alla finestra in attesa dell’anima-gemella, per sedersi accanto all’uscio a filare, a cardare, fare cestini, salare i pomodori, e tanto altro.
Pendòni m. camp. ‘persona spregevole’; cfr. sp. spendón ‘persona despreciable’. Per l’etimo non si può recepire “pèndere” (come invece pretende Wagner), perché non si riesce a spiegare che cosa c’entri la semantica del “pendere” con la semantica della “spregevolezza”. Wagner, al solito, si soddisfa nell’abbinare due vocaboli foneticamente simili, senza indagarne la comune semantica. Egli fa ciò sempre e comunque, ma si sente particolarmente soddisfatto quando con l’abbinamento di due voci egli crede di “dimostrare” l’origine della lingua sarda da quella iberica. È invece congruo indicare la base etimologica di pendòni nell’akk. pēndu, pēmtum ‘charcoal, carbone’ (da cui anche pendû ‘mole, birthmark on face; neo, macchia scura sul volto’). In tal caso si assume pendòni come aggettivale in -òni, e si può agevolmente identificare questo pendòni come un antico ‘carbonaio’, il quale era sempre annerito per causa di lavoro. Di qui la metafora riferita a un ‘uomo spregevole’.
Poále, puále (Bitti, Posada, Dorgali, Orosei, Macomer, S. Lussurgiu); upuále log. ‘secchio di latta o di zinco per mungere’ = cat. poal ‘galleda’. Wagner rifiuta la proposta del Gröber che upuále fosse derivazione (aggettivale) da sd. úpu < cúppu. A maggior ragione rifiuta l’etimo simile proposto da REW 2409: lat. cuppa ‘coppa’. Fa tutto ciò per inchiodarsi all’origine catalana, quasi a testimoniare estremisticamente che in Catalogna fosse nata la lingua poi trasmessa alla Sardegna. E non s’accorge che la stessa voce catalana partecipa della Koiné Mediterranea < akk. kūbu ‘a drinking vessel’, che diede l’aggettivale *kūbu-ale > (ku)buale > upuale.
Recádu log. e camp. ‘notizia, ambasciata, saluto, ossequio’ = sp. recado. Base etimologica è l’akk. rēqu ‘far, distant; lontano, distante’ + âdu to take notice of’. Il composto rēq-âdu in origine significò ‘ricevere notizie da lontano’. Etimologia lineare per la quale non si può insistere sullo spagnolismo a senso unico proposto dal Wagner, quando è evidente l’origine comune.
Recuíre log. ‘raccogliere’. Cfr. sp. recudir ‘volver una cosa a su sitio’. La voce sarda pertinente al ‘raccogliere’ è gollίre, collίre, goḍḍίre, ingolli. Invece il riferimento spagnolo citato dal Wagner si attaglia soltanto al sd. recuίre ‘ritornare’. Qua, come si vede, Wagner ha raggiunto l’acme dell’assurdo, prendendo una voce spagnola, ritagliandole sopra una voce sarda inesistente, e dando a questa, forzatamente, il significato spagnolo.
Sabanitta (Macomer); banitta log. e camp. (Cuglieri, Busachi, S. Lussurgiu, Milis, Perdas, Escalaplano); sa baίnta (Usellus); ballitta (Fonni) ‘materasso’. Nel CSMB 32 banita è più che altro una ‘coltre’. In origine fu banitta, essendo sa- un articolo concresciuto. A sua volta banitta ha base etimologica nell’akk. banû ‘to become good, look after s.o. kindly; divenire buono, prendersi cura delicatamente di qualcuno’. Va da sé che il concetto originario fu quello del CSMB, e la voce è autenticamente sardiana. Rinvio al DES II 373 per capire l’arte sopraffina del Wagner nel menare il can per l’aia e discutere del sesso degli angeli. Inoltre il suo tentativo di accreditare queste due voci al mondo iberico è ad un tempo patetico e losco: egli infatti opera con argomenti insieme scoperti e subliminali per fissare l’origine del vocabolo nell’Iberia, nonostante ch’esso sia ufficialmente datato al 1242.
Saètta log. e camp. ‘freccia’; anche ‘fulmine’ (log. sett.). Cfr. it. saetta < lat. sagitta ‘freccia’. Wagner pretende senza ragione che la voce sarda sia da sp. saeta, quando è evidente che la voce nacque in ambito tirrenico.
Sumbréri log., sass., camp. ‘cappello’; gall. simbréri (Azara) = sp. sombrero ‘che fa ombra’. Ovviamente Wagner indica la parola sarda come accatto da quella spagnola. Ma ciò contrasta con l’arcaicità del lemma, che fu mediterraneo da parecchi millenni, poiché la base etimologica è il sum. šun ‘sole’ + bur ‘garment, clothing’. Quindi in origine šun-bur (di cui sumbréri e aggettivale di funzione in -éri) significò ‘indumento (copricapo) per il sole’.
Il Corominas volle sancire d’autorità che lo sp. sombra è «alteraciόn del lat. ŭmbra, id., conservado en las lenguas hermanas, y en el deriv. umbrίa, 1739; umbrίo, 1513. La s-, agregada sόlo en portugués y castellano, es probable que se deba al influjo de sol y sus derivados, por ser sol y sombra, solano y sombrίo, solear y sombrear, conceptos correlativos, opuestos y acoplados costantemente. La variante solombra, corriente desde antiguo, h. 1250, en los dialectos leoneses, judeoespañoles, portugueses y occitanos, comprueba la certeza de esta explicatiόn». Nel ragionare del Corominas osserviamo il vertice cui può giungere la perspicacia dei filologi romanzi, la quale, impiccata alla credenza che tutto abbia origine nel latino, si appaga nell’osservare i vari concetti correlati, senza però un sia pur minimo colpo d’ala che gli faccia cogliere le radici profonde dei processi che portarono al misterioso s-, da loro percepito puerilmente quale parente oramai consumato del… s-ole.
Nel capoverso iniziale ho indicato quali sono le vere radici dello sp. sombra ‘ombra’ (< sum. šunbur); mentre il lat. ŭmbra, sd. umbra ‘ombra’ ha diversa etimologia. Semerano (OCE II 599) propone ŭmbra dal sum. umbara ‘riparo, difesa’. Il Pennsylvania Sumerian Dictionary dà però umbara ‘aid, help; aiuto’, per quanto il campo semantico sia lo stesso. In ogni modo, è molto più congrua la base akk. ūmu ‘daytime’ + burûm ‘riparo, copertura, tetto’, dove il composto ūm-burûm in origine significò il ‘riparo dalla luce’.
Traggèra, traggèa, treggèa camp. ‘anici in camicia’ ossia minuscole palline zuccherate che imperlinano la superficie dei dolci. Cfr. it. antiq. treggea ‘idem’, ‘confettura’. La sopravvivenza di questa parola tirrenica è oltremodo indicativa, poiché ha la stessa formazione che ritroviamo in trággiu (vedi sotto): insomma, la traggèra fin dalle sue origini fu una leziosità, un impreziosimento visivo, e non poté mancare di essere abbinata all’idea della cortigianeria, del lusso di corte.
Trággiu (Bosa) ‘coro’. Soltanto a Bosa è così definito «il locale assetto di quattro voci maschili, dislocate secondo nomenclature analoghe a quelle delle altre tradizioni polivocali sarde: bassu, contra, tenore, contraltu»3. Su trággiu è insomma un quartetto, nel quale un tenore intona e canta con un certo ritmo ed una certa melodia, gli altri tre cantano le riprese e fanno l’accompagnamento.
Per Wagner trággiu, trazzu è la ‘foggia, moda di vestire’, secondo lui dal cat. trajo, sp. traje ‘vestito’; denominale attraggiare; log. aer bellu trággiu ‘attillarsi, avere buone maniere’. Quindi trággiu è il modo di ‘presentarsi’ cantando con buone ‘maniere’.
Trággiu-trajo-traje hanno un loro significato profondo, con base etimologica nell’akk. tīru(m) ‘un cortigiano’ + awûm ‘parlare’, ‘riflettere’ su qualcosa, ‘(parole) che sono in uso, che sono in alta considerazione, che sono studiate (per la loro preziosità)’. Abbiamo quindi uno stato-costrutto che produce il composto sardiano *t(i)r-awum > t(i)rággiu, significante ‘cortigiano che recita parole preziose’. In questo caso il riferimento è al tenore del quartetto di Bosa, ma s’estende agli altri significati di trággiu in quanto ‘stile personale dei poeti-cantori’ nelle sfide amebee. Questa etimologia crea un importantissimo squarcio di vita sociale e civile di 4-5000 anni addietro. Sappiamo quanto fosse ricca la letteratura semitica del secondo Millennio prima dell’Era volgare. Quella è la stessa letteratura che ha generato i poemi di Ugarit, i Salmi della Bibbia ed anche l’ineffabile poesia dei Vangeli. Sembra chiaro che a quei tempi un cantante capace di recitare e ritmare in melodia preziose parole poetiche veniva elevato ipso facto al rango di cortigiano (vedi l’esempio di Torquato Tasso, di Baldassar Castiglione, di Ludovico Ariosto, di Ovidio, di Virgilio e di tanti altri poeti del passato, elevati al rango di cortigiani per il talento poetico). È sbalorditivo che dopo 4000 anni il significato di certi termini non sia nient’affatto corrotto. Il log. aer bellu trággiu ‘attillarsi, avere buone maniere’ richiama proprio la figura del cortigiano, che delle buone maniere fece uno stile di vita.
Trettu log. e camp. ‘tratto, spazio, intervallo’; in cuḍḍu trettu (Laconi) ‘in quel luogo’; a trettu ‘a portata, vicino’; (Nuoro, Dorgali) ‘falciata, andana’. Cfr. cat. tret ‘distancia de lloc o de temps’. Manco a dirlo, Wagner lo accredita subliminalmente come vocabolo catalano («Il Salvioni… lo riconobbe come vocabolo catalano, ma opina che si è incontrato con l’ital. tratto, ciò che non è necessario»); e ciò gli basta non solo per omettere l’indagine etimologica, ma per additare l’opzione scartata (l’it. tratto) come ultimo (indiscutibile) approdo d’improbe fatiche culturali. Base etimologica di trettu è invero l’akk. ṭēru ‘terra, territorio’ + ettum, ittum ‘sign, signpost, road marker; indicazione, segnavia, miliario’. Il composto ṭēr-ettum significò in origine ‘tratto di territorio misurato’.
Turráu camp. ‘essere malato’; turráu in conca ‘malato di mente’. Base nel sum. tur ‘ essere malato’, ‘malattia’.
Vissentu Porru, che pubblicò il Dizionariu Sardu Italianu nel 1832, lo considerò tout court un termine catalano, un participio significante anzitutto ‘riarso, seccato, fatto adusto’; caffè turrau ‘caffè abbrostito, tostato’; méndula turrada ‘mandorle tostate’; pani turráu ‘pane arrostito, abbronzato’. Anche l’infinito turrái ebbe ovviamente la stessa origine catalana, lingua alla quale quasi tutto lo scibile sardo doveva origine e dignità, secondo loro. Erano tempi, quelli, in cui già si capiva, illuministicamente, che la lingua sarda doveva essere salvata in un Dizionario, epperò la convinzione “derivazionale”, “coloniale”, tra gli studiosi era monolitica: la matrice della lingua sarda, oltreché nel latino e nell’italiano, per gli studiosi stava esclusivamente nel catalano e nello spagnolo, ossia tra le lingue degli Stati che avevano colonizzato l’isola: la lingua sarda era insomma un’accozzaglia di vocaboli che forse, senza quegli apporti, non sarebbe esistita. Così la pensò pure Wagner, che precisò l’origine del termine sardo nel cat.-sp. turrar, torrar ‘torrefare, abbrustolire’. Anche su turróni ‘il torrone’ ebbe, beninteso, la stessa origine, e DELI viene pomposamente a ribadirlo, da turrar ‘torrefare’ (nonostante che la confezione del torrone stia agli antipodi della torrefazione). La pigrizia mentale fa tutt’uno con l’ignoranza, sua fedele ancella.
In realtà turráu nel senso di ‘malato’, turráu nel senso di ‘torrefatto’, e turròni ‘dolce di miele e mandorle’ hanno tre diverse origini. La prima è stata già vista. Il concetto della torrefazione, dell’abbrustolire, del riarso, bruciato, caldissimo, ha base nel sum. tur ‘ridursi, diventar piccolo’, akk. tūru(m) ‘ritirata, tornare indietro’, poiché l’effetto della temperatura caldissima è di seccare senza incendiare.
Circa il torrone, la semantica di questo friabile, croccante e squisito dolce di miele, mandorle (o noci) e albumi d’uovo va riferita esclusivamente al fatto che per la sua confezione occorre (occorreva) rimestare per almeno 4 ore il prodotto, riportandolo a una pasta dura e filante. Dall’interminabile rimescolare col bastone viene la sua semantica, dall’akk. turru ‘turned, rigirato’, tūru(m) ‘il rigirare’ + sum. unu ‘cibo, pasto’: il composto tūr-runu significò ‘cibo rigirato’.
Unità dei dialetti sardi col dialetto sassarese. La lingua sarda è complessa. Ma più complessa è la fatica di far ragionare su di essa gli specialisti. Ognuno ama rinserrarsi nel proprio particulare, vagheggia sui fumi di teorie mai discusse, accetta fideisticamente le datate “sentenze” dei dotti, e non s’accorge che la lingua sarda è veramente singolare. Purtroppo, è il percepire certi vocaboli come assolutamente peculiari alla propria zona di nascita a rendere partigiano il ricercatore sardo (ahimé, non soltanto lui!). Sì. Perché non è facile padroneggiare 100.000 vocaboli, e non è facile ammettere che tale massa va alleggerita scompartendola tra le varie subregioni. Il che non significa che ogni sub-regione debba curarsi soltanto dei propri vocaboli. Spessissimo molti vocaboli sardi sono identici tra le singole subregioni, ma si distinguono uno ad uno per peculiarità fonetiche. Va da sé che l’esorbitante numero di 100.000 si riduce d’un colpo se unifichiamo a grappolo tutte le voci sotto dei “capifila”, sotto lemmi capaci di raccostare e spiegare le diversità (come spesso faccio io in questo Dizionario, e come seppe fare magistralmente Wagner il quale, nonostante i tanti errori nel tentare di accorparli, riuscì a ricondurre i suoi 20.000 vocaboli entro 7000 lemmi).
La Sardegna ha un retaggio vetusto, parla la sua lingua da decine di millenni, e le sue radici lessicali s’intersecano tra zona e zona pervadendo tutte le aree linguistiche. Chi ignora l’esistenza di una vera e propria rete ignora la complessa unità della lingua sarda. Il concetto della rete è adeguato. E se la rete viene lacerata in un solo punto, ciò basta a far scappare i tonni. La rete è unica, la lingua è unica. Per capire la lingua occorre tenere integra la rete. Altrimenti sfugge un’intera fenomenologia.
La leggerezza culturale (direi la fanciullezza del neofita) che ha portato molti dotti a lacerare questa rete ha creato grossi danni, ivi compreso il danno sul dialetto sassarese. Da almeno 100 anni c’è la “conventiō ad excludendum” del dialetto sassarese, semplicemente perché nessuno degli esperti lo ha voluto studiare contestualmente a tutti gli altri dialetti sardi. Questa cappa di piombo pesa, beninteso, principalmente a causa della sorda opposizione del Wagner, il quale non ammise mai il dialetto sassarese nel novero delle parlate sarde. Ecco l’aristotelismo; ecco l’Ipse dixit! Ma pesò anche la ricerca di Antonio Sanna ai tempi del Wagner, intitolata “Il dialetto di Sassari”. Un ricerca che rinfrancò Wagner e lo stesso Sanna (ch’era nativo dell’Île de France logudorese: Bonorva).
Perché non dirlo?: quelli erano tempi da “Premio città di Ozieri”, i tempi della rivista “S’ischìglia” di Angelo Dettori, tempi in cui la cattedra di linguistica sarda era affidata a un logudorese, allorché le gare poetiche s’esprimevano spesso in logudorese e gli stessi premi di Ozieri toccavano a scrittori logudoresi. Non erano pochi i dotti che giuravano sulla sardità genuina del dialetto logudorese, mentre al campidanese toccava l’onta d’essersi macchiato con le lingue d’Oltre-Tirreno.
Ecco la pretesa purezza, l’ideologia che ha accecato coorti di studiosi, inducendoli a creare scale di valori, ad inventare lo spettro cromatico ai cui limiti la luce svanisce in frequenze non percepibili. Laddove pare che un dialetto sardo si squagli in altri universi linguistici, ecco gli studiosi a dichiararne la liminarità e per ciò stesso l’esclusione dai canoni portanti della sardità originaria. Nemmeno l’insularità della Sardegna è mai riuscita a fare accettare l’insularità della sua lingua, ed ancora oggi dei baldi scouts vanno alla scoperta dell’Arca, di un dialetto più originario del dialetto contiguo, che mai troveranno, almeno sinché i loro canoni ideologici inseguiranno un’idea sortita cervelloticamente, anziché parametrare materialmente una realtà che da decenni aspetta d’essere conosciuta.
In questa mia premessa metodologica ho abbondantemente mostrato (e dimostrerò ulteriormente) gli errori di metodo in cui tali studiosi sono incappati. Ammesso e non concesso che sia possibile parlare di una schiettezza sarda nel senso di una originalità genuina riferita a una precisa zona linguistica, andrebbe poi spiegato di che si tratti, e perché mai si voglia individuare quella zona. Sinora nessuno lo ha fatto, o per meglio dire: ci hanno tentato, senza riuscire. Ma è singolare che, sotto-traccia, il tarlo della schiettezza sarda, della individualità sarda, abbia lavorato e stia ancora lavorando, divorando i migliori cervelli delle nostre Università.
Sulla lingua sarda ognuno è andato liberamente per suo conto, come un “ragazzo sul delfino”, affrancato e sognante in una galoppante e selvaggia indisciplina che nemmeno Wagner ha saputo raffrenare, nonostante il suo ideologico scalimetro che dà la pagella del superiore e dell’inferiore, nonostante che Wagner abbia prodotto una Fonetica Storica del Sardo giudicata la “pietra di paragone” per qualsiasi studio linguistico.
Lo studio di Antonio Sanna non fu di per sé la “pietra dello scandalo”. Tale studio andava fatto, e ringrazio il Sanna per i suoi meriti. Ma al solito i danni sono creati dagli epigoni. Si accampa lo studio del Sanna come un Moloch abbagliante e totalitario, e lo si accetta come un “nec-plus-ultra”, Colonne d’Ercole invalicabili, termine degli spazi consentiti allo studio del dialetto sassarese. È nella contemplazione di quel Moloch che accettiamo (quasi come una tesi che ci affranca da ogni responsabilità) l’incatenazione del dialetto sassarese a quello gallurese → alla lingua còrsa → alla lingua italiana (al toscano, al genovese), creando la centrifuga che proietta Sassari oltre la stratosfera e lo fa atterrare in suolo lunare.
Ma Antonio Sanna voleva fare soltanto uno studio storico, dimostrando il peso dei còrso-galluresi nel ripopolare Sassari a seguito delle due Grandi Pesti. Siamo noi ad aver visto in lui le “Colonne d’Ercole” ed esserci sinora privati della possibilità di tesaurizzare positivamente lo sforzo del Sanna, nel più vasto ambito di una ricerca, sempre possibile, che conduca a capire esattamente il ruolo del dialetto sassarese nella storia linguistica della Sardegna.
È stato proprio lo studio analitico del D.E.S., da me condotto sino all’ultimo lemma, ad aver accertato che il dialetto sassarese condivide con i restanti dialetti sardi quasi il 90% dei vocaboli (salvo una parte della sua fonetica, la quale è condivisa però dall’Alto Logudoro, della cui arcaica sardità ho abbondantemente discusso nella mia Grammatica Storica, al cap. 3.1.10).
In questa Premessa manca lo spazio adeguato a discutere esaustivamente sulla sardità del dialetto di Sassari. Più spazio gli è riservato nel mio Dizionario Etimologico del Dialetto Sassarese, in via di completamento. Qui mi basta anticipare che il dialetto di Sassari condivide con Cagliari più vocaboli (e persino più fonetica) che con la restante Sardegna. Questa sentenza non va vista come némesis da me scatenata contro i detrattori dell’unità linguistica isolana; è però un aspetto che da solo è in grado di fare esplodere tutte le pregresse certezze. E qui chiudo, proponendo soltanto qualche lemma che dimostra l’unità dei Sardi.
Abbastu camp. ‘sufficienza’; di abbastu ‘a sufficienza’; sass. abbáłtu ‘idem’. Vedi sp. abasto, cat. abast; it. abbastanza, bastare ‘essere sufficiente’, che DELI ritiene di etimologia sconosciuta. Invero la base è l’akk. bâštu ‘dignità, sorgente d’orgoglio’; bašû ‘to become ripe, diventare maturo; be available, in safekeeping, essere disponibile; materializzare un profitto’.
Abbauca’, abbacca’ sass. ‘stordire, sbalordire, intontire’: è tuttu abbaucaḍḍu da li midizini ‘è intontito dalle medicine’. Per i tanti lemmi che ne sono coinvolti, rinvio la discussione al quart’ultimo paragrafo (“La dittatura dell’incompetenza”).
Abbundare, -ái log. e camp. ‘abbondare’; anche log. bundare: bundat sa vida in noa giuventura; sass. abbunda’. Wagner considera abbundáre e abbundíri (vedi) come italianismo o spagnolismo, evidentemente collegati al lat. abundantia ‘straripamento, flusso eccessivo’, abundo ‘straripare, traboccare, sovrabbondare’. Vi sono due opzioni: la prima delle quali porta al lat. ab-unda, richiamante il concetto dell’onda che straripa (ab- + unda); la seconda opzione è il sum. bun ‘spingere’ + du ‘to heap up, pile up, accumulare’, onde bun-du col significato sintetico di ‘ammassare’: ciò andrebbe bene al sardo bundáre.
Abbundíri camp. ‘cibo che aumenta di volume in cottura’; log. bundìre. Per l’etimo vai ad abbundáre.
Accabussái, cabussái camp. ‘tuffare, tuffarsi’; cfr. cat. accabussar ‘id.’. Il significato iniziale fu ‘entrare di testa come punta di freccia’, da sd. cabu ‘testa’, sass. ‘idem’. (v. lat. caput ‘id.’). L’origine dei lemmi sardo e latino è l’akk. kāpu, kappu, kāpum ‘roccia, riva, cliff, embankment (of river, of mountain)’. Il secondo membro del lemma cab-utza’ ha base nell’akk. ūṣum, uṣsu ‘punta di freccia’.
Accattái(sì) camp. ‘accorgersi’. Cfr. sass. agattassi ‘idem’. Base etimologica è l’akk. qatû ‘be completed, be achieved, essere completato, essere acquisito’. Vedi log. agattáre, sass. agatta’ ‘trovare’.
Acciappinái camp., ciappináre log. Per l’etimo vai a sass. ciappínu.
Ciappínu sass. ‘incompetente, schiappa, poco capace’; sass. acciaputza’, log. acciaputzáre, inciaputzáre, camp. acciaputzái ‘acciarpare, abborracciare’. Base etimologica di questi lemmi mediterranei è l’akk. ḫapû, ḫepû ‘to break’ (vessel etc.), ‘to ruin destroy’ (city, land, people), ‘to crack, crush, injure’ (part of body).
Accióu camp. ‘chiodo’, sass. ciódu.
Aggaffare log.; aggatta’ sass.; -ái camp. ‘afferrare, acchiappare’; cfr. cat. agafar ‘coger, asir, apañar’, anche accaffiáre log., accaffái, aganfái camp. Base etimologica è l’akk. kappum ‘mano’.
Aláscia camp. ‘mobile’. Wagner lo deriva dallo sp. ant. alhaja ‘mueble, utensilio’. In log. aláscios ‘attrezzi, suppellettili, strumenti di lavoro’. Ma occorre confrontare questi lemmi col log. e camp. calásciu ‘cassetto’ (di un canterano, di un contenitore di biancheria), che è il prototipo, almeno per la Sardegna. A quanto pare, siamo dinanzi a varie forme lessicali con vari esiti fonetici e varie semantiche; ciò reca ragioni valide per vedere i vari lemmi come crescite autonome, ognuna nel proprio territorio, nell’ambito della lingua sarda. In ogni modo la base etimologica di log. calásciu, sass. carásciu è il sum. ḫal ‘basket, pot’, kallu ‘bowl’ + aš ‘bread’; quindi il composto ḫal-aš in origine significò ‘cesta del pane’.
Alloriái camp. ‘turbare l’altrui mente con grida o atti che intronano il cervello in modo che si perde il sentimento e il discorso’. Per Wagner è una formazione espressiva (sic), al pari di log. alloroscáre ‘abbaiare rabbiosamente; gridare con ira’ (vedi).
Ma il termine non è espressivo, è invece la base genetica del log. allorigáre, in formazioni del tipo mi fazzi vinì la lòriga sass. ‘mi sta logorando i nervi’, arrigga’ a la lòriga ‘ridurre all’estremo della sopportazione’.
Lòriga nel senso di ‘estremo della sopportazione’ ha base etimologica diversa dall’altra lòriga (anello); i due lemmi si sono assimilati per paronomasia soltanto nel medioevo. Per capire lòriga ‘estremo della sopportazione’ occorre porre mente allo stato fisico prodotto negli astanti da una persona assillante, o lamentosa, o pedantissima, che siamo costretti a sopportare a lungo. Il nostro eccesso di tolleranza nei suoi confronti viene – per ragioni di educazione – somatizzato, ma opera lo svuotamento delle energie positive; ci si sente infine compressi, o emunti, privi di forze, incapaci di sentire le vibrazioni positive della nostra anima, la quale a questo punto è spenta, violata. Questo è il momento della fuga, o della rimozione della persona che produce tanta negatività; ma può essere il momento di un’esplosione di rabbia e di urla (o di violenza) contro il pedante. Mi fazzi vinì la lòriga ‘mi porta all’estremo della sopportazione’ sembra avere base etimologica nel sum. lu ‘to stir up, risvegliare, fomentare, provocare’ + ri ‘to cry, cry out, wail, complain; urlare, gemere, lamentarsi’. Il composto lu-ri (di cui il log. lóriga è aggettivo in -ca) in origine significò ‘provocare gemiti, urla’.
Ammaccionaisì camp. ‘rannicchiarsi, ripiegarsi su se stesso, seduto o coricato’. Secondo Spano anche ammasonaisì. Wagner non riesce a quagliare l’etimo. Questo è un verbo legato all’estasi, alle sensazioni estreme in fase oracolare’, da akk. maḫum ‘to rave, delirare; dipartirsi (da se stesso)’; maḫḫû ‘esaltato’, da cui sd. maccu ‘matto, scemo, pazzo’.
Aúndi camp. merid. ‘dove’. Il prototipo è il sass. undì (vedi). Wagner osserva: «nel gall. e nel sass. abbiamo úndi (sic, al posto di undì) ‘dove’; ma questo úndi non può essere identico al camp. aúndi, già per la discontinuità geografica (sic!). Esso invece si continua nel còrso, specm. còrso mer., onde (cfr. soprattutto Lichtenhahn, l.c., p. 79, seg.). A torto, sedotta dalla fallace omonimia delle forme gall. e camp. mer., l’Autrice le considera come geneticamente identiche». Il lettore scoprirà in questo pezzo del Wagner un autentico pasticcio, dove emergono due situazioni false. La prima (undì ≠ úndi) è stata qui svelata. La seconda falsità è da lui stesso evidenziata nel considerare il dialetto sassarese una bastardaggine italianeggiante, anziché uno dei tanti dialetti sardi, il cui fondo arcaico ancora oggi mostra migliaia di identità con la parlata cagliaritana.
Guruséle nome della celebre fonte di Sassari, oggi detta Rosello o Ruseḍḍu. Un tempo stava fuori delle mura cittadine, alla base della parete calcarea alta 25 metri. Guru- ha i confronti etimologici con l’ebr. יְרוּ* (*iěru) ‘insediamento’ < sum. iri ‘città’. -Sèle = Šalimu (dio semitico della salute) < akk. šâlu ‘rallegrarsi, godere di qualcosa’, ‘star bene’, salāmu ‘essere in pace’ (ebr. šālom ‘pace, salve!, arabo salām ‘pace’). Cfr. Bruncu Salámu (un monte di Dolianova, dove sgorgano acque ritenute curative); e vedi il monte Guruséle, il più alto dei Supramonte di Baunei, dove si diparte il primo ruscelletto che va a formare il fiume sacro chiamato Ilune. Cfr. comunque l’akk. šalû ‘sommerso’ (> “battesimi”), salā’u ‘spruzzare’ acqua’ (nei rituali di purificazione).
Guru-séle > Ru-séllu = Jerušalaim significò ‘città di Šalam’. La Sardegna è intrisa di nomi che ritroviamo anche nella civiltà ebraica.
Ille, illu, illa ecc. esisteva come pronome indipendente dopo preposizione in sardo antico (CSP 203: Et ego tenninde corona cun ille; 227: Et ego kertainde cun ille; 45: et kertai cun illu; 33: ca non bi abean bias in illos; CSNT 133: sos ci certaban cun illu. Le forme atone sono (i)lu, (i)la ecc. e per il dativo (i)li, (i)lis (CSP 29: et issos derunilos appare, e ccoiuuainusilos; 3: Judicarunili ad issos a destimonius; 31: naraitili iudike; CSNT 49, 50: aprezarunmilas; 74: indulserunmilu; 171: issos kertarunlis, ecc.). Frequentemente occorrono forme in funzione enclitica (CSP 98: et giraitsemi supra’lla; 33: sinde kertat alikis pro ‘llos; CSNT 145: certabat pro’lla; CSMB 149: kertait cu ‘llu; 168: et ego binki de’ llu, ecc.). Nel camp. ant. abbiamo le stesse forme (CV XI, 2: illi illas firmu ego; III, 1; IV, 1 ecc.: ki mi ‘llu castigit; VI, 4: ca ‘lla dau, ecc.); in sede postverbale pare si preferisca ell- (VIII, 4; XVI, 4: dedi ellu; XIX, 3: dau ella, ecc.).
Nel sardo moderno queste forme toniche si usano molto poco cedendo il posto a isse, issu; come forme atone abbiamo in camp. ḍḍu, ḍḍa, ḍḍus, ḍḍas, ḍḍi, ḍḍis; in log. lu, la, los, las, li, lis (queste ultime anche nei condaghes).
Tra le forme logudoresi qua citate, va notato che lu log. e sass. è anche art. det. = ‘il’. Attualmente, il sum. lu in quanto articolo determinativo mediterraneo, sopravvive proprio nel dialetto sassarese-gallurese: es. lu cani, lu pani, la prància ‘il cane, il pane, il ferro da stiro’. Sopravvive anche nell’Italia del sud: es. lu pisci-spada ‘il pesce-spada’. Altri esempi sardi del sum. lu si trovano attualmente nei suffissi cristallizzati dei cognomi sardi in -lu, nei quali confluisce pure il pronome dimostrativo sum. ul. Cfr. il cgn Buttόlu composto dal sum. bu ‘perfetto’ + tu ‘formula magica’ + lu ‘persona’, ‘colui che, colei che’: bu-tu-lu, col significato originario di ‘chi è addetto alle formule magiche’. Da tutto quanto si è detto, si capisce che le forme sd. ille, illu, illa hanno subìto l’influsso del lat. ille, illa, che si è sovrapposto alle forme sumeriche in lu originariamente usate in tutta la Sardegna.
Spaperrottái, spapparottái camp. ‘fueḍḍai meda e sentza neçessidadi’ (Porru), ‘ciarlare, cianciare’. Casu registra ispabarrottare ‘gridare, vociare’. E già l’apporto del Casu dimostra l’unità lessicale tra Cagliari e Alto Logudoro. Wagner le considera voci onomatopeiche, non aiutando così a legare i fili. In realtà, la base etimologica di spapperrottái è la stessa che vale per i ‘rondoni’ (chiamati a Sassari babbarrotti), dal sum. par ‘canale’ (raddoppiato in senso superlativo) + ud ‘bird’: quindi pa-par-rud significò, già 40.000 anni fa, ‘uccello dei canali’ (infatti questo animale si nutre esclusivamente d’insetti, di zanzare, e per questo frequenta i siti umidi dove gl’insetti abbondano). Questo traslato riferito a chi ciarla continuamente è dovuto al fatto che le rondini, i rondoni, quando cacciano a stormo strillano senza sosta, volando a bocca aperta e creando un chiasso festoso. Con ciò ho dimostrato un triangolo lessicale inossidabile tra Cagliari, Sassari, Alto Logudoro.
Tukké sass. ‘sorta di benda che fascia o abbellisce il capo delle donne’. Base etimologica è il sum. tuku ‘acquisto, tessuto, stoffa’. Si capisce che il tukké un tempo fu un oggetto di cosmesi, per i momenti della festa. Vedi anche sum. tuku ‘to acquire, acquistare’ (nei tempi arcaici le cose acquistate costituivano dei veri e propri beni di un qualche pregio); anche tuku ‘to beat, strike of cloth, to weave’ (e qui siamo nel campo semantico della fabbricazione delle stoffe).
Wagner preferisce registrare in altro modo: a dukè ‘a punta, dicesi del modo come le donne si abbigliano il velo in testa’ (Spano). Egli non scrive altro, suggerendo ex silentio che dukè sia un modo, non una cosa, e lasciando subliminalmente intendere che la forma sassarese sia un accatto francesizzante, ignorando del tutto la sua origine arcaica, sardiana.
Forte parentela tra logudorese e campidanese. Oltre ai brevi accenni del paragrafo testè concluso, sono i pochi esempi seguenti a mostrare, a maggior ragione, la strettissima affinità del dialetto logudorese col dialetto campidanese, la quale si esprime in decine di migliaia di voci.
Abbojare, abbojare (Mores) ‘incontrare’. Lungi dall’etimo di attoppare (vedi), questa voce ha base etimologica nel sum. bu’i ‘to face, incontrarsi, mettersi a confronto’.
Abbóju log. e camp. ‘appuntamento’. Per l’etimo vai ad abbojare.
Abborréssere log., abborréssiri camp. ‘aborrire, avere in odio’; sass. abburrissi’ ‘svergognarsi, coprirsi di vergogna, screditarsi’. Per l’etimo vai ad abburrésciu.
Abburrésciu camp. ‘ubriaco fradicio’; burràcciu ‘ubriacone’, burraccera ‘ubriachezza’. Wagner lo fa derivare dallo sp. borracho ‘ubriaco’. Invero i lemmi sardo e spagnolo sono forme metatetiche dall’akk. buḫḫuru ‘cuocere, riscaldare’, ‘tener caldo’; buḫru ‘stato di cottura’. Non a caso in Sardegna cottura equivale semanticamente a sbornia. A dire il vero, le semantiche convergono dall’origine, poiché anche il log. cóttu ‘ubriaco’ ha origini accadiche, da akk. quttû ‘completato’ (ossia riempito, messo KO dal vino). Sembra di capire che mentre la forma abburrésciu ha attecchito soltanto nel sud dell’isola, cóttu ha attecchito nel nord. Abburrésciu s’incrocia, pure semanticamente, col log. sett. abburrare, abburrigare(si) ‘immergersi nel fango o nell’acqua’, ‘infangarsi’, che Wagner ritiene dallo sp. barro ‘fango’: ed è possibile. Ma intanto c’è il confronto con l’akk. barruru ‘con occhi luccicanti’ con riferimento anche alla persona ubriaca. In ogni modo la vera base etimologica è l’akk. burrû ‘prostituto, prostituto sacro’ (tutto un programma).
Alleputzíu, alleputzáu camp. ‘ben vestito’, ma anche ‘ringalluzzito’, ‘allegro’; forse i tre campi semantici in origine furono idealmente più contigui, poiché nei tempi arcaici il ben vestire era tipico delle grandi feste, quindi dell’allegria. La base semantica si riferisce al composto akk. allu ‘puro, chiaro’ + pūṣu ‘bianchezza, candore’: stato costrutto alli-pūṣu, col significato di ‘candore immacolato’. Da respingere la proposta del Wagner di ricondurre queste voci a lèppore ‘lepre’.
Questo part. pass. ha il referente in alleputzare log., alleputzái camp. ‘attillarsi, vestirsi elegantemente, vestirsi con cura, abbigliarsi’.
Attobiái camp. ‘incontrare’. La base etimologica è diversa da quella di attoppare (vedi): attobiái contiene una labializzazione intervenuta per legge fonetica campidanese sul sum. tul ‘well, pozzo’. Nelle età primitive il pozzo era l’unico punto d’incontro certo e diuturno della comunità. Cfr. log. attόliu ‘convegno, appuntamento’; attoliare ‘chiamare, unirsi’ (Fonni): Spano.
La lingua arcaica fu compresa spesso sino al Rinascimento. Può sembrare una boutade, ma sono astretto ad ammettere che la lingua arcaica in Sardegna fu compresa sino a tempi recenti. Con essa, cinque secoli fa, si confezionarono ancora parole nella consapevolezza che si stavano utilizzando radicali primitivi, ancora compresi nella loro essenza e come tali ritenuti portatori di significato, capaci di entrare a buon diritto nella costruzione delle frasi. Anche qui gli esempi possono abbondare, ma limito l’intervento a pochi lemmi.
Allóḍḍu2 nome tabuistico della ‘volpe’. Base etimologica può essere il sum. ala ‘demon’, o alad ‘spirito’ + ud ‘storm demon’; in ogni modo, quel modo d’intendere la volpe transitò anche nell’akk. allû ‘that (one)’ + ūdu ‘distress, affliction’: all-ūdu significò ‘quello dei malanni’, quello che porta malattie, sventure’, etc. Chiaramente, il nome fu satanizzato in epoca bizantina, e questa è una delle tante prove che almeno nell’alto Medioevo in Sardegna si parlava ancora semitico, con una vasta base di vocaboli sumerici.
Cozzorottu (Orgòsolo) ‘tutolo, pannocchia del granturco’. La base etimologica è nel bab. kuṣṣuru(m) ‘zeppo di nodi’.
Mammòne (gatto). Come si è visto ai lemmi gattu e catzu, la figura del gatto subì un radicale capovolgimento tra l’epoca antica ed il Medioevo cristiano. Il gatto per gli Egizi era un dio (in virtù del fatto che liberava i granai dai topi e le piantagioni dai ratti). Nel Medioevo divenne, per influsso dei preti cristiani, una creatura posseduta da Satana. Sacchi pieni di gatti vivi venivano buttati nel fuoco per festeggiare il solstizio d’estate, pratica che continuò in Francia sino al secolo dei Lumi. Il Gatto Mammone, clericale invenzione del Medievo, è un gatto dalle fattezze infernali, terrificanti. Non poteva essere altrimenti, considerata l’esigenza di capovolgere la splendida visione che del gatto avevano gli antichi. La base etimologica è il sum. ma ‘to burn’ + munu ‘scorching, rovente’: mam-munu ‘che brucia al calor bianco’ (un essere demoniaco, insomma). Si noti che questo è uno dei tanti lemmi creati esplicitamente in epoca medievale, in epoca bizantina, ed è testimone del fatto che ancora nei primi secoli cristiani in Sardegna si parlava semitico.
Mangrofa è il cognome di Maria Mangròfa, moglie di Antòni Cracassòni, il favoloso costruttore dei nurághes nominato in tante storielle facete del Nuorese. Mentre lui era un gigante buono, Mangròfa non era gigantessa ma orca, e si cibava di carne umana (Francesco Enna, SS, 98). La sua fine violenta ha varie tradizioni, compresa quella che fu bruciata dai genitori dei ragazzi che divorava. Scrive Dolores Turchi4 che la sua dimora fosse una grotta presso la chiesa di santa Lucia a Oroséi, ma la sua personalità è raccontata in modo diverso secondo i paesi o l’informatore: quindi può essere pure sacerdotessa-maga.
L’etimologia, sempre che il nome attuale non si discosti in modo significativo da quello antico (a noi ignoto), porta alla agglutinazione sum. ma-ḫurum-bu, col tempo aggiustato in maḫ(u)rumbu e metatesizzato in manḫrubu > mangrofa: da ma ‘bruciare, arrostire’ + ḫurum ‘bimbo’ + bu ‘cavità’ = ‘(colei che) ‘arrostisce i bimbi nella grotta’. Si noti che questo è uno dei tanti lemmi creati esplicitamente in epoca medievale, in epoca bizantina, ed è testimone del fatto che ancora nei primi secoli cristiani in Sardegna si parlava semitico.
Mardi. Nel meridione s’intende con mardi la femmina del porco, il cui etimo è universalmente proposto dal lat. mater. Ma è molto strano che un animale così vilipeso in tutta la storia della letteratura abbia tale etimo. Quando non si è trovato di peggio, al momento della gravidanza il suo ventre è stato adattato pure al concetto dell’esecrando cavallo che sconfisse la civiltà dei Troiani: e la scrofa diviene troia, appunto. In realtà mardi, col significato attuale, è nato in epoca bizantina, quando il clero cristiano si dedicava con pertinacia ad estirpare l’antica religione. E così l’akk. wardu (leggi mardu) ‘ministro addetto al culto della divinità’ è diventato nientemeno che una ‘troia’.
Mincidissu camp. ‘demonio’. Questo lemma ha parecchie variabili: log. mintsídiu ‘provocazione, alterco, macchinazione’, mintsidiáre ‘provocare, attaccar brighe, seminar zizzanie’; camp. mincídiu ‘bugia’, mincidiόsu ‘bugiardo’, smincìri ‘sbugiardare’.
Secondo Wagner queste forme hanno base nel’it. omicidio, passato attraverso forme di antico sassarese (Stat.Sass. III, 33 (92 r): tu de menthis). Ma la proposta del Wagner non ha nessun puntello, essendoci una fortissima differenza semantica tra la supposta base ed i supposti derivati. Le forme qui trattate hanno invece la base in una incredibile metamorfosi semantica voluta dai preti bizantini nel primo Medioevo, allorché la polemica antiebraica, per iniziativa dei Padri della Chiesa e dei primi concilii, era divenuta parossistica. La forma di partenza è proprio il sardo minca, mìncia ‘membro virile’ (vedi), che si compose con la forma akk. deššû ‘eccessivamente opulento, dotato’, dīšu ‘sviluppo (del virgulto, della verga)’, dešû(m) ‘essere copiosamente dotato’, dēšû(m) ‘abbondante, fiorente’.
Ai preti cristiani della Sardegna non bastò quindi dissacrare la Minchà (lett. ‘offerta’: la preghiera ebraica del pomeriggio, che s’apre col Salmo 84 e prosegue con un lungo passo tratto dai Numeri 28, 1-8 che parla dei sacrifici quotidiani), facendone addirittura un cazzo; non bastò: si volle identificare la Minchà pure col Diavolo, e con blasfema doppiezza (riferita a un tempo al cazzo ed al Diavolo) si volle presentare la minchà come l’Essere infernale “molto grosso”, “fiorente”, “eretto” (dešû, dīšu) proprio come un cazzo.
Monteleone Rocca Dòria. È l’altura che un tempo fu la più munita della Sardegna. Lassù la Potenza divina discendeva al naturale, senza l’ausilio del genius loci. Lassù c’era la sede naturale del Dio-Toro, del Dio-Fecondatore, ossia ci risiedeva la Potenza che generava il Mondo. Quella rocca ebbe poi il nome dai Dòria che se n’erano impadroniti. Ma in origine fu Monte Leone (e conservava pure l’alternante epiteto di Perda e Tòri, preferita dal Fara). La confusione è evidente.
Cominciamo da Tori, ancora conservato in numerosi cognomi, quale Turi, Toro, Tore, Torre, Dettori. Il Taurum ‘Toro’ per i primitivi Romani era l’emblema dei ‘giuramenti d’amore’. Ma noi sappiamo che il nostro Tori deriva dal sum. tūr, akk. tūru ‘rifugio, protezione’. Quindi Perda e Tori = ‘Rupe della Protezione (divina)’. Quanto a Monte Leone, abbiamo la base akk. līʼum ‘toro’. E così torniamo al Toro, ch’era l’effige vivente del Dio della Natura, il Fecondatore sacro. Tra Leone e Toro, una delle due parole è paradossale. È chiaro che quel “leone” in Sardegna non ha nulla a che fare: i Sardi nei tempi primitivi non conoscevano i leoni. Monte Leone si riferiva certamente a un Toro, al Toro Protettivo (che veniva nominato līʼum in accadico e tūr in sumerico). Da qui il doppio nome Monte Leòne nonché Perda de Tori.
Moriscu (figu moriscu) ‘ficodindia’. In Sardegna c’è un concorrere di linguisti, a loro volta influenzati dai botanici, che sostengono l’origine del termine dalla Spagna, dove l’Opuntia ficus-indica è chiamata higuera de moro (cat. figuera de moro): Wagner DES 128.
Si sostiene che gli Spagnoli chiamarono in tal modo il fico d’India “perché importato dagli Arabi”. Ma tale diceria osta clamorosamente col fatto che gli Spagnoli sono gli scopritori dell’America, gli stessi importatori dell’Opuntia ficus-indica, ch’era espansa in tutta l’America centrale con focus negli altipiani messicani. Come mai avrebbero dovuto chiamarla “fico degli Arabi”, “fico dei Mori”?
Quello della higuera de moro è il più grossolano equivoco della storia della linguistica. Certamente è da pensare che questo fu uno dei primi frutti gustati dagli equipaggi, visto che la scoperta dell’America avvenne il 12 ottobre, quando ai Tropici il fico d’India contiene il massimo della polposità e, specialmente nei luoghi d’origine, si presenta nel massimo vigore.
Va fatta attenzione alla differenza tra higuera de moro / figuera de moro e il sardo figu morìsca. Per quale ragione i Sardi, che a quei tempi erano una colonia catalano-aragonese, avrebbero dovuto tradurre diversamente dai loro dominatori, inserendo quello strano suffisso -ìsca, e per giunta credendo che il prodotto provenisse… dagli Arabi?
Ecco come la paronomasia (o l’equivoco che dir si voglia) ha agito indisturbata sino ad oggi.
È a questo punto che occorre mettere in ballo gli equipaggi di Colombo, gente avvezza all’uso della propria lingua mediterranea. Essi sono la chiave di volta che fa capire l’equivoco. Ma da soli non basterebbero, se non entrassimo nell’ordine d’idee che gli stessi Sardi, e gli Spagnoli, specialmente i Catalani, avevano lingue col sottofondo semitico. In realtà moriscu è aggettivo sardo, che non significa ‘moresco’ ma ha base nell’akk. mūru(m) ‘giovane animale; giovane toro’ + išku ‘testicolo’, col significato di ‘testicolo di torello’. Fu la forma del frutto a colpire i Sardi. A sua volta, higuera de moro significò, per gli Aragonesi, ‘fico del torello’ (sempre riferito ai testicoli).
Perdigònes, -is log. e camp. m. pl. ‘pallini da caccia’ = sp. perdigones ‘granos de plomo para la escopeta’. Ovviamente il prototipo è sd. perda ‘pietra’ (< akk. paṭāru ‘tagliare, fare a pezzi’, ebr. pāṭar ‘to split’, akk. piṭru ‘pezzo’) + akk. gunnu ‘mass, bulk; massa, volume’. Quindi perdi-gònes è uno stato costrutto, col classico -ī- intermedio, e significò in origine ‘massa di pietruzze’. Chiaramente, la voce composta è riferita ai primi archibugi di fine ‘400, allorché s’inserivano delle pietruzze (graniglia marina o fluviale), mancando spesso la disponibilità dei pallini di piombo. Ciò che stupisce in questa etimologia è che persino agli albori del Rinascimento il popolo riusciva a formare in lingua accadica parole nominanti tecnologia avanzata.
Sirimágus. Il Monte Sirimágus fu ritenuto l’abitazione del Diavolo. Vietato portarci le greggi, andare a far legna, avviare coltivazioni. Sta al centro di un triangolo tabuico nell’area collinare tra Carbònia, Tratalìas e Perdáxius. Soltanto le pendici del Monte fanno eccezione, grazie alle sorgenti. L’area è meglio nota come Sa skìna de s’Ifférru ‘la schiena dell’Inferno’. Si dice però (ecco il fatto illuminante) che fino a circa 400 anni fa il Monte fosse meta di pellegrinaggi cristiani: ai canonici che ci avevano eretto una chiesa si portavano cibi e doni. Qualcosa andò storto, e la zona divenne off-limits. Sino a poco tempo fa, le vecchie dicevano che chi si avventurava rischiava di venire schiacciato da massi rotolanti.
La memoria della gestione pretesca delle processioni riguarda, a quanto pare, la volontà della Chiesa cattolica di controllare certe processioni paganeggianti. Che poi tale controllo sia cessato con l’avanzare dell’Inquisizione e della Controriforma, fu soltanto perché si preferì rendere maledetto il sito. Queste notizie, estrapolate da pag. 39 de L’Unione Sarda del 16 luglio 2006 (articolo di Andrea Scano), aprono uno squarcio sui processi di dominio della Chiesa, operati sino ad epoche recenti, considerate le varie tendenze paganeggianti ancora presenti nelle tradizioni popolari.
Il mistero di quelle processioni pagane e della loro logica intrinseca può essere chiarito soltanto con l’indagine etimologica, mediante la quale si capisce che Sirimágus è un composto sardiano con base nell’akk. ṣīru(m) ‘esaltato, supremo, splendido’ di un dìo + maḫû(m) ‘delirare, diventare frenetici’. Si capisce allora che il Dìo venerato sul Monte era il dio della Natura, destinatario delle processioni bacchiche e orgiastiche mirate alla rigenerazione.
Sixiliánu camp.; gigiliánu (Perdas); xixiniáu (Mogoro); sitziliánu (Villacidro) ‘granturco’. Qualcuno lo riferisce al ‘(grano) di Sicilia’. Ma viene ostico tentare di giustificare tali passaggi commerciali per un grano proveniente dalle Indie. Siamo dinanzi a una paronomasia.
Anche qui, come per cíxiri ‘cece’ (vedi), il primo concetto fu quello di ‘grano tondeggiante’ (rispetto alla forma del grano mediterraneo). Ma pare che abbia influito anche il sum. ḫili ‘luxuriant, lussureggiante’, opportunamente raddoppiato (ḫil-hili-ánu) per riferirsi alla grande produttività di una pannocchia rispetto alla spiga del grano.
Il nome di questo moderno tipo di grano è una delle tante prove del fatto che ancora nell’arco del XVII secolo il popolo sardo utilizzava con naturalezza le radici della propria Urspache, che ancora comprendeva appieno quale eredità di un arcaico passato in cui la parola era analizzata a tutto tondo, nella sua forma e nel suo significato. Vedi anche l’altra forma trigu muriscu.
Wagner evita di produrre etimologie. Con riguardo al paragrafo precedente, sento che qualche linguista insorgerà invocando prudenza e ponderatezza. Queste virtù sarebbero i metri di un meritorio atteggiamento obiettivo, se fossero espresse da uno che le esercita nell’affrontare i problemi più scottanti. Ma, diciamolo serenamente, sono virtù spesso conclamate, che suonano sarcastiche quando s’invocano da chi sinora ha fatto esercizio d’immobilità senza dare alla linguistica sarda contributi solidi.
Non disconosco a certi filologi romanzi il prezioso impegno da loro profuso nella studio della lingua sarda, ed è proprio perché sono pronto a riconoscere apertamente i loro meriti che chiedo il corrispettivo del perdono quando la mia franchezza rischia di ferirli. Mi manca l’intenzione. Ferire non è mai stata la mia vocazione, anzi preferirei che le mie constatazioni fossero sempre accettate per amichevoli e concilianti, quando non soffuse d’entusiasmo. Infatti a me interessa unire, non profligare. Ma quà entra in campo la serietà scientifica, una severa maestra di disciplina che non posso celare dietro il velo della timidezza o dell’ipocrisia, a meno che non voglia dichiarare falsa la mia metodologia.
Occorre rivelare un fatto sconcertante, che è persino difficile da fare accettare, ed è che Wagner ha sempre evitato d’impegnarsi nelle etimologie. Parimenti accade a molti linguisti che avrebbero dovuto esserne gli eredi. Detta così, anche quest’affermazione sembra una clamorosa boutade espressa per suscitare nuovo sconcerto e discordie. Ma io, essendo uno studioso della lingua sarda, mi sento fortemente coinvolto nella ricerca della verità, e pertanto sono obbligato a proporre un metodo che rimetta saldamente in piedi ogni tipo di studio sulla lingua. Il DES, capolavoro riconosciuto del genio wagneriano, non individua nemmeno una etimologia. Ho cominciato a spiegarlo nei paragrafi precedenti, sto per spiegarlo in questo paragrafo, proseguirò in quelli seguenti. Se il lettore leggerà coscenziosamente, capirà la verità della mia proposizione. Vediamo all’uopo (tra le migliaia) qualche lemma trattato dal Wagner.
Gammurra camp. antiq. ‘specie di panno: gamurra’ (Porru) = it. antiq. gam(m)urra ‘veste antica di donna, gonnella’. Base etimologica è l’akk. ḫammû (a garment, un vestito) + ūru ‘city’ < sum. Il composto ḫamm-ūru significò ‘vestito da città’ (ossia vestito di buona fattura). Wagner (cfr. voce nel DES) non ha prodotto alcun etimo.
Gana log. e camp. ‘voglia, desiderio, appetito’ = sp. gana; mala gana ‘svogliatezza’. Base etimologica è il sum. gana ‘shackles, ceppi, impedimenti’. Evidentemente il concetto di ‘voglia’ si è evoluto da un significato arcaico che privilegiava l’atto del trattenere, inceppare. Questo vocabolo è un chiaro testimonio di come le idee abbiano acquisito il senso astratto partendo da un fatto concreto. Wagner propone surrettiziamente l’origine spagnola del vocabolo sardo ma non produce alcun etimo, dispensandoci dall’esigenza d’indagare almeno il vocabolo spagnolo. Invero, gana è voce mediterranea.
Grori, groli (Bitti) ‘avannotto di trota’. Base etimologica è il sum. giru ‘fish, pesce’ (da cui it. gir-ino ‘piccolo pesce’) + uri ‘fish, pesce’. Il composto pleonastico (duplicazione semantica) gir-uri in origine ebbe significato moltiplicativo, e nel contempo diminutivo. Wagner considera il vocabolo “probm. preromano”: un’ipotesi gettata così, con nonchalance, tanto per chiudere il discorso senza indagine.
A sa muda log. ‘zitto, in silenzio’; sd. mudu ‘muto’; cfr. lat. mūtus ‘che non ha le capacità fisiche di parlare’. La voce latina fu usata dapprima per gli animali (mutae pecudes), interpretate dal DELI nel senso che «non sanno fare altro che mu». Interpretazione assurda, ovviamente, poiché il mu è solamente tipico del bove. A nessuno venne in mente che anche i saggi preferiscono star zitti. Infatti il sd. istare assa muda significò sin dalle origini ‘stare come il saggio’, da akk. mūdu ‘saggio, sapiente, esperto’.
Pèsame, -i log. e camp.; pèsamu log. ‘condoglianza’; donai su pèsame camp. ‘condolersi’ = sp. pésame, dar el pésame. Cfr. sic. pèsami, pèsamu ‘idem’ (Traina); nap. ant. pésame ‘idem’. Base etimologica è il sum. peš ‘to disappear, scomparire’ + ama’era ‘mourner, parente del defunto’ (composto da ama ‘mother’ + er ‘mourning, essere in lutto’). Wagner tace, soddisfatto nella convinzione che il vocabolo sardo derivi dalla Spagna. Ma il vocabolo è mediterraneo.
Tricca (Nuoro, Fonni); triga (Norbello, Aritzo); trija log. ‘pergola e uva galletta’ (Stat. Sass. I, 128 (42v): pastinare tricla et simiçante uva); trigarzu, trijarzu ‘pergolato’. Base etimologica è l’akk. tīru (a covering) + suffisso mediterraneo -ca. Wagner sull’etimo tace.
Gli equivoci e le paronomasie. O tace, o cade nell’equivoco. Ed anche quando s’accorge dell’equivoco, Wagner purtroppo non lo risolve scientificamente (rinvio, come esempio, alla voce kenábura, già trattata).
Le lingue sono zeppe di equivoci, e la Sardegna non è immune. Essi sortiscono spesso nell’intimo di una singola lingua (o dialetto), ed ovviamente tendono a moltiplicarsi nel confronto tra lingue o dialetti. Così avviene in Sardegna, dove il sintagma camp. Toccamì ainnantis ‘cammina davanti a me’, in log. può essere inteso come ‘tòccami davanti, nelle parti anteriori del corpo’.
In Italia ha preso vigore da molto tempo il sintagma “fare repulisti” nel senso di ‘fare pulizia’ (reale o morale). Evidentemente l’espressione fu inventata da qualche giullare o studente medievale ed il volgo, ignorando il latino, non poteva sapere che quel buontempone aveva stravolto semanticamente il perfetto lat. repulisti ‘respingesti’ (vedi il salmo 44 (43),10: Nunc autem reppulisti et confudisti nos ‘ma ora ci hai respinti e coperti di vergogna’).
Wagner nelle sue opere non trascurò di annotare qualche equivoco, ad esempio citò l’uso del vocabolo centro-merid. suppa ‘niente’: Kirco e non b’agatto suppa; Non ni budìa fai suppa. Egli, più divertito che scientificamente coinvolto, nel DES riproduce la seguente situazione: «rientra nell’inventario dell’italiano maccheronico la frase, riferita al figlio: Non ne posso fare zuppa: è morto bicchierino = ‘non posso cavarne nulla: è molto birichino’». Wagner non s’accorse che quella frase maccheronica sguazzava nella paronomasia. Egli dichiarò ignoto l’etimo del sd. suppa, mentr’esso ha base nell’ass. ṣuppu ‘decorato, rivestito, ricoperto, placcato’, šūpû ‘rendere splendente, visibile’, col significato riferito semanticamente al risultato dell’abbellimento di un corpo bruto, una trasformazione da oreficeria, una decorazione che migliora fortemente lo stato grezzo.
La paronomasia è una legge linguistica, come tale subita passivamente dal parlante; salvo nei casi di umorismo, dove un comico produce la risata attivando l’opposizione dei significati tramite lo slittamento, il doppio senso, la polisemia, l’equivoco tra due identiche formule fonetiche (v. cap. 1.3 della mia Grammatica Storica).
La paronomasia (quindi la conseguente paretimologia) scaturisce ad esempio dal log. janna a bòi ‘porta con i battenti accostati per bloccare e filtrare la luce’, intesa dal Wagner come ‘porta a bue’, mentre la base etimologica è l’akk. apu ‘foro, apertura’; abû, apû ‘velato’ < abû, apû ‘diventare velato, nuvoloso’.
Altro esempio di paronomasia è il camp. arròsa ‘morbillo’, che i ricercatori derivano dal nome di fiore rosa, mentre la base è l’akk. rūšum ‘rossore’.
Altro esempio sono le locuzioni andare esse per essi ‘andare girovagando senza meta’; a pili esse ‘coi capelli scomposti’; craba corressa ‘capra con le corna reciprocamente sghembe’; asse’ tuttu a esse ‘essere smidollato, sbilanciato, sciancato’ (Sassari); barrócciu a esse ‘carro sgangherato’ (Sassari); occi a esse ‘con gli occhi storti’ (Sassari). Wagner, incappando nella paronomasia, ritiene che essi, esse sia un termine video-fono-semantico, dalla lettera S. Invece la base è l’akk. ešeum, ešû(m), ašu, išû ‘confuso, aggrovigliato, arruffato’ di filo, capelli, barba, mente, occhi.
Nella paronomasia s’incappa spesso indagando i toponimi, è ovvio. Ad esempio Pedru surdu, interpretato come ‘Pietro il sordo’, è il nome di un’alta sella rocciosa e selvaggia, improduttiva, vicina alla vetta del Gennargentu, sepolta per quattro mesi dalla neve, dove i pastori s’astennero dal salire, lasciandola alla vocazione selvaggia, a dimora dei mufloni e delle aquile, che sono i veri signori della montagna. Il nome ha base nell’akk. pitru(m) ‘territorio selvaggio’ + surdû ‘falco’ = ‘selvaggio sito di falchi’.
Purtroppo debbo constatare che ai filologi non è bastato impaniarsi nella paronomasia; alcuni sono andati oltre, giungendo a distruggere qualche parola sarda. Lo scempio è stato persino facile, quando il filologo era un ignaro straniero; ma l’effetto non è stato diverso quando alla distruzione hanno contribuito dei filologi sardi. La filologia esercitata sulla lingua parlata non s’addice a dei lavoratori-a-tavolino, a gente che non ha mai vissuto col popolo, nei villaggi, e non ha mai ascoltato l’intenso palpito del linguaggio. Lo scempio è avvenuto come in una commedia degli equivoci, illuminata da un “ipse dixit”, da un moloch di provenienza oltremarina, dinanzi al quale non solo il popolo ma persino i “dotti” paesani, i “dotti” cittadini, per quanto indigeni, hanno flesso la schiena in nome dell’autorità. E così nei dizionari sardi non si trova tadannu! ma ita-dannu!, interpretato ‘quale danno!’. Io, che sono glottologo, che vivo nel popolo e col popolo campidanese da 54 anni, non ho mai sentito ita-dannu ma soltanto tadannu! Quei linguisti, quei dotti, non avrebbero mai osato violentare la lingua sarda, se avessero saputo che l’invocazione di paura Tadannu! non è altro che l’invocazione akk. dandannu ‘Dio Onnipotente!’.
Nello scempio delle parole sarde ritrovo anche l’eponimo Sardus Pater. In questo caso la responsabilità maggiore va agli archeologi. Per la verità Giovanni Ugas (Shardana e Sardegna) ha cominciato a raddrizzare la questione, parlando autorevolmente di un dio eponimo. Però dico che non gli sarebbe stato eccessivo andare oltre invocando una sensata etimologia a supporto di questa intuizione. La dedica Sardus Pater Babay fu gestita dai Romani senza sapere ch’era sumerica. L’architetto di Antas non riusciva a comprendere il significato sardiano, che oggi può tornare finalmente in auge partendo dal sardiano Babay, che ancora nel sd. attuale si pronuncia babbáy, babbu ‘babbo, padre, Padreterno’, con tutte le conseguenze del caso. Va osservato che Babay o Baba fu una grande divinità femminile sumerica, da babaya ‘old man’ (il vocabolo era originariamente maschile, e tale rimase in Sardegna; soltanto dopo, e soltanto in Mesopotamia, esso fu proposto al femminile per la trasposizione al femminile del culto di Baba). E così in suolo sardo ancora una volta sveliamo le radici arcaiche della lingua sumerica. In Sardegna in origine questi vocaboli dovevano essere composti nella sequenza Šar Dū Padr Babay, col significato di ‘Terribile Signore Creatore dell’Universo’ (Šar ‘totalità, mondo’ + dū ‘Creatore’ + Padr ‘distruttore’ + Babay ‘Signore, Kýrios’).
Lo stesso epiteto, evidentemente corrotto dall’intervento del clero bizantino, ritroviamo nel Monte Santu Padre, una montagna visibile da mezza isola, il cui nome desta immediato sospetto perché in Sardegna dovrebbe dirsi Monte Babbu Santu (padre non esiste). L’epiteto è una paronomasia: in origine doveva essere Monte Sardu Padr. La dedica corrotta del tempio di Antas, il nome corrotto di questa montagna, sono prove concorrenti a dimostrare che Sardu è l’arcaico Dio eponimo dei Sardi. Insomma, questa figura sacra era lo Jupiter sardo.
Ma torniamo a suppa, che fece ridere Wagner. Non so s’egli abbia riso anche nel voler tradurre pilu e titta ‘mastite’ come ‘pelo nella mammella’. Non c’è nessuno che abbia inteso diversamente questo malanno, nemmeno il medico che affrontò scientificamente questo sintagma, S.A. Zonchello (v. Bibliografia). Nessuno potè accorgersi che la base stava nell’akk. pīlu, pēlu ‘calcare, pietra calcarea, blocco di calcare’ + ‘nutrimento, cibo’ (tîtum): pertanto pilu e titta, da almeno 5000 anni, significa ‘pietra della mammella’.
Adesso ci tocca sostare su log. pazza, ‘idea presumida ki unu tenet de iss’etotu, comente canḍo si daet bàntidos kentza méritu’ (Puddu); palla camp.; páglia sass. Questo vocabolo è stato compreso da Wagner come ‘bugia’, ma non è così. Esso si applica ai presuntuosi che si esibiscono, si sovraespongono, fanno spacconate, millantano: pazzósu, pallósu, paggiósu, palléri. Sarebbe una contraddictio in terminis assumere a base di questa voce proprio la paglia, una sostanza umilissima. Va da sé che ci troviamo dinanzi a una paronomasia, e di palla, pazza si sono ignorate le origini. Base etimologica è il sum. pala ‘a royal garment, un vestito da re’. La plurimillenaria parola rimane quindi viva per indicare chi vuole assumere vesti regali anche quando è un pollo da batteria. In collegamento c’è il log. ispazzare ‘millantarsi’; cfr. nap. paliúsǝ ‘vanitoso’; pagghiuse ‘fanfarone, millantatore’. È fuorviante che Wagner inglobi in questo lemma l’it. battere la paglia ‘vagare col discorso’, ted. leeres Stroh dreschen ‘batter la paglia senza ricavo, fare discorsi a vanvera’. Infatti il sintagma del Wagner è autodimostrativo: nel senso che non si ricava nulla dal battere la paglia, come non si ricava nulla dal battere l’acqua: sono follie di gente che ignora il valore del tempo e fa perdere tempo agli altri. Dobbiamo ammettere che i campi semantici del vanitoso e di colui che fa discorsi a vanvera sono radicalmente diversi.
Penultima voce da me proposta è pittiracca log. sett. ‘viottolo incastrato, incassato, ossia scavato nella roccia o nelle alluvioni’. Secondo Wagner, la voce «si spiegherebbe bene come pettúri + acca ‘petto di vacca’ (indicando un viottolo talmente stretto che ci passa solo il petto di una vacca)». Ma questa è una puerile contraddizione, non tiene conto che lo scavo delle strade (tali erano i viottoli nell’antichità) richiedeva grande impiego di braccia e perenne manutenzione; quindi nessuno si sarebbe sognato di realizzare vie così anguste e inutili. I viottoli furono sempre realizzati a misura del carro tirato da 2 buoi, larghi almeno 3-4 metri. Invero, la base etimologica è l’akk. petû(m) ‘aprire + raqqum ‘thin, fine; sottile’. Il composto significò ‘scavo angusto’, ma ciò non giustifica l’interpretazione del Wagner in relazione ai viottoli (evidentemente la definizione nacque per altri scopi). Tantomeno aiuta quando l’insigne studioso intende rafforzare la sua interpretazione con la locuzione sa janna est a unu bòe ‘la porta ha i battenti socchiusi’ (dov’egli intende bòe come bue, annotando che janna a bòi «si dice di una porta socchiusa, che lascia passare un solo bue» (sic!). Egli non si è reso conto che un solo bue nelle porte contadine non riusciva nemmeno a infilarsi, o le infilava danneggiandole, anche se spalancate. La base del sintagma a bòi è stata già spiegata.
Valverde. Ecco una delle più assurde paronomasie della Sardegna, talmente espansa e corruttiva, da avere infestato pressoché l’isola intera. È doloroso che nessun filologo se ne sia accorto. Cominciamo dalla dorgalese (Nostra Sennora de) Balu Irde o Palu Irde. Quel Valverde, tipico delle più antiche chiese campestri dove si adora una Madonna cristiana sconosciuta fuori dell’isola, non è altro che la paronomasia di Ba‛al Irdu (akk. Bēlu Irdu, Bēlu Išdu), epiteto sacro col significato di ‘Signore Base-del-Cielo’, ‘Ba‛al Base-del-Cielo’. Ba‛al è attestato in Sardegna e in tutto il Vicino Oriente: in arabo, ugaritico, fenicio, punico, aramaico, nabateo, palmireno, amorrita, babilonese, accadico. In ug. fa bʽl ‘signore, proprietario’, amorr. baʽlum, bab. ba’lu ‘grande, maggiore’, akk. bēlu ‘signore, proprietario’, e così via.
Questo dio, particolarmente onorato in Cartagine dal V sec. a.e.v. assieme alla compagna Tanit, fu onorato in Sardegna allo stesso modo. Onde il suo nome è sotteso a tutti i toponimi o nomi sacri echeggiati in Sardegna col nome Palu o simili. Furono talmente importanti le onoranze a Ba‛al, che la Sardegna ha lasciato in suo onore persino dei cognomi: anzitutto Palùma, Palùmu, Palomba (quest’ultimo storpiato e indirizzato alla semantica di ‘colomba’). La loro base etimologica è l’akk. palûm ‘bastone, phallos, palo sacro’ (riferito a Ba‛al “Fecondatore”) + ūmu ‘giorno’, significando ‘Giorno del Palo’, ‘Festa del Palo’. Ricordo ad es. Su Palu di Santu Lussùrzu, celebrato al colmo del Carnevale. Vedi anche i cognomi Pala, Palitta, Paliotta (gli ultimi due significano ‘Seguace di Ba‛al’), Palimoḍḍe (epiteto = ‘Saggezza di Ba‛al’). Vedi inoltre i vari toponimi rimasti in Sardegna: Balláo, Paláu, Baláy, Punta Palái, etc.
Onomatopee. Spero si sia capito che in questo lavoro non ho avuto mai intenzione di sminuire il prestigio universale che Wagner si è meritato nell’indagare con dedizione ineguagliata la lingua sarda. Prima di lui nessuno lo aveva fatto, mentre agli studiosi posteriori non venne alcun uzzolo di cimentarsi perché ai loro occhi il monumento eretto da Wagner era compiuto e perfetto, e sembrò sciocco smantellarlo per ricostruirlo su altre basi. Anche da me la statua del Wagner fu sempre considerata come perfetta. Ciò per 31 anni dopo la mia laurea in glottologia. Mi si perdonerà se da soli 15 anni sto tentando di delineare una nuova via d’interpretazione della linguistica sarda. Dal mio punto di vista, lungi dal voler dissacrare il pater noster, ogni mia osservazione rivolta al pater non è altro che un fraterno memento rivolto ad filios. Sono i ricercatori posteriori, quelli già morti e quelli viventi, a non aver capito che i tempi stavano maturando verso orizzonti più scientifici. Quanto ai ricercatori ancora viventi, vorrei comunicargli che il più grande omaggio che possiamo fare al grande Wagner è di rimetterci a studiarlo con la prospettiva di rinnovare almeno l’intonaco della sua grandiosa piramide.
Se è vero – come sto dimostrando per tutta questa premessa metodologica – che a Wagner difettava il metodo e, come corollario, ch’egli non trovò mai il modo di approfondire le etimologie, allora corre l’obbligo di perseverare nella dimostrazione affinché i posteri capiscano. In questo paragrafo mi soffermo sull’onomatopea, da Wagner pretesa per almeno il 20% dei suoi lemmi. Con tutta evidenza, egli propose un numero altissimo di onomatopee tanto per chiudere la discussione, trovandosi nell’impossibilità di proporre l’alternativa di un etimo credibile. Vediamo gli esempi.
Per Wagner è onomatopea il log. e camp. racca ‘rantolo del moribondo’, mentre la base etimologica è il sum. raḫ ‘disease’, ‘to beat, kill; battere, uccidere’. Altra pretesa onomatopea è tzoccare ‘battere’; tzoccu ‘scoppio’. Noto intanto l’affinità fono-semantica con l’it. ‘toccare (delle campane etc.)’. Su tzoccu o toccu (cfr. it. tocco) indica una gamma di suoni od azioni: il tocco della campana, il tocco o tatto. Base etimologica il sum. tuku ‘to beat, battere, dare un colpo’.
Affine a tzoccare è tzaccare, tzaccái log. e camp. ‘fendere, spaccare, scoppiare, crepitare, crepare’ e per estensione ‘screpolare’ e simili; tzaccadùra ‘fessura, scoppio, crepitio’ ma anche ‘ragade della cute o dei capezzoli’. Wagner, seguito dai ricercatori seriori (Zonchello e altri) ritiene che la voce sia rigorosamente onomatopeica. Invece ha base nell’ass.-bab. ṭaḫadu(m) ‘fiorire, sbocciare, divenir lussureggiante’, anche ‘scoppio, esplosione, rottura’; ‘spaccare, cedere’ (riferito specialmente al foruncolo)’.
La quintessenza della (falsa) onomatopea, contaminata dalla pregiudiziale latina, si percepisce nel sd. páperos (donnos páperos). Nel medioevo sono i ‘vassalli’ del giudice o i ‘membri della famiglia reale’ (e genericamente il ‘patrimonio della corona’). Una sola volta nei codici si legge pauperos, ed ecco affiorare la precoce confusione che già ne stava tarlando la semantica. Tale confusione entrò anche in un documento cagliaritano del 1119 (CDS I, p. 198b), che in latino scrive: servos de pauperum. Questa parola s’incontra solo in documenti del sec. XI o dei primi del XII (Bonazzi, ed. CSP, p. 156). I donnos paperos ricordati dal CSP 34 sono precisamente i monaci di S. Pietro (pag. 58 dell’estratto). Ma ecco il tarlo del diavolo!: Wagner non capì che in tutta questa situazione si era insinuata la confusione, ed imprudentemente scrisse una ovvietà, ossia che la voce pauperes indica in numerosi documenti i poveri ed i degenti (CDS, p. 226b, anno 1164): ad sustentationem pauperum; ibd p. 244a (sec. XII): sa eclethia paupera; p. 251a, 252b (anno 1182): ab alimentis istorum pauperum (Solmi, Cost., p. 47, n. 4).
Però Wagner percepiva che qualcosa non combaciava, quindi il termine páperu applicato ai ricchi del Giudicato continuò a sembrargli strano. A noi sembra persino più strano che un linguista della sua levatura si lasciasse intrappolare da una banalissima somiglianza di vocaboli: le somiglianze fonetiche sono normali in qualsiasi vocabolario. Egli non si scosse nemmeno al sapere dai giuristi delle materie medievali che a quei tempi tre classi sociali si contrapponevano ai ricchi (ai majorales): i servos, i liberos, i pauperos (ma non i paperos!). Egli si chiedeva disperato «In séguito a quali circostanze i liberos si identificarono con i pauperos?». Lo stesso equivoco-confusione persiste ancora oggi tra gli aggettivali pauperile e paberile (quest’ultimo interpretato oramai (e ci mancava!… dopo il tarlo del diavolo!) come “terreno proprio dei pauperes, da loro posseduto a titolo collettivo”: «Erano precisamente i terreni che si chiamavano anche terras de páperos» (Wagner). Assurdo. Queste confusioni inqualificabili gravano sugli studiosi contemporanei come un macigno, e nessuno si scuote nel constatare che in sardo moderno l’aggettivale paborile, paberile significa semplicemente ‘pascolo, maggese’, e che soltanto qualcuno (es. Guarnerio, Solmi) lo identifica col lat. pabŭlum (sbagliando però anch’essi).
Invero, su paberìle era la terra coltivabile di un villaggio: era il vidatzone messo a riposo annuale o biennale (maggese), e diventata prato domestico (che è diverso dal pardo naturale) a disposizione, in comunione gratuita, degli abitanti ad uso pascolivo. Si trattava di campi non riseminati, dove si poteva pasturare il bestiame controllato da speciali incaricati (i maiores de pradu o pradàrgios). Questi diritti reali pubblici assunti per consuetudine si chiamarono, in epoca iberica del Regno di Sardegna, ademprìvi, e furono aboliti in epoca sabauda con la legge sulle chiudende.
Quando si dice incantesimo… Tornando al pl. páperos, Wagner s’impuntò a tal punto sulla identità di sd. páperu con lat. pauper ‘povero’, che chiuse tre lunghissime pagine di disamina del problema con una dichiarazione ultra-salomonica, giungendo a squartare con una sciabolata il bimbo che Salomone aveva solo minacciato: «Come già fu detto, l’accezione giuridica di páperu si è perduta, ma nel senso ordinario di ‘povero’ la voce vive tuttora nel camp. rustico come pábaru, páburu. È diventata ormai rara, ma l’abbiamo notata a Cabras; e cinquant’anni fa, l’abbiamo sentita giornalmente da un povero cieco, nativo del Campidano di Oristano, il quale, sulle Scalette di Santa Chiara a Cagliari, mi soleva chiedere l’elemosina con la sua cantilena monotona, ma molto chiara: Po s’amòri de Déusu, sa garidari po unu báburu tsurpu». Questo è il livello infimo al quale non avremmo mai voluto che Wagner scendesse.
Al fine di rompere l’incantesimo di tale immarcescibile equivoco-confusione, dichiaro che l’aggettivale paberìle, poborìle, paborìle ha base etimologica nel sum. pa ‘fronda’ + be ‘tagliare’ + ri ‘camminare lungo (pascolare)’ + li ‘fronda, germoglio’: pa-be-ri-li. Il significato originario fu ‘pascolo per brucare i germogli’. Tutto qui. Gli armenti del villaggio avevano un anno di tempo per brucare i germogli di quei terreni, sortiti dai semi delle coltivazioni dell’anno precedente (grano, ortaggi). Quello del paberìli era dunque un pascolo speciale, molto diverso da quello del saltu, sartu (vedi), quest’ultimo composto di flora selvatica meno appetita dalle pecore: infatti a su sartu si mandavano soltanto capre, maiali, bovini, che si consolavano con le frasche della macchia e con le fronde degli alberi.
Quanto all’etimologia di (donnos) páperos, essa si basa sul sum. pap ‘primo e più importante’, ‘preminente’ + era ‘leader (dell’assemblea)’: pap-era. Il significato è ovvio: gli antichi “nobili” erano chiamati páperos né più né meno come i pennuti che avanzano sicuri, dondolanti, pettoruti e schiamazzanti. Anche Wagner l’avrebbe capito, se non si fosse incagliato sulla pregiudiziale latina. Mentre DELI e la stessa Treccani considerano papero, papera di origini onomatopeiche (sic!).
Voci imitative, formazioni scherzose. Indubbiamente, Wagner appare poco credibile nell’aver disseminato il suo DES d’inesistenti “onomatopee”, anche quando, cambiando il vocabolo, decise di nominare le presunte onomatopee come “voci imitative”, oppure come “formazioni scherzose”, o “formazioni infantili”. Si segua il grande groviglio di lemmi accorpati dal Wagner sotto il seguente vocabolo.
Accuccaresì log. accuccaisì camp., accuccassi sass. ‘accoccolarsi, accovacciarsi’; ‘appiattarsi, nascondersi’. Secondo Wagner queste sono voci fonosimboliche, e porta l’esempio dell’it. accoccolare, sic. ncuculari, sp. acucularse, astur. encucase. Wagner reca molti altri esempi, tentando una catalogazione che però diviene un guazzabuglio, dov’egli propende per considerare tutta la folla di questi lemmi sardo-italo-iberici come onomatopee (DES 49-50). Mi rincresce constatare che Wagner, qua e là, dà poca importanza alla legge della polisemia. Ora ne avremo un saggio.
Considerando il significato di accuccaresì come ‘appiattarsi, nascondersi’, la base etimologica è il sum. kukku ‘buio, tenebre’, ciò che consente l’azione della civetta (Athena noctua), in sd. detta cuccu, che s’aquatta nel buio e poi aggredisce repentinamente; vedi akk. ḫua ‘civetta’, da cui sd. a cùa ‘al modo della civetta, nascostamente’.
Considerando invece il significato di accuccaresì come ‘accoccolarsi, accovacciarsi’ (detto anche dei cani che si rannicchiano ai piedi del padrone o che si sottomettono al cane più forte), entra in campo l’akk. akû ‘weak, powerless, humble; debole, senza potere, umile’, ripetuta per potenziarla (akû-aku-), e si riferisce ai gesti rituali che gli antichi accattoni, o prigionieri, o bisognosi, facevano in atto di sottomissione chiedendo protezione.
Questo discorso relativo all’it. accoccolarsi è talmente serio e imponente, che corre l’obbligo di soffermarsi a dipanare il grande groviglio culturale creato dal suo uso. Infatti ci sono varie parole con fonetica simile che han fatto delirare (letteralmente: uscir dal solco) il fior fiore degli etimologisti.
E allora comincio dall’it. còccola, il ‘frutto del ginepro’. DELI ne registra la prima apparizione nel sec. XIV: la voce avrebbe l’etimo nel lat. cŏccu(m) ‘nocciolo dei frutti’. Ma ciò è assurdo, ed è in compagnia con altri etimi assurdi apparecchiati per gli altri lemmi affini, quali coccolàre, cocco (uovo di gallina), còccolo (bambino paffuto, bambino prediletto), il cognome sardo Coccolòne, e così via. In questo guazzabuglio occorre mettere ordine, poiché ogni termine ha una precisa e distinta etimologia, radicalmente diversa da quelle proposte.
Iniziando da còccola, il lemma non ha affatto l’etimo su citato, anche perché la còccola non è un nòcciolo, ossia non ha un guscio duro come quello della noce, ma è uno dei tanti frutti morbidi. Questo frutto viene usato moltissimo dagli uccellatori in Sardegna (si può immaginare che nei tempi andati fosse d’uso comune nel Mediterraneo) per attirare e catturare al laccio gli uccelli da passo. Còccola ha base etimologica nel sum. ḫu ‘bird’ + kul ‘meal’, col significato di ‘cibo degli uccelli’.
Analizziamo adesso l’it. coccolare ‘vezzeggiare’, ritenuto dal DELI voce infantile da confrontare con cocco ‘uovo di gallina’, considerato onomatopea da confrontare con coccodè (sic!). A fronte dell’inadeguatezza delle etimologie proposte, preciso che coccolare si basa sull’akk. kukku(m) ‘(un genere di) dolce’ + ul ‘frutto’, col significato di ‘frutto-dolce’, ovvero ul ‘qualsiasi cosa’, col significato di ‘qualcosa di dolce’; ma può andar bene anche ul ‘gonfiarsi, ingrossarsi’ (riferito in questo caso ai bimbi paffuti), col significato originario di còccolo come ‘dolce polposo’.
Cocco in quanto ‘uovo di gallina’ è considerato onomatopea, imitazione del coccodè emesso dalla gallina quando sta per espellere l’uovo (sic). Ma un suono con la sequela di fonemi c-o, c-o, d-e non viene mai emesso dalla gallina, e nemmeno viene emesso il più semplice c-o, c-o, trattandosi invece di un rumore indistinto emesso dalla strozza a causa dei dolori dello sfintere. L’uovo fu chiamato cocco dall’akk. kukku(m) ‘dolce’, poiché di esso la gente è sempre stata ghiotta; e coccodè (che indica propriamente la ‘gallina’, anziché il suo verso) non è termine onomatopeico, non corrisponde ad alcun rumore, ma è l’esito dell’akk. kukku + sum. de ‘versare, emettere’, come dire, ‘emettitrice di dolci’. Ma tanto per attenerci unicamente alla lingua sumerica, possiamo proporre per la ‘gallina’ anche la seguente etimologia: kuĝ ‘scala a pioli’ + deg ‘radunarsi su’ (kuĝ-deg > kug[u]-deg > kugudè), col significato di ‘(colei che) si raduna sulla scala a pioli’: è infatti nota la tendenza della gallina a dormire di preferenza sulle scale a pioli, in difetto a dormire sugli alberi, che raggiunge svolazzando goffamente: tutto ciò per sfuggire alle volpi.
Quanto al cognome sardo Coccolòne, Coccollòne, preciso intanto che non è italiano, come vorrebbe Pittau DCS 223, poiché non è recepito dal De Felice; circa l’etimologia, essa non si basa sul fatto che il coccolone “ama farsi coccolare” (Pittau), ma si basa integralmente sull’accadico, essendo un raddoppiamento fonetico di ḫullu(m) ‘collana (in quanto ornamento)’, quindi ḫu-ḫullu + suffisso sardiano -ne (ḫu-ḫullu-ne), col significato di ‘(colui, colei che) si impreziosisce con le collane’: riferito a chi si agghinda per le feste, o riferito alle prostitute sacre ed ai prostituti sacri.
Di seguito propongo altre etimologie relative a voci che escono dal groviglio appena discusso.
Pimpirínu nelle frasi a pimpirínu (Fonni); assu pimpiríu (Milis); appimpirinare, -ádu log. sett. (Casu); a pirpirínu o a pirpirináos (Nuoro); apirpirináu (Dorgali): apprippieḍḍádu (Desulo); istare appispirináu (Orani); istare assa pispirináta (Siniscola); a pispirinádu (Macomer); a culispíspiri (Bitti); a culispíspidi (Nule); appippirináu (Norbello); a pippiniáu (Mogoro); a bibbirínos, a bibbirináu (Baunei, Busachi, Tonara, Belvì, Laconi); abribiḍḍáu (Tortolì); istáe a sa rbibiḍḍincáda (Villagrande); a culimpípiri log. gen.; a curimpíparu sass. ‘accoccolarsi, accolato alla beduina’. Per Wagner queste sono formazioni infantili e scherzose. Ma egli non può sentirsi autorizzato a classificare a modo proprio tutto ciò che non comprende! Invero, la base etimologica è il bab. parû ‘to excrete, defecare, cagare’. Da cui si evince che in Sardegna il prototipo fu la forma sassarese, ovviamente reduplicata per esigenze icastiche con le formalità dello stato costrutto (dove la -a- intermedia diviene -ī-), onde culu in pī-paru ‘culo nella posa di defecare’.
Altro esempio: straùllu ‘grido, urlo emesso per spaventare, chiasso sconvolgente’, deverbale di straullái ‘strillare, urlare, far chiasso’, che deriverebbe dal corrispondente it. strillare. Gli etimologisti non hanno ancora trovato accordo sull’etimo dell’it. strillare, e comunque è azzardato accostargli il sd. straùllu. Per Wagner quella sarda è “voce imitativa”, ma non spiega che cosa ci sia di “imitativo” tra il vocabolo e la voce scomposta di chi urla (la quale, fonicamente, è nient’altro che un iii!!!, aaa!!!). Invero, la base etimologica di straùllu è il sum. tar ‘to cut down, abbattere, tagliare’ + uli ‘lamentation’. Il composto tar-uli, reso icastico dall’accrescitivo s- e sottoposto a metatesi (s-tra-uli), in origine indicò un lamento straziante (lacerante, dirompente)’.
Zariθθu, giaríθθu «si chiama nella Barbagia una specie di ritornello bizzarro che accompagna la chiusura di certe canzoni e che difatti rassomiglia al nitrito del cavallo» (così Wagner). Ma si osservi il collaterale verbo zarridare (Nuoro, Orgosolo, Mamoiada, Orani); giarraspidare (Oliena); garrizzare (Gavoi) ‘nitrire’. Base etimologica è il sum. zara ‘concern, preoccupazione’. Ma può essere anche il sum. zaraḫ ‘wailing, lamentation’. A proposito del ‘ritornello’ su citato, G.M. Cabras (Vocaboláriu baroniésu p. 400) scrive a un dipresso le stesse cose del Wagner, attingendo da lui a piene mani acriticamente. È invece sensato credere al linguista baroniese Andrea Deplano – il cui metodo non ha mende – quando afferma che a lui in Baronia non sono noti i vocaboli zarridare e zariθθu; e tantomeno gli sarebbero noti coi significati addotti dal Wagner.
Omofonie. Le false “onomatopee”, le false “voci imitative”, i falsi “fonosimbolismi”, riguardano complessivamente il 30% dei lemmi studiati dal Wagner. Sono una percentuale eclatante a dimostrazione della sua assenza di metodo. Un altro 30% riguarda più propriamente le omofonie (e siamo così al 60% dei lemmi: una enormità). Pretendere di risolvere le questioni etimologiche soltanto in forza dell’omofonia tra due elementi, senza alcun rispetto per gli aspetti storico-semantici, pone l’etimologista al difuori del metodo scientifico. Non si riuscirà mai a risolvere le etimologie, senza un approccio che proietti la parola sullo sfondo socio-culturale dei tempi primitivi. Purtroppo è solita del Wagner la pratica di accorpare le parole aventi fonetiche identiche o simili entro un solo campo semantico, senza tener conto della legge della polisemia e quindi senza prendersi la briga d’isolare ogni vocabolo per tentare di rinverdirne l’originaria indipendenza fono-semantica. In tal modo sfugge al Wagner la possibilità di far pulizia entro i propri sistemi logici, e gli sfugge anche l’esigenza prìncipe di non confondere e fuorviare il lettore. Nel paragrafo precedente abbiamo testè discusso di accuccaresì, sotto la cui voce Wagner ha preteso di accorpare, per semplice omofonia, concetti enormemente diversi. Passo ad altri esempi, che ho contenuto nel numero, nonostante ce ne siano migliaia.
Allughinzare log. ‘sporcare, annerire’; alluxingiái ‘sgualcire, sporcare i vestiti’; lughinzósu log., luxingiósu camp. ‘sporco, lurido, sudicio’. Wagner pretende come base lukinzu, lughinzu, luxίngiu ‘lucignolo’ (omofonia), ed è assurdo, poiché la base delle sue tre voci è lughe, lùere (vedi). Egli non è in grado di osservare che la vera base etimologica di allughinzare è il sum. luḫum ‘charcoal, carbone’.
Astra ‘ghiaccio’. Il gelo, il ghiaccio è un elemento che i pastori sardi hanno sempre temuto. Le transumanze esistettero fin da Età paleolitica proprio per evitare le morie del bestiame. I Sardi inventarono ben otto parole per indicare il gelo, il ghiaccio (altre cinque seguono qui appresso). Ma astra in origine indicava l’idea del tremare. Infatti la base etimologica è il sum. ašru ‘che fa rabbrividire dal freddo’, una metonimia per ‘frost, gelo’. Va da sé che gli altri vocaboli sardi àstragu, àstrau, astròre, astraòre, indicanti il ‘ghiaccio’, sono aggettivali di astra. Che poi i filologi romanzi propongano l’origine del sardo astra dal lat. astra ‘stelle’ (che invece hanno etimo nettamente distinto, come vedremo), la dice lunga su chi si fida soltanto dell’omofonia.
Attoccare log. ‘abbaiare, latrare; urlare come i cani’; attoccu, attόkkida ‘abbaio, canizza’; dare s’attoccu ‘emettere un grido a intervalli’. Base etimologica è l’akk. tukkum ‘alarm, warning’. Va da sé che va respinto l’assurdo invito del Wagner di vedere in questo verbo una variante fono-semantica di toccare ‘toccare’ in tutte le accezioni italiane.
Tzóu log.; accióu camp., ciódu sass. e gall. ‘chiodo per ferrare i cavalli’, ‘chiodo per le ruote piene’, ‘chiodo per le scarpe’. A Nuoro si dice cravu < lat. clāvus ‘chiodo’. Wagner crede tzóu accatto italianistico da chiodo, ma sbaglia, poiché ambedue sono voci tirreniche aventi base nel sum. zu ‘tooth, dente’. Si può notare che la voce logudorese è assai più vicina al sumerico che non la voce italica, quindi sembra il prototipo delle voci che poi si sparsero nel Tirreno.
Dissíbulu (Osilo) ‘diavoletto, ragazzo irrequieto, discolo’. Base etimologica è l’akk. dešû ‘to sprout, flourish, let prosper, be copiously supplied; germogliare, essere fiorente, far prosperare, essere copiosamente dotato’ + būlum ‘animals, livestock; bestiame di proprietà’. Dal composto si nota che le qualità positive elencate riguardavano il bestiame di proprietà, e costituivano l’orgoglio del proprietario. Va da sé che l’uso sopravvissuto ad Osilo riguardò nel passato i bambini assai vivaci (quanto a intelligenza, agilità, forza) e poi dilatò verso ulteriori specificazioni. Quindi è da rifiutare la pretesa del Wagner di ricondurre la voce osilese a discípulu ‘discepolo’ (di Cristo).
Fraitzínu (tussi) o tussi molentìna ‘tosse asinina’. Puddu ricorda che per fraίtzu e l’agg. fraitzίnu si è conservato il significato di ‘furbesco, astuto’. Wagner traduce la voce come ‘traditore, imbroglione, fuoriuscito, bandito, ladro’, e ritiene che il campo semantico sia prodotto, nientemeno, dall’it. fra’ ‘frate’, col significato quindi di ‘frataccio’. Ma questa interpretazione è miope. In realtà la base etimologica è l’akk. parriṣu ‘criminale’, da cui metatesi prai-, frai-. Vedi in ogni modo il lemma faurratzίnu, per capire la deriva paronomastica cui può portare un termine oramai incompreso.
Frazare log., frazza’ sass., fragia’ gall. ‘corrodere, consumare’; mancarri ki sia frazzàda ‘anche se è consumata’; male cuádu, frazu de pubiḍḍa ‘male nascosto, rodimento di moglie’; cfr. genov. frażżâ ‘consumare, sciupare’; romanesco frajasse ‘guastarsi, andare a male’; irpino e calabr. fraiá ‘abortire’; tosc. dial. frazzo ‘avanzo, frammento’. L’analisi etimologica del Wagner è un classico esempio della metodologia corrotta dalla pregiudiziale latina. Egli infatti produce anzitutto l’ipotesi del Romanisches Etymologisches Worterbuch, ossia che il termine derivi da un lat. fractiō, fragium, da un inesistente *fragulare (dove si cita un camp. *fragiare che parimenti non esiste: parole del Wagner); poi lo stesso Wagner riprende le distanze dal *fragulare del REW. Altra tesi da lui esposta è che il nostro termine derivi in ultima analisi da lat. (nau)fragium. Quanto al fragiu degli Statuti Sassaresi, e quanto alle forme odierne, esse sono tutte relegate in Logudoro, e, mancando nel resto dell’isola, per Wagner «sono sicuro indizio della provenienza forestiera» (sic). Il lettore, da quanto precede, ha agio di notare che Wagner non prende esattamente posizione, ma lascia intuire ex silentio d’essere d’accordo col lat. fragium attraverso forme quali (nau)fragium. Al che noi osserviamo anzitutto la tesi miope e colonialista secondo cui un lemma presente esclusivamente nel Logudoro «sia sicuro indizio della provenienza forestiera». Osserviamo poi l’arroganza del credere all’esclusiva origine latino-romanza. Osserviamo infine che è metodologicamente anormale avvicinare due campi semantici descriventi, rispettivamente, il logoramento (putacaso, di una stoffa) ed il naufragio!, il quale, si sa, ha il corrispettivo nel lat. frangere ‘rompere’.
Ciò accade perché non sono stati scrutati i dizionari semitici, dove per frazzare troviamo l’akk. parāṣu(m) ‘sbrecciare’ una parete’; parā’u(m) ‘affettare, tagliare di netto’; onde da p(a)rāṣu > frazzáre.
Gutta2 margh. ‘sincope, paralisi’. Per l’etimo ci possiamo riferire alla base bab. akûtu ‘invalidità’, da akû ‘debole, senza forze’, specialmente ‘zoppo, sciancato’; anche uqqu ‘paralisi’ (voce apofonetica in u-). Ma vedi l’ampia discussione a proposito di agottiadùra ‘vitiligine’. Spiace osservare che i linguisti precedenti hanno interpretato anzitutto per assonanze, traducendo gutta come ‘gotta’ (Spano, Wagner): mentre quest’ultima è malattia diversa. Spiace anche osservare che spessissimo Wagner accorpa le voci similari o identiche sotto un unico lemma, creando notevole confusione. Tale destino ha avuto anche gutta2, che è stata abbinata a gutta1 ‘goccia’ nonostante l’evidente discrasia semantica.
Igumarras (Laconi), irgumarras (Desulo); vigumarras (Mogoro, Escalaplano) ‘lampi secchi, il lampeggiare parossistico e senza pioggia durante certe perturbazioni sciroccali di settembre’. Questo termine meteorico, il cui prototipo pare irgumarras, ha base nell’akk. irḫu ‘aggressiveness, insolence’ + marrum ‘bitter’ (of wind). Il composto irḫu-marrum in origine indicò la ‘paurosa aggressività’ (del temporale). Immagino che la sequenza ininterrotta di migliaia di saette aria-aria fosse vista come dimostrazione della rabbia del Creatore. Wagner inserisce queste voci tra quelle legate a vicru marinu (v. vicru ‘vitello’) ossia alla ‘foca monaca’, tentando di accreditare fantastiche sarabande di foche eccitate dai temporali di fine estate. Ma vicru ha tutt’altro etimo rispetto a quello ora esposto.
Imbòrvita (Bitti), imbòrvida (Nuoro) «si chiama il pane che si manda ai vicini e ai poveri il settimo o il nono giorno dopo la morte di un familiare». Secondo Wagner è così detto perché “coperto da un panno”, quindi da imbόrvere ‘involgere’. Wagner, a mio parere, sbaglia su tutti i fronti. Occorre tener presente che in Sardegna l’assistenza alla famiglia del morto è un obbligo morale. Per s’imbòrvita non è la famiglia del morto che invia ma anzi è quella che riceve dai vicini i beni eduli. Anche se è vero che in Campidano la famiglia del morto dopo 30 giorni dona un pane a coloro che hanno assistito alla messa di suffragio. Ma è s’imbòrvita come parola a destare forti sospetti sull’operato del Wagner, poiché non ha attinenza né con l’involgere né col celare il dono. La base etimologica è il solito in- mediterraneo (complemento di moto a luogo, oppure dativo) + akk. bu’’ûm ‘to look for, cercare qualcuno; look after, prendersi cura di’ + wêdum ‘sole, solitary, alone; solo, solitario’. Il composto in-bu’’ûm-wêdum in origine significò ‘prendersi cura delle persone sole’.
Incappare it. ‘essere irretito, preso da una situazione impediente, spesso malevola’. Cfr. log. incappare, camp. -ái ‘capitare’: tristu a kin’incappat ‘sfortunato colui al quale succede’. Base etimologica è l’akk. kappum ‘palmo della mano’. In questo caso il concetto basilare è quello d’essere afferrato da una mano rapace. Sbagliato l’etimo del DELI da cappa ‘mantella’. Wagner (DES I 622), senza immischiarsi in questioni di etimologia, sostiene che la voce sarda è un accatto dall’it. incappare.
S’incappat. Dopo l’azzardo di incappare, Wagner rafforza la sua idea accreditando la stessa origine all’avverbio di dubbio: s’incappat. Quindi traduce Ómine pipadore s’incappa non ‘nde leo ‘uomo fumatore, se capita, non lo sposo’. Invece sincappat è voce log. ‘forse, probabilmente, mi pare che, secondo me’; sincappat appo intzertáu ‘mi pare d’avere indovinato’; sincappat mi lu faghes iskìre ‘spero me lo farai sapere’; sincappat l’as cumpresa ‘mi pare che l’abbia capita’; sincappat lu fricas tùe! ‘stai fresco che lo freghi tu!’. Questa è un’antichissima invocazione del genere di quella araba (inshallàh ‘che Dio voglia’),ed ha base etimologica nell’akk. Sîn ‘la Dea Luna, la Dea Madre Onnipotente’ + kapātu ‘mettere insieme, riunire’ (dei segni portentosi, segni d’auspicio). Quindi sincappat significò in origine ‘che Sîn mostri dei segni positivi’.
Inférias log. ‘pastoie’. Cfr. tosc. ferie ‘idem’; cal. férgia ‘pastoia di ferro da cavallo’, abruzz. ferge. Wagner ne propone la parentela col ferro, evidentemente attratto dalla “pastoia di ferro” qui citata, alla quale non credo in linea di principio. Infatti una cosa è la ‘pastoia di ferro per uomini (manette)’, applicata ad esseri intelligenti per ammonirli a star calmi e non farsi male inutilmente, altra cosa è ‘impastoiare col ferro un animale’ che, non essendo intelligente, auto-distrugge le proprie gambe, condannandosi alla morte e producendo un danno economico al padrone. Questo lemma è uno dei tantissimi che denuncia la scarsa acribia del Wagner, il quale risolve le sue etimologie soltanto in funzione delle assonanze (inférias/ferro), senza considerare la semantica. Invero, la base etimologica più congrua per inférias è il sum. birig ‘to sneer at, farsi beffe di qualcuno; contract oneself, contrarsi, rattrappirsi; roll up, arrotolare, rimboccare’, da cui si può evincere un campo semantico dove domina l’atto d’imperio o di violenza ed il concetto di mettere attorno (appunto: i lacci ai piedi).
Ingenium in CSMB 93: Ismendarunt su condage suo in corona de logu, ki aviat factu ad ingenium (ch’egli aveva falsificato) et segarunt illum. La traduzione è del Wagner. Egli riconduce il sd. ingenium ad irghenzu nuor., abbenzu, aenzu, enzu ‘difetto fisico o morale; debolezza, macchia’; e deriva irghenzu e tutte le voci ad esso legate dal lat. ingĕnium ‘natura, qualità, indole, inclinazione’. Non si rende conto che la vera base etimologica di irghenzu è l’akk. irḫu ‘aggressiveness, insolence; aggressività, insolenza’. L’interpretazione del Wagner è ascientifica, e in quanto tale incappa in tre errori: il primo quando rifiuta l’approccio semitico; il secondo quando prende come base una voce latina senza alcun criterio, poiché tra irghenzu e ingenium c’è troppa differenza fonetica ed anche semantica; il terzo quando pretende che si accetti il lat. ingenium come “falsificazione” anziché come ‘natura, qualità, indole, inclinazione’. Detto con rispetto, questo è un imbroglio oratorio che induce subliminalmente il lettore ad accettare la proposta come vera, omologando ingenium ad irghenzu e ponendo l’origine di quest’ultimo in ingenium medesimo! L’imbroglio va svelato: la proposizione subordinata ki aviat factu ad ingenium è da tradurre ‘che aveva fatto (scritto) secondo le proprie intenzioni (e non secondo verità)’.
Istuvada log. ‘colpo di coltello al fianco; percossa’ (Casu). Contrariamente a quanto propone Wagner, questa voce autenticamente sardiana non ha alcuna relazione con tuvu (agg. ‘cavo, profondo’ detto d’alberi, per estensione ‘spelonche’, base etim. bab. ṭubû ‘un genere di canna’). Base etimologica di istuvada è il sum. tub ‘to strike down, colpire’.
Là locuzione esortativa camp., usata in frasi quale Là ki ti partu de conca! ‘Sta attento che ti parto di testa, che ti dò una testata!’; Là ki ses fendi su scimpru! ‘Attento a te che stai facendo lo scemo!’. La base etimologica è l’ug. l-, /la/ ‘o’ (interiezione). Il camp. là funziona esattamente come nell’ugaritico, prefisso alla parola o al verbo seguente come interiezione vocativa. Ma vedi anche l’akk. di Emar la = ingl. to, it. a, lat. tibi. Come base etimologica primaria abbiamo il sum. la ‘mostrare, esporre’, col significato quindi di ‘guarda!, attento!’; si noti l’interiettivo sum. a-la-la, che riappare nella interiezione camp. là là là, per richiamare l’attenzione di qualcuno su qualcosa: ‘guarda, guarda, guarda!’. In Campidano s’usa la particella là anche col significato similare di ‘tieni, afferra!’ (uso pure italico). Ma altrettanto spesso la particella campidanese è strettamente agglutinata nella più complessa forma infinitiva labái.
Non è lecito considerare il camp. labái ‘osservare’ come avente base nel sum. la ‘mostrare, esporre’ + ba ‘colà, là’ (prefisso dativo-locativo): la-ba, con significato di ‘guarda là’. Oggi i linguisti percepiscono là – in quanto particella isolata – come forma imperativa dell’infinito camp. labái ‘guardare, mirare, osservare’. Ma si noti che la voce labai, essendosi oramai consolidata come supposta da un sd. *labai, *labare, riceve anche le forme congiuntive di rispetto lebi, lébidi ‘guardi’. In realtà la forma labái ‘guardare’ è già di per sé corrotta, ed ha base nel camp. la + bá(d)-. Non a caso c’è il corrispettivo log. ab-baid-áre (con a- dat. prefissato): cfr. badiáre (Olzai, Ovodda, Gavoi) ‘guardare’; it. bad-àre ‘osservare, mirare a’.
Il camp. la-bái è quasi sempre impiegato all’imperativo, dove abbiamo il semplice là! ‘guarda, osserva!’, ma pure il composto labbáḍḍu!, labbaḍḍu innòi! ‘mìralo, védilo qua!’ (da là baḍḍu…). La base etimologica di bad- è il sum. bad ‘fortezza’ ossia ‘luogo alto d’osservazione’. Ultima osservazione: Wagner (DES II 1) cita questo lemma sotto la voce italianistica labare ‘lavare’, principalmente ‘cercare i pidocchi in testa’ (e le pulci sul corpo), pretendendo l’origine etimologica di là, labái dal lat. lavāre. Un modo di ragionare che esula da ogni approccio scientifico.
Maiòre log. ant. ‘titolo comune significante la preminenza assunta da un uomo sui suoi dipendenti’; pl. anche maiorales. La base etimologica è la stessa di magistru, maistru, mástriu, mastru log. ant. ‘maestro’ (vedi). Questa voce è passata attraverso il lat. magister (da magis, majus), ma ha base etimologica nel sum. maḫ (cfr. it. maiùscolo ‘di proporzioni maggiori’) ‘grande, potente’; il suff. -yo-, -yu- ha basi semitiche: ug.-ebr. jṣ’, aram. j‛a, akk. aṣû ‘salire; to rise, to grow’. È inammissibile che Wagner abbia preteso di porre come base di maiòre il camp. mòri ‘viottolo di campagna’. Infatti tra l’aggettivo connotante il maggiore ed il nome riferito al sentiero passa un abisso semantico. Wagner non potè capire che mòri ‘sentiero’ ha base etimologica nel sum. mu ‘good’ + rub ‘to go, andare’: mu-rub indicò in origine il ‘buon andare’ ossia la possibilità di muoversi senza attraversare né selva né sterpaglie.
Mudróxu (Sarrabus) ‘orifizio dell’alveare, unico ingresso delle api’. Base etimologica è il sum. mud ‘cavità’ + uru ‘dwelling’. Il composto mud-uru in origine indicò il ‘buco dell’abitazione’. Da scartare l’assurda proposta del Wagner che indica l’origine nell’it. mordere.
Muldidòri (Teulada) ‘ragno’. Base etimologica il sum. mul ‘insect’ + de ‘to winnow, vagliare, discernere’ + dur ‘to dwell, abitare’. Il composto mul-de-dur in origine significò ‘insetto che abita dentro il vaglio’ (per la forma della ragnatela). Da respingere l’interpretazione del Wagner, che lo considera ‘il morditore’, da it. mordere.
Oru log. in leare όru ‘aver sentore’ (Spano). Base etimologica il sum. ur ‘to smell, sentire odore, annusare’. Purtroppo Sanna e Wagner lo derivano dal log. orettare ‘guardare dalla soglia della porta’.
Pibaratzu agg., detto di un cavallo screziato o di pecora bianca a macchie rosse (Sarrabus). La voce non deriva dall’it. vipera (serpente velenoso viviparo), come suggerisce assurdamente Wagner, ma dal sd. píbere, píbiri ‘pepe’. Quindi significa peperato.
Pistoccu log. e camp. ‘pane biscottato e scisso in due sfoglie’. Wagner lo considera metatesi dell’it. biscotto ‘pane cotto due volte’, ‘pasta dolce cotta lungamente al forno’ (< lat. biscŏctum ‘cotto due volte’). Questa interpretazione ha lasciato il segno tra i “dotti” e nel volgo. Invero, la voce sarda è totalmente autonoma, avente base etimologica nel sum. piš ‘bank, shore, rim, quay, bancata, riva, costa’ + tuk ‘to break off, cut, scratch, staccare, tagliare, incidere’. Il composto piš-tuk in origine indicò un ‘(pane) piatto e secco che si scinde in due’.
Pasticci e funambolismi. Come abbiamo constatato, purtroppo, sono migliaia i pasticci ed i funambolismi esibiti dal Wagner in fangose, assurde, lunghissime discussioni entro le quali egli macina voci latine o “neolatine”, condite dalle leggi fonetiche della Scuola Indogermanica (da me rifiutate: vedi Grammatica Storica), le quali creano una cortina fumogena adeguata a sfinire il lettore ed indurlo ad accettare fideisticamente ogni proposta. Comincio la breve sequenza con un esempio sardo-italico.
Aquà = it. ‘qua’ = sd. innòi, innòghe. Questo è termine del gergo ramaio di Isili. Il lemma è una spia del fatto che i ramai di Isili in origine ebbero rapporti stretti con i ramai d’Italia. Infatti quest’avverbio in Sardegna non viene usato, ed è evidente che il lemma acuà (o aquà) è lo stesso lemma italico qua, da cui però il gergo ramaio si distingue in virtù del ridondante prefisso locativo a-.
Stando al DELI, l’italico qua ‘in questo luogo, in questo posto’ dovrebbe avere la base etimologica nel lat. (ěc)cu(m) hāc ‘ecco pur di qua’. Ma non occorre grande acribia per notare l’ybris …creativa del DELI: quel Dizionario infatti ci fa assistere dapprima alla distruzione di una parola intera (ěccum), poi alla religiosa delicatezza con cui se ne preleva un pezzetto (-cu-), infine all’azzardo da Frankenstein che appiccica -cu- al lat. hāc e crea il minotaurico -cu-hāc, senza più curarsi della fine che possano aver fatto tutti gli altri membri, compresa la velare finale (-c) che, non si sa mai, poteva anche essere un pezzo importante.
A me, incapace dei vertiginosi e avveniristici esperimenti del dottor Frankenstein, resta un’unica, arcaica, risorsa: attingere al dizionario sumerico, dove trovo ku ‘to place, collocare, mettere, porre’ + -a (suffisso locativo con valore ‘in’): ku-a significò ‘in questo luogo, in questo posto’, proprio come in italiano.
Berríle, verrίle, errίle log. ‘vernino’: anzone verrile. Per l’etimo vai a iverru ‘inverno’. In ogni modo, per questa voce occorre molta cautela. Infatti il giusto prototipo di essa è barrίri agg. sass. ‘agnello grande’, propriamente del mese di aprile. L’interpretazione, qui postata dopo essere stata semplificata (dove si mescolano i concetti dell’inverno, dell’agnello grande, del mese di aprile), è del Wagner, non mia: io non la condivido affatto. Persino Bazzoni si périta di accreditare l’incredibile certezza del Wagner. Invero, base etimologica di barrίri (a quanto pare anche di berrίle) è l’akk. barûm ‘to be on the market, available; essere disponibile per il mercato’ ossia essere grande abbastanza per valere come carne da vendere.
Cadattu ‘cardo stellato’ (Centaurea solstitialis L., Centaurea calcitrapa L.). Inserisco, tra quelle trattate dal Wagner, una voce trattata espressamente dal Paulis NPPS 78-80 in relazione alla calcitrapa. Nel ricordare che Wagner ne ignora l’etimo, Paulis propone tale fitonimo come contrazione di kardu ed al contempo continuazione di un inesistente lat. *atractulus, forma basata su atractylis (che però secondo Plinio è il Cartamo lanato) quale imprestito d’epoca bizantina (sic!), il quale in Sardegna avrebbe prodotto – secondo lui – una serie contorta e defatigante di assimilazioni, dissimilazioni, semplificazioni, complicazioni, rinvii, obliterazioni, contrazioni, anaptissi, epentesi, dilegui, aferesi, metatesi, analogie produttive… e quant’altro si voglia pescare da un trattato di tecnica fonetico-stilistica. Alla fine Paulis, irrimediabilmente perduto nel labirinto da lui stesso creato, non produce alcun etimo, lasciando il lettore stanco e frustrato dopo aver letto tre pagine col desiderio di scorgere una soluzione. I miei lettori sono vivamente pregati di ripercorrere quelle pagine.
In realtà cadattu è un composto sardiano con base nell’akk. kādu(m) ‘sentinella’ + atû(m) ‘portinaio’. Per capire questo sintetico appellativo significante ‘guardiano degli usci’, basta leggere tutti gli altri consimili significati dati dai Sardiani alla calcatreppola, pianta d’elezione con cui si fanno delle effimere “porte”, “cancelli” per impedire alle bestie di rapina di entrare negli ovili.
Féstina centr., gall. designava originariamente le scale a intagli, oggi inesistenti. Oggi il vocabolo si usa per la ‘scala a pioli’ (Nule, Dorgali), in Gallura anche per il ‘tronco d’albero coi rami sporgenti e sfrondati al quale s’appendono utensili o bestie scannate’, altrove chiamato anta. Base etimologica è il sum. peš ‘to slice, affettare, to cut into, tagliare in…’ + ti ‘rib, stecca’ + nug ‘plant’. Il composto peš-ti-nug in origine indicò una ‘pianta resecata a stecche’. Esemplare l’affanno indagatore del Wagner (DES I 514), che abbina la nostra voce a questa e a quella, arrecando soltanto danni; es.: l’abbina al lat. infestus ‘ostile, aggressivo, nemico’; allo sp. enhiesto ‘alto, levantado’; al lamant. injiestro ‘ognuno dei quattro pali ai capi del carro’. Egli vi assomma anche il berbero tafesna ‘scala’ (voce del tutto diversa), ch’egli ostinatamente pretende ravvicinare al nostro féstina.
Fúndere log., fúndiri camp. ‘fondere, liquefare’. Cfr. lat. fundere ‘sciogliere, spargere, disperdere, volgere in fuga, sconfiggere’; infundibulum ‘imbuto’; fūtis ‘vaso per mescere’; fūtilis ‘che si versa o si disperde’ < base apofonica corrispondente ad akk. pādum ‘to set free, liberare’. Vedi DES I 556 per capire la disastrosa e confusissima operazione con la quale Wagner riesce ad unificare l’etimo di due lemmi assai diversi, fúndere e infúndere.
Ineḍḍa centr. ‘lì, in quel preciso punto’, ‘là, colà, lontano’; anche inḍeḍḍa: mirare sa luna de ineḍḍa ‘guardare la luna da un punto preciso’; in cuḍḍa biḍḍa ineḍḍa ‘proprio in quel villaggio’; ineḍḍa andet sa fama ‘la fama si levi alta’ (cfr. sum. ed ‘to go up, salire in alto; to come forth, uscire’). Wagner sbaglia a dare a ineḍḍa il significato di ‘lontano’, tout court. Parimenti sono insufficienti le traduzioni date dal Puddu 865: ad es. prist-inneḍḍa ‘prestu a un’ala’ (peráula po kizire su cane) ha un significato assai distante da quello dato dal Wagner, e Puddu questo non l’ha chiarito.
A mio avviso, la base etimologica di alcune di queste locuzioni sta nel sum. ed (vedi l’esempio citato), per altre nell’akk. eddu(m) ‘punto, appuntito’ < edēdu ‘essere appuntito’. Per non impegnare spazio, non riporto la fangosa, lunga discussione del Wagner (DES I 629), che ruota sulla manipolazione di alcune voci latine, condite dalle leggi fonetiche inventate dalla Scuola Indogermanica, le quali, partendo da basi irrimediabilmente sbagliate e compromesse, creano soltanto pasticcio.
Osca log. ant. ‘poi, dopo’. Frequentissimo nei condaghes, in séguito cede il posto a posca (vedi) ‘poi, appresso, dipoi’ (avverbio), che però spunta ogni tanto anche nei documenti antichi. Nella CdL posca è l’unica forma. Facile arguire che osca è la forma arcaica della parlata sardiana. Infatti, base etimologica è il sum. us ‘to follow’ + ca log. e camp. ‘che’ come introduzione delle proposizioni dirette (accusative) e in applicazioni varie, da sum. ka ‘to talk, parlare’. In pratica us-ka anticamente ebbe il significato di ‘poi che’. Wagner, convinto della priorità temporale di posca, ha scritto tre pagine nel disperato tentativo di scoprire un arcano per lui inscrutabile.
Regra (Nuoro, Dorgali, Orune, Nule); rega (Bono); règia (Oschiri, Buddusò, Mores); sa regge (Sennori); règgia (Berchidda); rèja, melarrèja (Luras, Ozieri); melarèggia (Pattada); arrèga camp. ‘favo di miele’. Regra e simili sono retroformazioni dal prototipo melarrèja. Per l’etimo vai a méli, mela + akk. rēyûm, re’ûm ‘shepherd, pecoraio, pastore’. Nell’alta antichità melarrèya significò ‘miele dei pastori’.
Impossibilitato a riscrivere e riproporre l’intera pagina da cui ho preso le mosse, rinvio a DES II 346 affinché i futuri linguisti percepiscano il guazzabuglio prodotto dal Wagner il quale, paralizzato nella ricerca di un etimo qualsivoglia (salvo poi parare a un lat. reg(ŭ)la ‘regola’: sic!), s’impelaga in una cabalistica manipolazione delle leggi fonetiche da lui stesso inventate, confrontandole con quelle altrettanto inventate della linguistica indoeuropea. Inoltre introduce anche rèya ‘traversa del cancello’, oltre a voci similari basso-italiche aventi tutt’altri significati, quasi che tali voci abbiano a che fare con la nostra. Il risultato è, purtroppo, una pagina allucinata.
Resare log. (rasare: Nuoro, Mores); arresái, arrasái, arrosái camp. ‘recitare il rosario’; ‘fare orazione’, ‘dire il breviario’; fagher (fai) su résu, s’arrésu ‘la preghiera quotidiana del prete’. Cfr. sp. rezar ‘recitare orazioni’, rezo ‘preghiera’; arreséndu (Mogoro, Terralba), arreséndi (Cagliari), arroséndi (Villacidro) ‘Credo’ (la preghiera-cardine del cristianesimo). Quanto precede è scritto dal Wagner, e si può notare ch’egli ha fatto un po’ di confusione, mettendo assieme il Rosario, il Credo, ed una poco chiara ‘preghiera quotidiana del prete’. Wagner è partito da sp. rezo ‘preghiera’, credendolo l’origine delle altre parole spagnole nonché di quelle sarde. Ma, a parte che non dà l’etimo di rezo, rezar, egli ha fatto dei grossi errori. Base etimologica di rezo è, invero, l’akk. rēṣum ‘helper (god, goddess), che soccorre’; ‘to help, soccorrere’: Sîn-rēṣam ‘Help me, Sîn!; Dea Luna, soccorrimi!’ (usato come invocazione nella preghiera, ed anche come nome muliebre). Quindi è inadeguato quanto propone Wagner, che il verbo sia riferito al rosario, alla ‘preghiera quotidiana del prete’ e pure al Credo. Possiamo invece notare che oramai a livello popolare ed a livello colto la confusione ha prevalso, mentre al fondo rimane l’akk. rēṣum che tramanda intatta sino ad oggi una parola che denuncia una incredibile sopravvivenza della religione pre-cristiana.
Scrikkillònis m. pl. camp. (Escalaplano); scrikkillôis (Mogoro); cicillònes (Villagrande); sciscillònis (Cagliari); pripixònes (Laconi); spripillôis (Usellus) ‘racimoli’. Base etimologica di scrikkillònis ed affini è il sum. kirkir ‘bird’ + lum ‘drinking vessel’, anche ‘fruit’. La Sardegna nel periodo della vendemmia sta ancora nel pieno della siccità estiva, e gli uccelli sono in grande sofferenza per assenza d’acqua. Pertanto il composto kirkir-lum in origine dovette significare, più che ‘frutta degli uccelli’, ‘acqua degli uccelli’. [Questo è l’esempio di come devono essere trattate le etimologie, con un occhio agli antichi vocabolari e l’altro all’ambiente del luogo. Invece Wagner DES II 394 satura le proprie ipotesi con parole inventate (con l’asterisco) e con depistaggi epistemologici operati mediante la presentazione d’una serie di vocaboli travianti, quale sd. kiskizza ‘vagliatura del grano’, sp. cencerrón ‘racimolo d’uva’, sd. pipiòne ‘acino d’uva’].
Séru log. ‘sentore’: leare su séru ‘aver sentore’ (detto specialmente dei cani da caccia); cane de séru ‘cane dal naso fine’; fig. ‘persona molto accorta’ (Casu), ‘giudizio, riflessione’ (Soro); leare séru ‘subodorare’ (Spano); ista in séru! ‘mantieni il senno!’; serare ‘sentir la preda’ (detto dei cani); riflessivo ‘ravvedersi, rinsavire’; anche seriare: l’apo seriadu in cussu logu ‘l’ho visto in quel luogo’.
Leggendo in DES II 411 si apprendono le angosce dei linguisti nell’indagare questa voce. Antonio Sanna, non sapendo che fare, tentò di sentenziare che Spano, Soro e Casu avevano registrato parole inesistenti (sic); ciononostante s’arrovellò paradossalmente nel sostituirvi verbi e significati d’altri campi semantici, tipo it. segregare (operazione illecita e assurda, la sua, seguita dal Guarnerio che tentò d’intruppare quelle voci nell’it. sceverare ‘discernere con la vista’). Il Meyer-Lűbcke rigettò il tentativo del Guarnerio ma se ne lavò le mani. Il Salvioni dubitò del Guarnerio e propose in cambio l’origine dal lat. verus ‘vero’ (sic). Wagner rigettò salomonicamente tutti quei rovelli, per andare at random e pescare infine la parola sostitutiva dal sintagma leare oru (dallo Spano), che considerò sinonimo di leare séru. Invero, Wagner nel suo cieco brancolare cadde bene, in quanto leare όru ‘aver sentore’ ha base etimologica nel sum. ur ‘to smell, sentire odore, annusare’. Ma rimane il clamoroso smacco di quattro luminari della filologia romanza, che preferirono by-passare il problema di séru, dispensandosi dall’indagare la sua base etimologica, che poggia nel sum. sir ‘to be pointed, essere acuto’.
Súmere, sumίre log.; sumίri camp. ‘trasudare’ (detto delle botti e altri recipienti). Base etimologica il sum. sumun ‘soaking vessel, vaso bagnato, inzuppato’. Rinvio a DES II 444 affinché si capiscano gli assurdi funambolismi del Wagner e dei suoi colleghi nel tentare di accreditare un qualsivoglia etimo.
Supuzzare nuor.; suguzzare log.; sumbuzzare (Ghilarza); sumbullái, sciumbullái camp. Wagner dà a supuzzare, ed a quelle presentate come varianti, quattro significati collegati (vedi di seguito). Ma è tale il caos da lui creato nell’esporre la questione (v. DES II 446), che porvi rimedio è arduo. Il lettore, dopo aver letto pazientemente nel DES l’esposizione del Wagner, adesso dovrà seguire con la stessa pazienza i miei tentativi di sbroglio.
1) ‘sconvolgere, scompigliare’: tengu su stόgumu sciumbulláu, camp., anche sciamballáu ‘scompigliato, sciamannato ossia sciatto o maldestro’; cfr. lucch. sciambugliare ‘muovere lo stomaco, suscitare nausea’ (Nieri); anche ‘rimescolare, intorbidare l’acqua’. Quanto precede è esposto dal Wagner, senza che fornisca esempi fraseologici di supuzzare, che invece ritroveremo ai punti 2 e 3. La forma sciumbullái sembra parente di it. subbuglio ‘confusione tumultuosa, scompiglio’ (che DELI suppone dal tardo lat. subbullire ‘bollire un poco’ [assurdo!] mentre deriva dall’akk. šūbu ‘rush, affollamento, ressa; to flatten, abbattere, spianare’).
2) ‘portare di notte le pecore al pascolo’ (come si fa nella stagione calda). Il rumore e lo scompiglio che ne nasce si chiama supúzzu, suguzzu, sciumbullu (cfr. it. subbuglio), ciò che spiega l’applicazione del verbo al trasporto notturno delle pecore. Il sostantivo e il verbo si usano anche per un qualsiasi rumore: inténdu sciumbúgliu ‘sento rumore’; (Mogoro) s’áqua sciumbúllada mei sa brocca ‘l’acqua diguazza nella brocca’. Tutta questa esposizione è fatta dal Wagner, ed è caotica, anzitutto nell’abbinare allo scompiglio il pascolare delle pecore (che è quieto e mansueto, anche di notte: esperienza mia personale); poi nel forzare subliminalmente il lettore a considerare l’origine di sciumbullu (subbuglio) da tale idilliaca quiete. Nel tentativo di mettere ordine, dico che suguzzu deriva dal sum. suḫ ‘to confuse, confusion’ (supuzzu è l’effetto di Lautverschiebung: v. la mia Grammatica); per sciumbullu ho dato l’etimo al punto 1.
3) log. suguzzare(sì) significa anche ‘svegliarsi presto’ (Mores, Bonorva), e così anche camp. sciumbullái: sciumbulla! ‘svegliati!’ (Domus de Maria). Questo significato deriva dall’anteriore: i pastori che portano le pecore al pascolo di notte, si devono lavare presto. Perciò si chiama nel Logudoro Suguzzadora la ‘costellazione d’Orione’ (Spano, il quale osserva: “con esso i pastori chiamano la prima stella di Orione, quando di mattina spunta nell’estate e muovono dalla mandra le pecore per pascere un’altra volta”). Il Canonico dà come etimo del nome il lat. sequor, ma ciò è impossibile.
Quanto precede è esposto interamente dal Wagner, e si noterà un incredibile pasticcio dove si mescolano i concetti dello “svegliarsi presto” (all’alba, di notte?); del “pascolo notturno”; del “pastore che si lava presto” (all’alba o di notte?, ma a che serve introdurre l’idea balzana del lavarsi?); della costellazione di Orione (la quale, osservo io, non sorge durante il pascolo estivo-notturno ma d’inverno, e sorge dopo il tramonto, non di mattina); del “muovere il gregge di mattina” (mentre Wagner era partito dicendo che il gregge viene mosso in piena notte). Wagner, insomma, concatena cinque concetti che fanno a pugni, ed il lettore rischia d’impazzire davanti a un’esposizione folle.
4) per il log. sett. il Casu dà sumuḍḍίre, simuḍḍίre con tutte le accezioni essenziali di supuzzare: ‘muoversi, menar le pecore al pascolo’, inoltre ‘nascere, spuntare (di erbe)’ (tutto ciò è registrato dal Wagner). Invero, la base etimologica è il sum. sub ‘to go’ + ud ‘goat’, udu’l ‘sheep, fat sheep’, udul ‘herdsman’. Da queste radici potè nascere il significato del ‘condurre le pecore, o le capre’ (sub-ud o sub-udu’l), relativo al sd. supuzzare, e pure relativo a sumuḍḍίre o simuḍḍίre interpretati come nasalizzazione di sub-ud.
5) Quanto alla costellazione di Orione, Wagner non ha spiegato perché essa sia chiamata Suguzzadora, da lui intesa come ‘colei che risveglia presto (la gente)’. Invero, il tentativo di trovare l’etimo passa per il sum. šugi ‘senior, elder, old person’ + za ‘man’ + duri ‘male, virile’. Il composto šugiz-za-duri significò in origine ‘uomo anziano dall’aspetto virile’ (ed abbiamo l’idea della costellazione di Orione).
Tiváni ‘corvo’ a Baunei, Villagrande, Arzana, Gairo, accanto a crobu: esattamente crobu-tivani, specialmente nella locuzione ancu ti nḍi lè tivani! ‘che tivani ti porti via!’. Quanto precede è riportato da Wagner DES II 492, dove l’Autore insiste ad affermare che tiváni è l’arcaico nome ogliastrino del corvo. A parte che, come suo solito, non opera l’indagine etimologica, egli nemmeno si pone l’obbligatoria domanda: Per qual ragione un minuscolo corvo sarebbe in grado di rapire un uomo? Invero, la base etimologica di crobu-tivani è l’akk. kurūbu (a bird) + tībum ‘attacco, insurrezione’; quindi kurūbu-tībānu (-ānu è suff. aggettivale) indicò in origine un ‘uccello d’attacco, di rapina’ (evidentemente si riferì all’Aquila reale, la quale ha la forza di sollevare persino una capra adulta; oppure si riferisce a s’ingurtosu). Tivani s’impiega anche nel senso di ‘ingordo’: quindi a maggior ragione restiamo nel campo semantico di s’ingurtόsu (‘gipeto o avvoltoio degli agnelli’). Rafforza questa impostazione il fatto che esistette anche il cognome medievale Tiuani (CV XIC) e Tifani (CSMS), il quale indica chiaramente un arcaico nome maschile correlato proprio all’avvoltoio (nome di guerriero). L’impenitente protervia ideologica del Wagner lo induce a scartare persino il bèrbero siwân, che in tutte le varietà di quella lingua designa vari uccelli di rapina, per lo più il gheppio o l’avvoltoio. Ma Wagner preferisce la forma marocchina tsiouânt, perché essa indica il corvo e ciò conferma la sua convinzione ideologica!
Tutare centr; tudare, tudái log. e camp. ‘coprire il fuoco con terra o cenere’, ‘sotterrare, seppellire’. Base etimologica è il sum. tun ‘to cover’ + tab ‘to burn, fire; bruciare, infiammare’. Il composto tun-tab in origine significò ‘coprire la fiamma, il fuoco’. Rinvio a DES II 537 per apprendere le assurde evoluzioni nel tentativo di giustificare un (inesistente) lat. *tutare e persino un’origine dal fr. tuer ‘uccidere’.
Visèra, bisèra, isèra log. ‘figura, apparenza’. Rinvio a DES II 580 per osservare il guazzabuglio creato da Wagner, il quale ha abbinato arbitrariamente a questa voce anche iseriare ‘nauseare, schifare’, nonché isèria, bisèra ‘beffa, trastullo’, sostenendo che «da ‘maschera, viso contraffatto’ si spiega l’idea di ‘contorcere la faccia per effetto dello schifo o della beffa’» (sic). Invero, le basi etimologiche sono tre, molto distinte.
Tzira camp. ‘sa natura de is vitellus, mascus e angionis’; ‘verga, natura, nervo’ (Porru); sa sίra (Iglesias) ‘pene’; sirìle, serìle log. ‘membro genitale del toro, del verre, dell’uomo’. Base etimologica nel sum. šir ‘testicolo’, di cui sirìle è aggettivo. Vedi anche tzirogna. Rinvio a DES II 595 affinché si apprenda direttamente l’assurdo discorso del Wagner, il quale coinvolge il Guarnerio, il Rolla, l’Alessio in fuorvianti ipotesi sull’origine di queste voci.
Voci spurie (per Wagner) o voci da lui stesso inventate. Dopo la segnalazione dell’enorme congerie di errori di traduzione fatti dal Wagner, non può mancare la segnalazione di un altro fenomeno osservabile nel DES, cioè le cosiddette “voci spurie” (interpretate così dal Wagner ma che spurie non sono). Ci affianco anche le voci che lo stesso Wagner inventò ma che non trovano riscontro nel vocabolario sardo.
Carrubba camp. ‘carru sentza rodas po trasportai perdas etc, ki is bois trascinant po terra’ (Porru). Era, insomma, un ‘slitta’ (per la quale cfr. tracca). Base etimologica è il sum. ḫara ‘wagon, carro’, akk. ḫarû ‘contenitore supportato da un carro’ + ubûm ‘misura di capacità’. Quindi è da tenere in non cale la meraviglia del Wagner per questa parola, ch’egli ritiene sbagliata, una voluta deformazione popolare al posto di carrùca (vedi).
Cardanéra nuor. e camp., cordonèra (Busachi) ‘cardellino’ (Carduelis carduelis). Base etimologica è l’akk. qardum ‘valiant, heroic, coraggioso, prode, eroico’ + nēru (a bird). Quindi qardu-nēru ‘uccello valoroso’ fu il primo nome del cardellino in Sardegna. Sussiste anche il cat. cadarnera, cadernera, di cui Wagner (DES 299) non ha saputo dare alcuna spiegazione, negandone addirittura l’esistenza.
Ducu (Ghilarza) ‘frana’ (Spano). Wagner, non avendo conseguito conferme etimologiche, la considera “voce dubbia”, come dire che la dichiara spuria. Invece, a quanto pare, la base etimologica è il sum. du ‘to build, heap up, accumulate’ + kud ‘to cut, break off; tagliare, rompere a pezzi’. Il composto duk-kud in origine significò ‘rottura del cumulo’.
Lareḍḍa camp. ‘piattola’, voce registrata solo dallo Spano. Wagner, dopo adeguata discussione, dubita molto della correttezza di questa voce, ed attribuisce allo Spano un errore, che con ciò s’assomma ai molti errori che lo Spano avrebbe fatto nell’interpretare il dialetto campidanese. Ma la questione non sta nei termini delineati dal Wagner, e va detto che Spano, specie per le parole da nessun altro registrate, è invece molto preciso. A mio avviso, lareḍḍa ha base etimologica nel sum. la ‘to hang, agganciarsi’ + rig ‘to eat, mangiare’ + dab ‘to seize, overhelm; afferrare, sopraffare’. Il composto la-rig-dab in origine volle significare il tipo di attività delle piattole, le quali succhiano il sangue attaccandosi tenacemente alla parte puberale.
Pádriu log. ‘chiaro, articolato’; ispadriare ‘parlare chiaro, articolare bene i suoni’. Wagner ne ignora l’etimo, pur dichiarando pádriu, per principio, “non indigeno” (spudoratezza di chi, non riuscendo a trovare un etimo, dichiara spurio il vocabolo la cui fonte gli è ignota). Egli cita anche l’interpretazione del Salvioni (lat. pātrius ‘paterno’) e del Rolla (lat. practicus). Come al solito, i miei predecessori scavano soltanto nel latino, anche se poi, come spesso, e come in questo caso, la loro riuscita è fuorviante. Invero, base etimologica di pádriu è il sum. padr ‘rompere, fare a pezzi’. Pádriu è un evidente aggettivale in -iu dall’originario padr, e si riferisce alla capacità del parlante di spezzare bene la catena parlata evidenziando i singoli vocaboli e facendoli intendere pianamente all’ascoltatore.
Pádulu camp. rust. (Sarrabus: corra bádua ‘corna divaricate’): questa citazione è del Wagner (DES II 204). Ma osservo che pádulu è voce inventata al posto di ádulu, bádulu. La b- di bádulu è concresciuta come spesso accade nell’intera Sardegna davanti a vocale (peraltro in Sardegna accade anche l’opposto: es. berbèke > erbéke). Base etimologica di ádulu, bádulu è il sum. ad ‘crippled, zoppo’ + ul (pronome dimostrativo: ‘quello’). Il composto ad-ul in origine significò ‘lo zoppo’ (per l’andamento poco armonioso); evidentemente col tempo s’inventò la metafora anche per le corna scomposte, altrimenti dette in Sardegna corressas (vedi).
Voci tradotte alla carlona. Abbiamo quindi che Wagner talora inventa anche voci inesistenti. Altre volte, inopinatamente, le traduce alla carlona. Faccio un solo esempio tra tanti, per non tediare.
Irrancare log. ‘arrivare, giungere’. Questa è traduzione del Wagner, il quale non solo non mostra alcun etimo, ma prende, come suol dirsi, “fischi per fiaschi”. In realtà le frasi dove si trova questa voce sono le seguenti: irrancare a pisciare ‘pisciare con ostentazione’; irrancu, irrancada ‘pisciata’; unu irrancu e pίsciu ‘un grande arco d’urina, un ponte di urina’ (Casu). Base etimologica è l’akk. reḫû ‘versare, inondare’.
Voci trattate da Wagner sotto un solo lemma. Infine annoto che Wagner praticò il particolare metodo d’intruppare molte parole sotto lo stesso lemma (onde io parlo di “lemmi a grappolo”) per il solo fatto di trovarle molto simiglianti nella fonetica (di ciò ho scritto qua e là nei precedenti paragrafi). Ma il lettore avrà capito che le simiglianze fonetiche tra parole (omofonie) non possono di per sé autorizzare quest’operazione. Tantomeno possono portare a un etimo. Affinché questo possa accettarsi, serve che le parole messe a confronto abbiano in comune un’arcaica antenata che ne comprovi la parentela fono-semantica. L’operazione, insomma, deve disegnare una sorta di triangolo, mettendo ai vertici di base le due voci a confronto, e ponendo al terzo vertice un’altra voce (quella più antica) che riesca ad unirsi semanticamente con gli angoli di base.
Per dare almeno un esempio, elenco quattro voci trattate dal Wagner sotto il lemma soru, dove purtroppo egli ha prodotto un pasticcio. Si noterà invece che le quattro voci sono legate a coppia da due diversi etimi.
Sóru ‘siero’ (del formaggio, della ricotta); (Urzulei) suru ‘ciò che resta dopo la produzione del formaggio’. Wagner ovviamente non dà l’etimo. Il lemma ha base nel sum. sur ‘premere, pressare’ e pure ‘gocciolare, piovere’ (metonimia dove s’indica l’effetto al posto del processo di caseificazione).
Assorare1 log. ‘ingrassare il maiale con siero’. Per l’etimo vedi soru.
Assorare2 (Bitti) ‘essere puzzolente’: ovos assoratos; (Talana) όu assuráu; insuríri camp. ‘idem’: pisci insuríu ‘pesce guasto’. Wagner, con nonchalance, lo apparenta a soru ‘siero (del latte)’, ignorando che il siero non si guasta mai e semplicemente si trasforma. La base etimologica è il sum. šurum ‘litter, dung; immondezza, merda, letame’.
Insuríri camp. ‘guastarsi’: pisci insuríu. Wagner lo apparenta parimenti a soru, mentre la base etimologica è la stessa di assorare2.
La dittatura dell’incompetenza. Il porkeḍḍìno. La Questione della lingua osservata dal basso (ossia, osservata a mente libera da un qualsiasi parlante capace di mettere a fuoco il pensiero dei persuasori che dall’Accademia inventano le regole), viene spesso vista come una dittatura. Nel dire ciò non intendo “politicizzare” il fenomeno linguistico, anche se altri ci hanno tentato e ci stanno tentando, come quei dotti che vorrebbero imporre una Limba de Mesanìa intesa ad unificare i vari dialetti della Sardegna.
Leggendo i primi tre paragrafi, specialmente il terzo (“È possibile sopraffare una lingua?”), il lettore avrà capito com’è difficile sopraffare una lingua. Ciò vale anche per i dialetti (o lingue regionali, o sub-regionali) che la lingua-corifea (o dialetto-corifeo) vorrebbe omologare …o sopprimere. Nel considerare la Questione della lingua, non è affatto secondario il problema dei maestri di cappella. Quanti di loro hanno esperienza e nozioni adeguate ad esercitare il mestiere? A mio avviso, quelli sinora succedutisi non erano buoni emuli di Bach ma orecchianti, gente spaesata che per caso si è ritrovata sul podio a far cantare il coro.
I vari paragrafi di questa premessa metodologica hanno evocato gran parte degli errori di metodo prodotti, a mio avviso, dai miei predecessori in rapporto alla lingua sarda, in rapporto a quella italiana ed in rapporto alle lingue mediterranee. Per far capire meglio che cosa significhi dittatura dell’incompetenza, propongo di analizzare ancora altri due lemmi.
Abbàcchio it. ‘agnello di uno, massimo due anni’; anche ‘agnello arrosto’. La voce entra nei migliori dizionari italiani per il suo prestigio, maturato dall’essere usata in Roma e dintorni; la si introduce nel novero italiano col previo marchio di “romanesca”; per ciò stesso, nell’ambito della lingua italiana essa è individuata quale “civis minoris juris”, perché non è propriamente “italiana”. Adesso assumiamo come ipotesi di lavoro che tale parola fosse soltanto sarda, parlata da 1,6 milione di persone; ebbene, essa non sarebbe nemmeno entrata nel dizionario italiano, neppure se barattata come “civis minoris juris”. Due pesi e due misure.
Questo esempio bipartito basterebbe a far risaltare l’inadeguatezza di un dizionario che vuol essere “nazionale”, che accetta il romanesco e non accetta il sardo. Quale tipo di “nazione” vagheggia quel dizionario? Ed è giustificata l’apartheid riservata ad abbàcchio classificato come “romanesco”? Quale tipo di “scavo archeologico” è stato fatto per accettare infine (sia pure con riserva) abbàcchio tra le voci “italiane”, mentre poi, paradossalmente, lo si è relegato tra quelle “romanesche”? Quanto all’etimo, il DELI acquisisce la proposta che abbàcchio derivi dal lat. ăd băculum ‘presso il bastone’, «dato che, come ci informa Varrone, De re rustica II, 2, 15-18, gli agnellini, dieci giorni dopo la nascita, vengono legati a un palo di modo che, saltando qua e là tutto il giorno, non si facciano male tra loro, e così sono allevati fino al quarto mese, allorché sono svezzati e sono immessi nel gregge». Quindi essa sarebbe voce prettamente latina. In realtà abbàcchio, a parte quell’interpretazione peregrina che qualunque persona sensata rifiuterebbe, è parola mediterranea, italiana, romana, persino sarda, ed ha base nell’akk. bakkā’um ‘belante, lamentoso’. Questa radice si ritrova nella voce greca Baccanti, e pure nel personale sd. Bakis, come altrove ho già specificato nelle mie etimologie. E non serve fantasia ad intuire un certo legame tra l’abbacchio e le Baccanti le quali usavano sbranare ritualmente i giovani animali vivi.
Ancora più eclatante è il seguente esempio relativo a una voce dalla fonetica simile.
Abbauca’, abbacca’ sass. ‘stordire, sbalordire, intontire’: è tuttu abbaucaḍḍu da li midizíni ‘è intontito dalle medicine’; una tzanda abbauccada ‘un papavero appassito’. In log. e camp. abbaccáre, abbaccái ‘rallentare, calmare, calmarsi (es. del vento, del dolore)’; su bentu abbacat. In sass. anche abbraca’ ‘diminuire, scemare’. Cfr. sic. abbacari ‘calmare, cessare, abbonacciare’; calabr. abbacare ‘stare in ozio, avere tempo libero’; così anche a Molfetta, in Abruzzo, nei dialetti italici settentrionali, es. lomb. balcà; in provenzale moderno c’è (a)baucà; cat. (a)balcar. Tutte le citazioni sono di Wagner, il quale respinge l’origine catalana soltanto perché in Alta Italia i Catalani non dominarono. Bontà sua: stando alla sua interpretazione, se i Catalani ci avessero messo il piedino per qualche anno, avrebbero potuto confermare il proprio marchio in tutta Italia, oltreché sulla Sardegna. Modo miope di studiare una etimologia, quello del Wagner. Invero, la parola è mediterranea, con base etimologica nell’akk. baḫû ‘to be thin, be scarce’, anche ‘to make emaciated’. Vedi it. abbacchiato, bacchiato ‘depresso fisicamente o moralmente’.
La vicenda di abbàcchio e di abbacchiare (abbaucca’) lascia comprendere quanto l’Italia sia zeppa di parole recanti la dignità che dovrebbe autorizzare ad usarle nel Vocabolario Italiano senza discriminazioni, senza le ascientifiche distinzioni tra “italiana” e “rurale”, tra “italiana” e “sarda” o “sicula” o “piemontese”.
La lingua italiana ha disperato bisogno di gente che ne comprenda l’esaltante, immensa, folgorante ricchezza perché, oltre a essere italiana, tale lingua è stata primamente mediterranea, e nei tempi arcaici il Mediterraneo era anche, se non principalmente, un mare sardo. Le parole che i Sardi hanno contribuito a forgiare in tanti millenni, sono ancora vive nella lingua sarda, e moltissime sono vive anche nella lingua italiana, sia pure con lievi modifiche di forma o significato. Spesso furono gli stessi Sardi ad introdurle in Italia, ma ciò è ben lungi dall’essere riconosciuto.
È metodicamente deplorevole che la lingua sarda (una lingua con 100.000 voci) sia da troppi considerata minore, mentre quando i Romani presero a forza l’isola essa era ancora in grado di collaborare attivamente al vocabolario mediterraneo. La sua vitalità è stata tale, da riuscire a mantenersi viva sino ad oggi, nonostante cinque colonizzazioni. I radicali comuni a tutto il Mediterraneo ed alla Sardegna lo testimoniano. I Romani hanno continuato per millenni ad usare le parole sarde. Nel mentre arrivò il Medioevo, superato il quale, l’Italia (+ la Sardegna) si scoprì zeppa di lingue (che ora gli studiosi, per disfarsene, chiamano dialetti). Nessuno più è in grado di capire che l’Italia era ed è composta da 32 lingue + la variegata lingua sarda + quella siciliana. Occorrerebbe gestire queste lingue in una visione unitaria ed inclusiva, se è vero che si pretende l’unità politica degli Italiani. E che fanno invece i dizionari italiani? Continuano a distinguere senza criterio, e persino ad escludere senza criterio, senza nemmeno sapere quanta vita in comune abbiano avuto le parole distinte od escluse. I dizionaristi operano alla cieca. Quando si dice dittatura dell’incompetenza…
È tale e tanta la dittatura dell’incompetenza, che l’imposizione e la conta delle parole accettate e di quelle rifiutate è una moda alla quale si applicano le migliori accademie, a cominciare dall’Accademia della Crusca. Alla quale – per quanto nata agli inizi del ‘600 per tutelare esclusivamente la lingua toscana – nessuno si sognerebbe di negare autorità e meriti. Nessuno oggi si sogna di obiettare alcunché a tale Accademia, anche perché il suo lavoro è diventato sempre più inclusivo sino alla quinta edizione ed oltre.
Ma che significa oggi includere, quando l’inclusione riguarda soltanto l’uso scrittorio anziché badare all’uso parlato delle numerose lingue italiche nell’ambito di un’unica nazione?
È tale il disastro fatto dalle Accademie, che troppi Sardi avvertono disagio nel parlare l’italiano, nell’usarlo senza remore. Avvertono di essere dominati da processi porkeḍḍìni, maccheronici. Nessuno si rende conto che un tempo tali processi erano non solo ammessi ma favoriti, essendo spesso gli unici processi che appianavano l’incontro tra portatori di idiomi diversi nell’ambito di una sola Koiné.
Porkeḍḍínu log. e camp.; puχeḍḍínu log. e sass., agg. ‘bastardo, maccheronico’ (riferito al modo di parlare, al discorso); itariánu puχeḍḍínu ‘italiano maccheronico’, fabiḍḍa’ puχeḍḍínu (avverbio) ‘parlare in maccheronico’. Il termine non è registrato nei dizionari, anche perché risulta ostico ai linguisti questo termine paronomastico riferito stranamente ai ‘maialetti’ (porkeḍḍus).
La base etimologica è invece l’akk. puḫḫu(m) ‘scambiare, sostituire’ < pūḫu ‘scambio, sostituzione’ + (w)ēdu(m) ‘singolo, solitario; hapax’: stato costrutto pūḫ-ēdu, col significato di ‘singola sostituzione (di vocabolo)’; vedi pure akk. pūḫizzaru ‘scambio equivalente’. Quindi il sass. itariánu puχeḍḍínu significa ‘italiano sostitutivo’ ossia parlato sostituendovi una o alcune parole della lingua sarda.
Ebbene, il rifiuto e la demonizzazione del porkeḍḍìno devono cessare immantinente! Il porkeḍḍìno deve essere ammesso!, anche dalle Accademie!, come procedura strutturale nella comunicazione verbale. Nessun sardo deve sentirsi discriminato. Anche perché, focalizzando l’uso che si fa dell’italiano non in Sardegna ma nella Penisola, notiamo che tutti i Continentali (sos Terramannésos) si esprimono reciprocamente tra di loro senza alcuna remora, nonostante che si percepisca molto spesso il loro ancoraggio indefettibile alla lingua del proprio territorio. Nessuno di essi se ne vergogna, e nessuno dei “puristi” s’adonta nell’ascoltarli. Anche loro, tra Italiani, parlano porkeḍḍìno.
Nell’osservare e mettere a confronto il fenomeno dell’incompetenza e dall’altra quello del porkeḍḍìno, percepiamo soltanto i cachinni degli idioti, i quali credono d’essere aquile mentre sono ridicoli polli. Gli idioti sono facilmente identificabili tra certi giornalisti o certi attori i quali, avendo ricevuto un’educazione stringente e rigorosa all’uso di quella che gli è stata additata come “lingua italiana”, mettono sempre alla berlina la gente più in vista (parlamentari, ministri, uomini e donne di successo) per la loro “alienità”, per la distanza tra la loro parlata e la cosiddetta “lingua italiana”.
Io chiamo ciò dittatura dell’incompetenza, poiché questi giornalisti ed attori sono stati assoggettati alla dittatura del buon dizionario, della buona vocalità, alla dittatura di una grammatica e di una sintassi ritagliate su misura. Con tale formazione, quei saputoni non si rendono conto che l’avverbio KE usato al Sud Italia al posto del SE toscano ha lo stesso valore, ed è identico al KI campidanese (segno di una Koiné mediterranea plurimillenaria). Parimenti, quei giornalisti sono lungi dall’avvertire d’essere immersi nel brago dell’ignoranza allorché criticano la gente del Sud Italia per il fatto che “maneggiano male” la sintassi italiana. E non sanno che la sintassi “italiana” ricalca la falsariga della sintassi latina (la sintassi del latino ciceroniano), mentre gli Italiani del Sud, eredi della lingua greca, non subirono mai una sintassi così rigorosa e limitante, visto che l’antica lingua greca preferì la massima libertà d’espressione, la quale spessissimo si risolveva, persino nei massimi scrittori antichi, con forme sintattiche molto simili a quelle dell’attuale inglese, saltando a pie’ pari le forme congiuntive e condizionali. Imporre a quelli del Sud una grammatica e una sintassi ancorate al latino, è una violenza.
La purezza della lingua. Il campidanese rustico. I due paragrafi precedenti sono legati in certo qual modo alla “purezza della lingua”, la quale a sua volta non può scindersi da tutte le considerazioni sin qui fatte in questa premessa metodologica. Stiamo imparando che i dotti che pretendono padroneggiare la questione della purezza sono molti ma alquanto impreparati.
Paradossalmente, Wagner fu il più grande scopritore della “purezza” sarda. Dico paradossalmente, perché anche lui fu legato alla moda prevalente di chi vuole abbandonare le lingue minori alla libera invasione da parte delle lingue dominanti, senza alcuna cura di proteggere il patrimonio storicamente costruito nei millenni. Oggi migliaia di parole inglesi s’introducono nella lingua sarda, nella lingua italiana, nelle lingue non più egemoni nelle faccende internazionali. L’inglese è fenomeno che tarla da 60 anni. Ma l’italiano tarla il sardo da 3 secoli. Certamente le accademie (ad esempio la Crusca) hanno fatto del loro meglio per scacciare il tarlo dalla propria lingua. Ma sono voces clamantis in deserto, nel bene e nel male. Epperò è una fortuna che l’Italia abbia una accademia. Mentre la lingua sarda non ha alcuna protezione accademica (mi rifiuto di chiamara “accademici” gli attuali linguisti delle due Università sarde). La Sardegna non è Israele, che difende la propria lingua ed i propri vocaboli con tutti i mezzi possibili: fare buona politica significa anche questo. Ma occorre attenzione e distinzione, poiché Israele fonda la propria accademia con degli scopi peculiari. Noi in Sardegna, se vogliamo puntare a una nostra “Crusca”, dovremo farla operare solo ed esclusivamente nel vasto e fruttuoso ambito che ho tracciato in tutti i paragrafi precedenti. Altrimenti quell’accademia produrrà soltanto… crusca.
Il mio compito di etimologo non può affatto prescindere dalla difesa del patrimonio linguistico consolidato dai Sardi. Nel far ciò, mi sono chiesto quale sia il patrimonio da difendere e quali vocaboli spuri da “rispedire al mittente”. Anch’io ho dovuto fare una scelta, cominciando ad espellere dal Dizionario del Wagner 690 voci, che ho messo a disposizione, per il controllo da parte del lettore, nell’Appendice a questa premessa (v. infra).
Di questo “taglio” (pari al 10% dei lemmi trattati dal Wagner) mi assumo piena responsabilità. E dichiaro, addossandomi anche qui la responsabilità, che lo smalto della lingua sarda con tale operazione non è stato del tutto rilucidato. Rimangono ancora delle opacità. In quest’ottica, mi sono assunto la responsabilità di dichiarare come accatti almeno il 15% tra i vocaboli da me risparmiati entro il corpus del Wagner e trasferiti entro il mio Dizionario. E così siamo al 25% dei lemmi che furono accolti dal Wagner e da me rifiutati (o accettati col marchio). Insomma, io dichiaro accettabili nel patrimonio consolidato della lingua sarda soltanto i ¾ dei lemmi proposti dal Wagner, oltre a qualche migliaio di voci sinora indagate per mio conto.
A giustificazione dell’operazione da me condotta, dichiaro di ritenere assurdo l’introdurre in un vocabolario le voci spurie, appartenenti più propriamente a un altro vocabolario. So perché Wagner le introdusse nella lingua sarda: egli le considerava acquisite dall’uso sardo. Ma è proprio a questo punto che s’erigono le barricate e si scatenano i conflitti. Un conflitto che non si placa barattando la percentuale degli accatti (mille in più, mille in meno, come dire che Wagner avrebbe sbagliato per eccesso o per difetto): non siamo al mercato delle vacche. Io dichiaro che Wagner eccedette per una ragione ben precisa: la sua conoscenza diretta della lingua sarda parlata dalle genti paesane e montagnine era poco profonda. Voglio dire che Wagner peccò d’ignoranza (nonostante la sua grande erudizione), non avendo indagato a sufficienza la lingua sarda, ed avendo tralasciato l’indagine diretta in numerosissimi villaggi. Ciò si evince anche dal DES, dove egli cita come fonti dirette meno di 40 villaggi, quelli un tempo serviti da strade percorribili con mezzi a motore. Ne rimane fuori il 90%.
Per intenderci, Wagner svolse la seguente operazione: prima dell’indagine diretta trasferì nel DES tutti i vocaboli acquisiti (e tradotti) dai suoi predecessori nelle loro indagini, in qualsiasi forma condotte. Per il campidanese egli acquisì, oltre ai lemmi delle Carte Volgari, tutto il Dizionario del Porru, senza tener conto che Porru, cent’anni prima, aveva già infarcito per suo conto il proprio Dizionario con una gran massa di vocaboli italianeggianti. Questo fu il primo errore del Wagner, poiché il Porru non aveva infarcito il Dizionariu con gli accatti liberamente adottati dagli indigeni. No, non lo aveva fatto. Porru aveva infarcito la sua opera di voci italiane scelte da lui (non dal popolo) con l’intento ideologico di spurgare la parlata campidanese dai vocaboli che considerava troppo rustici o popolani. Porru fece un gigantesco errore metodologico, una “pulizia etno-linguistica” che io ho già denunciato al cap. 1.1 della mia Grammatica Storica; a sua volta Wagner trasferì nel DES quel macroscopico errore, nonostante che ne fosse avvertito, poiché il Porru aveva dichiarato esplicitamente il proprio intento nella prefazione al Dizionariu.
Potrei continuare indicando le altre fonti del Wagner, anch’esse nutrite d’inserimenti spuri ed ideologici, sia pure non dichiarati con sicumera secondo lo stile del Porru. Davanti a tale sfacelo metodologico, mi è stato forza intervenire sul Wagner con tagli o esplicite avvertenze.
Oltre agli italianismi, Wagner introdusse nel DES anche numerosissimi catalanismi e spagnolismi. Molti di questi sono accatti (valutabili al 15% dei lemmi del DES). Ma qui è più arduo stabilire se l’accatto sia stato operato dal parlante sardo, oppure sia stato Wagner ad aver forzato la situazione, inserendolo nel DES con atteggiamento ideologico, replicando il comportamento ideologico del Porru. Infatti sappiamo con quanta protervia Wagner sostenne che la lingua sarda fosse stata iberizzata fino al midollo. Il suo “derivazionismo” filo-iberico non è accettabile, e l’ho già dimostrato e discusso in alcuni dei paragrafi pregressi, specialmente in quello intitolato “La pregiudiziale iberica”.
Al riguardo, l’unico grimaldello in grado di evidenziare, schiavare e mettere “con le spalle al muro” i troppi accatti del Wagner è la considerazione che l’indagine fatta dal Wagner sulla lingua sarda partì sempre dalle città, specialmente da Cagliari quale “capofila” del Campidano meridionale; Oristano quale “capofila” del Campidano centrale; ed anche Nuoro come “capofila” della parlata nuorese. Una cartina di tornasole privilegiata, per lui, fu sempre Alghero per la testimonianza della pervasione catalana sulla lingua sarda. Operazione scorretta, quella di Alghero. Ma furono scorrette anche le altre “basi” di partenza, che invece per lui costituivano dei veri capisaldi culturali, le fonti da cui la lingua sarda s’irradiava contaminando il contado, il mondo dei villaggi, il mondo delle montagne. Un’operazione, la sua, che fu esattamente contraria a quanto una indagine scientifica sulla lingua sarda avrebbe dovuto fare. Questo è almeno il mio parere.
Infatti, tenuto conto che la lingua sarda esiste viva e vegeta da almeno 40.000 anni grazie al diuturno uso dei montagnini, dei pastori, degli agricoltori, pretendere di considerare le città (specie quelle costiere) quale base d’irraggiamento della lingua sarda verso l’interno significa dimenticare che le città furono prese e ripopolate ab imō dapprima dai Romani, poi da Pisani e Genovesi, poi dai Catalani, poi dagli Spagnoli, poi dai Torinesi e dagli Italiani. Wagner non tiene conto che furono invece le città a ricevere volta per volta la genuina linfa dell’autoctonia da is biḍḍáius, dai biḍḍíncuri che via via le ripopolarono di elementi genuinamente sardi, scacciando gradatamente, se non tutti, almeno parte degli elementi coloniali.
Oggi non è più tanto facile, se non in pochi casi, distinguere tra accatto operato dai Sardi e accatto operato dal Wagner. Però nel mio Dizionario ho tentato – molto prudentemente – di farlo. C’è peraltro un macro-elemento che aiuta la mia cernita ed àncora la mia indagine alla procedura scientifica: è l’elemento del “campidanese rustico”, patrimonio prezioso che spesso è testimone dell’antichità (e sardità) del vocabolo. Wagner distingue spesso tra “campidanese” e “campidanese rustico”. Fa questa distinzione nella presunzione che il prototipo sia sempre quello “campidanese” (la parlata del Campidano di Cagliari), al quale affianca con pari dignità il “cagliaritano” parlato in città. Insomma, la parlata del Sud viene da lui tripartita, e da tale operazione si apprende che il “campidanese rustico” per Wagner rimane sempre un sotto-tipo, un elemento corrotto, una dimensione retrograda vissuta da gente poco capace di fare la storia di una lingua.
Io, come si è visto, la penso al contrario del Wagner, anche se nel presente Dizionario ho preferito spesso intruppare sotto l’unica qualifica “campidanese” i lemmi marcati dal Wagner come “campidanese rustico”. Tenuto conto che il cosiddetto “rustico” ha inflessioni particolari, difficili da rendere graficamente (specie per San Vito), ho evitato di scrivere gli strani caratteri usati dal Wagner, poco utili alla percezione da parte del lettore. Ho preferito invece scrivere quei vocaboli come ho scritto i consimili del Campidano di Cagliari, senza contrazioni né “colpi di naso” (operazione che ho replicato anche quando ho dovuto evitare i “colpi di glottide” del nord-Barbagia). Il fatto che la maggior parte dei vocaboli sarrabesi e gerreini siano condivisi anche dal Campidano di Cagliari (poiché condividono le stesse radici), può considerarsi quasi sempre una reciproca garanzia di autenticità. Nei rari casi in cui il vocabolo appaia solamente come “campidanese rustico”, a maggior ragione l’ho registrato per la sua preziosità. Tutto ciò è bastante per un etimologo.
Tutto quanto precede, però, sarebbe stato incongruo dirlo per la difesa della lingua italiana; tanto più incongruo lo sarebbe per la difesa della lingua inglese, oggi dominante nel mondo. Le lingue, purtroppo, non convivono tutte paritariamente. Non è vergogna ammettere che tra di esse c’è una scala, e la lingua dominante tende inesorabilmente a comprimere, erodere, annebbiare, sminuire, infine abolire la lingua minoritaria contigua. È un po’ lo stesso fenomeno della foresta. Le piante nobili sono tali perché crescono sotto la protezione del sottobosco. Ma poi s’evolvono, superano in altezza il sottobosco, ricoprendolo infine con una vasta chioma. È quindi il sottobosco ad essere dominato e “tenuto a bada”, quando non impoverito per l’assenza della luce catturata dalla chioma dominante.
Fuor di metafora, va detto che una lingua minoritaria non ha bisogno di una vaga “liberta”, impossibile da gestire al confronto con le lingue egemoni; ha bisogno invece di protezione (da non configurare come una campana di vetro!). Pertanto sono da condannare sotto ogni punto di vista le assurde “libertà” cui le sottopongono certi dottori in Lettere, i quali hanno della lingua (di qualunque lingua) una nozione gracile e bettolesca, priva di rigore scientifico. A maggior ragione le lingue minoritarie sono nemiche di ogni tipo di slang, poiché l’invenzione dello slang da parte di buontemponi incapaci di mettere a valore il proprio tempo libero, è perniciosa, deleteria. Infatti lo slang viene orecchiato e imposto proprio dai parlanti meno motivati all’uso e alla salvezza del “thesaurum”.
Il “thesaurum” della lingua sarda c’è, è cospicuo, è saldamente ancorato a radici plurimillenarie che ancora oggi si lasciano esattamente comprendere. Andare a inventare di sana pianta forme “sradicate” (lo slang, appunto) è operazione demenziale che porterebbe prestissimo alla sparizione della Lingua. Lo slang medesimo è di per sé una miserrima operazione anti-culturale prodotta da chi non ha alcun amore né rispetto per la cultura, da chi, per intenderci, ha già resecato il cordone ombelicale con la lingua-madre e di essa si fa sarcasticamente beffe con segni di dispregio e di commiato definitivo.
L’ortografia sarda e sa Limba Sarda Comuna. Nella lingua inglese esistono circa 40 suoni fondamentali, ma le forme ortografiche per rappresentarli sono oltre 500; non è un caso che i bambini inglesi siano molto più soggetti di quelli italiani alla dislessia: un disturbo neurologico non da poco. La complessità del sistema di scrittura anglosassone rende incapaci molti residenti di leggere e comprendere un intero scritto pur comprendendo ogni singola parola. In Italia la situazione è notevolmente migliore perché la differenza tra pronuncia ed espressioni ortografiche è meno astrusa, e semmai capovolge il rapporto numerico.
La Sardegna, dopo 1000 anni di anarchia ortografica, si pone soltanto oggi il problema del rapporto tra espressione fonica e corrispondenza ortografica, e con le regole della LSC (Limba Sarda Comuna) vorrebbe mirare a semplificare ulteriormente, rispetto all’italiano, il rapporto suoni/ortografia. Senza però riuscirvi appieno. Infatti il sistema LSC incorpora parte del sistema italiano (e parte del sistema spagnolo), lasciando nel caos – per fare un esempio – la grafia delle velari e delle palatali. In questo Dizionario il mio sistema tenta di sanare almeno in parte quelle discrasie normative della LSC.
A scanso di equivoci, avverto il lettore che i singoli lemmi del mio Dizionario non vengono scritti utilizzando i caratteri fonetici internazionali (i quali sommano a circa 300), anche perché essi mancano sulla tastiera del computer e comunque genererebbero nel lettore più confusione che rilassatezza. In omaggio a Wagner, concedo eccezionalmente alle dentali sonore sarde l’espressione grafica -ḍḍ-. I miei lemmi sono di regola scritti con i pochi caratteri storicamente attestati nel Mediterraneo centro-occidentale, al fine di agevolare il lettore a capire istantaneamente la parola espressa, evitandogli d’impelagarsi in un sistema tecnico inventato dai fonetisti, del quale è destino che siano gli stessi fonetisti a rimanerne fruitori unici. Ho inoltre scelto, stavolta in omaggio al sistema della LSC, di non scandire i lemmi col sistema accentuativo internazionale (quindi non in-kendere ma inkèndere; non inkime-rare ma inkimerare).
Il sistema grafico da me adottato, disancorato dalla pletora delle grafie internazionali (e con l’occhio indulgente alla ridotta disponibilità della tastiera), si trascina pur sempre delle imprecisioni residue. Ma questa maledizione perseguita anche i grammatici di buona volontà, non essendo tecnicamente possibile ridurre a tre decine i 300 caratteri fonetici, senza che ciò comporti delle “sbavature” grafiche rispetto alla pletora dei suoni idiomatici, che in Sardegna superano largamente i 30. Ma spero di avere proposto, rispetto alla LSC, un numero di caratteri che, per quanto pari a quelli della LSC, giungano a un climax più equo, tale da permettere all’utente di comprendere meglio il testo sardo, senza alcun disturbo percettivo.
Termino le avvertenze sulla grafia con un cenno alle consonanti rafforzate (le doppie). La LSC tende a renderle tutte scempie, salvo eccezioni che rendono ondivaga la scelta, dal momento che prende a modello le forme latine ed al contempo se ne libera a piacere, senza criterio. Notiamo che la LSC giustifica la sua originale “aspirazione alla semplificazione” con (non meglio chiarite) “esigenze etimologiche”. Esprimo sconcerto dinanzi a quelle affermazioni, dal momento che la fonte etimologica della LSC rimane saldamente ed unicamente il latino, il quale peraltro nel proprio sistema contiene sia le scempie sia le doppie.
Al riguardo ho ampiamente fatto osservare in questa premessa metodologica che delle etimologie, in Italia e in Sardegna, è stato fatto un autentico vituperio. Anche sulla vicenda delle scempie/doppie sarebbe ora di stendere un velo pietoso.
Tocca a me, a questo punto, dichiarare responsabilmente la mia scelta al riguardo. Ebbene, al contrario della LSC, dichiaro di utilizzare le doppie, ma limitatamente ai momenti in cui ciò serve veramente. In tal guisa, spero che la mia scelta non presenti alcun carattere ondivago, avendo legato le eventuali doppie al vero etimo della voce. Per l’occasione ho tenuto conto di un fatto a un tempo storico e tecnico, ossia che le doppie, almeno nella tradizione italiana, sono spessissimo il risultato dell’incontro di due consonanti differenti appartenenti a sillabe differenti (es. -c-t-, -p-t-, -d-c-). Tale ragione storico-tecnica m’induce a non sottovalutare la tradizione scrittoria dell’italiano, dalla quale attingo fintanto ch’essa non debordi dal quadro di coerenza appena citato.
Peraltro nessuno ha mai criticato l’uso di scempie e doppie fatto dal Wagner (un uso anch’esso trascurato, quindi ondivago). Come unico esempio indicherei fittianu, che in base alla vera pronuncia ed in base alla vera etimologia deve essere scritto fitianu.
Presento di seguito l’elenco dei 30 segni grafici da me adottati. Parecchi di questi meritano delle precisazioni per i problemi che pongono alla lettura dei testi in lingua sarda.
Elenco: A, B, C, D, E, F, G, GH, GL, GN, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, SC, T, U, V, X, Θ, Z, TZ.
Precisazioni
1) Il segno B non si presta a molte varianti, tranne che nel logudorese settentrionale e specialmente nel sassarese, dove esprime non soltanto la /b/ vera e propria ma anche molte voci dove la /b/ s’avvicina alla /v/ e spesso sosta in una terra di mezzo, svanendo in una spirante bilabiale appena soffiata (quasi come fanno i cubani per pronunciare La Habana).
2) Il segno C
Wagner usa questo segno, espresso però con /č/, soltanto per indicare la consonante palatale o comunque per esprimere la consonante seguita da vocali palatali. Esempi: dίccia (che Wagner scrive dίčča), dispacciare (Wagner: dispaččare), ciorixeḍḍa (Wagner: čorižèḍḍa), círcuri (Wagner: čírkuri).
Io, come si noterà, seguo l’esempio italiano, usando c-, -c- sia per le velari sia per le palatali nei vari casi che ora vado ad esplicare:
– anzitutto con c-, -c- marco la palatalità sia della consonante sia della sonante successiva (es. cibíu);
– con c-, -c- esprimo anche le velari nei casi in cui la sonante seguente non sia palatale: es. casu, cosa. Escludo l’uso della c-, -c- per le velari seguite da -u- + sonante (per questo gruppo uso qu-: vai al punto 11).
La mia scelta semplificante ha una ragione storica importante ed unificante, cioè che C è grafema latino di estrema antichità, avente lo stesso valore (ed essendo la semplificazione grafica) del gr. K. Non solo, C è lo stesso segno della velare ebraica kaph (scritta a rovescio: Ͻ). Quindi la tradizione dell’uso di questo segno è plurimillenaria e mediterranea. Che poi dall’Alto medioevo la C sia usata anche per le palatali, è segno che la cultura latina non sentì mai il bisogno di sdoppiare questo grafema.
3) Il segno D
Tutte le volte che una parola sarda esprime un’alveo-dentale rafforzata, Wagner scrive /ḍḍ/, come in biḍḍa. In ciò ho seguito fedelmente Wagner. In certe sub-regioni o in certi villaggi c’è qualche leggera variazione nella pronuncia della consonante /d/. Wagner lo fa osservare, e pertanto scrive moltissimi vocaboli in -đ- (es. biđale ‘ditale’; io scrivo bidale).
4) Il segno G
È scritto dal Wagner con ğ quando esprime l’affricata prepalatale sonora, come nell’it. gente. Es. gáğğu (Dedola: gággiu). Altre volte è scritto col suono velare sonoro fricativo: es. fóiǥa (Dedola: fóiga).
5) Il segno GH
Viene espresso dal Wagner col segno occlusivo velare sonoro davanti ad e, i: ĝiníperu ‘ginepro’ (Dedola: ghiníperu). Altre volte è scritto col segno velare sonoro fricativo: diǥitale (Dedola: dighitale).
6) Il segno GL
Wagner lo scrive col carattere l’ (palatale, come in it. figlio). Io preferisco l’uso italiano gl.
7) Il segno GN
Wagner scrive /ñ/: es. diñu (Dedola: dignu), diéñu ‘zimbello’ (Dedola: diégnu). Altre volte Wagner scrive n’ (da leggere come in it. vigna). Io preferisco sempre -gn-, perché la -ñ- manca nella tastiera del computer, e perché n’ non appartiene alle tradizioni mediterranee.
8) Il segno J
Questo segno è da me preferito rispetto ad -y- che invece è usato a piene mani dal Wagner. La ragione è semplice: i vocaboli del Wagner in -y- sono soggetti a frequenti metafonesi che li fanno pronunciare con -j- (come j francese o inglese). Di qui la mia preferenza. Es. yáyu ‘nonno’ (Dedola: jáju, poiché la prima semiconsonante in sardo è pronunciata spessissimo -g- come in it. gente).
9) Il segno K
È da me usato per le velari precedenti le palatali /e/, /i/, e soltanto per queste. Ciò per non sottostare al doppio carattere italiano ch- -ch- preferito invece dalla LSC. La mia preferenza è in linea con l’identica pratica dei condaghes e di altre carte antiche della Sardegna. Peraltro questa scelta rispetta la natura velare del carattere, nonché l’identico uso presso gli anglosassoni.
A sua volta Wagner, nell’esigenza di evidenziare qualsiasi tipo di velare, usa largamente la /k/ davanti ad ogni vocale; quindi kaduffu (Dedola: cadduffu), kasu (Dedola: casu), kena (= Dedola), kida (= Dedola), kokka (Dedola: cocca), kras (Dedola: cras), kunnu (Dedola: cunnu), kuḍḍu (Dedola: cuḍḍu).
10) Il segno L
Oltre agli usi normali della grafia italiana, questo segno è da me proposto talora nell’uso sassarese con grafia Ł, ł, ogni qualvolta io intenda esprimere la /L/ fricativa laterale, quella che precede -t-, -d- esplodenti dopo il “fregamento” laterale della lingua (v. fałta, fałdetta). Gli stessi grafemi sono da me utilizzati, sempre per il sassarese, per esprimere l’incontro di -r-t- o -r-d-; es. lardu log. e camp. ‘lardo’, sass. lałdu.
11) Il segno Q
Intendo fermamente proseguire nell’uso di Q, nonostante che le norme della Limba Sarda Comuna (ed. 2013, p. 17) lo vietino favorendo al suo posto lo spagnolesco C (es. cuadru, cuatru, ácua). La velare Q si trova primamente nell’uso delle lingue semitiche (accadico etc.: le quali addirittura hanno quattro segni per distinguere quattro velari: q, k, ḫ, ḥ); poi la stessa Q si ritrova nell’uso latino, e passa nell’uso grafico italiano. Ciò basta ed avanza per rifiutare l’imposizione della LSC, che va nella direzione di nobilitare acriticamente la moda spagnolesca inaugurata partigianamente dal Wagner.
12) il segno S
L’orecchio del Wagner era indubbiamente addestrato a percepire le minime differenze fonetiche. In tal guisa, il vocabolo da me scritto sderroccái da lui è scritto śderroccái (ś alveolare); il vocabolo da me scritto dismajare è scritto da lui diśmayare. (Per meglio comprendere la y del Wagner vai a j).
13) Il segno SC
Wagner scrive sempre š. Io ho preferito la complicata sc, sci (all’italiana). Quindi: Wagner šorroccái (fricativa dentale), Dedola sciorroccái; Wagner šorái, Dedola sciorái. Peraltro š non esiste sulle mormali tastiere del computer.
14) Il segno X (= gr. χ)
Giusto l’ampio uso fàttone dal Wagner, c’è bisogno d’introdurre questo grafema al fine di rendere meglio i suoni del dialetto sassarese, che del grafema hanno bisogno per esprimere il log. o sd. -rc-, -sc-. Quindi: log. barca → sass. baχa; log. áscamu → sass. áχamu.
15) Il segno X (= fr. j)
Wagner lo rende con ž-, -ž- (es. čorižèḍḍa, ážina), mentre io preferisco la -x- (es. čorixèḍḍa, áxina). La mia preferenza è dovuta al fatto che da parecchi secoli in Campidano si usa la grafia -x-, ed inoltre quest’uso è identico a quello degli Etruschi; storicamente è tramandato anche dai Catalani. Quindi nel Mediterraneo questo carattere non fu affatto sconosciuto, e non c’è bisogno di sostituirlo con una innovativa ž, peraltro inesistente sulla tastiera del computer.
16) Il segno T
Anche questa esplosiva interdentale, che sembra pulita e inconfondibile, in Sardegna presenta qua e là qualche variante fonica che la riconduce agli usi da me raggruppati sotto il segno θ. Vedi le alternanze rilevabili per uno stesso omo-semantema, quale sd. tanda/tzanda ‘papavero’; sd. tumu/gr. θύμος ‘timo; sd. tura < sum. zur ‘nerezza’.
17) Il segno Θ
Segno greco introdotto da Wagner per distinguere certi fonemi appartenenti ad unica radice, da lui espressi variamente per le varie sub-regioni coi simboli tz, z, zz, th, tt. Esempio: aθθéθθu (Bitti, Nuoro, Dorgali), θénθu (Baunei), distinti da atténtu, attéttu log., atzentzu (S.Lussùrgiu), séntzu camp. ‘assenzio’ (Arthemisia absintium). Wagner con la lettera θ volle indicare l’esplosiva dentale simile alla th inglese. Ho accettato di scrivere la θ quasi le stesse volte del Wagner, pur non condividendo la sua rigorosa esigenza distintiva; esigenza peraltro non necessaria, bastando volta per volta l’uso di una o dell’altra consonante da me qui riprodotte per esprimere la reale pronuncia espressa nelle singole sub-regioni.
18) Il segno Z
Indica esclusivamente la z-, -z- sonora come in ziru ‘orcio, giarra’, eventualmente rafforzata (-zz-) come in azzu ‘aglio’. Wagner la esprime con dz-, -dz-, rafforzata in ddz-, -ddz-.
19) Il segno TZ
Indica esclusivamente la tz-, -tz- sorda (in italiano: z- -zz-) come in tzaccare ‘fendere, spaccare’, o atzárgiu ‘ferro, acciaio’.
La tz (esplosiva dentale sorda) è stata espressa nella lingua sarda in vari modi, anche con i caratteri ts: vedi log. ant. dirittsadores (Stat. Castels.: diriçadores). Sembra che Wagner prediliga proprio la forma ts, tts, con la quale egli ha scritto moltissimi vocaboli da me espressi invece con la tz.
APPENDICE: Elenco lemmi del D.E.S. esclusi dal No.F.E.L.Sa.
Abate, abbáttiri, applikare, appoggiai, apporkai, apostadamente, appraniare, appresare, appretziare, appuntare ‘cucire leggermente’, aranguitzu, arantzu, arkette, arkibusu, arcione, ardidu, arengu, arghentu, arghidda, arguire, argudzinu, arma, armigoddu, arrabbiare, arrancare2, arrapillai ‘ripigliare’, arrappiare ‘rapire’, arrecabai ‘ricavare’, arrefa, arregordai, arrembumbare, arremusulla, arrèndirisi, arrenomenai ‘nominare’, arrepentire, arrivare, arritzare, arruffare, arrughire, arrustire, arte1, ascultare, ásinu, asma, asperges, aspersorio, aspettare, aspu (e naspu), assaltare, assazzare, assembrare, ássidu ‘acido’, assistere, assuntu, asta, astile, ástiu, astutu, asurru ‘azzurro’, ascendere, ascensione, asciugare, asciuttu, asuttu, attaccare, attediare, attenticare, atterrire, attilladu, attuffare, atturdire ‘stordire’, ausente ‘assente’, autu ‘atto’, avarìa, avaru, avemaria, avidu, avvalirisì, avvértere, atzéndere, azzuttare ‘aiutare’. Totale 81
Baccánu, bagamundu, baia, baiu, balaustru, baldanza, baleriana, balire ‘barile’, balordu, baluardu, banchina, baraunda, barbaridadi, barbéri, barbugliai, bardadura, bardottu, barella, bártziga (gioco di carte), basìlica, bassottus, basta, bastarda, bastardu, bastimentu, bastinu, battazzu, báttere, battéu, beccàccia, beffa, belare, belladonna, benignu, benzìna, berrùga ‘verruca’, bessare ‘versare’, béstia, beta ‘bietola’, bicicletta, bidriólu ‘vetriolo’, bile, bìglias ‘biglie’, binistra ‘ginestra’, biscottu, bisquadru, bistorinu ‘bisturi’, bistrattare, bizzarru, blandu, blusa, bóccia, boda ‘botte’, boga (pesce), bomba, bonatza, bòo, borbottare, boscu, botta ‘colpo’, bottáju, bravata, bravu, brίcola1, briglia, brindare, brogliatzu ‘brogliaccio’, bróu, bruncu1, brunu, bruscu, bùccia, búcculu, bugliólu, bùiu, burdellu, burdone ‘contrabbasso’, buriàna, burίnu ‘bulino’, burò ‘canterano’, burrasca, burru ‘gioco di carte’, burtsu ‘polso’, buttìglia. Totale 80
Cabanna, caffè, calafattare, calamari ‘calamaio’, calamidade, calancà (sorta di tela), caldaròne, caldu ‘brodo’, calìgine, calma, calmúk, calòre, calùra, calvu, caltzare1, caltzettéri, caltzoláju, caltzones, camúsciu ‘camoscio’, canavácciu, cannétu, cannocciale, cantârida ‘cantaride’, caparra, capigliè, capitanu, capòccia, cáppara!, cappella, cappellanu, cappone, cappuccínu, carabinéri, caramella, cárdine, carésima, carestìa, caríssia ‘carezza’, carreyone ‘carnagione’, cartúccia, casacca, casána, cáspita, cassarola, càssula, castorru ‘cappello di castoro’, cáttara!, cautela, cavessa ‘cavezza’, céfalu, centáura (Centaurium), cérnia, cértu ‘certo’, cicculatta, cimitériu, cinematόgrafu, cipressu, ciuffu, ciurma, cognakki ‘cognac’, collana, còllera, colore, colostru, comunigare ‘comunicare’, congeniái ‘convenire’, coniurare, conkistare, conservare, contentu, contestura, controvérsia, coraḍḍu ‘corallo’, corággiu, coroḍḍa ‘corolla’, corrèggere, corrugái, coscίnu ‘cuscino’, crésima, crespu ‘tela di seta’, criantza, cricca2, cricca3, crίmene, crine, crista, cristallu, cristèle ‘clistere’, cristianu, Cristu, crosta, cuaglia, cuartu, cubare ‘covare’, cullega, culpa, cumbattàre, cumbáttere, cumpagnu, cumparare, cumprèndere, cundennare, cunduttu. Totale 110
Damascu, dantsare, debusciau, deféndere, déntike ‘dentice’, determinare, devastare, dilúviu, din ‘danaro’, discípulu, discretu, dispéndiu, dispettu, donzella, dossu ‘dorso’, dottrina, duana ‘dogana’, dulcamara. Totale 18
Ecclisse, èdera, érpice, escluíri, esécuias, esigíre, esímere, espressare ‘esprimere’, estínghere, estremuntsiòne, evangéliu. Totale 11
Faccenda, fagottu, falcone, fangu, fantasma, farina, fellone, feluga ‘feluca’, fiancu, fiera, fiducia, filone ‘astuto’, flanella, flemma ‘spurgo del catarro’, fléttere, fluíre, fluttu, folada ‘folata’, fonte, forgiái ‘foggiare’, forma, formica, frana, frángia, frotta, fundare, furtu, furúnculu, fuscu. Totale 29
Gábbia, gabella, gabellottu, gaḍḍína, galibardìna (varietà di gallina), gagliardu, garitta, gasetta ‘gazzetta’, gelosu, gentziana, ghiácciu, ghirlanda, giallu, giarrettéra, giassintu ‘giacinto’, gilè (relativo a un gioco di carte), girándula, giubiléu, glòria, gobba, golfu, gonfalone, graduare, graffiare, gressinu ‘grissino’, grida, gríglia, grillu, grúccia, grúe (uccello), grumma, grumu, grunda, gualdrappa, guante ‘guanto’, guarnire, guastare, guérciu, gúmena. Totale 39
Imbastire, imbáttere, imbidai ‘invitare’, imbraga ‘imbraca’, impedire, impiastru ‘cataplasma’, impicciare, importunare, imposta ‘tassa’, impostore, impostura, improverare ‘rimproverare’, imputare, incabigliare ‘accapigliarsi’, incarnadu ‘incarnato’, incastrare, inclinare, inclúiri, increadu, incuadernare, incensu, ìndigu ‘indaco’, indìvia, infermedadi ‘malattia’, insalada, intantu, intempèrie, intermesu, intimare, inzegnéri, isbáttere, isbirru, iscansìa, iscartafógliu, iscartare, iscassu ‘scarso’, iscátula, isciallu, isfarzu ‘sfarzo’, iskeda, iskiera, iskiffu, iskitzare, ismarrire, isopu ‘santoreggia’, ispásimu, ispilórciu, ispinatzu ‘spinacio, spinaci’, ispinette ‘spinetta’ (strumento musicale), ispitale ‘ospedale’, isprolokkiare, ispuntare ‘spuntare’, istabilire, istincu, istίtigu, istivare, istoccu ‘stocco’, istrapatzare, istrappare, istrapuntu ‘strapunta’, istraviare ‘togliere dalla via’, istringa, istufare, ίsula, isvalorire, iumentu, iustu. Totale 80
Kidru ‘cedro’, kimera, kìmighe ‘cimice’, kina ‘chinino’, kìnghere ‘cingere’, kintàna ‘quintana’, kitáde ‘città’. Totale 7
Labare ‘lavare’, lambiccare, lanterna, lapida ‘lapide’, lastra, latrina, latta, lavamanu, lavandinu, legùmene ‘legume’, leίtimu, letanìas, lìnia ‘linea’, lίttera, lizzadru ‘leggiadro’, lordu, lucru, lupu, lusingare, lustrare, luttare, luttu, luttsu ‘luccio di mare’. Totale 23
Magestade ‘maestà’, malandrinu, mandίbula, mangerίa, mániga, manovra, manzu, marcurella ‘mercorella’, maretta, margherita, mariólu, marionetta, marmotta, marramáu, martsapane, massacru, masserίtzia, masticare, mattone, mattutίnu, mélica ‘medica (erba)’, melissa, mendicare, mendίgu, mentirosu ‘bugiardo’, merenda, mermelada ‘cotognata’, méru ‘puro’, mèsse, méstruu, minestra, moda, molare (dente), mòrdere, morίa, muččačča, muffa, mustarda. Totale 38
Natzione, negare, negru-de-fumu ‘nerofumo’, nervόsu, néspula. Totale 5
Oca, occiales, odore, offèndere, olfátu, onta, όnus ‘peso, carico’, opprίmere, ordίre, orίna, òrma, òro, osare, òstia, ostinare, ottanta, ottòbri. Totale 17
Pa ‘bacio’, pacotίglia, paccioccòne, padiglione, paèse, palitsada, páncia, paòne ‘pavone’, pappagallu, parággiu, paralίticu, paramánu ‘nettatoio dei muratori’, parente, parláta, parrocchiánu, passatiémpu, patata, pattúglia, paúra, pérgula, Perú, piastra, picocuán(n)a ‘ipecacuana’ (radice di pianta americana), picciòne, pidemìa ‘epidemia’, pioppu, pipίta de sant’Ignátsiu (albero), pistòla, pitanza ‘pietanza’, placca, placare ‘intarsiare’, impiallacciare’, porru (Allium porrum), porta, portante ‘ambio’, portare, posare, postitzu ‘posticcio’, precettare, prelatu, prevaléssiri ‘prevalere’, primavèra, prim(m)èra ‘primiera’ (gioco di carte), priváda ‘cesso’, prostrare, provulòne, prúa, prudíre ‘aver prurito’, puéstu ‘posto’, pugnale, pula, pulcinella, puntale, puntéḍḍu ‘puntello’, puttsolána ‘pozzolana’. Totale 56
Rampa, rapίna, rappare ‘tosare’, rastréllu, reale ‘schietto’, rebárbaru ‘rabarbaro’, recúsa ‘ricusa, rifiuto’, rédina, redingottu ‘cappotto’, refittulèra ‘che lavora nel refettorio’, repente, rettsètta ‘ricetta’, risu (cereale), ròdere, ròre ‘rugiada’. Totale 17
Sabadίglia (erba esotica), sábia, salámu ‘salame’, saldare, salsa, sandália ‘sandalo’, sangrare ‘salassare’, satanassu, sciábica, sciacca-méndula, sceša (lettera x), scumbru, sériu, siática ‘sciatica’, sigillu, silίssiu ‘cilicio’, sòttanu. Totale 17
Tabaccu, taccágnu, taccòne, tafanáriu ‘sedere, deretano’, taffettánu ‘taffettà’, taitái, talèa, taléntu, talίsu, tan, tángheru, tassa ‘imposizione’, tassellu, tassu (Taxus baccata), tatà ‘bussa, percossa’, tèndine, tentazione, terna, terraplénu, tertzu, tesòru, tèssera, testa, tikki (tic), timbru, timòne, tinca, tipu, toppa, torbadu (torbato), tòrcia, tortu ‘torto’, tòtanu ‘totano’, tramuntana, trankillu ‘tranquillo’, trapassare, trementina, trikkitracca, trot(t)a, truffare, truppa, tulipani, turba, turbare, turrione ‘torrione’. Totale 40
Úlcera, últimu, úmidu, úmile, usùra. Totale 5
Vakketta, vagare, variare, vassallu, vata (voce sospetta), vendicare, ventágliu, viola, visu2 ‘faccia’, visúra ‘visura (di atti)’, vittu, volante (lakkè), vueccelléntzia ‘vostra eccellenza’. Totale 14
Zambayòne, tsipolla ‘nodo del legno che è a spicchi come la cipolla’. Totale 2
Totale generale: 690
ISTÉRRIDA METODOLÒGICA A SU “NOU FAEḌḌARZU ETIMOLÒGICU DESSA LIMBA SARDA” de Barore Dedola
I venticinquemila lemmi di quest’opera analizzano mediante la tecnica etimologica l’origine di altrettante parole. L’elenco arriva abbondantenente a un quarto dei 90.000 vocaboli inseriti nel più completo dizionario della lingua sarda, quello di Mario Puddu. Il mio scopo, evidentemente, non era di eguagliare i numeri del Puddu; invece ha inteso ricalcare uno per uno, e riesaminare ab imo, i lemmi trattati da Max Leopold Wagner nel “Dizionario Etimologico Sardo”, aggiungendone altri la cui analisi è già stata resa nota nella mia “Collana Semitica”.
Un’opera linguistica non si misura a numeri ma a contenuti. Peraltro l’opera del Puddu è diversa: egli ha ottimamente raggiunto lo scopo di ogni completo e buon “dizionario dell’uso” ed ovviamente non ha affrontato la questione etimologica; mentre il mio lavoro non solo dichiara nel titolo lo scopo etimologico ma lo assume a pivot dell’intera opera.
Sinora nessuno al mondo aveva studiato massivamente le etimologie del vocabolario sardo, salvo Max Leopold Wagner (stando almeno alle sue dichiarazioni). A parte sta l’impegno “classicista” di Giulio Paulis sulle voci pertinenti alla flora, al quale ha fatto seguire altri sporadici tentativi. Non metterebbe conto citare altri studiosi che ci hanno tentato, poiché i risultati sono stati assai discutibili (Massimo Pittau), o addirittura pessimi (Eduardo Blasco Ferrer); ovviamente non menziono certi altri appassionati, totalmente privi di formazione glottologica e pure di talento.
La revisione totale dei lemmi del Wagner è stata operata per la necessità d’illustrare con metodo più attuale e più incisivo la storia della lingua sarda, che lui aveva tracciato nelle sue opere. Applicarmi a questa impresa non è stato facile da nessun punto di vista, primamente perché si trattava di rimettere in discussione l’opera di un grande; non solo, ma nella discussione ho dovuto coinvolgere, direttamente o indirettamente, i lavori di numerosi professionisti colleghi o precursori del Wagner o che in lui hanno visto un maestro.
Il riesame dell’opera del Wagner non è stato intrapreso soltanto con questo Dizionario: è cominciato anni fa in alcune mie opere, ed ha raggiunto un punto di non-ritorno con la mia Grammatica Storica, intitolata “Grammatica della Lingua Sarda Prelatina”, la quale al cap. 3.1 (Fonologia) riesamina ab imo la Historische Lautlehre des Sardischen (edizione italiana proposta, con commento, da G. Paulis), confutandone uno ad uno tutti i risultati. Va da sé che la dimostrazione della vulnerabilità delle tesi wagneriane e delle stesse leggi fonetiche fondate sulla sua autorità non poteva rimanere isolata: aveva bisogno di quest’opera di completamento che – rivedendo tutti i lemmi proposti dal Wagner – li ricollocasse su un nuovo piano metodologico.
I miei predecessori nelle ricerche etimologiche hanno battuto una sola pista, la quale ha portato a collegare le parole sarde ad una presunta radice latina. Io invece apporto delle prove scientifiche che sconvolgono quel quadro, e dimostrano che il sardo, il latino e le altre lingue mediterranee hanno radici comuni, sono lingue sorelle, le quali vanno ancorate ad una matrice molto più antica, la quale ci è nota, è disponibile ed è facile da esaminare: si tratta del bacino sumero-accadico (con tutte le lingue strettamente legate a quell’ambito).
Penso non sia da addebitare del tutto al Wagner, tantomeno agli etimologisti che gli avevavo aperto la pista, il fatto che sinora nessuna pubblicazione sarda, italiana, straniera abbia raggiunto lo scopo di restituire correttamente l’etimo dei vocaboli sardi. I tempi trascorsi non erano perfettamente compiuti, non consentivano altissime percentuali di dimostrazioni. Invero, dopo oltre un secolo di sforzi e pubblicazioni, è soltanto da un decennio che l’élite dei ricercatori dell’intero orbe terracqueo ha terminato di contribuire al completamento di un’opera di base del linguaggio umano, che è il Chicago Assyrian Dictionary (CAD), un’opera in 25 volumi. Considerando i dizionari sumerici già completati grazie agli apporti di molte università di vari continenti, oggi possiamo dichiarare più agevole qualsiasi indagine storica sulle lingue mediterranee, nonostante che, purtroppo, oltre il 10% della lingua sumerica e di quella accadico-assiro-babilonese non risulti ancora tradotto; senza contare alcune opacità che rendono ancora insicuro financo il linguaggio biblico.
Per queste ragioni sino a un quindicennio fa anche l’etimologista più dotato – persino un sommo come Giovanni Semerano – ha lasciato qualche menda tra le proprie pagine, poiché le Università del mondo intero che già avevavo pubblicato dizionari sumerici o accadici palesavano più di una incertezza nell’interpretare varie voci.
La storia passata condiziona negativamente il metodo. Oggi possiamo ripartire sereni. E tale serenità può giocare finalmente un ruolo determinante, affrancando gli etimologisti da paure, limiti, sospetti e portandoli a riconsiderare più rettamente la complessa storia linguistica del Mediterraneo.
Però, oltre che dell’insicurezza dei dizionari del passato, occorrerebbe esser coscienti anche della futilità delle correnti filosofiche che hanno dominato negativamente sulle vicende degli studi linguistici. Volersene dichiarare immuni sarebbe ingenuo. Dopo la laurea in glottologia, io stesso mi sono dibattuto per 31 anni in un gigantesco garbuglio di problemi linguistici che non riuscivo a dipanare; e fu soltanto dopo aver deciso di “resettare” l’intera questione, riaggiustando i punti cardinali che orientavano il mio pensiero in relazione alla lingua sarda ed alle lingue mediterranee, che ho potuto riconoscere gli errori che bloccavano ogni iniziativa. Quegli errori avevano posto me e, beninteso, anche i miei maestri, in una condizione d’impasse. Mi accorgevo che il lavoro linguistico dei miei maestri, che da me furono seguiti disciplinatamente e senza discussione per 31 anni, era dominato dall’ideologia. Occorreva liberarsi da quella camicia di forza.
Si parla spesso delle correnti filosofiche, alcune delle quali passano nel breve trascorrere di una-due generazioni. Per converso, altre correnti filosofiche non hanno maestri conclamati, e tuttavia sono talmente imponenti da essere rimaste immobili e indiscusse da tanti millenni, divenendo i pilastri dell’intera storia umana. Non ha maestri, ed è immobile da tempo infinito, la “filosofia della superiorità” tra i popoli. Ad essa, come corollario, s’allacciano in modo indistricabile altre mode di pensiero le quali, tutte insieme, compongono una cultura che influisce negativamente persino sugli studi linguistici.
Posso citare, derivati dalla filosofia della “superiorità”, alcuni corollari storici che risultano negativi persino per gli studi etimologici: 1. le invasioni inaugurate dai musulmani “in nome di Dio”, che oggi sono rivitalizzate ad opera di due grandi Stati medio-orientali i quali dal 1945 stanno destabilizzando il Vicino Oriente, la Russia, l’Europa, l’Asia; 2. cito l’atrocità delle Crociate scatenate in nome di un “Dio superiore”; 3. cito le colonizzazioni post-colombiane dilagate negli oceani contro gli aborigeni ch’erano considerati “sub-umani” anzitutto in forza della pregiudiziale religiosa; 4. cito l’Inquisizione romano-ispanica, anzi le Inquisizioni condotte da ogni setta cristiana (e musulmana) nel proprio ambito, in nome dell’intangibile purezza della propria religione; 5. cito l’indegna appropriazione dell’Africa da parte di certi Stati europei, che la governarono “in nome della superiorità razziale”; 6. cito due apocalittiche guerre mondiali, generate ogni volta dall’unico Stato che si vantava del gene della “superiorità ariana”.
I corollari non si limitano a quelli indicati, e comunque sembrano tutti legati “a grappolo”. Nel grappolo rientra anche un tarlo incredibilmente vitale, che ha prodotto millenni di oscurità culturale nell’Occidente. È l’Aristotelismo. La sua scadenza è scritta nei manuali di filosofia, e viene fissata ingenuamente ai tempi di Dante Alighieri. Ma ancora oggi è tragicamente presente, producendo immani disastri ovunque vi sia una Università, ovunque il pensiero ambisca ad assurgere ad Accademia.
Purtroppo sono le Accademie a governare ogni e qualsiasi movimento di pensiero in relazione agli studi linguistici, e sono state soltanto esse ad avere voluto sinora la separatezza degli studi semitistici da quelli chiamati “indogermanici”. A me questa appare una pregiudiziale.
Ognuno di noi vive il proprio particulare subendo, spesso inconsciamente, la forza del pensiero impartito dalle Università. Tutto ciò è umano, è ovvio. Sarebbe assurdo il contrario, poiché le Università sono considerate le “forze armate” della ricerca e del libero pensiero.
Però osservo educatamente che negli studi linguistici oggi dovrebbe considerarsi inaccettabile che uno studioso di una lingua mediterranea ometta di consultare anche i dizionari e le grammatiche antiche della Sponda Sud, ivi compreso il dizionario e la grammatica egizia, poiché oggi dovrebbero essere caduti quei vincoli negativi che, sebbene surrettiziamente, sebbene non ravvisati e tantomeno conclamati, trattenevano ideologicamente gli studi entro le barriere concettuali di malintesi nazionalismi, e addirittura istigavano a negare ex silentio, o ignorare, gli apporti che ogni singolo popolo navigante o transumante ha reciprocamente dato al Mediterraneo fin dal più arcaico passato.
Oggi, finalmente, dovrebbesi dichiarare il declino della “pregiudiziale imperiale”, della “pregiudiziale di superiorità”. Oggi dovrebbe essere normale la condanna del mito “ariano” inventato durante il Romanticismo, che tante menti ha avvelenato, e ancora oggi avvelena sotto-traccia, financo nelle Università, financo tra gli eruditi che si millantano illuminati, quando non “di sinistra”.
Nel campo della glottologia il declino dell’arianismo, se fosse veramente avvenuto come bugiardamente si declama, avrebbe dovuto affievolire quel preconcetto accademico che induce a credere nella possibilità di cancellare una lingua in forza della sopraffazione armata o coloniale. Se veramente ci fosse stato il declino dell’arianismo, si sarebbe dovuto riconsiderare in toto quel monolitico pensiero accademico che, in nome di una “stirpe ariana” inventata dagli stessi intellettuali che architettarono il Nazismo, da 150 anni ha imposto nelle ricerche etimologiche la pregiudiziale di una immensa lingua ”indo-germanica” mai esistita, con al centro il popolo tedesco. Parimenti, si sarebbe dovuta riconsiderare in toto la bislacca teoria che l’Impero romano abbia soppresso le lingue mediterranee inaugurando la nuova era “neolatina”. Il declino di queste ascientifiche eredità tarda a cominciare, ed i conseguenti errori accademici non mostrano alcun cedimento.
Non ci fu mai catastrofe linguistica. Invero, nel Mediterraneo non ci furono mai rotture linguistiche traumatiche e le spinte imperialiste non poterono giammai decretare la morte di una lingua. Le dimostrazioni abbondano. Ad esempio:
1) Nel II-I sec. a.e.v., oltre un secolo dall’invasione romana, Cleone sente bisogno di scrivere un testo in greco-latino-punico (colonna bronzea di S.Nicolò Gerréi), per essere certo che i Sardi lo capissero almeno tramite la lingua punica.
2) Duecento anni dopo l’invasione, Cicerone denuncia (Pro Scauro) che la Sardegna non ha nemmeno una città amica del popolo romano. Se le città erano ancora ostili all’invasore, cosa dovremmo dire delle campagne e delle aspre montagne (che costuiscono il 70% del territorio sardo)?
3) I censimenti e la ripartizione dell’Italia ai tempi di Cesare Augusto mostrano una penisola composta da 32 popoli, che fino a prova contraria usavano 32 lingue. Numero che aumenta se sommiamo le lingue della Sicilia e quelle parlate in Sardegna dalle macro-ripartizioni tribali dei Balares, Corsi, Iliensens.
4) È famosa l’affermazione di Saulo di Tarso il quale, naufragando nell’isola di Malta, fu salvato dai residenti che parlavano una lingua barbara (ossia non greca né latina). Era una lingua semitica che tra quel migliaio di marinai e coltivatori durava in purezza nonostante che Malta fosse diventata romana da centinaia d’anni. I Melitesi si rifiutavano, forse persino inconsciamente, di adottare la lingua di Roma, nonostante che fossero così pochi e così esposti, che per i Romani sarebbe stato facilissimo imporglielo.
5) Altro episodio è quello del De Magia 98, in cui Apuleio, difendendosi dall’accusa di aver indotto con arti magiche la vedova Pudentilla di Oea (l’attuale Tripoli) a sposarlo, apre uno squarcio impressionante sulla società africana del tempo (siamo nel 159 e.v.). Infatti colloca da una parte Pudentilla, donna ricca e colta, che scrive e parla correntemente non solo la lingua latina ma pure quella greca; dall’altra mette il figlio di questa, Sicinio Pudente, che non solo non sa il greco pur essendo stato allevato nella cultura, ma che addirittura balbetta continuamente nel tentativo di esprimere, durante il processo, qualche frase in latino: non gli riesce per il semplice motivo che ha trascurato lo studio delle lettere latine, preferendo vivere come il resto della popolazione, la quale parla esclusivamente il punico. Dall’affermazione di Apuleio veniamo a sapere che nell’Africa latina, occupata da Roma nel 202 a.e.v. dopo la battaglia di Zama (Naraggara), ancora 360 anni dopo si parlava quasi esclusivamente il punico, nonostante che fosse stata romanizzata al massimo. Agostino, cittadino berbero, aveva imparato il suo ottimo latino, ma egli era uomo urbanizzato, apparteneva alla minoranza di cives cui era rivolta in esclusiva la predicazione cristiana, anch’essa espressa in latino.
6) Altra testimonianza: nel VI secolo e.v. i Barbaricìni adoravano ancora ligna et lapides (Lettere di papa Gregorio): solo le città avevano cominciato a recepire il verbo di Gesù, e tuttavia molti cittadini pagavano l’imposta per continuare ad adorare liberamente il Dio degli avi. Si badi, erano passati 3 secoli dalla liberalizzazione del cristianesimo, 5 secoli e mezzo dal suo esordio. Qualcuno dovrebbe riflettere sul fatto che i Barbaricini di Ospitone (ossia i ¾ dei Sardi, tutti residenti nell’immenso territorio montano), erano ancora pagani, e a maggior ragione non erano entrati stabilmente in contatto con i predicatori latini. Solo la religione è in grado di operare, con lento processo di secoli, dove non riesce il potere politico. La religione ha bisogno di essere predicata con somma circospezione, poiché i soggetti accettano il nuovo verbo soltanto se viene trasmesso nella lingua materna. Così fece Wulfila nel IV secolo e.v., il quale trascrisse la Bibbia ed i Vangeli greci nella lingua gotica, della quale inventò pure l’alfabeto. Così fecero Cirillo e Metodio, che per evangelizzare la Russia ebbero persino l’esigenza di creare un apposito alfabeto nazionale. Operò similmente Martin Lutero, che impose la propria Riforma traducendo la Bibbia in tedesco, previa correzione di numerosi passi.
Se questi episodi vengono traslati in un’isola grande ed aspra come la Sardegna, allora l’esempio di Malta, ancor più l’esempio dell’Africa romana, ma pure l’esempio di Ospitone, possono rendere bene i processi linguistici che s’instaurano presso un popolo di vinti. La chiave per comprendere il problema si trova proprio nella conquista delle città e nella netta frattura che nella storia del mondo si è sempre creata tra città e campagna, tra città e montagna. Infatti le montagne sarde rimasero libere dall’occupazione romana.
Beninteso, una religione può attecchire anche rapidamente: basta operare un genocidio (come fece Cortez). I sopravvissuti aderiscono, eccome! Ma i territori montuosi della Sardegna non furono mai conquistati con le armi, almeno fino al VI secolo, allorché l’esempio di Cortez ebbe un luminoso precedente nelle armi bizantine. Ospitone dovette salvare il proprio popolo: aderì al cristianesimo. In compenso la lingua sarda rimase indenne. Perché mai un popolo avrebbe dovuto cancellare la propria lingua a vantaggio di quella dell’invasore, un invasore che peraltro ai tempi di Ospitone cominciava ad esprimersi con la lingua greco-bizantina e non con quella latina?
È possibile sopraffare una lingua? Nel mondo abbiamo avuto varie prove di quanto fosse miope e incongrua la pretesa di un conquistatore di sopraffare persino la lingua del popolo soggetto. Ad esempio, lasciando da parte la famosa deportazione degli Ebrei a Babilonia (i quali conservarono in purezza la propria lingua), possiamo citare la politica dell’Impero assiro, le cui deportazioni avevano primamente lo scopo dell’unificazione linguistica. All’uopo, gli Assiri deportavano i vinti Cananei verso l’Assiria o verso altre province assire, e all’incontro deportavano gli Assiri, o i provinciali parlanti assiro, verso Canaan. «Scopo finale era l’assimilazione linguistica, culturale, politica, il più possibile completa, tale da trasformare i vinti in assiri. L’assimilazione completa la conquista, trasformando un regno ribelle e alieno in una nuova provincia del cosmo alle dirette dipendenze del re e del dio di Assur».1
«In questo contesto di rimodellamento demografico e territoriale al servizio degli interessi assiri, e sotto attento controllo di guarnigioni e funzionari assiri, la pratica della “deportazione incrociata”, che coinvolse qualcosa come 4,5 milioni di persone in un arco di tre secoli, svolse un ruolo essenziale. Il racconto biblico della conquista di Samaria narra dapprima la deportazione degli Israeliti:
il re d’Assiria prese Samaria e deportò Israele in Assiria, stabilendoli a Halah, sul Habur fiume di Gozan, e nelle città della Media. (2Re 17:6)
e poco dopo narra l’arrivo dei deportati alieni:
il re d’Assiria fece venire (gente) da Babilonia, da Kuta, da ‘Awwa, da Hamat e da Sefarwayim e li stabilì nelle città della Samaria al posto degli Israeliti. Costoro s’impossessarono di Samaria e si stabilirono nelle sue città. (2Re 17:24)
«Dai testi di Sargon II sappiamo che deportò in Samaria anche degli Arabi:
I Tamudi, Ibadidi, Marsimani, Khayapa, Arabi lontani abitanti del deserto, che non conoscono sorvegliante o funzionario, che a nessun re avevano mai portato tributo, per mandato di Assur mio signore io li abbattei, e il loro resto deportai e insediai in Samaria (ISK, p. 320).»2
Ma l’assimilazione non avvenne mai. Negli stessi passi della Bibbia è scritto che le nuove popolazioni di Samaria finirono per logorarsi e sfinirsi a vicenda. Non per altro, ma perché le guerre di conquista lasciavano delle scie d’odio e di revanche talmente grandi, da condizionare e trattenere per secoli o millenni i singoli popoli entro la propria lingua originaria, l’unico segno identitario salvabile. Il destino di Samaria è confrontabile – ma solo per farne risaltare le differenze di fondo – col destino della città sarda di Alghero. Ad Alghero nel 1353 era stato operato un innesto adamantino, un solo popolo e una sola lingua; ma quel popolo straniero rimase incastonato, “assediato” entro le mura cittadine come elemento spurio in un territorio parlante lingua sarda; e ancora oggi la situazione è invariata; la lingua catalana dopo 700 anni non ha mai varcato le mura di Alghero. A Samaria invece la questione fu pasticciata dal melting pot creato con la mescolanza di cinque popoli; e l’aggiunta del sesto popolo, gli Arabi parlanti una lingua più vicina a quella ebraica, non potè che esacerbare la situazione e mettere gli uni contro gli altri. Era questo il risultato che volevano gli Assiri? Non credo. Essi volevano mettere certamente gli uni contro gli altri, ma soltanto secondo la prassi del divide et impera. Invece quel seminare odio a piene mani fu foriero di declino economico.
Così andarono le cose nel Mediterraneo da quando Assiri e Babilonesi (poi Hittiti, Medi e Persiani, e infine Greci e Romani) tentarono di prevalere ed espandersi con la forza delle armi. Soltanto la libertà, la parità, la collaborazione pacifica, la dignità dei liberi commerci può fare integrare i linguaggi. È ciò ch’era accaduto per tanti millenni nel Mediterraneo, prima che gli Assiri e i Babilonesi inventassero la “persuasione” degli impalamenti di massa e quella delle deportazioni.
Il livello temporale. Le prospettive. L’Homo Sapiens. Tutto ciò acquisito, rimangono in piedi altre due fangosità da cui il pensiero accademico non riesce a depurarsi.
La prima fangosità colpisce nel vivo la tecnica dell’indagine etimologica condotta nell’ambito degli Istituti universitari di glottologia e di filologia romanza, nei quali si stabilisce a priori il livello temporale dove l’indagine debba cessare. Sinora la storia delle lingue tirreniche attuali e di quelle della costa nord-mediterranea è stata indagata a ritroso sino ad attingere al piano della lingua latina (salvo poi considerare l’apporto collaterale delle lingue germaniche, nonché una vaga citazione di “residui celtici” dei quali non si dice nulla sul piano scientifico). Ma ciò non è bene, poiché lo scavo etimologico è simile a quello archeologico, e non può eludere il proprio metodo, che è quello di toccare il livello più basso nel quale si ritrovino dei manufatti (per l’archeologo) nonché il livello più arcaico cui può condurre la manifestazione dei radicali di un vocabolo (per il glottologo). In linguistica occorre operare confronti lessicali e morfemici sino al più arcaico vocabolo che, in un’area indagata a raggio adeguato, possa credibilmente confrontarsi col vocabolo di oggi. Stabilire che il livello-base delle lingue tirreniche sia la lingua latina, significa rinunciare al criterio storicistico; equivale ad ammettere che prima di Roma la storia nel Mediterraneo non si sia mai svolta oppure (che è lo stesso) ch’essa sia obiettivamente inconoscibile. Invece la storia del Mediterraneo e dintorni è nota, con soddisfazione generale, fin dai millenni pre-greci. Mentre la conoscenza delle lingue ad essa correlate affonda ancora più lontano nel tempo e nello spazio.
Dalla prima fangosità deriva la seconda fangosità, concernente le prospettive. Affermare de imperio che la storia delle lingue tirreniche ed alto-mediterranee abbia una prospettiva di soli 2000 anni significa rinunciare a capire l’evoluzione del linguaggio mediterraneo, il quale è arcaico quanto può essere arcaica la presenza dell’Homo in questo bacino. I dati archeo-antropologici confermano la presenza del Neanderthal e poi del Cro-Magnon; e giacché quegli uomini lasciarono dei manufatti, è ovvio che parlassero, che scambiassero informazioni, che dessero i nomi alle cose, alle persone, al territorio, che usassero quindi la lingua, che avessero un vocabolario condiviso. L’idea nichilista ch’essi comunque parlassero lingue inconoscibili è generata dalle stesse pregiudiziali “latina” ed “ariana” su citate: pregiudiziali liquidatorie che bloccano ogni nuova spinta ad una seria indagine etimologica.
In verità, gli uomini mediterranei del Paleolitico parlavano. E parlavano una sola lingua: appunto la Lingua Mediterranea, per quanto essa fosse pluri-articolata secondo l’antichità e il radicamento degli stanziamenti nei singoli ambiti geografici. Questa lingua è perfettamente conoscibile mediante una semplice induzione, che è la seguente: la Scienza Glottologica ha sempre messo in evidenza un fatto elementare, intuitivo, cioè che le prime formazioni lessicali dell’Homo furono essenzialmente monosillabiche. Questa osservazione è così palmare, che tentarne una dimostrazione (peraltro facile) è ozioso. Ebbene, dalle età arcaiche è sopravvissuta, restituita a noi grazie alla riesumazione delle tavolette cuneiformi, una lingua che si articolava proprio a monosillabi: è la Lingua Sumerica, a tutti resa nota tramite vocabolari e grammatiche pubblicati da numerose Università. Quegli scavi, quelle scoperte hanno messo a disposizione dei glottologi odierni “l’altra metà del mondo”. Perseverare a non indagare quanta storia linguistica mediterranea sia ancorata alla lingua cosiddetta sumerica, non è più accettabile.
Infatti lo scrivente non accetta più di perpetuare la muta ostilità (ch’egli per 31 anni ha purtroppo condiviso) a conoscere l’altra “metà del mondo”. Lo scrivente da 15 anni ha cominciato ad indagare in ambo le sponde, ed ha scoperto che la Lingua Sarda è arcaica, aborigena, risale alle origini del linguaggio, e condivide con la Lingua Sumerica molto più della metà del proprio vocabolario. Come si noterà leggendo oltre nonché nel corpo dell’intero Dizionario, la mia scoperta è scientificamente dimostrata e rimane in attesa di prove contrarie. Come attende prove contrarie lo stesso dizionario egizio, il quale condivide metà della lingua sumerica.
Insomma, si perviene alla dimostrazione che la lingua (cosiddetta) sumerica era parlata ab origine in un’area molto vasta avente perno nel Mediterraneo centrale, ed entro l’ampia circonferenza roteavano già dai tempi arcaici la lingua egizia, le lingue che poi vengono riesumate in Mesopotamia, la lingua di Canaan compreso l’ugaritico, il fenicio, l’ebraico; inoltre quella araba, le lingue ad ovest del Nilo (es. il punico), la lingua che ancora oggi sopravvive in Sardegna, le lingue italiche compreso il latino, le lingue celtiche meridionali comprese quelle iberiche.
Questi vasti ambiti vanno considerati per difetto. Ma è uopo fermarsi per capire intanto la ragione di tale vastità. Per quanto in certi rami scientifici nulla possa considerarsi ultimativo, in relazione all’antropologia s’individua agevolmente un primitivo focus della Ursprache mediterranea. Che il focus possa essere l’Altopiano Etiopico o che altri lo pongano in Croazia (come qualcuno recentemente suggerirebbe), la questione non muta poiché si scopre che dal focus ci si è mossi lungo le coste per racchiudere a tenaglia l’intero Mare Nostrum.
Attenendoci alla corrente antropologica che narra della progenitrice Lucy, l’uomo (ed il linguaggio che ancora oggi ci appartiene) discese dall’Altopiano Etiopico lungo il Nilo, e da lì prese a tenaglia le coste Mediterranee, ad ovest verso la futura Cartagine ed alle Colonne d’Ercole, ed oltre in Andalusia, in Catalogna, in Linguadoca. Ad Est mosse verso Canaan e la Mezzaluna Fertile, e da lì lungo le coste anatoliche, ai Dardanelli, in Grecia, Dalmazia, Italia. Chiusa la tenaglia, toccò alle isole centrali del Mediterraneo. Erano tempi di glaciazioni, e l’arrivo in Corsica-Sardegna avvenne con mari bassi e molto transitabili nella direttrice dell’arcipelago toscano.
La remota antichità delle radici. Alcuni antropologi dichiarano la scoperta di un Neanderthal con osso o cartilagine glottale, anziano di 230.000 anni, ed ovviamente pensano che l’osso glottale favorì l’articolazione della lingua. Ma altri archeo-antropologi del Sud-Africa accampano la scoperta di una Dea-Madre vecchia di 700.000 anni: chiaramente, gli scultori di quella Dea-Madre parlavano ancor prima di questo Neanderthal citato. Comunque la mettiamo, l’Homo cominciò ad articolare parole e pensieri molto presto; e tentò di risalire sempre da sud a nord (verso l’enorme calotta glaciale che occupava l’Eurasia sino al livello delle Alpi, dei Carpazi, dei bassi-Urali, della Mongolia).
L’idea di un idioma “indo-germanico” sortito sulle pianure ghiacciate a nord dell’Ucraina e del Kazakistan, con improbabili rincalzi dal Pamir e dintorni, non tiene conto che l’Homo provenne sempre dalle zone non soggette a glaciazione. Quindi è forza immaginare soltanto pressioni da Sud, risalenti i vari corsi dei fiumi, lungo le antiche valli glaciali del Rodano, del Danubio, del Dnepr, del Don, del Volga, dell’Ural e forse – al dilà dell’Hindukush-Karakorum – del Brahmaputra, del Mekong.
Furono le genti che risalirono le valli glaciali a costituire poi – millennio dopo millennio – il fenomeno dei Popoli delle Steppe. E furono questi ultimi, a loro modo, che rifluirono a ondate verso Ovest nelle pianure centrali dell’Asia, nella Pianura Sarmatica, facendo capolino nella storia mediterranea col nome greco di Popoli Barbarici, quelli che affrontarono Mario, Giulio Cesare, l’Impero romano, ecc.
Financo la questione della Civiltà di Andronovo (the Indo-Iranians di Elena E. Kuz’mina) può ricevere ulteriori lumi se la inquadriamo in queste prospettive. Parimenti, si capovolge la prospettiva dei famigerati “popoli indoeuropei”, allorché andiamo a rivelare che pressoché ogni parola a loro attribuita è di origine sumero-accadica. Ad esempio, si pretende l’origine indoeuropea dei Persiani, ma intanto i loro nomi sono accadici, come Dario, nome d’imperatore persiano, dall’akk. dāriu(m), dārû(m) ‘lasting, eternal, eterno’ riferito agli déi, ai re (tipico appellativo di cui si dotavano i re delle origini, per marcare la propria forza e la nobiltà davanti al popolo).
Tornando al Mediterraneo, ci rendiamo conto che pure la questione delle lingue celtiche è fortemente zoppa, fintanto che non si tengono nel dovuto conto gli apporti millenari da sud. Se vogliamo, anche gli artisti contribuirono a dimostrare quanto sto affermando, come quell’uomo (ma immagino fosse una donna che attendeva il ritorno del marito dalla caccia) il quale (la quale) 32.000 anni fa dipinse la grotta di Chauvet con splendidi rinoceronti.
Sono migliaia le parole che noi consideriamo “nordiche” e invece provennero dal Bacino sumero-accadico. Di seguito, per ragioni di spazio, elenco poco più di venti lemmi.
Aggraviái camp. ‘ingiuriare, oltraggiare’; aggráviu ‘ingiuria, oltraggio’ = sp. agraviar, agravio. It. ant. aggravio ‘ingiuria, oltraggio’, che ritroviamo anche in Corsica. Base etimologica accadica, da garbu, garbānu ‘lebbroso’. Il termine penetrò tanto, da arrivare anche tra i Germani: cfr. ags. garbage ‘immondezza, porcheria’.
Alpi, ted. Alb. Il nome della catena montuosa che scompartisce mezza Europa ha lo stesso radicale di it. e lat. alba < akk. ḫalpû ‘frost, ice’, sd. alb-éskida, arb-éskida ‘alba’. Il nome più antico, conservato nelle due radici sarde, si ricava dal sum. ar ‘praise, preghiera’ + bar ‘to burn, bruciare’, anche ‘to open, aprire’. Il composto ar-bar in origine significò ‘preghiera al Folgorante’ (il Sole), o ‘preghiera dell’apertura (del giorno)’. È noto il “saluto al Sole” che molti popoli ancora oggi si tramandano, fin dal Paleolitico, al momento dell’aurora. Un tempo non era un “saluto” ma una preghiera, come vediamo al lemma Sud.
Bind (to bind) ingl. ‘legare’; cfr. log. bindellu ‘legaccio, nastro’, specialmente per legare i capelli; cfr. piem. bindel ‘nastro’. Base etimologica è l’akk. binītu ‘creation, structure’. A quanto pare il concetto è arcaico, proviene dall’Alto Paleolitico, allorché l’uomo, strappando le prime erbe tenaci, cominciò a intrecciarle facendone legacci, con i quali cominciò a fissare tra di loro i primi rami d’albero ed a costruirsi una capanna. Questa fu la prima barriera di difesa dai pericoli del mondo ferino, ed anche dalle intemperie.
Sud è il nome del punto più alto toccato dal sole nel suo spostamento est-ovest. Base etimologica è il sum. šud ‘preghiera’ (una preghiera con proscinesi, ovviamente rivolta al dio Sole, stavolta quando sta allo zenith). E ricordiamo il nome dell’Alba. Tale preghiera ci è noto tramite il cognome Sciùto, Sciuti, di area italica ma di sicura base tirrenica, con etimo anche nell’akk. šūtu, sūtu ‘sud’.
Ovest. Per indicare l’Ovest gli Šardana-Tirreni impiegarono addirittura due termini, l’uno e l’altro eternati, eccezionalmente, in due cognomi sardi. Il primo è Murru, con base nell’akk. amurru(m) ‘ovest’. Il secondo è il cogn. Erbì con la variante Erba, base nell’akk. erbu(m), erebu ‘tramonto, ovest’ (da cui poi il gr. Érebos, indicante il Regno delle Tenebre, il Mondo dei Morti, dove sprofonda il Sole). Del nome internazionale Ovest, West (creduto anglosassone) s’ignorò sempre l’origine, mentre la base è il sum. u ‘universo, universale’ + eš ‘shrine, sepolcro’ + de ‘creatore’ (ossia Dio Creatore dell’Umanità). Il composto u-eš-de, divenuto west tra gli Anglosassoni anche in virtù della nota Lautverschiebung germanica, in origine significò ‘sepolcro del Creatore dell’Universo’. La definizione si concilia con quella del Nord.
Est, altro nome del punto dove sorge il Sole, ha base etimologica nel sum. eš ‘shrine, sepolcro’ + tuk ‘to break off, rompere’. Il composto eš-tuk in origine significò ‘rottura del sepolcro’ (vedi le osservazioni per gli altri punti cardinali). In Italia certi popoli chiamarono altrimenti quel punto. Un indizio lo cogliamo dal cognome italico Zito, con base nell’akk. ṣītu(m) ‘uscita del sole’, ossia ‘Est’. Si può notare che i vari nomi per uno stesso punto d’orientamento mostrano l’autonomia dei vari linguaggi antichi.
Nord è il punto cardinale più citato, dal sum. nu-ra-du (nu ‘creatore’ + ra ‘limpido, chiaro, splendente, Dio’ + du ‘to hold, keep in custody, tener prigioniero’. Nura indicò il ‘Dio creatore’, quindi ‘Creatore della Luce, Sole’; Nura-du significò ‘prigione del Sole’ (perché negli antichi miti il Sole al tramonto veniva imprigionato dal Dio della Notte); cfr. sp. norte, ingl. north, norveg. nord, ted. Norden, della cui origine ogni etimologista ha sinora discusso invano.
Norge è il nome della lontana Norvègia, che non significa ‘terra del nord’ sibbene ‘Terra dei bagliori, delle aurore boreali’, da sum.-akk. nūru ‘bagliore’ + sum. ki, gr. gê ‘terra’ (in composto nurki). Cfr. il cognome sd. Nurki, che può sembrare un mistero finché non accettiamo che qualche Normanno tra quelli che raggiunsero la Sicilia dovette recarsi anche in Sardegna a fini di commercio trans-isolano. Con tutta evidenza, una bella vergine sarda lo ammaliò, ed egli s’insediò trapiantando un “cognome di origine”: ‘quello della Terra delle Aurore boreali’. Forse i Normanni arrivati in Sardegna per commercio furono numerosi. Un loro sia pur minimo contributo può senz’altro giustificare le molte teste bionde del centro-Barbagia, nonché gli occhi di certi barbaricini (es. ad Ovodda), spesso di un affascinante verde-smeraldo. Capisco l’imbarazzo di chi ragiona “a palmi”, ma questa etimologia s’affianca a molte altre della Sardegna acclaranti un fatto che sconcerta i più: in Sardegna ancora 500 anni fa si pensava in sumerico, come dimostrerò al paragrafo “La lingua arcaica compresa fino al Rinascimento”.
Mont Blank, noto in Italia come Monte Bianco, si dice abbia radice dal germ. blank ‘ripulito, lucente’; ma anche quella voce germanica proviene da sud, base etimologica è il sum. bar ‘bianco, libero’ + an-gal ‘cielo, cielo grande’ = ‘cielo limpido’. I cognomi sd. Barranca, Branca conservano ancora l’arcaico significato del bianco, che si espanse con fonetiche similari fino alla Mittel-Europa.
Monte Rosa è un oronimo italico persino banale. Ma tale banalità va spiegata, poiché quel magico colore rosa viene percepito soltanto dai Padani quando da Est il sole illumina di colpo l’altissima vetta, mentre il mondo se ne sta ancora avvolto dalle tenebre. È un momento di grande fascino, che riceve nome dall’akk. rûšum ‘rossore’, voce conosciuta bene dai Celti.
Monte Cervino è un altro oronimo italo-celtico, un aggettivale col suff. mediterraneo -ínu < akk. ḫerebū ‘torre’ (quindi ḫereb-inu). Nome antonomastico. Si badi che questo concetto riferito alla torre si ritrova esclusivamente nelle fonti accadiche relative agli scacchi (i quali testimoniano in tal guisa la loro arcaicità culturale, senza bisogno di coinvolgere nella loro invenzione gl’Indiani, e nemmeno gli Iranici).
Bàita è un’altra voce celtico-mediterranea abbarbicata sulle Alpi. Indica la ‘casa alpina’, specie quella isolata negli alpeggi, ma ritroviamo la voce nell’ebr. bait ‘casa, tenda’, akk. bītu ‘casa’, sd. bide ‘vite’, lat. vitis ‘idem’. Che provenga da sud, lo testimonia proprio il nome sardo della vitis. Infatti qualsiasi parola, sino a prova contraria, è arcaica, e l’ebr. bait ha un senso se lo leggiamo primamente come ‘tenda’; ha ulteriore senso se lo leggiamo anzitutto come ‘tenda’ (prodotta dalla vitis, dalla bide, che in certe zone mediterranee, crescendo nella foresta, crea un tendaggio enorme che fece concepire la primitiva idea della copertura).
Giorni della merla. Questo sintagma italo-celtico è legato ai giorni più freddi dell’anno nel nord-Italia, ed evoca le tempeste gelide da nord. Base etimologica il sum. mir-la ‘vento del nord’ (mir ‘chilly wind’ + la ‘to carry, portare, recare, apportare’). Dunque mirla significò ‘apportatore di tramontana, apportatore di tempeste’ (tutto un programma). Cfr. it. merletto ‘pizzo ricamato applicato a stoffe pregiate’, originato dall’osservazione dei fiabeschi ricami del gelo sulle superfici lisce. Da qui anche il merlo in quanto ‘sopraelevazione merlata delle mura difensive’, di cui i filologi hanno sempre ignorato le origini, confondendolo con i merli (uccelli) senza però riuscire a raccapezzarsi.
Hütte ted. ‘capanna’ ha il perfetto corrispettivo nel babibolese ḫuttu (a storage vessel, un recipiente per la conservazione). Va da sé che gli alimenti furono sempre ben protetti e immagazzinati contro le intemperie e contro gli animali. Dagli alimenti dipendeva la vita dell’uomo. Questa considerazione è sufficiente a capire la causa prima della creazione di robuste capanne presso i Germani.
Pò. Uno sguardo ai sistemi fluviali è d’obbligo, poiché il nome celtico del fiume più lungo d’Italia ha base nel sum. pû, akk. pû(m) ‘bocca’; cfr. akk. pāʼum ‘bocca’ da cui celtico Padum, altro nome del Pò. Il sum. pû, akk. pāʼum s’intese per antonomasia come ‘sorgente, scaturigine’. Cfr. poi il lat. Danubium, da akk. dannu ‘potente’ + bī’um ‘opening, outlet; apertura, fuoriuscita, sorgente’, col significato di ‘sorgente, fiume potente’.
Adda è nome di un grosso affluente del Pò, dal sum. adea ‘flooding’.
Arno è il nome del fiume toscano, idronimo celtico che però si ripete in Renania (Arnel), Svizzera (Orne), Catalogna (Arnon), Francia (Arnon, Arn), Transgiordania (Arnon).
Reno è nome di un grande fiume della Renania, da akk. reḫûm ‘versare, scaturire’ + ēnu ‘sorgente’.
Tina è nome di un fiume britannico = Tino, fiume sardo presso Tìana.
Normanni. Quanto ai popoli a nord delle Alpi, gli stessi Vikinghi erano detti Normanni, voce sumerica da nuru ‘luce’ + man ‘companion, compagno d’arme’. Il composto nur-man significò ‘guerrieri della Terra della luce’ (ossia ‘Quelli delle aurore boreali’). Pertanto dobbiamo smettere d’interpretare l’ags. man come ‘uomo’, poiché in origine indicava il ‘guerriero’, l’uomo ‘portatore di armi’.
Germani. Conosciamo benissimo questo popolo che diede filo da torcere ai Romani < akk. gērum ‘ostile’ + mānu ‘bosco’. Il composto gēr-mānu in origine nominava il ‘fiero popolo delle foreste’.
Danesi. Tutti i popoli del Nord erano conosciuti, prima ancora che apparissero le cosiddette “civiltà avanzate” del Mediterraneo. E non dobbiamo titubare anche se i primi a citare i Danesi furono Procopio di Cesarea e Giordane. Anche i Danesi, come i Normanni, come i Germani, erano noti per la forza temeraria. Infatti il nome ha origine dall’akk. daʼānu ‘potere, forza’.
Taurini. Non si può dire che tutti i popoli a nord dell’Italia non abbiano ricevuto il nome più appropriato, secondo la caratteristica più notevole. Ad esempio, i Taurini erano un popolo dimorante negli Alti Tauri, tra Austria e Italia. La paronomasia giocò il proprio ruolo, e gl’interpreti li collegarono al toro, lat. taurus, termine invero alquanto ostico da giustificare, per quanto esso provenisse da sud, dove il toro era adorato. Invero la base etimologica è l’aram. tur ‘monte’ (cfr. lat. turris ‘torre’). Con ciò dagli Alti Tauri passiamo al Monte Turu-séle il monte più alto del Supramonte di Baunéi, in Sardegna; questa pletora di nomi è mediterranea.
Per concludere, può essere utile uno sguardo agli oggetti preziosi, tenendoci sempre ancorati alle Origini, al Paleolitico, ai tempi in cui le lingue si formarono, allorché la meraviglia dell’Homo s’appuntava all’apparizione di pochi e rari reperti di superficie, ch’emergevano soltanto in qualche plaga.
Ambra. Facile immaginare che l’ambra del Nord fu il primo oggetto raro e prezioso dell’antichità, e se ne fece subito un proficuo commercio. Ci chiediamo donde sorse questo nome. Lo troviamo nell’ar. anbar, che però ha base nel sum. an-bar ‘cielo cotto’ (an ‘cielo’ + bar ‘cuocere alla fornace’ (pottery, vetro). Lo storico Tacito la indicò come “resina che trasuda dagli alberi”, mentre il nome latino dell’ambra fu glesum, anche questo dal sum. gilesi ‘tesoro d’albero’ (gil ‘tesoro’ + esi, eš ‘albero’). Ma ci accorgiamo che tale nome è uguale al germ. glass, Glas ‘vetro’. Con ciò intuiamo che questo fu il primo nome che i popoli nordici diedero all’ambra. Insomma, senza l’ambra oggi il nome del vetro non esisterebbe, sarebbe un nome diverso.
Vitrum. Ma com’è naturale, anche questo vocabolo latino, corrispondente al camp. bidri, ha origini arcaiche. Le scopriamo nell’akk. bitrûm ‘vedere attraverso, to see something through’.
Silk. Infine, chiudiamo con un nome nordico riferito alla ‘seta’. Essa, beninteso, fu conosciuta molto tardi. Non per questo i popoli germanici ed anglo-sassoni erano giunti impreparati all’impatto con le pregiate stoffe orientali. Disponevano già di un aggettivale appropriato derivante dal sumero: sikil ‘puro’.
La pregiudiziale della “barbarie” e l’intuizione del mondo arcaico. Il paragrafo appena chiuso dovrebbe far riflettere sulle civiltà arcaiche e sulle millenarie commistioni linguistiche impellenti da sud. Molti rifiutano a priori il parametro della remota antichità, perché applicano ad essa il giudizio negativo di una barbarie la cui indagine sarebbe infruttifera. Ma anche qui la questione è mal posta. I dipinti di Altamira pare stiano in Ispagna da 39.000 anni; essi indussero Pablo Picasso a sentenziare: “Dopo Altamira tutto è decadenza”. Figuriamoci s’egli avesse visto i dipinti della grotta di Chauvet (datati a 32.000 anni). Quei dipinti sfatano un altro luogo comune: che l’arte sia nata soltanto da 2,8 millenni in Grecia e che prima ci fosse solo barbarie. Francamente, soltanto Michelangelo e Rembrandt hanno posseduto la potenza espressiva dell’uomo (o della donna) di Chauvet. Basterebbe ciò per rifiutare la pregiudiziale della “barbarie”, che impedisce di capire serenamente le civiltà del passato e la formazione delle loro lingue.
Fu in quella remota fase arcaica, decine di migliaia d’anni fa, che nacque il toponimo Gibilterra, anzi due toponimi, com’è usuale nelle terre di confine. Da una parte fu Calpe, dall’altra Gibraltar. Chi s’attiene alla “pregiudiziale latina” (una pregiudiziale appena addolcita dal flirt con la civiltà greca) e crede alla inconoscibilità dei linguaggi precedenti, sostiene che Calpe è nome greco, e nemmeno lo traduce. Mentre la lingua sumerica agevola la comprensione, fornendo due monosillabi: ḫal ‘to divide; to open’ + pû ‘mouth’. Calpe, non meno di 40.000 anni fa, era nota come ‘opened mouth’. Dall’altra sponda, la tribù che l’aveva raggiunta la chiamò col tempo Gibraltar, che la “pregiudiziale latina” induce a interpretare come Jabal Tāriq ‘Mountain of Tariq’ (riferendola al conquistatore arabo ch’entrò in Andalusia, e tenendo in non cale quel fastidioso -iq). Ma è proprio il sovrabbondante -iq a far capire che la traduzione “araba” è forzata. Invero, anche questo nome è sumerico, da gi ‘to turn, return, change status’ + bar ‘to cut open, split’ + al ‘fencing’ + tar ‘to cut’: gi-bar-al-tar = ‘barrier cut, split, changing the destiny’. Si nota l’enfasi tautologica nella ripetizione concettuale bar ‘aprire’ + tar ‘to cut’.
Dall’etimologia di Calpe/Gibraltar il lettore, i giovani glottologi cui mi rivolgo, avranno capito che spesso l’etimologia non può proporsi pianamente se non ci si riporta, quando possibile, ai tempi arcaici, assunti come parametro scientifico (non sempre necessario, beninteso, ma pur sempre scientifico) allato al parametro della identità o simiglianza fono-semantica tra i radicali attuali e quelli originari. Il bisogno di corrette intuizioni non è soltanto mio, beninteso. Fu lo stesso Wagner nel DES a dare sfogo alle più svariate intuizioni, che il lettore è gentilmente pregato di giudicare in questo Dizionario, e di confrontarle con le mie.
Faccio l’esempio di ammurrare, -ái che in log. e camp. significa ‘legare le vacche per mungerle’. L’intuizione del Wagner è la seguente: ammurrare = ‘legare il muso’ (murru). Una volta supposta tale equivalenza, Wagner crede appagata e conclusa la sua indagine etimologica. Ma a mio avviso essa non può ritenersi conclusa, e penso che nemmeno il lettore possa soddisfarsi appieno, se non altro perché manca una conferma: l’etimo di murru. E allora vediamo quest’etimo, che poggia sull’akk. murrûm ‘uno che scopre, che scoperchia’. Il riferimento originario è ai suini, che usano il grugno per grufolare, ossia per “arare” e “scoperchiare” in cerca di radici e insetti. Da quest’etimo comincia a balenare che la radice -mur- di ammurrare e di murru non parte dal Neolitico ma dal Paleolitico, da quando l’uomo cominciò ad osservare il meticoloso grufolio dei suini dopo le piogge, che scoperchiano la terra rendendola fertile, e per ciò stesso fornendo l’idea rivoluzionaria dell’aratro. Secondo la mia intuizione, quindi, l’operazione del Wagner con la sua lineare equivalenza non aiuta, poiché nel Paleolitico, allorché le vacche erano ancora poco domite, e non si era nemmeno in grado di confezionare corde, l’unico modo per nutrirsi del prezioso latte era accattivare la vacca fornendole abbondante foraggio, in modo che stesse ferma. La base etimologica che poi rinveniamo “incistata” nella lingua accadica proviene da lontano, dal sum. mur ‘fodder, foraggio’. Ovviamente il significato sumerico s’attagliò in origine non solo al foraggio dei bovini ma anche al cibo esumato dai suini grufolanti. Da ciò s’apprende che il radicale del sd. murru in quanto ‘muso’ è molto arcaico e fu capace, già da decine di millenni, di configurare concettualmente sia il ‘foraggio’ sia il ‘muso’ che lo procacciava. In tal guisa nacque la metonimia sarda murru, a quanto pare non condivisa nel restante Mediterraneo.
Beninteso, in certi casi è possibile che l’indagine etimologica non riesca a discendere al disotto dello strato romano (o greco). È il caso del camp. pantéus nella locuzione portái a unu in pantéus ‘portare uno di peso’ (Porru); vedi anche log. in pantéus ándias. Casu propone a ppantèa ‘di peso’: lu giughίan a pantèa ‘lo portavano di peso’, ed anche ‘in trionfo’. Wagner in questo caso rinunciò a indagare l’etimo, poiché non riuscì a trovare addentellati. Dal mio punto di vista, invece, l’etimologia di questo sintagma è chiara, ed offre due opzioni; la prima è l’akk. bāntiš ‘like a mother’, bāntu ‘mother’ (in tal caso il significato del sintagma sarebbe ‘portare come porta una madre’, ossia in braccio). Una seconda opzione può soddisfarsi discendendo soltanto al livello bizantino, a 1400 anni fa, allorché le antiche processioni pagane vennnero progressivamente sostituite con quelle cristiane. In tal caso s’arguisce facilmente che il sd. pantéus non è altro che il biz. πάν-θειος ‘affatto divino, augustissimo’ (epiteto rivolto alla statua di Dio, della Madonna, del Santo portati a braccio in processione). Quest’esempio mostra la possibilità di fermare l’indagine etimologica al solo livello latino (o greco, in questo caso), senza bisogno di discendere oltre. Ma tale possibilità si appalesa soltanto a posteriori, dopo avere indagato anche gli strati lessicali più arcaici. In ogni modo, il lettore noterà che Wagner non potè giungere all’etimo nemmeno quando gli si presentò l’occasione di accreditare con certezza l’opzione greca, della quale non seppe approfittare.
Ciascuno di noi glottologi è conscio delle obiettive difficoltà dell’indagine etimologica. Ci accorgiamo di muoverci in un ambiente indefinito con l’onere di renderlo finito; e troviamo nell’intuizione uno strumento che – a seconda di come lo indirizziamo – può essere un prezioso alleato, che però può rivoltarsi contro di noi al minimo errore di prospettiva, ad ogni insufficienza nelle opzioni.
Prendiamo il caso del log. Cammínu de Roma ‘Via Lattea’. Essa fu mitizzata anche come un immenso sentiero incendiato. Wagner s’appagò nell’interpretare la locuzione nel suo significato apparente: ‘Cammino di Roma’, senza avvertire che tale soluzione è insufficiente e gravida di contraddizioni. Non mi sento obbligato a riempire oziose pagine dimostrative, e invito direttamente ciascun lettore a spiegare che significhi, secondo lui, ‘Cammino di Roma’: Cammino verso Roma?, Cammino appartenente a Roma?, Cammino inventato dagli antichi romani?, Banda luminosa che forma un ponte apparente tra Logudoro e Roma? O cos’altro? E che c’entra Roma con la Via Lattea? Forse che fu Roma ad aver indicato ai Sardi l’esistenza della Via Lattea? Forse che i Sardi prima di Roma non avevano alcuna nozione di astronomia? Chi vuole intendere in questo modo l’antica civiltà della Sardegna, avvalla la credenza che i Sardi nel passato fossero una nullità antropologica, un buco-nero della storia. In ogni modo, da questa situazione di stallo bisogna uscire in qualche modo; il ricercatore deve decidersi e giungere ad una soluzione, stando attento alle interpretazioni che lo immergerebbero nel ridicolo. A mio avviso, si esce dall’impasse assumendo quell’idea generalizzata su citata, che la Via Lattea sembri un immenso sentiero incendiato, e confrontando tale visione con la base sum. rub ‘to go, andare’ + ma ‘to burn, bruciare, incendiare’. In tal caso rub-ma indicò proprio un ‘cammino incendiato’, e l’aggiunta di log. cammínu non è altro che una replica dell’arcaico rub. Questa soluzione è una spia eclatante di come il sumerico sia stato la base del linguaggio sardo.
Senza la giusta intuizione è spesso impossibile pervenire al concetto primitivo che dimostra la giusta etimologia. Lo vediamo nel lemma pèttene nuor. e log. ‘pettine’. È giusto planare sul lat. pecten, ma poi occorre procedere sino all’ultimo livello, che è l’akk. peḫû ‘to close up, seal; bloccare, sigillare’ + ṭênu ‘to grind, macinare’. Per capire appieno quest’etimo occorre risalire all’era in cui la macina fu una pietra mossa avanti-indietro sopra una pietra fissa (quasi come il pettine viene mosso sulla testa). Il composto peḫ-ṭênu in origine significò ‘macina che blocca, sblocca (un corpo estraneo)’. Anticamente infatti il pettine era il migliore ausilio per ripulire la testa dai pidocchi.
Non sono mai sprecate le raccomandazioni al massimo rigore ed alla massima acribia nell’indagine. Esempio, il sd. tzimitóriu, cimitóriu ‘terreno destinato ad inumare i morti’, nel tardo lat. si chiamò cimitērium e lo si volle derivare da gr. κοιμητήριον ‘luogo dove si va a dormire’. Ma questa è una paronomasia, poiché l’arcaica base lessicale si rintraccia ai tempi in cui in tante parti del Mediterraneo vigeva l’incinerazione. Vedi akk. ḫimṭum ‘burning, abbruciamento, incinerazione’. Quindi un tempo cimitóriu fu il luogo dove si portavano i morti per incinerirli. Cfr. log. tziminèa ‘camino, il posto dove si arrostisce la carne’.
Unità delle lingue mediterranee. Il metodo sinora suggerito vale per tutte le contrade mediterranee.
Prendiamo il log. ant. carrúgiu ‘viuzza stretta’ (Stat. Castels. 155). È un evidente accatto dal gen. carroggio, carùggiu. A sua volta però la voce genovese mostra un’origine antichissima e interessantissima, legata al fatto che l’antica Genova, molto prima dell’avvento dei Romani, non aveva alcun sito pianeggiante: era un villaggio di pescatori abbarbicato sulla scogliera. I successivi piani alluvionali che pavimentano l’attuale città si crearono nei millenni col trasporto di ghiaioni durante le piogge rovinanti dai monti incombenti. Furono i ghiaioni, che avanzarono nel mare con ripetuti apporti, a dare fisionomia alla striminzita piana attuale. Per ovvie ragioni le prime case dei Genovesi nacquero con file perpendicolari al mare, allungandosi al disopra dell’erta dei canaloni che recavano acqua dalla montagna. Anche le case allungate ai bordi dei torrenti minori e dei ruscelli dovettero avere fin dall’inizio questa ubicazione, una direzione finalizzata a convogliare al mare senza ostacoli ogni moto d’acqua, la quale spazzava anche le deiezioni rilasciate lungo i carruggi. Di qui il nome carrùggiu, avente base etimologica nell’akk. ḫarru ‘water channel, water canal’ + uggu ‘rage, fury’. Carrùggiu indicò quindi, dall’origine, la ‘furia dei canali d’acqua’, ossia i condotti che convogliavano senza danno la furia dell’acqua piovana. Fu questa intelligente topologia ch’evitò le devastazione di Genova, in quanto non ostacolava i torrenti. In seguito, la fame di spazio portò ad edificare dentro gli originari carruggi, entro la golena dei torrenti principali, strozzandoli, o coprendoli, e sottomettendo parte della città ai capricci del tempo.
Aḍḍurare (Planargia), atturai(sì) camp. ‘fermare, fermarsi, rimanere’ = cat. aturar(se). Voce mediterranea con base etimologica nell’akk. dūrum ‘permanenza, eternità’, ‘stato permanente’. Cfr. it. durare.
Ammattái camp. ‘guarnire una nave dei suoi alberi’. Wagner lo confronta col tosc. livorn. ammattare ‘alberare, attrezzare una nave’; còrso ammattà ‘alberare, alzare all’aria antenne e sim.’, di conseguenza ne suggerisce subliminalmente la derivazione da quei lemmi italici. Invero questi lemmi sono tutti mediterranei, con base etimologica nel sum. ma da ‘to sail a boat’.
Angiulottus m. pl. camp. ‘sorta di ravioli’, che sono anche specialità della cucina piemontese (añulot). A quanto pare il termine è mediterraneo, con base nel sum. an ‘cielo’, akk. Anu ‘Dio sommo del Cielo’ + ḫul ‘gioire’, col significato di ‘Gioia di Anu’.
Aspro antroponimo medievale, il quale fu autenticamente sardo, sardiano, senza contatti col lat. Asper, come vorrebbe invece Pittau (UNS 144), che ci vede il solito latifondista romano. Aspro aveva base etimol. nell’akk. ašpû ‘tizio, individuo’ + urû ‘di Ur, nativo di Ur’: composto ašp(u)rû, col significato di ‘individuo nativo di Ur’. A questo riguardo occorre precisare che in Sardegna la nostalgia per la città di Ur fu tale, che se ne fondò una con lo stesso nome, il quale è rimasto identico fino ad oggi: è Uri, nel Logudoro nord-occidentale, che riprende il nome della biblica Ur (detta Uri in sumerico), per quanto dell’antica Ur questo villaggio non abbia ripetuto le glorie e gli sfarzi. Sarebbe faticoso convincere i renitenti che in Sardegna, attraverso gli attuali cognomi (molti dei quali sono antichi epiteti), siamo in grado di fare la casistica di quanti furono i luoghi di origine di certa popolazione antica insediatasi alla chetichella nell’isola; più che altro furono dei commercianti che poi, insediandosi stabilmente, furono chiamati col nome della città o della regione d’origine. Esempio: il cgn Assóru, Soru, Soro, è relitto aggettivale che denotò qualche commerciante assiro che costituì un fondaco in Sardegna: da ass. aššurû ‘Assiro’; bab. surû ‘a foreigner, uno straniero’. Altro esempio è il cognome Catte, Catta, da akk. ḫattû ‘Hittita’: esso mostra che nel primo millennio a.e.v. il commercio inter-mediterraneo era intenso, che c’erano pure dei commercianti hittiti, e qualcuno di essi, com’è naturale, andò a dislocarsi nell’isola di Sardegna. Ma andiamo oltre nella nostra indagine mediterranea.
Assu, sd. e it. asso ‘figura nelle carte da gioco o punto sulla faccia di un dado corrispondente al valore uno’. DELI lo crede dal lat. ăsse(m) ‘persona che eccelle’, e comunque non produce l’etimologia. In realtà la base sta nel sum. aš ‘uno’, hitt. aš ‘uno’.
Assussèna log. ‘giglio bianco’ (Lilium). Wagner, nonché Paulis NPPS 207, ne pongono l’origine nello spagnolo azucena; nelle laudi della Vergine e dei santi, è applicato alle sante (senza che il popolo conosca il significato della parola), e vale ‘qualcosa di estremamente puro e bello’: Candidissima assussèna (per Santa Greca). Quest’epiteto è variante del più noto Susanna, nome muliebre.
L’epiteto iberico, lo stesso nome muliebre, sono originariamente anche sardiani, ed hanno base etimologica nella lingua ebraica. Il muliebre Susanna significa ‘donna originaria di Susa’ (la capitale dell’antica Persia). Lo ritroviamo nell’ebr. Šušan ( שׁוּשַׁנ ). Pure il noto frutto del susíno ha la stessa origine: ‘originario di Susa’. In Italia abbiamo due cognomi ebraici italiani: Susin e de Susen. Dante Alighieri usa già prima del 1321 il nome del frutto, da ant. ebr. שׁוּשִׁין (šušin ‘nativo di Susa’), e s’affianca a Šošannah שׁוֹשַׁנׇּה (‘(fiore) di Susa’: Susa שׁוּשַׁה ).
Astru sd. ‘stella’. Cfr. lat. āster, gr. ἀστήρ ‘stella’. Se ne ignorò l’origine. La base etimologica è l’aram. Aštar, fen. Aštart, bab. Ištar ‘paredra del Dio sole (Anu)’. L’astralismo della religione babilonese simboleggiava la dèa con la stella Venere, con la quale fu identificata sin da tempi preistorici (OCE II 40); v. akk. aštaru ‘goddes, dèa’ (per antonomasia).
Karallu. Questo è un altro vocabolo mediterraneo, detto in it. ‘corallo’, in lat. corăllum, corăllium, in gr. κοράλλιον. Se ne ignorò l’origine, e nessuno s’accorse ch’esso fu pure il nome arcaico della città di Càgliari, detta in lat. Karalis ma citata da Tolomeo come Καράλλι. Il babilonese karallu è anzitutto il ‘gioiello’ (per antonomasia), ma l’assoluta antichità fa capire che questo gioiello fu inizialmente proprio il corallo rosso, di cui la Sardegna era zeppa. Facile arguire perché Cagliari fu chiamata ‘Gioiello’: non solo perché era il porto d’imbarco dell’intenso commercio del corallo nell’antichità, ma perché Cagliari stessa era incastonata nel sito più incantevole del Mediterraneo.
Cabillu camp. è un termine oscuro e incompreso. Lo si è considerato, da parte di moltissimi, dalla gente comune e, a quanto vediamo col Pittau, pure da certi linguisti viventi, come un aggettivo etnico indicante ‘chi è del Capo di Sopra’ ossia chi è della Sardegna settentrionale. Ma i dizionari sardi non recepiscono il lemma; in più, non si è dato conto di quel tema in -íllu. Peraltro, se cabíllu significasse realmente ‘quello del Capo di Sopra’, ci aspetteremmo che quanti risiedono a nord dell’isola usino anch’essi un epiteto reciproco per indicare “quelli del Capo di Sotto”. Ma non c’è reciproco. È un dato reale che questo epiteto sia usato soltanto nel sud dell’isola. Si risolve il problema esclusivamente se mettiamo in campo il vocabolario semitico, dove abbiamo l’akk. ḫābilu, ḫabbilu ‘criminale, malfattore’. Il significato non ha bisogno di commenti. Ma si pone il problema di quando sia potuto nascere un tale epiteto. Poiché il lemma è arcaico, sembra di poter affermare che sia nato in epoca prelatina, addirittura prefenicia. Cfr. ad esempio i Cabìli, i ribelli che stavano sull’Atlante a fronteggiare l’avanzata romana, e poi l’avanzata araba.
La durata della parlata accadica in Sardegna non è ancora cessata, e si può supporre che questa sia stata usata – con piena e reciproca comprensione da parte dei residenti – almeno fino all’anno 1000 di questa Era, nonostante lo sforzo del clero orientale mirante a omologare la parlata sarda a quella di Bisanzio.
È verosimile che l’epiteto sia nato durante l’epoca buia dei quattro Giudicati, allorché i quattro regni si combatterono tra loro senza esclusione di colpi in vista della supremazia allo scopo di unificare l’isola. L’epiteto, viste le premesse, è nato sicuramente nel giudicato di Càlari. I Barbaricini, coloro che transumavano in pianura da Désulo, Villagrande, Gavoi etc., erano i classici Cabilli, intesi come “malfattori”. Ma nella storia mediterranea ogni popolo errante si meritò un simile epiteto dalla popolazione residente, che male li sopportava. Anche Gli Ebrei furono chiamati inizialmente Habiru (la /r/ al posto della /l/ è tipica della fonetica espressa dagli antichi Egizi e dai Cananei del Sinai); tale parola significava proprio “malfattori, banditi”, perché essi erano nomadi e perché davano assiduamente fastidio alle città cananee attorno alle quali essi, tornati dall’Egitto, portavano le greggi al pascolo e organizzavano azioni di disturbo. Dall’antico Habiru abbiamo in seguito Hebrew, Ebreo (la stessa pronuncia, appena modificata).
Cadalettu log. ‘pagliaio’. Stando al Baldacci, è un annesso relativamente recente delle case anglonesi, è sopraelevato e vi si accede da fuori mediante scala a mano. In altre case tipiche sarde esso, quando veniva creato, stava al difuori dell’abitazione. Questa parola sarda è una delle tante prove viventi dell’espansione e omologazione mediterranea degli antichi linguaggi. A dire del DELI, la parola cataletto (‘sostegno della bara durante il trasporto’), significherebbe… ‘sotto il letto’, poiché viene interpretata dal gr. katá ‘sotto’ + it. letto. Questo è il miserrimo livello delle ricerche etimologiche in Europa. In realtà, questa parola sarda ha base etimologica nell’akk. qâdu ‘to ignite, incendiare, accendere, dar fuoco’ + littum ‘stool, sgabello’; quindi qâdu-littum indicò in origine la funzione sacra – tipica del Mediterraneo, del mondo greco ma anche del mondo indiano – di dar fuoco alla pira sopra la quale veniva posto il morto. Da quella figura, abbiamo il termine sardo cadalettu, vista la somiglianza delle forme e la stessa sostanza di ciò che viene posto nel cataletto.
Cadíra camp., barb., nuor. ‘sedia’; cfr. cat. cadira. In log. si dice cadrèa (vedi), a Bitti catrèa. Base etimologica è il sum. kad ‘to tie, weave a mat, fabricate’ + ri ‘to lay down, place’. Il composto kad-ri (+ suff. aggettivale -ca) significò in origine ‘(oggetto) intrecciato per riposarsi’.
Castòne. Tanto per restare in argomento, notiamo che la voce it. indica la ‘sede della pietra preziosa’; cfr. germ. kasto ‘scatola’ < akk. kasû ‘legare, trattenere, incapsulare, imprigionare, afferrare’, e simili, il cui sostantivo kasû ‘captivus, trattenuto’ ha il femm. kastû. Il tutto deriva dal sum. kasu ‘calice’, ḫaštum ‘buco’.
Altra voce mediterranea è dòga (Fonni) dòva, dòa log. e camp. ‘doga’, = it. e lat.; base nel sum. dug ‘pot, vaso’, duggan ‘leather bag, borsa di pelle’. Per metonimia, col passare dei secoli in Italia e in Sardegna si passò a indicare soltanto il fasciame ligneo della botte (innovazione tecnologica), mentre agli inizi il contenitore era considerato per intero, quale che fosse la materia di cui era fatto, ivi compresi i sacchi di pelle, ossia gli otri.
Varie metonimie ha subìto anche il sd. fetta, vetta ‘nastro, nastrino, fettuccia ornamentale’. Base etimologica l’akk. betatu (plur. tantum di un *betu evidentemente sopravvissuto in Sardegna), che fu una ‘decorazione usata sui vestiti’; in accadico ha pure il significato di ‘oggetti di pelle’ (che sono opere d’artigianato). Con questa etimologia togliamo d’imbarazzo il Dizionario Etimologico della Lingua Italiana (in seguito DELI), che annaspa nell’impossibilità di offrire un etimo dignitoso alla parola italiana fetta ‘parte di cibo sottile separata di taglio dal corpo principale’. Infatti già da epoca arcaica le fette di cibo furono assimilate alle fette ottenute da altri oggetti, ad iniziare dalle pelli sottili, utilizzate per vestiti, scarpe, cosmesi.
Di metonimie è zeppo il Mediterraneo, ivi comprese tante metafore poetiche come Tirana, nome di città, dal sum. tir-an ‘arco del cielo, arcobaleno’. Per contro, nel Mediterraneo condividiamo anche voci ferali, come sd. buggínu aggettivale in -ínu < sum. ugu ‘morte’ (che nei millenni fece fiorire persino il cognome piemontese Bogino ‘carnefice’).
Il sd. Déu, Déus ‘Dio’ equivale al lat. dĕus ed al gr. Ζεῦς < sum. de ‘creare’ + u ‘totalità, universo’: de-u ‘Creatore dell’Universo’. Questa parola è fissa da almeno 100.000 anni, ed è sciocco pretendere che i Sardi l’abbiano importata.
Altra fissità si ritrova nel gr. δίκη ‘giudizio’ < sum. diku, dikud ‘giudice’; cfr. lat. dicō. L’appartenenza al campo sumerico è palmare, e dimostra l’arcaicità di questa parola, legata all’atto stesso del parlare, ai tempi in cui una parola equivaleva a un sasso, ogni parola era sacra, ogni parola era conferma di un fatto o di una cosa, era un giuramento inviolabile. Da lì questo venerando vocabolo mediterraneo.
Domu sd., lat. domus, gr. domos ‘casa’ è un’altra voce di estrema antichità mediterranea. Con tutta evidenza, nacque sul finire del Paleolitico, allorché l’uomo, che pure continuava a dimorare nelle caverne o nelle capanne di frasche, decise di erigere qualcosa di duraturo agli déi, facendo tesoro delle numerosissime fratture che notava nelle pareti rocciose, che gli diedero la prima idea delle sovrapposizioni litiche. Infatti la voce domu ha base etimologica nel sum. du ‘costruzione’ + mu ‘crescere’: du-mu = ‘costruzione in altezza’.
Il lat. niger, nigrum è parola mediterranea arcaica. Oggi il parlante occidentale, infatuato dalle mode americane, non vuole più usarla, allertato da una moda beghina secondo cui qualsiasi uomo “di colore” se ne deve adontare (guai a proporgli il contrario!). Ovviamente i negri appena sbarcati in Italia con provenienza centro-africana non accetterebbero mai un tale aggettivale, perché arrivano già imboniti dalla propaganda americana, rivolta al feticcio della parola in sé anziché a un rispetto democratico tutto ancora da condividere (anche in Italia!). Eppure in Italia questo aggettivale fu usato senza ipocrisia da sempre, persino in varie canzoni recenti (es. “Pittore ti voglio parlare”, “Mamma negra”, “Hully-Gully”). Ma oggi l’ipocrisia ci sta affogando, e finora – guarda caso – si è ignorata la base etimologica di negro, che è il sum. ni gur ‘che incute timore’.
Questo aggettivale latineggiante a sua volta ha un riscontro nell’it. nero, che – guarda un po’! – deriva dal sum. neru ‘nemico’.
Il discorso si chiude a triangolo col sd. nieḍḍu ‘nero’, la cui base non è un inesistente lat. *nigellus ‘nereggiante’, come invece qualsiasi latinista va proponendo senza criterio, ma è il sum. ni ‘fear’ + e ‘far entrare’ + dub ‘tremare’ = ‘paura che fa tremare’, ossia ‘paura tremenda’.
Il triangolo tirrenico niger/nigrum-nero-niéḍḍu, da qualsiasi parte lo assumiamo, sarebbe un affronto per i negri. E noi tirrenici, terrorizzati (resi niéḍḍi) dalla “dittatura dell’ignoranza”, non sappiamo più come trattare i nostri fratelli di pelle diversa, e ci lasciamo dominare dalle ideologie razziste, rendendole ancora più abiette da una catastrofica debolezza nell’uso del linguaggio degli avi.
È del tutto normale che moltissime parole sarde siano rimaste fisse dal primo remotissimo gemito sino ad oggi, quale può essere il log. pertúnghere, camp. pertúngiri ‘bucare, forare’: indubbia corruzione dal lat. pertŭndere ‘forare, bucare’, da cui anche sd. pertuntare ‘traforare, corrodere’, infine pertusare, -ái ‘bucare, forare, pertugiare’. Il pref. mediterraneo per- indica il passaggio da parte a parte, e la base etimologica passa per il lat. tundō ‘batto, pesto’, planando sul sum. tud ‘to beat, hit; colpire, battere’.
Territorialmente più percepibili sono certe sopravvivenze come pilótu camp. ‘palo da palafitta’ = sp. pilote ‘madero rollizo armado frecuentemente de una punta de hierro, que se hinca en tierra para consolidar los cimientos’ (cfr. it. mod. pilotis ‘colonna in cemento armato dei moderni palazzi’ < fr. pilot ‘palo’, pile ‘pilastro’). Wagner si soddisfa nel proporre la discendenza della parola sarda da quella iberica, e lì si placa, senza ulteriore indagine. Eppure queste voci sono di estremo interesse. Per quanto a qualcuno possa apparire astruso, la circolazione culturale che rinsaldò la Koiné Mediterranea fece viaggiare anche i termini che un popolano non avrebbe mai potuto formare direttamente ma soltanto accettare in virtù degli approci reciproci. Un sardo non conobbe mai la proboscide e nemmeno l’elefante, ma quel nome circolava culturalmente nel Mediterraneo. Pertanto gli fu facile condividere con iberici e provenzali la voce pilótu, pilote, dall’akk. pīlu, pīru ‘elephant’ (metonimia: ‘proboscide’) + ūttu-, āttu- ‘belonging to, relativo a’. Che la formazione pil-ótu, pil-ote sia stata formalizzata nell’ambito del Mar di Sardegna, lo si capisce dal fatto che ūttu- in accadico veniva prefisso, mentre in Sardegna ed in Ispagna venne suffisso.
La Koiné Mediterranea, a bene intenderla, fa capolino con decine di migliaia di parole sparse qua e là, che nessuno però accetta di percepire come fenomeno unitario. Purtroppo, senza questa percezione non si arriverà mai a padroneggiare questa Koiné, e sfuggirà un fenomeno come pitarra (Oristano), nome della ‘gallina prataiola’ altrimenti detta ‘otarda minore’ (Otis tetrax Cetti). Cfr. salent. pitarra, sic. pitarra ‘idem’; it. sett. pita ‘gallina’. Premetto che il nome sd. più usuale dell’otarda è pidráxu, che però ha la stessa forma basica di pitarra (pidr-). Wagner si limitò a segnalare le coeve presenze di pitarra ad Oristano, nel Salento, in Sicilia, in alta Italia, e suppose che pitarra in Sardegna fosse un accatto, cadendo nel deviante preconcetto del colonialismo. Tale preconcetto, proprio perché deviante, gli tarpò le capacità critiche, come ora vado a evidenziare. Infatti Wagner (DES II 284) si era meravigliato del fatto che pure in Italia sopravvivesse il suffisso -àrra da lui considerato di “origine preromana”. Tale fantasma era emerso in luoghi per lui insospettabili, poiché Roma, secondo lui, aveva latinizzato gl’Italici fino al midollo. Se solo avesse percepito la superiore presenza della Koiné Mediterranea, si sarebbe rilassato, riuscendo persino a scindere meglio la voce pitarra. Infatti l’etimologia deve partire dal prototipo sd. pieppìa ‘gallina’ (dove ritroviamo la base pi- < akk. pīum ‘becco’, opportunamente raddoppiata ad indicare il frenetico uso del becco fatto dalla gallina nel razzolare). Il secondo membro di pitarra non è quindi -arra (immaginato come suffisso) ma -tarra < akk. tarru (a bird); e pitarra in origine significò ‘uccello che razzola’, indicando genericamente vari tipi di gallinaceo.
Ragùsa toponimo italico e dalmata (anche cognome italico: Ragosa). Termine sacro mediterraneo, con base nel sum. ra ‘luce, splendore (riferito al Dio Sole)’ + guza ‘trono’, col significato di ‘trono di Ra’: segno che nell’area sorgeva il tempio al dio Sole.
Occorre ammettere che noi, figli di un Mare chiuso, siamo eredi di lingue fortemente innervate dalla potente Koiné Mediterranea. Ammettere ciò comporta la dissoluzione istantanea della pregiudiziale “latina” e di quella “ariana” (sia pure quando quest’ultima è camuffata da indogermanica), tenute in vita nelle orangeries delle varie Università. Se non dissolviamo quei preconcetti non riusciremo mai a capire perché Sirèna sia un antichissimo cognome sardo, mentre lo si riteneva nome prettamente greco poi emigrato a Roma. Omero (Od. XII) ci fa conoscere quelle creature marine che affascinavano col canto. Infatti Sirena (gr. Σειρήν) significa ‘Colei che affascina col canto’ < sum. šir ‘cantare’ + en ‘incantesimo, fascinazione, opera di magia’. Il dover ammettere che il nome sia sumerico equivale a riconoscerlo come mediterraneo.
Scampiái camp. ‘cessare di piovere’, ‘schiarire’ (del cielo) = cat. escampiar ‘asserenar-se, aclarir-se el temps’; sp. escampar ‘dejar de llover’; anche in tutta Italia meridionale scampare ‘idem’. Wagner con questi raffronti da lui fatti (e miranti a validare l’idea dello ‘scampare, salvarsi da un male’) non ha indicato un’etimologia di appoggio alle sue proposte, che pertanto appaiono surrettizie.
Indubbiamente, il verbo scampare in quanto ‘salvarsi da un male’ ha base nell’akk. kappum ‘wing, ala’, ‘hand, mano’, dove il suff. s-, es- ha la funzione di far percepire l’apertura della mano che libera la cosa afferrata (questa figura etimologica, a ben vedere, rende perfettamente lo scampare). Ma nel caso sardo ed iberico il campo semantico si allarga notevolmente e mira anzitutto all’akk. kappum ‘harness, finimenti, bardature’, dove il suffisso s-, es- offre il concetto della privazione, liberazione. Vedi anche akk. kapārum ‘to wipe clean, ripulir bene’. Quindi è grazie a queste tre voci accadiche che il sd. scampiái ed i due verbi iberici tessono il proprio campo semantico.
Di questo passo nella lista dei nomi mediterranei potremmo annoverare centinaia di migliaia di voci, e non è utile proporli in questa sede. Serve però qualche esempio affinché il lettore capisca la situazione linguistica entro cui ci muoviamo. Quindi gli propongo anche il sd. seḍḍa = it. ‘sella’ < sum. šed ‘to rest, poggiare, riposare’: si può notare l’appartenenza della voce sarda al vocabolario sumerico nonché la differenza grafico-fonetica di quelle italica e latina. Il lat. sĕlla valorizza il significato di ‘sedia’ < akk. sellu ‘archivolto’ (an architecture feature: tutto un programma), ma per il resto la voce latina è precisa alla parola italica. La differenza fono-grafica tra seḍḍa-sedia-sella nonostante l’unità del campo semantico, deve far meditare sulle sottili differenze tra le lingue tirreniche, sulle minime convergenze-divergenze dovute all’autonomo maturare dei processi linguistici, senza che ciò richiami l’assurdo principio della “origine” o della “derivazione”. Questa opposizione fono-grafemica deve far meditare pure sull’inaccettabile modo di affrontare il problema della cacuminale sarda -ḍḍ- (presente anche in sud-Italia), la quale si differenzia dalle liquide -ll- del centro-nord Italia. Non è questa la sede per discuterne, anche perché questo problema è stato illustrato e risolto nel cap. 3.1.5 della mia Grammatica Storica (intitolata Grammatica della Lingua Sarda Prelatina).
Eccoci giunti all’avverbio si log. e camp. ‘se’, ‘nel caso che’, ‘nell’eventualità che’: indica esitazione, incertezza, dubbio, condizione. Di questa voce mediterranea s’ignorò l’origine. Ha base nell’akk. Sê’, Sîn ‘Dea Luna’. Nel lontano passato entrò in qualsiasi invocazione rivolta alla Luna. Si deve assumere per certo che questo onnipresente Se, Si fosse a capo di quasi ogni frase, così come ancora oggi Insciallah tra gli Arabi. Nella lingua italica medievale il se era usatissimo nel senso di ‘se, voglia il Cielo che…’, e ciò è una spia di quanto vado affermando.
L’esempio del monosillabo si, se rintuzza anche un’altra illusione pollonata assieme a quelle già esaminate: è l’illusione (o la scorretta prospettiva) della “evoluzione” delle lingue. Certamente l’evoluzione avviene, è innegabile, ma il lettore deve capire una volta per tutte ch’essa è molto più lenta di quanto s’immagini, e per moltissimi vocaboli è più apparente che reale. Diciamo pure che moltissimi vocaboli non si sono mai evoluti sin dal momento in cui (40.000?, 100.000 anni fa?) furono formulati. Rifacendoci all’agglutinazione prediletta dalla lingua sumerica (ma non solo da essa), possiamo affermare che moltissimi vocaboli mediterranei non sono altro che agglutinazioni di monosillabi sumerici. Prendiamo l’it. singulto ‘singhiozzo’, lat. singūltum ‘idem’. Base etimologica è il sum. sim ‘to swallow, inghiottire’, ‘deglutizione’ + gul ‘to destroy’ + tu ‘incantation, incantesimo’. L’agglutinazione sim-gul-tu in origine significò ‘incantesimo che distrugge la deglutizione’.
Lo stesso processo vediamo nel sd. tambùru, it. ‘tamburo’. Nel Mediterraneo il termine esiste da tempi arcaici; il nome dello strumento primordiale che rimbomba con la percossa ha origine primitiva, ed è facile ricavarlo dal sum. tun ‘contenitore, cassa, sacco, stomaco’ + bur ‘albero’ (tun-bur), col significato originario di ‘cassa d’albero’ ossia ‘albero cavo’.
Medesima fissità ritroviamo nel sd. zéru, it. zèro, fr. zéro, sp. cero. Rinvio al Dizionario per leggere le lambiccate e scorrette etimologie proposte dai più illustri etimologisti per una parola mai compresa. In realtà zero deriva dall’akk. zēru ‘seme’, ant. ebr. zeraʽ (זֶ֫רַע). Con ciò gli Accadici (Babilonesi), grandi cultori di matematica, volevano intendere che dallo zero, come da un ‘seme’, origina la sequenza dei numeri.
Altra parola inalterata è il sd. tzilléri ‘bettola, taverna’, sp. cillero, cat. celler ‘bodega’. Base etimologica di questo aggettivale in -éri è il sum. zil ‘to boil, peel; bollire, sbucciare’. Questa voce sardo-iberica ancora oggi indica il posto dove si cuoce (il cibo), ossia la taverna dove un viandante o un pellegrino poteva fermarsi a mangiare.
Molte voci sarde sono presenti sia in sumerico sia in accadico, com’è per toróju log. ‘urlo, grido, pianto scapigliato, mortorio, piagnisteo’; pránghere a toróju ‘piangere dirottamente’. Base etimologica l’akk. turu’u ‘a cry’ da sum. tur ‘to be ill, star male’. Cfr. gallego aturujar ‘ulular, berrear’ e altre voci simili.
Altre voci sarde si riesumano soltanto dall’accadico (e dall’assiro-babilonese), come il citato zéru. Consideriamo all’uopo vánuva, fánuva camp.; fánua, fáuna log. ‘coperta da letto imbottita’; cat. vànova ‘frazada’; è un aggettivale s’ignorò l’origine. Base etimologica è l’akk. banû ‘make good (object); look after s.o. kindly; render buono (un oggetto), prendersi cura di qualcuno delicatamente’. La presenza e consistenza di rarissimi oggetti di lusso tra le popolazioni del Neolitico rendeva una coperta imbottita (di lana di pecora) assai confortevole. Le pretese del Wagner che questa voce sia nata in Catalogna e poi esportata in Sardegna sono miopi e fallaci. Se fossero state scientifiche, egli avrebbe dovuto indicare la base etimologica della voce catalana.
Con l’ausilio dell’intuizione (dell’intuizione utile…) possiamo chiarire il mistero del sintagma italiano “sbarcare il lunario” ossia ‘riuscire a campare sia pure stentatamente’. Si crede il sintagma esclusivamente italiano, senza considerare i radicali sottesi alle due parole, che sono mediterranei, in uso quasi ovunque, anche in Sardegna. I radicali indicano lo stesso concetto, uno accadico e l’altro sumerico: s-barcare < akk. warḫu ‘moon’; lunario < luna (agglutinazione sum. lu ‘to flare up, divampare’ + nu ‘creator’: lu-nu ‘Creatrice divampante’, ossia ‘Dea Luna’, ‘Dea Madre’). Quindi “sbarcare il lunario”, con s- che precisa il valicare, l’andare oltre, indicò l’azione di “superare il mese” (quello lunare, ovviamente). La barca non c’entra nulla.
Altra voce mediterranea incompresa è il sd. casu ‘formaggio’. Perché gli dò importanza? I fautori della “pregiudiziale latina” lo derivano dal lat. căsĕus e non s’accorgono che căsĕus è aggettivo, quindi seriore rispetto al vocabolo sardo. La base etimologica è l’akk. kasû ‘rappreso, legato’ (e siamo al formaggio). Vedi anche akk. kāsu ‘cup, bowl’, ‘misura di capacità’ < sum. kasu ‘calice’ (e siamo alla ‘scodella che dà forma’, quindi nuovamente al formaggio, ‘quello che prende forma’). Però il cognome sd. Casu non significa ‘formaggio’ ma ha base nell’akk. ḫašû astron. ‘scuro’, gr. Χάος ‘immensa buia cavità che accoglie le acque primordiali’. Ebbene, sì, il Χάος greco in Sardegna si chiamava Casu, in virtù dell’autonoma elaborazione delle radici e dei suffissi mediterranei.
Buon penultimo è il sd. pilla ‘denaro, soldi’ (parola che riemerge anche in sud-Italia: vedi la mia Grammatica Storica). I cosiddetti “puristi” la considerano voce di slang, ed ignorano che la base è il sum. pil-la = ‘unità di pagamento’: pi ‘unità di misura’ + la ‘pagamento’.
Conscio d’essermi concesso molto spazio (ma la situazione lo reclamava, essendoci innumerevoli casi), chiudo l’elenco, illustrando brevemente la questione del sardónios ghélōs o sardánion ghélōn, ossia del ‘riso sardònico’. Non intendo affatto inserire l’argomento nel paragrafo seguente relativo alle voci autoctone del vocabolario sardo, poiché questa voce non è autoctona: è solo martoriata. La prima apparizione scritta collegabile a questa espressione è in Omero Od. XX 301-302, allorché Odisseo schiva la zampa di bue lanciata da Ctesippo e “ride sardonicamente” (μείδησε δε θυμῷ σαρδάνιον μάλα τοῖον ‘sorrise in cuor suo, però dolorosamente’). L’unica ricostruzione arcaica cui è possibile agganciare l’aggettivo avverbiale greco è il composto sum. sa ‘to burn’, ‘to sting, pungere’ + raḫ ‘disease’, ‘to beat, break, crush’ + du ‘to push, thrust, gore; spingere, attaccare, incornare’ + niḫuš ‘terrifying appearance’, che agglutinandosi (sa-raḫ-dú-niḫuš, poi contratto in sardúniḫuš) porta al significato compatto di ‘dolorosissimo, sconvolgente’.
Ma tanti seriori autori greci e latini, nel tramandarsi a vicenda un’incompetenza culturale sull’omerico σαρδάνιον, sono andati a parare su altri significati, a loro parere legati a un’erba speciale che fa morire tra spasmi di labbra e digrignar di denti; senza peraltro aver mai pensato che Omero con l’aggettivo σαρδάνιον volle descrivere lapidariamente un Odisseo muto e serio, che non aveva sorriso apertamente per la provocazione di quel prepotente ma aveva soltanto rimuginato nel proprio animo la vendetta.
Sul riso sardònico si potrebbe scrivere un libro, ma sarebbe sprecato, perché parlare dell’erba sardònia o del riso sardónio è come parlare del sesso degli angeli. Nella storia di questo appellativo ognuno degli autori è stato coinvolto in un vortice di traviamento collettivo, condito da ignoranza, da presunzione e dalla fiabesca distanza tra Grecia e Sardegna, un’isola che i Greci non avevano mai visto ed alla quale, considerata la sua dislocazione nel mitico Occāsŭs Sōlis, potevano conferire a man salva tutti i misteri mediterranei covati dalle civiltà dell’epoca. Tutto ciò portò poeti e pensatori a girare su se stessi sino a parare in una messe di paronomàsie che si stratificò ed ammuffì col passare dei secoli. Il riso sardónio puzza di stantio.
In ogni modo, il gr. sardónio può anche essere inquadrato nel sum. šar ‘vacca’ + du ‘imprigionare’: šar-du ‘imprigionare entro la vacca’. Era l’urlo lacerante emesso dai moribondi nel ventre metallico di questo arnese inventato dai Cretesi e surriscaldato. Altri lo chiamano Toro di Faláride, perché donato al tiranno Falaride di Agrigento da Perillo ateniese. Il sardónikos ghélōs fu una cosa orribile che oggi, con cinica metonimia, possiamo intendere come ‘risata smodata, plebea, esagerata, chiassosa, urlante’.
Se invece vogliamo mutare il gr. sardónios in gr. sardonicós, la voce sarebbe un po’ seriore, essendo da inquadrare in un composto sumero-accadico cui sarebbe da aggiungere l’akk. niqû ‘sacrificio’. A sua volta ghélos < sum. gi ‘giudizio’ + lu ‘divampare’, ossia ‘giudizio del fuoco’. Pertanto sardonicós ghélos, nella sua commistione di sumero-accadico, presenta una pari sovrapposizione di concetti, e andrebbe a significare nel complesso ‘sacrificio dell’imprigionamento entro la vacca’ o ‘giudizio del fuoco entro la vacca’.
Arcaicità della lingua sarda. Il breve saggio sui vocaboli mediterranei non deve far pensare che ai singoli popoli rivieraschi mancasse la possibilità e l’estro per invenzioni autonome (vedi il già citato Karallu). Ogni popolo ha sempre usato la lingua secondo il proprio genio, ed i fenomeni d’isolamento – macroscopici in Sardegna – impulsero a “far da sé”, senza per questo che si smettesse di collaborare al proficuo scambio culturale al quale la Sardegna non si è mai sottratta. L’enorme massa di radicali sumerici (ed in seguito accadici) fu la banca-dati da cui attingere sia per usare il vocabolo nella sua purezza sia per elaborare filiazioni, o “ricamare” concetti autonomi. Quindi non deve far meraviglia che la stessa radice sumerica o sumero-accadica abbia dato corso a voci diverse nei singoli popoli rivieraschi. I suffissi, i prefissi – eredità del plancher sumerico – sono l’ingrediente che arricchisce i processi della fantasia individuale; cui si somma l’abitudine alla metatesi (es. craba anziché capra), alla diversa accentazione (es. càmpana anziché campàna), all’apofonesi (citerò più oltre qualche sporadico esempio latino, italico, sardo, accadico, sumerico di mutamenti -a- > -i- oppure -a- > -u-). Questi processi sono stati da me studiati e illustrati nella Grammatica Storica, e qui non m’attardo.
Sta di fatto che, per ovvie ragioni, i singoli popoli hanno elaborato i propri vocabolari secondo esigenze peculiari, e pertanto non tutti i vocaboli rintracciati per l’ampio bacino costiero sono identici tra i popoli. Molte voci appartengono ad un solo popolo.
Di seguito propongo un breve elenco di vocaboli (tra le migliaia) che appaiono formati unicamente dal genio sardo.
Áere log. ‘avere’; camp. ái; sass. abe’. In sardo antico si usava come verbo transitivo. Oggi s’usa più che altro ténnere, ténniri, jùkere, al di fuori del centro-isola dove invece prevale ancora áere. Il sd. áere, ái ha sempre vissuto in autonomia senza ricevere influssi diretti dal lat. habēre, it. avère. La spia di tale separatezza è l’assenza nel verbo sardo di h-, la cui presenza avrebbe postulato tutt’altra radice di formazione, come ora vedremo.
A mio avviso, il sardo áere, ái ha base etimologica nel sum. ab ‘cow’, mentre il lat. habeo ha base nel sum. ḫabum ‘animal’. Ambedue le basi fanno riferimento ad animali (si presume d’allevamento), specialmente alla vacca, da sempre considerata il peculium per antonomasia. Così come ancora oggi accade presso i popoli pastori del centro-Africa, considerati “possidenti”, “benestanti”, contrapposti a coloro che non posseggono bestie, anche per gli antichi Sardi e Latini il destino dovette essere uguale: il possesso di bestiame li rendeva liberi e ricchi. Di qui la nascita del verbo avere, riferito alle vacche o agli animali in genere.
Agarrutu in una pergamena arborense del sec. XII, pubblicata secondo l’originale in AStSa II 426 dal Besta, che interpreta ‘qualità di terra, forse brughiera’ (p. 429). Il passo suona: Et ego donna Nibata ponioiue saltu de Suberiu et pauli de Figu e fenu e pastu e perra de bilbicesos e bau de bodes e agarrutu. (Nell’apografo pubblicato nl CDS I, 164, che formicola di errori, si legge: e pezza de bilbiusos, abandecodes e agarratu). Niente giustifica l’interpretazione del Besta e il passo non permette di dire niente di sicuro.
Tutto quanto precede è stato scritto dal Wagner nel DES. Posso sollevare Wagner dall’angoscia facendo notare che agarrutu ha il perfetto corrispettivo in accadico: agarrūtu ‘bracciante salariato a giornata’.
Alguatzíle, -i log. e camp. ‘usciere, sbirro’; Wagner lo considera ormai fuori uso, ed in ogni modo non evidenzia l’etimo. Base etimologica è l’akk. āliku ‘goer, traveller, messenger’ + aširi (person of a special status). Pare evidente che ālik-aširi nell’alta antichità in Sardegna fosse un messo con poteri ispettivi.
Allegare, -ái log. e camp. ‘discorrere, parlare’; allèga ‘diceria, discorso’. Wagner lo crede verbo dell’uso giuridico, da it. ‘allegare, addurre ragioni, argomentare’. Ma la forma-base del lemma sardo è composta da ad (particella sardo-mediterranea di moto a luogo) + sum. ligin ‘tavoletta d’argilla con excerpta scolastici da imparare’, ligtum ‘selezione, raccolta di materiale’. Va da sé che allegáre è verbo sardiano risalente alle antichità sumeriche, indicante l’azione del “trasmettere nozioni per l’apprendimento; parlare insegnando”.
Allégru log., allirgu camp. Questo termine sembra derivare dall’it. allegro ‘lieto, giocondo’, per il quale si accampano strane e incomprensibili etimologie: fr. allegre (1130) dal lat. alacrem (DELI). Quella voce francese va bene, fa parte dell’uso mediterraneo, mentre è la voce latina ad essere discorde. Penso che la base etimologica dei lemmi sardo, italico, francese sia il sum. lugura ‘reaper, mietitore’. Si può rendere giustizia a questo termine soltanto se ci mettiamo nella condizione di capire gli antichissimi mietitori, i quali entravano nei campi cantando le lodi dell’Altissimo, felici perché stavano partecipando al rinnovo annuale del dono della vita.
Alòre log. ‘caldo lento’ (Spano). Secondo Wagner è probabile derivazione dall’it. alidore ‘siccità, stagione alida’. Invero, base etimologica è il sum. alur ‘to bake, cuocere al forno’.
Attonare, -ái log. e camp. ‘ristorare, mettere in sesto’; attonare su stόgumu ‘ristorare, rifocillare’. Anche in Italia si dice attonare lo stomaco. Ma non siamo di fronte a un cultismo, come purtroppo crede Wagner, poiché la parola è mediterranea, avendo per base il sum. tun ‘stomaco’, ‘sacca’, ‘contenitore’.
Aúra log. ‘spirito misterioso, spettro’, ‘paura’; bonaúra ‘fortuna’, disaúra ‘disgrazia, sciagura’; auradu log. ‘spaventato, atterrito’; anche ura ‘evento cattivo’ (nel senso di ura mala). Wagner non sa trovare l’etimo. Invero la base etimologica è il sum. ur ‘liver, fegato’, quello che nell’alta antichità veniva sezionato per ricavarne gli auspici (buoni o cattivi).
Aúrghere log. ‘muoversi, sforzarsi, piegarsi’ (Sanna, StaSa XII-XIII parte II, p. 441); aúlghere ‘muoversi, sgranchirsi’ (Casu). L’etimo ha base nell’akk. urḫum ‘via, sentiero’. Wagner ne indica insensatamente la dipendenza dal lat. indulgeō ‘sono ben disposto’.
Avra log. indica la ‘brezza fredda nociva alla frutta’. La sua base arcaica sta nel sum. a ‘acqua’ + bar ‘to burn’: a-bar, per metatesi avra, indicò in origine l’acqua che brucia. Evidentemente siamo in quelle rare giornate di pieno inverno quando piove acqua sopraffusa, pressoché invisibile ma capace di lasciare un millimetrico strato di gelo dappertutto, distruggendo le piantagioni.
Bi, be sd. avverbio di luogo. Cfr. ug. b ‘in’, ebr. be- ‘in’; l’avverbio di luogo cananeo è sempre agglutinato alla parola retta (es. B-ŠRDN ‘in Sardegna’, dalla Stele di Nora). L’avverbio di luogo ugaritico-fenicio-ebraico b (be) è anche sardiano. Si ritrova in molte indicazioni di luogo nelle forme be, bei, bi; indica sempre un luogo, non sempre preciso, lontano dal parlante: ‘lì’, ‘in quel luogo’, ‘a quel luogo’: siéntzia bei keret, no bestire!; a contos male fatos si bi torrada; ite b’ada?; in s’isterzu de s’ozu non be podiat aer ke murca; de listincu be nḍ’aìat prus de una molinàda; a campu bi anḍo déo; bazibbéi a domo sua; a bi sezis, si benzo a domo bostra?; in su putu bi at abba; no bi creo!
Biscaccàda ‘lentiggini’. Zonchello ignora l’etimo ma azzarda derivi da biscaccu ‘conchiglia, patella’. Sbaglia. Base etimologica è l’akk. biṣu, biṣṣu(m) gocciolina’ + kakkû(m) ‘lenticchia’. Lo stato-costrutto significa, letteralmente, ‘pioggia di lenticchie’.
Cambiare, -ái log. e camp. ‘cambiare’. Verbo presente già nei condaghes, che secondo Wagner sarebbe un evidente apporto dal tardo lat. cambiāre, di origine gallica secondo DELI. Non sono d’accordo né con l’uno né con l’altro. Base etimologica è il sum. kam ‘to alter, modificare, cambiare, mutare’ + ba ‘to distribute, ripartire’. Queste sono le stesse radici sumeriche che determinarono la nascita della parola sd. camba, da cui l’it. gamba, la quale è l’arto degli animali e dell’uomo che ha la funzione di ripartire e mutare continuamente il peso durante il movimento.
Catóiba sass. ‘prigione’. Base etimologica è l’ant. akk. ḫaṭû, ḫaṭṭû, ḫaṭ’um ‘criminal, criminale; to do wrong, commit crime, agir male, commettere crimine’ (towards someone) + ewûm ‘to impose on, imporre’. Quindi il composto ḫaṭṭû-ewûm significò in origine ‘imposizione, pena per il criminale’. Col tempo ewûm fu pronunciato -ebu, -ibu, per legge fonetica tirrenica. Questo vocabolo non esiste in nessun altro dizionario sardo, tantomeno italico.
Cùa è voce assente nei dizionari mediterranei. Dovette essere l’antico nome sardo della ‘civetta’ e del ‘gufo’, sopravvissuto grazie al cognome Còa, registrato nel condaghe di Bonarcado 57. La locuzione log. fàghere assa cùa significa ‘agire di nascosto’. Cùa, cuba è l‘atto del nascondere. L’infinito cuare ‘nascondere’ è un chiaro denominale, essendo cùa il sostantivo originario, da akk. ḫū’a ‘civetta, gufo’.
Débile, débili log. e camp. ‘debole’; cfr. lat. dēbilis ‘che manca di forza’. In Sardegna sarebbe arrivata dalla Spagna (débil) secondo Wagner. Invece la voce è decisamente sardiana, prima ancora che latina e spagnola: esattamente è l’opposto di ábile, che ha base nell’akk. ābilu ‘trascinatore’ (detto della professione di chi trascinava le navi lungo i canali o i fiumi, e detto anche dell’aquila in Logudoro).
Ábile log., ákila, ákili camp. ‘aquila’; áe (Nuorese). È proprio questa serie di vocaboli sardi (uno per ogni macro-tribù preromana) a testimoniare la scaturigine autoctona del su citato débile. L’etimologia di ákila ha base nell’akk. ākilu ‘divoratore’ (cfr. lat. aquila). Ma in Sardegna un’altra tribù utilizzava un secondo (e doppio) registro, che è āgilu, ābilu ‘trascinatore’ (detto della professione di chi trascinava le navi lungo i canali o i fiumi). Infatti destò sempre ammirazione il fatto che l’aquila con la sua forza poderosa sia in grado di sollevare e portar via persino un animale di media stazza come una pecora o un muflone. La controprova dell’autoctonia di ábile si ha in barbaricino col terzo vocabolo áe, indicante l’Aquila del Bonelli, il cui nome si riferisce parimenti al “trascinatore di navi” (dal sum. aʼu ‘towman’). Non fa meraviglia che il nome dell’aquila abbia migrato dalla Sardegna a Roma, e non viceversa: la Sardegna è fortemente montuosa e selvaggia, mentre il Lazio è fortemente pianeggiante, o leggermente collinoso, quindi totalmente arabile: luogo difficile per la dimora delle aquile.
Dogare centr., doare, addoare log. ‘scavare un fosso intorno ai terreni da debbiare’: fákere sa doga (Nuoro) ‘dissodare la terra in modo che il fuoco non passi’. Base etimologica è il sum. dub ‘to go around, encircle, turn, surround’. Col tempo, evidentemente, il termine sumerico fu omologato foneticamente al radicale sum. dug ‘pot, vaso’. Notiamo anche l’evoluzione di dogare nel significato di ‘ripararsi dal fuoco’ (fattende dogas), poi in generale ‘ripararsi’, ‘scansare’, anche ‘ripararsi (dalla pioggia)’.
Forru log. e camp. ‘forno’; cfr. lat. furnus. Base etimologica il sum. bur ‘to glow, abbagliare; to light, accendere, infiammare; to shine, risplendere, brillare’ + ru ‘architecture, costruzione’. Il composto bur-ru significò in origine ‘costruzione per accendere (il fuoco)’. La sardità della voce si percepisce per l’assenza del riempitivo -n- esistente invece nel lat. furnus. Mio malgrado, debbo segnalare DES I 536 affinché il lettore conosca le prolisse e allucinate elucubrazioni scritte su forru, ammannite come fossero ragionamenti scientifici.
Francusìna orist. ‘colica’, ‘mal di pancia’. Cossu 151 ricorda che quando uno restava a lungo col broncio gli dicevano: Pigáu sa francusina t’esti? ‘t’ha preso la colica?’; e per una persona che s’intristiva alquanto (s’affringillonàḍḍa) e non aveva voglia e forza di fare dicevano: Paris cun sa francusìna ‘Sembri con la colica’. Ma è veramente strano che per francusìna s’intenda proprio la colica, considerata la sua etimologia.
Per Wagner sa francusìna è una formazione scherzosa. Replico di no, poiché francusìna ha un proprio etimo, l’akk. parāku(m) ‘giacere di traverso, ostruire’, ‘impedire, ostacolare’ + sînu ‘luna’ col significato di ‘avere la Luna (il dio Luna) di traverso, ossia contrario’. Ora sappiamo quale è la locuzione più antica, e da dove ha origine la frase italiana tanto nota, relativa a una persona (donna prevalentemente), momentaneamente asociale, che appunto “ha la luna di traverso”, da parāku(m) > p(a)raku > franku + sînu.
Fruttòsa (Bitti) ‘piccola spazzola per pulire l’aia’. Wagner dichiarò d’ignorare l’etimo, essendo rimasto sconcertato da questo vocabolo evocante un frutto. Invero, la base etimologica è la stessa di bruttu ‘sporco’, bruttèsa ‘immondezza’; centr. bruttáre, log. imbruttáre, camp. imbruttái ‘sporcare, lordare, imbrattare’. Per la discussione e l’etimo vai a bruttu.
Gangorra ‘svasso maggiore’ (Podiceps cristatus) (Campidano); in camp. indica anche la ‘strolaga minore’ (Colymbus septemtrionalis). Base etimologica è il sum. gan ‘child-bearing, to bear young’ (infatti lo svasso maggiore porta i neonati sul dorso) + gur ‘bearer’: gan-gur ‘colei che porta i bimbi sul dorso’. L’analisi di questa voce portò Wagner fuori pista inducendolo ad associarla a gangas ‘tonsille’ (sic), e proponendola addirittura come onomatopea (sic).
Génti arrùbia ‘fenicotteri’ < sum.-akk. enti rubû ‘uccello re’ (v. akk. rubû ‘re’).
Grillu camp. ‘germoglio delle patate invecchiate, di semi, frutta, cipolle, aglio’ < sum. gir ‘erbaccia’ + lu ‘spuntare’: gir-lu > met. grillu = ‘germoglio che spunta, che fiorisce’.
Gutta1 camp. ‘goccia, gocciola’; cfr. lat. gutta ‘goccia’; centr. gúttiu ‘goccia’; log. búttiu, úttiu ‘idem’. Base etim. nel sum. gu ‘pulse, polso, vibrazione; bean, chicco, grano’ + tar ‘to untie, scatter, disperse, decide; disfare, sciogliere, slegare, spargere, sparpagliare; disperdere; staccare’. Quindi il legame gut-tar in origine indicò il ‘chicco che si stacca (dalla massa idrica)’. Da qui l’it. goccia.
Ibi, ibe barb. ‘costà, colà’ (Oliena: a ibe ‘là’; CSP 62: iui iumpat ribu; 63: aue sa foke a derettu ad iui; 220: e ccun sa uinia ki est iui; CSP 30: ki ui fuit curatore; ecc.). Si badi che questa voce è latina, e fu portata in Sardegna dai preti che scrissero le pagine dei condaghes (vedi più oltre). La propongo soltanto perché si capisca ch’essa a sua volta fu una rielaborazione latina della seguente voce autenticamente sarda.
Ingòlliri camp. ‘cogliere, incogliere’: questa traduzione è del Wagner, ed è riferita a una voce italiana alquanto omofonica ma non omosemantica. Ingòlliri indica invece il ‘colpire, ferire’: si podit ingolli ‘si può ferire’ (Villacidro). Base etimologica è il sum. gul ‘to destroy, break, flatten; distruggere, rompere, abbattere’. Il verbo è autoctono. Purtroppo quel significato di ‘cogliere, incogliere’ è messo in primo piano dal Wagner (DES 583) per evidente incapacità di comprendere il fenomeno sardiano. Il nostro filologo insiste nell’indicare la base italica di tale voce, anche a costo del ridicolo, nel centr. goḍḍìre ‘cogliere, raccogliere’, un significato che va in rotta di collisione con quello di ‘colpire, ferire, distruggere, abbattere’. La procedura d’inventarsi dei significati inesistenti e (ciò che è peggio) legarli d’autorità al campo italiano (o iberico) è frequente in Wagner.
Ísola cognome sd. < bab. is lê, iš lê ‘le fauci del Toro’ (ossia costell. delle Hyadi). Alìsa è lo stesso cognome Ísola ma rovesciato. Notisi che l’akk. is lê, iš lê in sd. è usato pari pari oppure è capovolto in al isu, ma il composto si traduce ancor sempre ‘le fauci del Toro’ (Hyadi) < alû ‘Toro del Cielo’ [ossia costell.] + isu ‘fauci’. Quanto precede è un luminoso esempio di come tra i Mesopotamici ed i Sardi in quel periodo, pur usufruendosi di una stessa Koiné linguistica, si aveva agio di “personalizzare” la combinazione degli elementi.
Kenábura, cenábura, cenábara. La Sardegna è l’unica regione mediterranea dove il ‘venerdì’ ha nome kenábura, sd. ant. kenápura.
Wagner (La lingua sarda p. 72) ricorda che già S.Agostino afferma la presenza della locuzione cena pura nella Bibbia precedente la Vulgata (locuzione sparita poi, stranamente, proprio dalla Vulgata): e qua notiamo la prima confusione del Wagner. Egli non spiega perché la “locuzione latina” fosse già presente nella Bibbia (ebraica o greca?) prima ancora della sua traduzione in latino; dice soltanto – senza dimostrarlo – che corrispondeva al gr. δεῖπνον καθαρόν ‘cena pura’. «Gli Ebrei lo adottarono per designare la vigilia di Pasqua, durante la quale ogni traccia di lievito doveva essere rimossa dalle case». La denominazione cena pura indicava, insomma, per Wagner, la vigilia della Pasqua ebraica, ed oltre a ritenerla locuzione del rituale pagano (sic!) egli confonde ancora il discorso, introducendo παρασκευή (parascève) come corrispondente alla voce cena pura (sic!), mentre noi sappiamo che παρασκευή significò ‘preparazione’ (preparazione al sabato, shabbat)’, e solo in seguito giunse a significare tout court ‘venerdì’. A Wagner sfuggì che il sd. kenàbura, kenàpura non deriva dal lat. cena pura ma da un composto sd.-ebr. kena-pura, forma cananea indicante la ‘cena di Purim’, che è la grande cena che il popolo ebraico fa il 14 ed il 15 del mese di Adar in commemorazione della propria salvezza dallo sterminio rischiato in terra babilonese prima della definitiva liberazione (la celebre congiura di Amàn); essa cade per caso abbastanza vicina alla Pesah. In tal guisa si è confusa Purim con la purificazione dai lieviti attuata prima della Pasqua. Ma tale confusione fu introdotta nel medioevo dai preti bizantini. Fatto sta che kenábura in terra sarda è un lascito ebraico precristiano. Non esiste né in Israele né altrove. Si può calcolare che la parola sia nata in Sardegna dopo il 500 a.e.v., ossia dopo la liberazione degli Ebrei, la cui strabiliante fama si espanse immantinente presso gli Ebrei che avevano già operato le prime diaspore mediterranee durante le grandi persecuzioni degli Assiri e dei Babilonesi. A meno che la parola non sia nata tra i 4000 ebrei trasferiti in Sardegna da Tiberio nel 19 e.v. Sta di fatto che la parola nacque in terra sarda, tra ebrei che si erano perfettamente fusi con la popolazione sarda. Quindi kenábura è la testimone più recente della produzione lessicale dei Sardi prima o a ridosso dell’Impero romano.
Kida, kita, kèḍḍa, ceḍḍa, cida ‘settimana’< sum. kid ‘staccare, spezzare, rompere; tagliare’. Con tutta evidenza, già dal Paleolitico i Sardi avevano capito il vantaggio di sezionare in quattro settimane il ciclo lunare, per scopi non solo astronomici ma anche calendariali. Questa parola sarda non ha alcun riscontro nel bacino, ma l’arcaica Koiné Mediterranea rispunta prepotentemente nell’anglosass. cut (to cut) ‘tagliare’ < sum. kud ‘tagliare’. E si noterà in kid/kud l’apofonesi i/u (poi vedremo quella a/i) da me citata nell’incipit, che operava nella grammatica sumerica e dilagò per tutti i popoli mediterranei (cfr. lat. faciō-efficiō, it. faccio-feci).
Miále, Miáli log. e camp. ‘Michele’; nei documenti antichi Mical, Michali, Migali, Miali = gr. biz. Μιχάλη(ς). Si può notare la caduta della velare già nel Medioevo. Poi questo processo ha preso il sopravvento in base alla legge fonetica sardiana che fa cadere le velari, specialmente nelle sillabe accentate. Questo processo infine contagiò l’altra sponda tirrenica.
Nuráki sd. ‘nuraghe’ < sum. nu ‘creatore’, ‘sperma (divino)’ + ra ‘puro’, ‘ fulgido’, ‘splendente’ (v. eg. Ra ‘Sole che splende’) + ki ‘place, earth’ = ‘sito di Ra Creatore’. Questo vocabolo è autoctono della Sardegna, al pari di log. nuraghe dove si sostituisce -ki con -ghe, evidenziando così il radicale sum. ĝa ‘house’, ge ‘shape’ (leggi ghe; ‘an architectural term’); quindi nel caso del Logudoro il significato fu ‘forma, edificio di Ra Creatore’. Insomma, i nuraghes erano dei monumenti al Dio Sole, epifania di Ra (egizio), di Eli (semitico), che rappresentavano il Dio Sommo.
Parissùos log. ‘Diavolo, Satana’. Base nell’akk. parriṣu ‘criminale’ o parīsu ‘colui che divide’. Wagner gli dà il significato di ‘(da) pari suo’, al medesimo livello’ «perché il diavolo vuol farsi pari a Dio» (sic!). La sua forzatura è suggerita dalla “pregiudiziale latina”, poiché Wagner non si volle mai misurare con le lingue semitiche. Invero, questo vocabolo è strettamente sardiano.
Piréḍḍu (Siniscola) ‘ugola’. Può essere diminutivo di pira ‘pera’ o di piru ‘cavicchio di legno’ (vedi). Però debbo rimarcare un fenomeno già chiarito nel paragrafo precedente (alla voce pilótu). In akk. pīru significa ‘elefante’ (questa è la traduzione del CAD e del CDA), mentre nelle attestazioni sarde il vocabolo prende l’inequivocabile significato di ‘proboscide’ (metonimia). Se sono nel giusto, traduco il sd. piréḍḍu come ‘piccola proboscide’ (per il modo come l’ugola si muove). Quella di piréḍḍu è una delle tante prove dell’autonomo svolgimento della lingua sarda rispetto al sumerico e all’accadico, al dilà della vasta condivisione dei radicali.
Reusare log.; arreusái camp. ‘rifiutare’: sa morti ki no podéis reusari (A. M. di Esterzili); arreúsa ‘rifiuto’; (Nuoro) su mare no rebusat abba (con -b- estirpatore di iato). Cfr. it. ricusare, sp. rehusar. Si cita come fonte il lat. recusāre voce dotta col senso di ‘fare opposizione (contro una causa giudiziaria)’, considerata dai latinisti (e da Wagner) derivante da re- + cāusa. Ma le cose non stanno così. In ogni modo, la voce sarda è autoctona, la sua base etimologica è il sum. ri- (vedi: con valore di contrarietà) + uš ‘to shut off, block up; rinchiudere, bloccare’. Chiaro quindi il significato d’origine: ‘chiudere contro’, ‘non accettare qualcosa’.
Sinnare, -ái log. e. camp. ‘segnare’, anche nel senso di ‘marchiare’ il bestiame; sinnu ‘segno, marca’; sinnadorzu log., sinnadróxu camp. ‘sito dove si marcano le bestie’, e siccome ciò si suole fare nel giorno dell’Ascensione, si chiama così anche l’Ascensione.
Base etimologica di sinnare, sinnu è l’akk. šiknum (lat. signum) ‘figura, immagine’, gr. ἴχνος ‘orma, traccia’, originariamente ‘segno, figura’. Si può notare l’evidenza della legge fonetica sarda, che fin dalle origini assimila in -nn- le consonanti estere -kn-, -gn-.
Talu cognome sardo che pare riprodurre il gr. Talos (Simonide), mostro metallico che abitò in Sardegna e traslocò a Creta. S’immergeva nel fuoco prima d’abbracciare i nemici < sum. tal ‘cry, clamor; battle cry’.
Trattalía camp. ‘frattaglie, busecca’; tartalía (Nuoro) ‘idem’; tattaréu sass. ‘coratella, vivanda preparata con interiora di agnello o di capretto infilzate allo spiedo e avvolte dalle budella dello stesso animale’. Secondo Wagner queste voci sono deformazione dell’it. frattàglia ‘interiora degli animali macellati’ < fratto ‘spezzato, frazionario’. Ma la situazione non sta in questi termini, derivando fratto dal lat. frangō ‘rompo’, mentre le voci sarde hanno base etimologica nel sum. tar ‘to cut, tagliare a pezzi, resecare’, ripetuta (tar-ta-) a indicare la molteplicità dei pezzi. Anche questa è una parola sarda in purezza.
Arcaicità del linguaggio del centro-Sardegna. L’ultimo lemma su citato coinvolge anche il Nuorese. Invero, sono una caterva le voci nuoresi conservate anche in log. e camp., per quanto poi ogni sub-regione abbia le proprie varianti fonetiche. Non mette conto osservare che il linguaggio del centro-Sardegna è né più né meno arcaico degli altri linguaggi sardi, ma è un po’ più conservativo (quasi un’isola nell’isola) – considerate le più difficili comunicazioni nel passato –. Questa osservazione va ovviamente sostanziata, poiché sui linguaggi nuoresi (e in buona quota barbaricini) si sono affermate delle idee contraddittorie che nella diffusione della cultura hanno arrecato confusione e sconcerto. Tutto nacque quando un primo intellettuale dei secoli recenti osservò che il Nuorese, tenendo Bitti come pivot, manteneva in purezza la lingua latina, al punto tale che si ritenne più conveniente prendere a misura il linguaggio bittichese per svelare alcune leggi fonetiche del latino. L’esistenza esclusiva di molti vocaboli latineggianti nelle inaccessibili aree centrali suscita indubbiamente dei problemi, ma a ben vedere sono problemi creati dagli stessi intellettuali, i quali contro ogni logica hanno imposto la falsa teoria dell’integrale colonizzazione latina delle Barbagie e del Nuorese; ne sarebbe corollario la teoria della tenace sopravvivenza del lessico e della fonetica latini in virtù dell’isolamento. Non intendo destare il riso del lettore, ma la questione suscita l’idea di un temerario generale il quale penetra profondamente in territorio nemico, rimanendone intrappolato. Mutatis mutandis, sarebbe come la situazione di Alghero: una parlata nemica incistata entro la parlata sarda.
Ma la Barbagia non fu mai colonizzata dai Romani (l’ho dimostrato nel mio “Toponomastica in Sardegna”); l’ampio territorio montano fruì (tacitamente?) di uno statuto di “libero-scambio” con le aree granarie, minerarie, portuali dell’isola, ed i montagnini continuarono imperterriti le loro millenarie transumanze tra monte e piano, senza disturbo alcuno per il collaterale commercio dei loro prodotti, a cominciare dai formaggi, dal bestiame, dai prosciutti, dalla lana, dalle pelli, dal miele, dal legno delle foreste.
Prendiamo l’esempio del verbo bittichese verberare, (Nuoro) berberare ‘percuotere, picchiare’. Cfr. pis. berberà ‘idem’. Il prototipo sembrerebbe a tutta prima il lat. verberāre ‘battere, percuotere’ < verbera ‘verghe, frusta, colpi di verga’. Ma attenzione!: la base etimologica è il sum. bir ‘to shred, strappare, trinciare’ (ripetizione icastica: bir-bir-). Si può notare che è proprio Nuoro a mantenere in purezza l’eredità sumerica, e nessuna ragione dimostra la nascita di questa parola nelle contrade laziali. La forma pisana può essere anch’essa, con tutta tranquillità, un accatto dalla Sardegna, visti i rapporti tenaci (non solo nel Medioevo) tra Sardegna e Pisa.
Occorre accettare un’evidenza scomoda per alcuni, e cioè: la sopravvivenza di sd. verberare è la dimostrazione che nella conservativa Barbagia l’arcaica Koiné Mediterranea dei tempi preromani ha mantenuto sinora più saldi caratteri, proprio in virtù dell’isolamento montano. Quindi occorre accettare che il lat. verberāre sia verbo seriore, un imprestito dal sardo.
Ci sono inoltre dei vocaboli nuoresi la cui unicità è lampante. Prendiamo bisenda ‘settimana’ (Bitti). Wagner, fisso nella pregiudiziale latina ed italica, lo volle derivare dall’it. vicenda ‘serie di fatti che si succedono alternandosi’, ed aggiunse, a rafforzo della propria intuizione: «Campus crede che si tratti di un termine pastorale, che in origine doveva indicare quel periodo di tempo in cui una persona doveva badare al bestiame in campagna in attesa che un’altra la sostituisse; ma forse si riferiva al turno settimanale per fare il cacio». Ma tutto ciò è assurdo. Wagner non sa che i pastori un tempo (e sino a ieri) facevano il formaggio ogni giorno per impedire il deterioramento del latte. Inoltre si noti il fatto imbarazzante che, mentre i due linguisti derivano la voce sarda dall’italiano, gli studiosi della lingua italiana non si sono ancora raccapezzati sulle vere origini dell’it. vicenda (DELI). In tal guisa, tutti questi linguisti non si sono accorti che è il sd. bisenda ad essere stato il prototipo dell’it. vicenda, e non viceversa.
Ciò si capisce bene osservando la base etimologica di bisenda (poi di vicenda), che è l’akk. wīṣum ‘alcuni, few’ (giorni) + emdu ‘sovrapposto’ < emēdum ‘to lie on each other, add; adjoins’. Il composto wīṣ-emdu significò in origine ‘pochi giorni affastellati; gruppo di pochi giorni’. Era un modo primitivo ma efficace per indicare i giorni della settimana, che si affastellano in gruppo per servire come base di conto dei quarti di luna. La settimana sarda chiamata bisenda è l’eredità accadica ancora conservata in rari recetti della Sardegna montana. Ma sappiamo, e vedremo oltre, che la lingua accadica è seriore rispetto a quella sumerica: penetrò in Sardegna meno di 5000 anni fa, promuovendo parole nuove, formazioni nuove, ivi compreso lo stato-costrutto. Il fatto che bisenda sia conservata proprio nel Nuorese ripropone l’idea da me evocata, quella del condottiero temerario che poi rimane intrappolato. Oggi bisenda è trattenuta soltanto sull’area montuosa, mentre dappertutto nell’isola è conservata l’arcaica voce sum. kida, cida (già citata), ch’ebbe il vigore di tenere segregata ed isolata nel Nuorese la sopravvenuta voce accadica.
È sempre dall’accadico che riceviamo la chiave del misterioso pilósu, piloséḍḍu (Fonni) ‘bimbo in età tenerissima’. Per Wagner l’origine è dal lat. pilōsus poiché, scrive, fino all’adolescenza i bimbi non si tagliavano i capelli. Ciò è ridicolo. Invece la base etimologica è il bab. pelû(m) ‘uovo’. Questo aggettivale è veramente arcaico, risale al Paleolitico o comunque al primo Neolitico, allorché s’affermo l’idea dell’Uovo Cosmico Primordiale nella mitologia di numerose civiltà, la cui forma ritroviamo in vasi elladici, in crateri minoici, in piatti moldavi (3700-3500 a.C.), nella religione egizia, ecc.
Aímu (Posada) ‘vicino’ (Spano). Wagner lo considerò lemma sospetto, inaffidabile, ma sbagliò. La dimostrazione proviene in linea indiretta dala lingua italiana, dove s’usa la parola vicìno < lat. vicῑnus < vῑcus, indicante ‘quello che vive nello stesso gruppo di capanne’, da cui it. vìcolo ‘stradetta stretta’ (luogo dove tutti fanno vita in comune). Parimenti, a Posada scopriamo la più antica parola mediterranea indicante ‘colui che vive sull’altra sponda del fiume’. Ricordo che Posada sorge sulla foce di un fiume ad estuario. Con tutta probabilità, in origine su ambo le rive c’erano due villaggi, due gruppi di capanne, onde si formò un epiteto riconducibile ad akk. aḫû ‘to fraternize, diventare fratelli’ + mû ‘acqua’ (del fiume): il composto di stato costrutto aḫῑ-mû significò in origine ‘fratello del fiume’, ‘dirimpettaio del fiume’.
Ammadeskinzu (Dorgali) ‘un cibo che si ferma nella gola e vorrebbe tornare su’. Base etimologica è l’akk. ma’dû ‘large quantity’ + ešqu ‘solid, massive’.
Azírima nella frase sunt azírima ‘sono opposti’ (Orotelli: Spano); éssere azìrima ‘essere in discordia’ (Casu). Wagner ignora l’etimo. Base etimologica è l’akk. zīru ‘hate, odio’ + emmu ‘hot, bollente’. Quindi a zírima in origine significò ‘’(essere) in odio al calor bianco’.
Tornerò più volte e in altro modo sui “latinismi” del Nuorese e della Sardegna, poiché serve riproporre su basi nuove l’intera questione.
Le prevaricazioni dei preti nel Medioevo. La storia è feconda di notizie sugli scontri religiosi, ma non riesce a narrare minutamente gli avvenimenti a causa delle lacune prodotte dall’uso perverso della damnatio memoriae. Si conoscono pure altri tipi di silenzi plumbei. Siamo indotti ad intuire che molti silenzi della storia celino, in quanto tali, delle trame significative; l’assenza di documenti dovrebbe costringere lo studioso a un supplemento di sforzo per individuare un metodo capace d’interpretare le verità che non ebbero cronisti.
La procedura da me suggerita è normale tra gli archeologi. Purtroppo i tempi in cui il clero cristiano prevaricò le culture precristiane e cancellò le religioni patrie hanno focalizzato gli storici soltanto sulla documentazione emersa: edicta, historiae, epistulae, anecdota; però è mancata la curiosità per le modifiche forzose del vocabolario, non foss’altro: perché mancano le fonti scritte, e laddove scripta deficiunt lo studioso spegne le luci, venendo meno alla propria funzione. Per fortuna, la lingua (il vocabolario di un popolo) è capace, per sua natura, di superare d’un balzo millenni di silenzi. E qui subentra il glottologo. Per fare il balzo, però, egli deve operare col massimo rigore, con metodo etimologico indiscutibile, che sia veramente capace di riesumare le verità del passato. Basta un passo falso, e l’oggetto della ricerca, anziché ricomporsi, si frantuma.
Si può immaginare che durante i “secoli bui” del Medioevo sardo i preti cristiani operassero di gran lena per capovolgere la situazione religiosa a loro vantaggio, e lavorassero decennio dopo decennio per imporre al popolo analfabeta, abitatore dei villaggi, vari giochini di parole i quali travisavano, distorcevano, capovolgevano i significati originari, lasciando quasi intatte le fonetiche. Dopo lo tsunami di Saulo che aveva stravolto i vocaboli greco-romani facendogli maturare nuovi concetti universali, era il tempo del lessico dei singoli popoli. Quello fu l’unico aspetto incruento della rivoluzione cristiana, che avanzò lungo il sentiero dell’evoluzione semantica, coniata a tavolino da chierici dotti, impartita dai pulpiti e accettata lentamente e supinamente dai fedeli. Un metodo anch’esso combattivo ma subdolo, che sovvertì parte del patrimonio lessicale dei popoli.
Tutti questi aspetti sono stati da me trattati scientificamente nel 2° volume della Enciclopedia della Civiltà Shardana, oltreché nel libro Monoteismo Precristiano in Sardegna. Qui non m’attardo.
Latinismi veri e latinismi degli amanuensi. I preti che hanno travolto l’universo religioso dei Sardi erano di origine e formazione bizantina, e tra di loro usavano la lingua greca. Guarda caso, di grecismi la lingua sarda è totalmente e paradossalmente scevra, nonostante che quei preti si siano avvicendati (o siano rimasti) nell’isola per cinque secoli. I famigerati “latinismi” del vocabolario sardo, che tutti suppongono nati ad opera dei preti bizantini nell’Alto e nel Basso Medioevo, sono invece di epoca pregressa, non appartengono affatto al periodo medioevale (tantomeno al periodo romano), e quindi vanno ben spiegati. Di essi s’era già accorto Dante Alighieri, il quale nel De Vulgari Eloquentia I, XI scrive: Sardos etiam, qui non Latii sunt sed Latiis associandi videntur, eiciamus, quoniam soli sine proprio vulgari esse videntur, gramaticam, tamquam simie homines imitantes: nam domus nova et dominus meus locuntur ‘…e rigettiamo anche i Sardi, i quali non sono italici ma agli italici sembrano doversi associare, perocché questi soli ci appaiono privi di un loro proprio volgare, e imitano la grammatica [ossia il latino] come le scimmie imitano gli uomini; essi dicono infatti: Domus nova e Dominus meus’.
Ma i Sardi non hanno mai scimmiottato i Latini. Sulla questione, non c’è stato un solo dotto che non abbia preso un abbaglio. Il lettore appassionato che abbia la possa di leggere tutto intero questo Dizionario Etimologico, apprenderà che i vocaboli sardi derivanti direttamente dal latino sono molto meno del 10%. A chi vuol dichiarare tale residuo un’eredità della colonizzazione romana, glielo concedo, ma stupirei se dicessi che i Romani a loro volta hanno ereditato dalla Sardegna molto più del 10% di vocaboli.
Sino a che non cambierà il punto di vista dei dotti sulla questione, sino a che non si accetterà che la lingua latina e la lingua sarda fecero parte della grande Koiné Mediterranea, non potrà mai cadere la funesta “pregiudiziale latina”. Essa deve cadere a maggior ragione, se si considera che migliaia di parole che i più considerano latine erano parlate dai Sardi in piena età nuragica, ossia almeno 1000 anni prima che sul Palatino sorgesse la prima capanna di frasche. Com’è che il popolo laziale era riuscito a saturare di latino la lingua dei Sardi, se a quei tempi Roma stava ancora “in mente Dei”?
Questo fenomeno apre un ulteriore spiraglio che aiuta a capire la conservativa parlata nuorese e la conservativa parlata barbaricina del nord, che somigliano molto più al latino rispetto alle parole consorelle parlate nel resto della Sardegna. Beninteso, con ciò non sto concludendo il discorso accennato al paragrafo “Arcaicità del linguaggio del centro-Sardegna”. Anzi, sto allargando la visuale; ma preferisco rivelare gradualmente, lungo tutta questa premessa metologica, come dev’essere considerata l’intera questione.
In questo paragrafo mi preme affrontare i latinismi profusi a piene mani nei più antichi documenti sardi, ossia nei condaghes e nelle carte coeve. Non ho mai letto alcuna indagine da parte di nessun linguista, che illuminasse tutti quei latinismi con l’unica ragione che può giustificarli: a quei tempi nei quattro Regni sardi c’era un altissimo tasso di analfabetismo che coinvolgeva anche parte dei nobili (i quali furono per lo più i dettatori dei documenti dell’epoca). Non intendo dire che i majorales fossero una massa di analfabeti. Però posso affermare che non erano fior di letterati. Al punto che s’affidarono docilmente agli amanuensi che registravano ufficialmente le loro dettature. Ma chi erano quegli amanuensi? Presto detto: erano gli stessi preti di formazione latina che periodicamente andavano e venivano tra i monasteri, abitando ora in cenobî del Continente, ora in quelli sardi, e viceversa. Non era gente stabile (esclusi pochi), tantomeno nativa della Sardegna; in più, il latino era la loro lingua principale, anche per capirsi reciprocamente, visto che ai monasteri convergevano preti di varia origine, del profondo Sud e del profondo Nord italiano. In certi monasteri dimoravano i preti francesi. Qualcuno sa dire con quanta facilità quei preti dominassero la lingua sarda, anzi i vari dialetti esistenti nell’isola?
Non mette conto allungare la spiegazione: quei preti scrivevano sotto dettatura o sulla traccia di un papier scritto rozzamente dal proponente; e nell’esigenza di rendere nel modo più perspicuo il pensiero del proponente, spesso e volentieri innestavano qua e là i propri latinismi. Di latinismi arbitrari sono zeppi i condaghes. Ciò che fa male in questa vicenda è che i filologi votatisi a tradurre le antiche carte della Sardegna abbiano creduto che i latinismi appartenessero alla parlata sarda.
Di seguito faccio qualche esempio, tra le migliaia che impellerebbero (ma si vedano per questo i lemmi nel Dizionario). In ogni modo, approfondirò la questione nei due paragrafi successivi oltreché, passim, in tutti gli altri paragrafi.
Auinde log. ant. (CSP 5: et falat su ualliclu derectu ad riuu, auinde riuu falat isc’a badu de preuiteru et cludet; CSNT 290: auinde toctuve via a derectu ad rivum de gulpe). Cfr. lat. ăb-inde ‘di là’ (moto da luogo). Questa voce antica è tratta di peso dal vocabolario latino ad opera dell’amanuense che scrisse il documento sardo. Di questo procedere “disattento” sono colmi i testi antichi della Sardegna (nota, qua stesso, ad rivum, costruzione inequivocabilmente latina). Per ulteriore nota, faccio seguire il lemma-base inde.
Inde log., indi camp. avv. ‘ne’ (traduzione del Wagner). Questa è una delle tante voci sarde discutibili. Esiste anzitutto nelle carte antiche. Sono troppi gli indizi che denunciano una certa “scioltezza” nelle redazioni dei testi antichi, i quali quasi certamente, o quasi sempre, erano scritti sotto dettatura, e venivano arrangiati secondo la dottrina linguistica dell’amanuense, al fine di evitare le oscurità o le asperità del linguaggio sardo, percepite come tali dall’amanuense stesso.
L’avv. di luogo lat. in-dě (ant. im-dě) significa ‘di là, di lì, da quel luogo’ (moto da luogo): inde reversus ‘tornato di là’; provenienza sociale: ‘da lui, da loro’: inde oriundus erat ‘derivava da lui’; fig. ‘da ciò, quindi, per conseguenza’. Questa voce latina ha per base il sum. im ‘to run, uscire di corsa’ (moto da luogo) + de ‘to bring’. Il composto im-de significò in origine ‘uscire portando, recando’.
Riporto al riguardo le citazioni antiche prodotte dal Wagner: CSP 207: derun inde su saltu de Ualle de Cucke; CV XV 4: pro su ki apat indi proi sanctu Antiogu. Spesso indě si esprime encliticamente: ‘nde, ‘de (CSP 204: non tinde do; ca ui andai e ‘nde la leuai; CSMB 48: Comporeilli a Petru Zote terra in Pubusone et fegindelli sollu).
Carnattu (St. Sass. I, 69) è un altro tra le migliaia di testimoni: dessos qui fachen carnattu et dessa bructura de cussu. A quanto pare la frase si riferisce ai macellai che manipolano la carne per fare salsicce e altro, producendo inquinamento. In Sardegna, oltre a petza, l’altro vocabolo indicante la ‘carne’ è carre (vedi per l’etimo); in Sardegna manca la parola-base carne. In questi documenti medievali, inevitabilmente composti da scribi di estrazione pretesca e formazione latina, sono molte le parole influenzate dalla cultura latina e italiana.
Famígiu Stat. Castels. 179: gasi su iuuargiu, famigiu i ouer figiu dessu pupidu; 232: ouer roba de alcunu famigiu ‘servo’. Cfr. it. ant. famiglio. Questa voce è un esito eclatante della libertà con cui i preti di formazione latina, arrivati in Sardegna nel Medioevo dall’Italia o dalla Francia, maneggiarono le parole autenticamente sarde che gli venivano dettate per i testi ufficiali.
Fizzastru log., fillastu camp. ‘figliastro’ (CSP 31: cun sos fiastros; CSNT 29, 200, etc.: filiastru, filastru). Questa voce è influenzata dal suffisso italico di figliastro < lat. filiaster (REW 3297).
Gotantu, gatantu log. ant. = it. antiq. cotanto. Il vocabolo è l’ennesima spia del fatto che i preti e gli altri amanuensi scrivevano la lingua sarda con una certa disinvoltura, impaniati dalla propria formazione di base.
Infra log. e camp. ‘fra, infra’ (Stat. Sass. I, 27: infra dies XX; infra de otto dies; Liber Jud. Turrit., cap. 8: infra sa ottova de Pascha Manna; Cod. Sorres, cap. 20: infra dies XV). Questa voce in Sardegna si usa ancora; ma è italianismo dotto dal lat. infra. Anzi, qui siamo al latinismo puro.
Patre log. ant. ‘padre, babbo’ (CSP 15, 38, 262); patri (CV V, 3); padri (CV III, 3; V, 3; XIV, 9; XIX, 5). Accatto dall’italiano padre < lat. pāter. Questa parola non è mai stata usata in sardo (del Monte Santu Padre discuterò oltre). Questo è uno dei segni macroscopici che gli amanuensi latini dell’epoca rimaneggiarono ad libitum il linguaggio sardo nella registrazione delle carte; lo fecero, a quanto pare, persino sotto dettatura diretta.
Pecuiu sd. ant. CSP 231: II sollos de pecuiu; CSMB 43: in tremisse de pecuiu), scritto anche peculiu (CSMB 41: et sollu de peculiu) ‘sostanza, peculio’. Nelle CV XX, 2 figura nell’antico significato di ‘animali’ (bollant pasquiri cum peguliu issoru, bollant arari…). Chiarissimo esempio del fatto che molto spesso gli amanuensi (preti) di formazione latina acquisiti ai vari monasteri dei giudicati si esprimevano, quand’era possibile o necessario, con vocaboli estratti dal proprio bagaglio culturale, per quanto il vocabolo fosse estraneo alla tradizione sarda. Vedi anche pecuiare e pegugiare.
Termen log. ant. (CSP 187; CSNT 43) ‘confine’; pl. termenes. Per l’etimo vai a tremma. Questa voce è palesemente raccordata al lat. termen. Attualmente si preferisce trèmene.
Turpe log. ant. in faker turpe ‘fare un torto, offendere’ (CSP 43: ca minde aueat fattu turpe duas uias; 73: e cca ui li feki turpe). La voce è un classico accatto dal latino.
Uske a, log. e camp. ant.; usca a (CV, IX, 2) = lat. usque ad. Voce dotta latina.
La pregiudiziale latina. A mio avviso i latinismi delle antiche carte sarde sono stati sottovalutati a causa dei pregiudizi, perlomeno a causa degli equivoci che da sempre hanno covato sulla questione. A quanto pare gli equivoci sono sorti persino prima che Dante prendesse la celebre posizione nel De Vulgari Eloquentia, considerando i Sardi scimmiottatori dei Latini. Forse gli equivoci risalgono addirittura agli antichi Romani. Non ci possiamo meravigliare più di tanto. Si dice che Giulio Cesare fosse poliglotta, e fosse tanto geniale da saper dettare in una sola seduta più lettere in diverse lingue straniere. Io ho grande ammirazione per il genio di Cesare, ma penso che le dettature parallele e simultanee gli riuscissero facili per il fatto che i popoli celtici ai quali scriveva parlavano lingue molto simili a quella latina (ed a quella sarda), ancora prima di essere colonizzati da Roma. Io sono convinto di questa asserzione, la quale va a ribadire la verità di quanto ho asserito nel primi paragrafi di questa premessa.
Insomma, la Koiné Mediterranea era tanto forte proprio perché univa molte lingue tra loro simillime. Wagner ai suoi tempi non potè restare immune da tali equivoci oramai cristallizzati da millenni. Peraltro l’educazione da lui ricevuta nella natia Germania non era in grado – in quei tempi di odio e di revanche – di ribaltare quella poderosa corrente di pensiero che proprio partendo dal focus germanico stabiliva “scientificamente” che ogni lingua del Mediterraneo fosse stata cancellata dal poderoso intervento romano e poi dalla “tabula rasa” operata dai popoli germanici con le Invasioni barbariche.
Wagner credette in buona fede ed acriticamente a questi millenari pregiudizi, incancreniti con l’avvento del Romanticismo, assumendoli come verità, e non è un caso che quasi ogni lemma del DES evidenzi in primo piano le voci bittichesi, o quelle nuoresi, rispetto a quelle logudoresi e campidanesi. Egli era convinto – e lo ribadì apertamente nella “Fonetica Storica del Sardo” – che le voci bittichesi e nuoresi fossero i prototipi (latini) del vocabolario sardo, e che le voci consimili del Logudoro e del Campidano fossero semplici derivati adattati foneticamente secondo il genio delle singole parlate sarde.
Anche i vari linguisti che avevano preceduto Wagner erano stati abbagliati dai “latinismi” del Nuorese, e Wagner, ereditando il pensiero dell’accademia, ne fu corifeo entusiasta. I tentativi del Wagner di formalizzare le sue credenze entro la “Fonetica Storica del Sardo” sono stati da me denunciati, come spiego nel cap. 3.1 della mia Grammatica Storica. Fu tale l’arbitrio dei linguisti del passato, che hanno addirittura inventato delle “leggi fonetiche” le quali dovrebbero dimostrare la derivazione del sardo dal latino.
Ad esempio, Wagner sostenne che il log. abba deriverebbe dal lat. aqua, in virtù dell’esito lat. -q- > sardo -b-. Nella mia Grammatica io dimostro che -q- = -b- non è prova di alcun processo derivativo; non siamo di fronte ad un fonema derivato diacronicamente dall’altro, bensì di fronte a due fonemi sincronici, operanti ognuno per proprio conto prima dell’invasione romana. Abba esisteva già nel vocabolario accadico: abbu ‘palude, pantano’; abbû ‘fauna acquatica’; bā ‘acqua’; sum. a’abak ‘(acqua del) mare; sea (water)’, a-ab-ba ‘idem’ (< a ‘water’ + ab ‘sea’ + ba ‘marine creature’). Il sd. abba, in tal guisa, non ha concesso niente alla lingua latina, rimanendo inalterato fino ad oggi ed ignorando il lat. aqua, il quale invece riuscì ad insinuarsi nel dialetto campidanese (áqua). In origine la Sardegna aveva un doppio registro, che poi lasciò in eredità due lemmi: abba a nord, áqua a sud. Al secondo registro appartiene l’akk. agû, egû ‘onda, corrente, flutto’. Fenomeno di Lautverschiebung nord ≠ sud, come spiegherò nel successivo paragrafo.
Stesso discorso vale per il suffisso sardo -u, che Wagner fa derivare dal lat. -us, mentre esistevano entrambi nella stessa epoca, ognuno operante nel proprio campo linguistico prima dell’invasione romana. Per il sardo -u non c’è da accampare un supposto influsso romano, poiché già le lingue mesopotamiche (sumero-accadico-assiro-babilonese-cananeo) mantennero per migliaia d’anni il proprio suffisso -u al quale possiamo e dobbiamo riferire una -u sarda originaria.
Percepiamo ancora le arcaiche desinenze cananee in -ū per il nominativo anche nell’antico ebraico (1Sam 2,10 ‘ālū “l’Altissimo”, corrispondente a Yahweh del primo stico; Sal 140,9 yārūmū “l’Eccelso”, anche esso in parallelo con Yahweh del primo stico). Parimenti percepiamo ancora nell’antico ebraico le arcaiche desinenze cananee in -ī per il genitivo (Sam 22,44; Ez 5,3; Os 11,4; Sal 26,10). Altro che genitivo di formazione latina! Il genitivo latino non è altro che un genitivo mediterraneo con basi etimologiche semitiche!
Tornando alla Sardegna, era tipicamente sardiano, quindi originario, pure il suffisso femminile -a, per il quale non c’è da accampare la colonizzazione romana, come pretende Wagner, essendo tale forma, di per sé, latamente presente nel Mediterraneo, comune, ad esempio, ai Latini, agli Šardana, agli Aramei. Ed è proprio l’identità o similitudine di certe leggi fonetiche tra Sardiano ed Aramaico che lascia capire l’autoctonia di molte forme della lingua šardana, preesistite all’invasione romana e coeve alla celebre Koiné aramaica esistita prima delle falangi di Alessandro e prima dei Cesari.
Pari discorso riguarda le velari sarde k, ĝ, che Wagner crede derivati dal lat. c, g, mentre esse preesistevano nella lingua sardiana, con un impianto confrontabile alle velari accadiche k, g, ḫ.
Questa certezza scientifica è corroborata da un fatto celebre ancorché strambo, che è il seguente: dalle leggi fonetiche del sardo attuale (e del sardo medievale) i cattedratici hanno derivato le loro certezze sulle leggi fonetiche latine, non viceversa! Infatti per dimostrare che il latino ciceroniano aveva le velari non si è fatto di meglio che supporne l’esistenza (altrimenti indimostrabile) attraverso l’attuale parlata di Bitti, in Sardegna. Ma quei “linguisti” non sono gli stessi che pontificano l’origine del sardo dal latino?
Insomma, quei cattedratici hanno preso al guinzaglio la lingua sarda per andare in soccorso della lingua latina intesa come Ursprache mediterranea. Si badi, è stata soccorsa la lingua latina: nessun’altra! Come dire che la “trasfusione di sangue” è andata ad una sola lingua da loro prescelta. Mentre tutte le altre lingue italiche e quelle mediterranee lato sensu non hanno meritato le loro attenzioni. Perchè? Ovvio: essi sono partiti dall’ideologia secondo cui tutta la civiltà mediterranea oggi percepibile avrebbe l’incipit nell’Urbe. Da qui il “soccorso” della lingua sarda nei confronti della propria… “madre”! Ma vediamo di seguito qualche esempio che meglio illustri la questione.
Accásu log. ‘per caso, forse’; cfr. sp. acaso. Wagner deriva accásu dal sardo casu, e questo direttamente dall’it. caso ‘avvenimento fortuito, imprevisto’, considerandolo dunque non solo un prestito ma anche un cultismo italianizzante. A sua volta, occorre badare che tutti i linguisti sinora hanno considerato la base di it. caso, ossia il lat. cāsus, come cultismo che fu tale già nella fase latina. Non hanno saputo fare altra considerazione davanti al verbo da loro considerato come incipit, che è cădere ‘cadere, cascare’. Il cultismo sortirebbe – secondo loro – dalla fusione (o confusione) della semantica del “cadere” con quella dell’ “accadere”. Questa confusione dura da oltre 2500 anni, ma è confusione confezionata “a tavolino”, freddamente, senza meditazione, quindi idealistica, ed è ora di dare un colpo a tale nodo gordiano. La vera base etimologica del lat. cāsus, it. caso, sd. casu è l’akk. ḫašû ‘frantumare’, anche ‘to become dark, diventar buio’, ‘suffer darkness, essere cieco’. Insomma, tutto rinvia alle origini dell’Universo e all’arcaico cognome sardo Casu, identico al gr. Χάος, che identificano l’immensa buia cavità che accolse le acque primordiali. Pertanto il riferimento non è alla caduta ma al caos.
Avu it. ‘nonno’, apparso in Italia prima del 1374 col Petrarca; al pl. ‘antenati’ (1581, T. Tasso); vocabolo ritenuto dotto dal DELI, originario dal lat. āvu(m), a sua volta considerato di origine indoeuropea col sign. di ‘anziano’. Non discuto, per spirito di carità, che l’origine possa essere quella, ma la voce è condivisa anche nel campo semitico, dall’ebr. āv ‘padre’ ( אׇב ).
Cartu log. ‘misura di grano, di fave, ecc.’. Cfr. it. quarto ‘idem’ (che soltanto foneticamente corrisponde al lat. quartum ‘quarta parte’ aggettivale di quattru: vedi). Wagner non dà l’etimo, sembrandogli ovvia e bastante la derivazione latina. Invero, base etimologica è l’akk. kārtum ‘prezzo corrente’. Cfr. akk. qa ‘misura di circa 1 litro’; karāṭum ‘(merce vendibile), da cui it. carato (misura per pietre e metalli preziosi).
Para camp. ‘frate’. Wagner lo deriva dal cat. parə ‘padre’ (padre in ogni senso, anche come sarcerdote o mestierante del sacro). Anche in altri dialetti italiani abbiamo gli stessi esiti. Ma in ciò Wagner è generoso, perché ogni volta che cita l’origine catalana vuole sempre intendere che il catalano stesso a sua volta ha origini latine, quindi le parentele con analoghe voci italiane sono già messe nel conto. Ovviamente questo modo di andare per etimologie è incongruo, quindi mi tocca subentrare precisando che para potrebbe forse allinearsi con l’uso akk. di pāru, accus. pāram (un ufficiale). Ma ci viene incontro una migliore opzione, l’akk. pâru(m) ‘cercare, andare a cercare’. Per decidere quale delle due opzioni s’attagli alla voce sarda, dobbiamo osservare che i primi monaci che diedero impulso alla costruzione della Cristianità (non parliamo poi dei frati minori francescani) erano anzitutto frati “cercatori”, per aver fatto voto di assoluta povertà. Nonostante tale vocazione, i frati non sono mai stati indicati come “pitocchi” ma in altro modo, almeno in Sardegna; il Sardo aveva un tale rispetto della povertà, che anche il classico mendicante non veniva chiamato così, sibbene mazináiu ‘venditore d’immaginette sacre’, con riferimento a ciò che lo caratterizzava. Così fu per i primi frati cristiani, che vennero catalogati come ‘cercatori’, dall’akk. pâru(m).
Párdula. In Campidano è il corrispettivo della casatìna del nord Sardegna, ma al posto del formaggio si preferisce la ricotta. La base etimologica è l’akk. parû ‘base’ + dulû ‘secchiello’ (stato costrutto par-dulû > párdula), col significato di ‘(dolce sostenuto da una) base a secchiello’. Secondo Wagner questa voce può risalire a lat. quadrula «siccome le pardulas sono di forma quadra». Invece le pardulas sono tutte di forma tonda. Sale a galla l’ennesimo intento ideologico d’indovinare anzitutto la fonetica latina più consona, proporla come fosse una base etimologica cogente, e ricondurre ad essa il significato della parola sarda, con plateali stravolgimenti della realtà.
Pesáre1 log., pesái camp. ‘pesare, bilanciare’ (Stat. Sass. I, 30 (13r): Sa mercatantia et issas cosas qui si aen uender sas quales se pesan, neuna persone uendat ouer peset ultra libras .X. si non cum sa istatea dessu cumone); fig. ‘apprezzare, giudicare il carattere, l’indole di una persona, ponderare’: l’appo pesadu bene. Cfr. lat. pendere ‘appendere, pesare, pagare’. Se ne ignorò l’origine, che è dall’akk. pedû, padûm ‘to set free, absolve, be merciful; liberare, assolvere, esser pio’. Questi concetti sono strettamente legati alle pratiche dei dazi reali ed anche alla pratica della decima data al tempio: da una parte il concetto della assoluzione, affrancamento del cittadino che ha fatto verificare la produzione, cedendo una parte come tributo al re; dall’altra, parimenti, la giustezza del tributo dovuto al tempio, dimostrazione di pìetas, di correttezza nel rapporto con Dio.
Piatza sass. (nell’agglomerato urbano è il luogo alquanto largo creato per ampiamento d’una via, d’un sito). Termine paneuropeo ed eurasiatico, del quale uno dei riferimenti sta nel gr. πλατύς ‘largo, ampio’, fem. πλατεῖα ‘via ampia nella città’; cfr. lat. plătēa ‘via ampia, cortile’. Pompeo Calvia: Li Candaléri fàrani in piàtza / cu li vétti di rasu trimuréndi… ‘I Candelieri scendono in piazza (ossia nella via più larga di Sàssari), con i nastri di raso tremolanti…’. Vedi anche sp. plaza ‘piazza’, fr. place ‘piazza’ ma anche ‘posto, sito’ = ingl. place ‘luogo, sito’ (le ultime tre voci sono latinismi da plătēa).
Il lemma sardo piatza, pratza, paltza e simili, così semplice e così complesso, ha numerose parentele semantiche oltre a quelle viste, ad iniziare da it. pertùgio ‘stretta apertura naturale o artificiale’, sd. paltùsu, partùsu ‘foro’, per estensione ‘ano’; camp. pratzìri, log. paltìre ‘dividere, staccare’, lat. partior ‘divido’; it. partìre ‘dare origine al moto di allontanamento’.
Il termine sardo non è un latinismo, non lo è nemmeno il termine italico, e nemmeno lo sono i derivati sardi come pratzìri, paltzìri ecc. Il termine è arcaico, mediterraneo, primamente sumerico: appunto da sum. pad, padr, par ‘rompere, spaccare, dividere’ + zu ‘lama o punta dell’aratro’: par-zu ‘spaccare con l’aratro’, oppure par + tab ‘compartire in due, suddividere’: par-tab ‘rompere in due’.
Pilu1, filu. In log. e camp. significa ‘pelo, capello’. Viene proposto dal lat. pĭlus. Ma se ne ignorò l’origine. In analogia con pūbēs ‘peluria’ dei giovanetti, la -l- è una originaria -r- mediterranea: cfr. ebr. pera ‘pelo’, akk. per’u ‘bud, shoot’; vedi sass. péru ‘pelo’.
Pisciòni camp. ‘polpaccio’. Ancorato alla pregiudiziale latina, Wagner segnala come base il lat. piscis ‘pesce’, senza badare all’assurdità dell’accostamento. Invece la base etimologica è il sum. peš ‘topo’ + unu ‘(animale) selvaggio’, col significato di ‘topo selvaggio’ (ossia Rattus). Questa voce è autoctona della Sardegna. Ma la circolazione culturale nel Mediterraneo non è mai cessata; pertanto anche i Latini vollero comparare il muscolo (ad esempio, quello del braccio) a musculus ‘topolino’, causa l’atteggiamento tipico dei topi d’ingobbire la schiena quando stanno fermi.
Ragno (voce italiana). Ma vedi sd. ranzόlu, aranzόlu, arranzόlu ‘ragno’ (Araneum species). Cfr. lat. arāneum, gr. αράχνη ‘ragno’. Base etimologica il sum. raḫ ‘to kill, uccidere’ + nu ‘to spin (thread), tessere (fili)’. Il composto raḫ-nu (> it. ragno) significò ‘assassino che tesse’. In Sardegna ritroviamo la stessa base mediterranea ma col suffisso aggettivale -lu. Questo è uno dei tanti esempi di false origini latine.
Siḍḍu2 (Bitti) ‘moneta antica’; (Desulo) ‘occhio di pernice’ (callo); (Cagliari ‘stella di mare’ (echinoderma), ‘cerniera, cardine delle ostriche e delle arselle’ (Marcialis); ‘coppetta, ventosa del polpo’. Nel CSNT figura col senso di ‘sigillo’; armentariu de sigillu (88, 115, 240); maiore de siillu (129). Wagner propone sbrigativamente per tutte queste voci l’origine dal lat. sigillum. Ma quest’operazione è ametodica, poiché le semantiche sono molto diverse e vanno spiegate una a una.
La prima voce, relativa alla ‘moneta antica’, ha base etimologica nel sum. šid ‘to count’. Quella relativa alla ‘ventosa’ del polpo può avere base nel sum. sidug ‘cavity, cavità’. Il significato di ‘stella marina’ può corrispondere al sum. si ‘horn, corno’ + du ‘to go, andare’ (col significato di ‘corni che camminano’. Il significato di ‘occhio di pernice’ può essere dal sum. si ‘horn, corno’ + dun ‘to dig, scavare’ (col significato di ‘corno che scava, che infilza’).
Sitzillu camp. ‘quarzo, silice’; sa pedra sitzía ‘pietra focaia’ (Mogoro). Base etimologica il sum. zi ‘life, vita, soffio’ + zu ‘flint, pietra focaia’ + illu ‘source, sorgente’. Il composto ziz-z-illu significò ‘pietra (focaia) sorgente di vita’. Tale fu il grande significato iniziale. Voler derivare questa voce dal lat. siliceus ‘di silice’ (come propone Wagner) significa storpiarne la vocalità e dare alla voce sarda un marchio d’accatto immeritato.
Suspirare log. ‘separare il siero dal latte’ (Spano). Base etimologica il sum. peš ‘to be thick, essere spesso’. Il latte nella cagliata s’ispessisce. La definizione dello Spano è infelice, poiché il siero non è un bi-componente separabile dal latte ma è un prodotto di trasformazione, diventato tale dopo l’inserimento del caglio. Wagner a sua volta s’intromette aggravando la situazione (DES II 252), poiché origina suspisare da un inesistente lat. *suspe(n)sare, quasi un ‘sospendere’, ignorando peraltro il contesto della caseificazione e rinunciando a interpretarlo.
Lautverschiebung. L’Accademia degli indogermanisti presenta la Lautverschiebung come problema esclusivamente germanico, mentre invece essa pervase (in parte ancora pervade) mezzo mondo, ed è vivissima anche in Sardegna. La Lautverschiebung (“rotazione consonantica”) divide la Sardegna metà per metà. Quindi a sud égua, a nord ebba. Se si chiedono lumi all’accademia, la risposta è che la /b/ del nord è fenomeno indotto dal latino (Wagner e Paulis), e non si va oltre: si legga per intero la Fonetica Storica del Wagner, con annesso l’ampio commento del Paulis.
In realtà, la “Rotazione consonantica” sarda è fenomeno arcaico, che vige nell’isola da almeno 40.000 anni (dai tempi Cro-Magnon), se non da prima, in ogni modo da quando si parla la lingua sumero-sarda. Il tutto è collegato strettamente a un fatto non considerato, ossia che in Sardegna sin da allora si svilupparono due fortissime tribù e, come accade in ogni divisione tribale, esse sono vissute sino a pochi millenni fa combattendosi (quando necessario) o almeno separandosi. Peraltro il 70% dell’isola è montagnoso, e già il Lamarmora indicava nei vertiginosi sprofondamenti tra le montagne un problema immenso che favorisce le reciproche separazioni.
Le separazioni tribali, e la scelta di starsene l’uno separato dall’altro, determinò anche la perdita dell’indipendenza sarda, a ben notare. La libertà delle tribù sarde finì con Josto, nel pessimo indimenticabile momento in cui Amsicora tentava disperatamente di far scendere a valle contro i Romani qualche squadrone di Barbaricini. Ebbene, non ci riuscì perché i Barbaricini si sono sempre sentiti un corpo separato. La disfatta portò Amsicora al suicidio. L’unità linguistica della Sardegna non si era mai potuta fare, ed ancora oggi si parlano vari dialetti. Problema immenso. Ma la lingua mediterranea parlata dalle genti sarde (il sumero dapprima, poi il sistema accadico, che si sovrappose e finì per convivere e imbozzolarsi entro il sumerico) avevano già determinato anche la scelta di vocaboli diversi per uno stesso concetto. Questo è evidente con abile “aquila” contrapposto ad ákili (fenomeno discusso più su).
Modelli del genere sono centinaia in Sardegna. Ed è da questi modelli, non da altro, che prese avvio la Lautverschiebung, in modo che la /b/ del nord fu letta /k/ o /g/ nel sud (o viceversa), persino in assenza di parole sumero-accadiche che consentissero di operare in tal senso, distinguendone i significati-base.
Égua/Ebba. Sul modello di ábile, l’originario égua (corrispondente al femminile lat. di equus) produsse al nord ebba (ma ciò accadde millenni prima dei Romani). Ebba non corrisponde ad alcun vocabolo originario del campo sumero-accadico (come invece abbiamo visto per abile/akili): è pertanto un perfetto esempio della Lautverschiebung, che opera a prescindere, essendo una legge fonetica.
(Tra parentesi, se qualcuno osasse dire che i cavalli arrivarono in Sardegna soltanto con i Punici, è pregato fraternamente di andare a vedersi i cavalli dipinti nelle Grotte di Lascaux, 32.000 avanti Era volgare, dimostrazione che i cavalli erano di casa anche con l’Homo Cro-Magnon). Ma vediamo di seguito alcuni altri esempi di Lautverschiebung.
Abbattare log. ‘schiacciare’; anche ‘sbattere le uova’; nasigattâdu ‘che ha il naso schiacciato, camuso’. Osserva anche il frequentativo abbattigáre ‘calcare, premere, pigiare (l’uva)’. Base etimologica è, per il significato ‘schiacciare’, l’akk. watārum ‘to be outsize, surplus, in excess, greater’. Respingo l’etimologia del Wagner (da lat. coactāre) perché foneticamente distante e priva di metodo. Wagner nella presentazione di abbattáre ripropone la falsa teoria secondo cui il sardo /b/ deriverebbe dal lat. /c/, pertanto sbaglia l’etimo di abbattáre, proponendo un analogo cattáre da catta, e da catta arbitrariamente egli fa risalire l’infinito abbattáre. In realtà, abbattáre e cattáre sono due verbi distinti nella forma e nell’etimo, ed è un puro caso che abbiano significati convergenti. Per l’etimo di cattáre e catta vai a cattigáre (ma catta significa pure ‘frittella’, e in quanto tale ha un terzo etimo: l’akk. kattu ‘che corrobora’).
Abbentinnare, abbintinnare log., agghentinnare nuor. ‘contrassegnare il manto del bue o del cavallo’; a Nuoro anche ‘rassomigliare’ (parlando delle bestie): processo di Lautverschiebung. Base etimologica l’akk. binītu ‘shape, appearence; forma, apparenza’.
Abbénzu log. ‘difetto fisico o morale, debolezza, macchia’. Per l’etimo vai ad irghenzu.
Abbuttinare log. ‘calpestare, investire, travolgere’ (detto specialmente dei cavalli e dei buoi); fig. ‘danneggiare, rovinare, disonorare’. Wagner propone l’etimo dal lat. coactare ‘schiacciare’. Ma tra le due parole c’è un abisso fonetico. La vera base è il sardo botta ‘scarpa’. La voce sarda indicante la ‘scarpa’ corrisponde all’ingl. boot ‘stivale, stivaletto, scarpetta’ < ant. fr. bote, ed ha base etimologica nell’akk. uttû(m) ‘ghirba di pelle, otre’, per estensione ‘scarpa’ (in origine la scarpa non fu altro che un rifascio di pelle, poi rafforzato dal cuoio).
Fitiánu, vitánu ‘comune, di ogni giorno’: bestíres fitiános ‘vestiti di ogni giorno’, dìes fitiánas ‘giornate di lavoro’ (non festive); ‘necessario, regolare’: sa proènda fitiána ‘la razione di biada’; ‘avventore assiduo’: fitiános dessu tsilléri ‘frequentatori della bettola’; a fitiánu ‘nei giorni di lavoro’: custa beste mi la ponzo a fitiánu ‘questa veste la indosso nei giorni di lavoro’, filende fitiánu ‘filando assiduamente’. Wagner, convinto che la p (f) sarda non sia altro che un derivato automatico dal lat. q, c, non trovò di meglio che far derivare il lemma sardo dal lat. cotīdiānus, quotīdiānus ‘di ogni giorno’, per quanto ammettesse poi, prudentemente, che lo sbocco sarebbe dovuto essere b- anziché p- o f- (bontà sua!). L’inadeguatezza degli studi passati ed attuali è dimostrata dalla vera etimologia di fitiánu (di cui il camp. vitánu è normale lenizione): sta nell’akk. bītu ‘casa’, bītānu ‘di casa, interno, familiare, casareccio’, bītānû ‘intimo, personale’. Da questa b- semitica ebbe origine la lenizione /v-/ del campidanese.
Báttica (Orosei) ‘la parte di un orto riservata alla coltivazione dei cocomeri e dei poponi’. Pittau (Studi Sardi di Linguistica e Storia, Pisa 1958, p. 98), approvato dal Wagner, sostiene che la voce derivi da un lat. aquatica, che produrrebbe la famigerata trasformazione q > b. Invece la base etimologica sta nell’akk. batqu ‘cut (off), tagliar via’. Infatti, poiché báttica è parola arcaica, vecchia di parecchi millenni, non occorre fantasia per capire che le antiche coltivazioni irrigue venivano fatte separando rigorosamente il terreno dagli spazi liberi, dal tradizionale regno degli armenti.
Bènnere log., bènniri camp. ‘venire’; p.p. bénnidu, bénniu ‘venuto’. Base etimologica è l’akk. bā’um ‘andare, venire’. La forma sarda sembra la più vicina all’originale, mentre il lat. ueniō è un derivato. Questo è uno dei tanti verbi su cui gli indoeuropeisti si sono infervorati a “dimostrare” origini indimostrabili da un (inventato) indoeuropeo *guen (Benveniste, Origines 156).
Bodále log. ‘coso, cosa o persona indefinita’. Non è dall’it. cotale (come pensa Wagner) ma dall’akk. wuddi, uddi ‘certainly, probably’, poi aggettivalizzato in -le. Nel CSP 356 e 358: in gotale tenore. Ovvia la voluta corruzione dell’amanuense sulla falsariga dell’it. cotale.
Gustare, -ái log. e camp.; secondo Wagner, questa voce è identica all’it. gustare, di cui sarebbe un accatto. Ma Wagner ha preso un abbaglio, anzi ha volutamente forzato il suo lemma (illustrerò più oltre la strana tendenza del Wagner alle forzature). In realtà la voce sarda non è gustare ma bustare ‘desinare, mangiare’, anche ‘far colazione’; bustu ‘pranzo’. È l’equivalente di ismurzáre, immurzáre, smurzái. Wagner quindi erra a dare il significato di ‘gustare’ < lat. gustare ‘provare il sapore, assaggiare’. Infatti il termine bustare è autoctono, sardiano, con base nel sum. bur ‘tempo del pasto, ora del pasto’ > akk. būru(m) ‘fame’ + uštu, ištu ‘fuori da’ (stato costrutto būr-uštu > bū(r-u)štu nel nord Sardegna e b(ū)r-uštu nel sud), col significato di ‘fuori dalla fame’.
Isbattulare log. (Bonorva) ‘colpire violentemente’. Base etimologica l’akk. bâṭu ‘to show contempt, mostrare disprezzo, disdegno; oltraggiare’. Respingo la proposta del Wagner dell’origine dal lat. coactare ‘schiacciare’. Wagner anche in questo caso volle imporre la “legge fonetica” da lui inventata.
Patatas. Il toponimo Sas Patàtas nel monte Albo di Lula, territorio carsico, deriverebbe da un lat. *coactiare ‘schiacciare’ (secondo Giulio Paulis NLS 522), causa la forma “schiacciata” del sito rispetto al restante rilievo montano (ma è una falsità), e significherebbe ‘grande avvallamento’. Posta così, la questione appare già traballante, poiché il toponimo convive nello stesso sito con l’altro toponimo Janna e Nurái ‘il passo della voragine’ (perché presso l’angusto passo che introduce nel selvaggio Monte Albo c’è una grotta verticale molto profonda, a campana), ed il toponimo convive anche col contiguo Sos kilívros ‘i crivelli’ (termine che è tutto un programma, poiché quel suolo è fortemente carsicizzato e presenta vari buchi pericolosi). In realtà patàtas non attiene a *coactiare (verbo inventato tanto per giustificare un’assurda trasformazione da lat. c- a sd. p-) ma attiene all’akk. pattu, pātu, puttû ‘aperto’, termini che indicano i vari sprofondamenti del terreno (quelli che in sardo si chiamano normalmente putzos ‘pozzi’,da puttû ‘aperto’). Cfr. sum. pa ‘pouch, tasca’ + taḫ ‘to add, increase; addizionare, ingrandire’, il cui composto (pa-taḫ, raddoppiato per resa icastica: pa-taḫ-taḫ) potè significare in origine ‘pozzi profondi’; akk. patāḫu ‘bore through, perforato’.
Pazzare log. ‘mettere il caglio nel latte’; rifl. ‘coagularsi, accagliarsi’; anche di altre sostanze ‘aggrumarsi’ (su sàmbene); sost. pazzu ‘caglio’; anche ‘malattia infantile con vomiti’ (Casu). Ma quest’ultima voce, inserita arbitrariamente dal Wagner nel contesto del lemma, rientra in un campo semantico diverso, quindi per essa rinvio a pazzu. Quanto a pazzare, base etimologica è l’akk. pazārum ‘to hide o.s., conceal o.s., be hidden; nascondersi, celarsi, stare nascosto’. A quanto pare, alle origini l’uomo osservò anzitutto la capacità delle ferite di “metter crosta”, di celarsi. In un secondo tempo al verbo pazārum associò anche l’idea del coagulo del latte, il quale avviene appunto nascostamente. Wagner invece fa derivare pazzare da it. e lat. coagulare, riproponendo l’assurda “legge fonetica” che forza il lat. K, G a diventare sd. P, B. Qui debbo sottolineare un fatto incredibile, che Wagner inventò la sua “legge fonetica” per soddisfare una manciata di vocaboli (non più di 15 citati nel DES) per i quali egli non riusciva a far quadrare l’etimologia. Ammesso e non concesso che fosse mai esistita una tale legge fonetica per una irrisoria manciata di vocaboli, Wagner avrebbe dovuto rendersi conto che il lat. coagulāre è composto da un primitivo cum + agō ‘faccio convergere’. E allora avrebbe dovuto capire l’insormontabilità di ridurre il lat. cum al sd. pa-. Chi pretende di accreditare l’esistenza di questa assurda trasformazione mostra la risolutezza di chi si lancia senza paracadute sperando d’atterrare incolume.
Altri latinismi supposti da Wagner. La falsa “legge fonetica” appena discussa, inventata per soli 15-20 vocaboli al solo scopo di dare più lustro alla forzosa idea che la lingua sarda derivasse dal latino, è stata soltanto uno degli escamotage inventati dal Wagner per ancorare la propria teoria alla romantica “ossessione imperiale”. Per non tediare, scelgo soltanto due lemmi tra le migliaia disponibili. Ma si notino i molti altri “latinismi” già discussi o che discuterò nel corpo della presente premessa metodologica.
Murru2 log. e camp. ‘grigio’ (CSNT 282: I caballu murru). Per Wagner questo aggettivo è contrazione da lat. murīnus ‘color del topo’. Il termine è usato anche dagli antichi scrittori di veterinaria proprio ad indicare il manto del cavallo. Ma invero, Wagner non sa quale concetto avessero in mente gli antichi romani. Altro esempio sd.: braba murra ‘barba grigia’ ecc.
Per tutte le altre occorrenze citate dal Wagner in relazione a questo aggettivo (tipo ispiga múrina, etc.), rinvio alle voci múrina, múrinu, poiché le loro basi etimologiche sono assai diverse da quelle suggerite dal Wagner. Quanto a murru2, anche qui Wagner cade male, poiché pretende di accostare la barba di un vecchio nonché uno dei colori del nobilissimo cavallo al colore del ratto, un essere che l’uomo ha sempre tenuto in gran dispregio. Basterebbe ciò a mettere in allarme un ricercatore. Infatti la base etimologica di murru2 è il sum. muru ‘rainstorm, mist, drizzle; tempesta di pioggia, foschia, pioggerella’. Da qui quel meraviglioso colore picchiettato del cavallo.
Paríga è il termine col quale nel Campidano s’indica ‘un certo numero’, ‘una dozzina’; impropriamente pure il ‘paio’. Con incredibile insufficienza e nonchalance, Wagner scrive quattro-parole-quattro: «parίga camp. ’paio’, = *PARIC(Ŭ)LA». Nient’altro. Egli era uomo accorto, e sapeva che l’origine da lui proposta è inesistente: viene da lui supposta per riempire un vuoto cognitivo. E lascia il lettore impiccato a questo laconico ‘paio’, senza nemmeno un seguito esplicativo.
Peraltro non è che lo stesso Porru, dal quale Wagner attinse il vocabolo, abbia avuto incertezze a registrare la seguente frase contraddittoria: «Parìga s.f. pajo, paro, coppia. Ses parigas di ous, de pira ec. Su propriu de una duzzina, una serqua d’ova, di pere ecc.». Egli però trattò la materia con più sufficienza, lasciandoci una vaga traccia del concetto di dozzina. Questo è un progresso, che però non bastò a mettere sull’avviso Wagner. Inoltre il modello italiano ha il suo peso, e il DELI, nel registrare il lemma paio ‘coppia di cose, persone, animali’, attinge direttamente da it. paia, fondato sul lat. pāria, neutro plurale di pār ‘pari’.
Riconosco al Wagner la poca disponibilità di materiale alternativo, stante il fatto che si auto-condannò a frugare soltanto nella lingua latina. Ed avendo davanti agli occhi il modello pār, va da sé che lo vide come archetipo. Gli riconosco pure che in Sardegna sul tema ebbe pochi altri modelli, visto che in sardo per indicare il paio abbiamo soltanto dei lemmi italo-latineggianti concorrenti, quale l’italianismo coppia (con metatesi e rotacizzazione camp. croppa, dal lat. cŏpula), nonché páya (italianismo) e, appunto, parìga, che viene considerato una sopravvivenza medievale originata da un (inesistente) *paricŭla.
A nessuno è sembrato importante indagare perché il popolo sardo tende a misurare tutto in dozzine. Da quando sono nato non ho mai visto gente acquistare a decine ma soltanto a dozzine: una dozzina di paste, una dozzina di uova, una dozzina di piatti, e così via. E quando un campidanese va a far la spesa e vuole comprare una quantità di merce numerabile, ne chiede sempre una barίga, che non interpreta come paio ma proprio come ‘una dozzina’ (così è per le mele, le pere, le arance, e così via). Quando egli vuole andare oltre il numero uno o due, parla sempre di parίga. Il termine è usato estensivamente anche per la merce non numerabile, con procedimento generalizzante: così è per le ciliegie e tutta la merce minuta, ivi compresa, ovviamente, quella non edule. Cantu? Una parìga «Quanto? Un po’» (a indicare una quantità non misurabile ma già cospicua). Parìga è termine sardiano con base nel sum. bariga ‘unità di misura, di capacità’, ‘un contenitore per misurare’, da bar ‘forma esterna’ + iku ‘unità di misura’.
Italianismi. Una sotto-classe della “pregiudiziale latina” è la “pregiudiziale italiana”, cui Wagner ed i suoi epigoni si àncorano per giustificare l’origine di circa il 10% del vocabolario sardo. La riserva mentale dei ricercatori è che, intanto, anche gli italianismi sono di origine latina. In ogni modo Wagner, quando potè, volle distinguere e parlare propriamente di “italianismo”. E non lo sfiorò nemmeno l’idea che l’Italia romana era suddivisa in 32 popoli, con relative lingue, e che quelle lingue hanno prodotto i dialetti italici attuali. Talché io stesso, nel trattare le voci della Penisola, preferisco parlare spesso e volentieri d’italico anziché d’italiano, affinché si percepiscano le autonomie dell’antichità rispetto al latino.
Peraltro, il sud Italia formò per oltre 500 anni la Magna Grecia, e non è che dopo la conquista romana il greco delle coste sia decaduto nel giro di decenni. Ma sarebbe lungo rivangare questa problematica. A me compete in questa sede proporre alcuni esempi del tema prefissatomi.
Abbolicósu log. ‘diabolico’. Wagner ne propone l’origine dall’it. diabòlico, con perdita della prima sillaba. Ma in realtà la base etimologica è il composto akk. bu’’uru ‘catturato, prigioniero’ + leqû ‘prendere il potere’. Il composto bu’’uru-leqû significò in origine che è ‘succubo, preda di un potere (diabolico)’.
Accasare1 log. ‘maritare’; cfr. it. accasar(si). Wagner e chiunque altro pongono l’origine del termine sardo dall’it. casa ‘costruzione abitativa’ < lat. casa ‘capanna’. In realtà il termine accasáre è parimenti antico anche in Sardegna, ed ha base etimologica nell’accadico: v. kasû ‘legare, legare assieme’, ḫâsu ‘installare’, ḫuṣṣu (a kind of reed hut). Con ogni probabilità, la base più appropriata del lemma sardo relativo al matrimonio è l’akk. kasû ‘legare, legare assieme’.
Accássu log. ‘bisognoso’; accassu de sidis, de fámene ‘mezzo morto di sete, di fame’ (Spano). Wagner deriva il termine sardo dal sic. e it. casso ‘stanco, lasso’. In realtà il termine sardo è arcaico: vedi il verbo acansáre, accassáre, cansìre ‘star male, soffrire’; cansìdu p.p.; acassu, acansu, akensu ‘che sta male, che soffre’, ‘esausto, bisognoso’; camp. accasiòni ‘sofferenza, fastidio, malessere’; camp. acasionéri ‘chi produce un male, chi crea sofferenza’. Per traslato: cansàda ‘digressione, deviazione’. Base comune a tutti questi lemmi è l’ass.-bab. kanšu, kaššu, kansu ‘sottomesso, remissivo’ < kanāšu ‘sottomettere, assoggettare’.
Cascavallu camp. ‘caciocavallo’. Italianismo. DELI non sa trovare l’etimo, non riuscendo a individuare addentellati per il secondo membro -cavallo. La base etimologica può essere individuata soltanto dopo aver capito la tecnica di produzione del caciocavallo, il quale è un formaggio stagionato a pasta filante dell’Italia meridionale (specie della Campania), ottenuto da latte di vacca podolica. La forma è quella di una grossa pera (infatti in Sardegna è detto pireḍḍa ‘peretta’), il cui tozzo “picciolo” serve per legarlo ed appenderlo ad asciugare e stagionare. Talora il caciocavallo viene appeso entro una rete di rafia. Per il primo membro cacio- rinvio a casu; il secondo membro -cavallo ha base etimologica nell’akk. ḫabālum ‘to bind, harness; legare, imbrigliare’.
Incocciare, incocciái log. e camp. ‘incontrare, trovare, sorprendere’, come it. merid.: sic. ncucciari ‘ghermire, cogliere, soprendere’ (Traina); cal. ncucciari ‘accostare, avvicinare’; irp. nguttsà ‘indovinare’ e ‘colpire’ (Urciolo). Base etimologica è l’akk. ḫuḫārum ‘bird-snare, trappola per uccelli’. Il significato originario è chiaro, ed è chiara la sua evoluzione semantica nel bacino tirrenico.
Invece Wagner pretende che – siccome il vocabolo esiste anche nell’Italia meridionale – in Sardegna esso sia importato dal sud. Non lo sfiora nemmeno il sospetto che già dal Paleolitico sia esistita una Koiné tirrenica, alla quale la Sardegna partecipava da signora.
Ovviamente, il danno maggiore Wagner lo fa nel raffrontare fra loro sincronicamente queste voci, senza tentare la ricerca etimologica che ne avrebbe stabilito la loro origine prima, e se possibile la loro diacronicità.
Insólica in erba insólica (Cagliari); arbasólica (Cuglieri) ‘varietà di vite a frutto bianco’; corrisponde al nap. uva ‘nzoleca (Sarnelli); Isola del Giglio anzónaca; Elba: ansónico (Merlo); Pitigliano anzónica (Longo); cal. ansólia, insólia (DTC); sic. nzólia (Traina). A quanto pare, la voce sarda è d’accatto. Lascio al lettore l’impegno di controllare l’irresolutezza del Wagner (DES I 637) sull’etimo di queste voci italiche. Un indizio linguistico (il suffisso -ik-) fa pensare che tale vite sia entrata in Magna Grecia provenendo dalla Grecia. Lascio ai grecisti l’indagine, che sicuramente porta molto lontano, quasi certamente fuori dal loro mondo, esattamente al mondo semitico (vedi bab. īnu ‘vino’ + ṣulû ‘supplication, prayer; supplica, preghiera’). Secondo la mia interpretazione – la quale è in linea con tutti i nomi delle viti da me analizzati – insólica (īn-ṣul-ikos) in origine significò ‘vino da messa’, ‘vino per le suppliche nel Tempio’, e simili.
Pirone2 m. log. sett. ‘romano (contrappeso) della stadera’. Base etimologica è l’akk. pirru, perrum ‘payment collection, tax delivery; raccolta dei pagamenti, consegna delle tasse’. Nella prospettiva della nascita del linguaggio, questo vocabolo nitidamente sardiano acclara come si svolgeva il pagamento delle imposte allorché mancava ancora la moneta. Su una grande bilancia si poneva da una parte il peso accertato, e dall’altra il contribuente caricava grano od altro tributo, sino a che il peso si equivaleva.
Duole notare la superficialità con cui Wagner liquida la questione etimologica, scrivendo (DES II 276): « = ital. pirone (la limitazione al solo log. sett. e l’assenza del vocabolo negli altri dialetti esclude l’indigenato e più ancora l’etimo ‘pedone’ del Salvioni, RIL XLIX, 724, n.). Cfr. REW 6366». Si possono notare nella nota del Wagner due atteggiamenti culturali ancora oggi tipici dell’accademia: 1) quello di annotare comunque le soluzioni proposte dai suoi colleghi accademici, anche quando sono impresentabili e grondano mistificazione; 2) quello di sentenziare categoricamente la non-sardità dei vocaboli logudoresi allorché manchino delle controprove campidanesi.
Rata log. e camp. ‘rata, parte, quota in cui viene frazionato un pagamento’. Per Wagner è italianismo. DELI lo deriva dal lat. răta p. p. di rēri ‘pensare, opinare’ ma senza convinzione: infatti s’ignora persino l’etimo del verbo latino. Invero, base etimologica del tirrenico rata è il sum. raḫ ‘to break’ + taḫ ‘to add’. Il composto originario raḫ-taḫ significò ‘frazione (di un insieme) da addizionare’.
Reghentiare, arreghentiare log. ‘inasprire, inciprignire’ (di ferite, tumori); rifl. ‘inasprirsi, incocciarsi’; regentίa ‘collera, rabbia, ostinazione, cocciutaggine’. Base etimologica è il sum. raḫ ‘to beat, kill; picchiare, battere, uccidere’ + ti ‘arrow, freccia’. Il composto raḫ-ti- in origine indicò il ‘colpire di freccia’. Ovviamente è da espungere la proposta del Wagner di derivare questa voce da un it. recente (lat. recens, recentis) ‘avvenuto da poco tempo’ (sic).
Sinnu log. ‘senno, criterio’, parola usata anche nel Medioevo (CSP 348). Base etimologica il sum. šennu ‘priest, sacerdote’ (tutto un programma). Cfr. ant. fr. sen ‘intelligenza, ragione’ (DELI), evidente segno dell’arcaica Koiné Mediterranea. Wagner lo deriva dall’italiano, DELI dal francese, ma essi rimangono sempre nell’angusto cortile della filologia romanza.
Vária (Bitti), oggi válgia (s’álgia); sa várgia (Fonni); barza (s’arza) log.; bárgia, braxa camp.; viene definito dallo Spano ‘falangio, sorta di ragno velenoso, il solo che abbiamo nell’isola, dal Berni si chiama tarantola, ma meglio solìfuga’. Difatti non è la vera tarantola (Lycosa tarantula) e neanche il malmignatta (solifuga, che si chiama in Sardegna soloίga, suίga), ma una specie di Mutilla, un imenottero vespiforme “le cui femmine rassomigliano a formiche graziosamente screziate di giallo e di rosso” (Marcialis, Pregiudizi 59).
Base etimologica di vária è l’akk. bārû(m) ‘to catch, trap (with a net), wicked people; hunt, go hunting; catturare, intrappolare, gente cattiva; cacciare, andare a caccia’. Questa è l’esatta descrizione dei ragni in generale. Nel caso specifico, bária è aggettivale del verbo accadico qui indicato. Va da sé che le etimologie del Wagner sono fuori posto, poiché non si può sostenere che la denominazione provenga dal colore variegato (vária).
Caḍḍémis, caḍḍémini ‘persona miserabile, vestita di stracci o comunque male vestita, sporca’ (Puddu); kaḍḍémis cagl. plebeo ‘straccione, sporco, malvestito’ (Wagner); bestίu a caḍḍémis; Wagner lo presenta come equivalente del sic. gaddémi ‘chi somministra legna alla caldaia, abietto, dappoco’ allato a gaddìmi ‘idem’ e lo ritiene una probabile derivazione dall’ar. ḥadîm ‘servo’. L’ipotesi del Wagner va bene per la Sicilia. Per la Sardegna propendo a vederci l’influsso dell’akk. qaddu(m) ‘piegato’ da miseria, preoccupazioni, malattie + emû, ewûm ‘diventare’, ‘essere come’; questo verbo si usa spesso col suffisso modale -iš ‘come, like’. Il significato è ‘diventare come uno schiavo, un servo’. Alcuni sardi, influenzati in buona fede dal fatto che certe parole della Sardegna somigliano stranamente a lemmi inglesi con significato similare, giurerebbero che il termine sia stato creato da emigranti sardo-americani di un secolo fa, dalla locuzione God damned ‘che Dio sia maledetto’. Registro questa curiosità per far capire quanto forte sia la legge della paronomasia (della quale tratterò in seguito), la quale esercita la sua tirannia sia nel popolo sia tra gli intellettuali.
Caḍḍótzu camp., specialmente cagl. ‘sudicio’ (di persone). Il termine si ha pure ad Escalaplano, ossia sulle montagne degli antichi Galilla. Wagner propone una probabile etimologia da kaḍḍu ‘cotenna, pelle del maiale o del cinghiale’ < lat. callum. Ma è difficile accostarsi alla proposta wagneriana. Era nota nell’antichità l’abitudine all’igiene del maiale (a maggior ragione del cinghiale), che non è nè più sporco nè più pulito di altri animali, ed appare “sporco” solo allorché viene chiuso nell’abiezione del brago. Ma il brago, si sa, viene cercato naturalmente dal maiale (e pure da molti animali della savana) per crearsi addosso un impasto che, seccando, racchiude e uccide le zecche e tutti i parassiti della pelle. Nella stagione calda è usuale vedere branchi di maiali (quelli liberi in natura) immersi per lungo tempo nei fiumi d’acqua pura, col solo muso fuori (proprio come i bufali o gli ippopotami) allo scopo precipuo di annegare i parassiti. Il termine ‘sozzo, sudicio’ non poteva dunque richiamare il maiale, nonostante che gli Ebrei lo avessero considerato un essere immondo (ciò riguarda soltanto la loro religione, per la quale era immondo persino il cammello).
Suppongo che il termine caḍḍotzu col semantema attuale sia nato nell’alto medioevo ad opera dei preti cristiani, decisi a far tabula rasa di ogni forma di religione anteriore, della quale bersagliavano i termini sacri distorcendoli nella forma e molto più nel significato, che veniva capovolto, umiliato, lordato e quindi demonizzato. Nelle città sarde – giusta la (relativa) tolleranza degli imperatori – le religioni attestate erano le stesse professate a Roma: quella ufficiale dello Stato, ma pure quelle orientali (ebraica, egiziana, persiana, etc.). Era forte specialmente la religione ebraica, non solo per la forte presenza della diaspora ma anche perché gli Ebrei, dovunque stessero, erano gli unici a saper leggere e scrivere. Erano pertanto rispettati ed apprezzati.
L’unico termine antico accostabile a caḍḍotzu è il fen. qdš (qodeš) ‘santo, santuario’, ‘consacrare, consacrato’, riferito a tutto: sacerdoti, offerte, tempio e divinità. È principalmente accostabile l’ebr. qadòš ‘martire, santo’ (SLE 85). Ma può esserlo pure qaddiš, ch’era la preghiera ebraica ripetuta varie volte al giorno (SLE 73), o il kidduš, la benedizione a Dio espressa la mattina del sabato, recitata accanto a due candele, su una coppa di vino.
Somiglianza originaria tra sardo, catalano, spagnolo. Nonostante le obiezioni che fin qui ho mosso a M.L. Wagner, riconosco che per il passato egli fu il maestro indiscusso e insuperabile degli studi di linguistica sarda. Nato nel 1880 e morto nel 1962, compì gli studi al regio Humanistiches Gymnasium bavarese di Neuburg a. d. Donau e alle Università di Monaco, Würzburg, Parigi e Firenze. Dal 1905, su borsa di studio dell’Università di Monaco, cominciarono i numerosi soggiorni in Sardegna. Nel mentre dal 1907 fu nominato professore di lingue moderne alla Deutsche Realschule di Costantinopoli. Wagner conosceva, oltre al tedesco, il sardo, l’italiano, il francese e lo spagnolo, e seppe approfondire anche la conoscenza del rumeno. Essendo di casa in Turchia, è pensabile che sapesse gestire anche la lingua turca. Era indubbiamente poliglotta, e in quanto tale si potè concedere impegni di studio anche nell’ambito dei gerghi e delle lingue popolari, del giudeo-spagnolo, del portoghese, dello spagnolo, del catalano. Ovviamente alla base dei suoi studi doveva esserci la lingua latina e quella greca antica. Caballero andante [y ingenioso hidalgo] della filologia lo definì Karl Vossler, e ancora oggi ogni linguista s’inchina davanti alla vastità dei suoi excursus.
Nell’approfondire le lingue iberiche, Wagner si era reso conto dell’identità pressoché totale della lingua sarda col catalano e con lo spagnolo. Leggendo estesamente il suo capolavoro, il Dizionario Etimologico del Sardo, si evince che lo studioso tedesco agganciò quasi il 90% della lingua sarda a quelle iberiche. Ovviamente egli aveva approfondito anche gli studi sulla storia sarda, e dagli storici del suo tempo apprese che le vicende sarde avevano portato nei secoli anzitutto all’occupazione romana, poi all’occupazione pisana, genovese, catalana, dopo la quale la Spagna intera subentrò estesamente nell’isola. Infine, furono i Savoia a dominare la Sardegna.
Wagner tenne conto di questo fenomeno, ma con tutta evidenza lo interpretò mediante la cultura da lui assorbita nei luoghi di origine in gioventù, quando la pregiudiziale nazista pervadeva ogni poro del pensiero germanico. Di conseguenza egli ammantò i propri libri di una visione poco meditata, che proponeva una lingua sarda derivata quasi per intero dalle lingue iberiche. Wagner, per ragioni di stile scrittorio, non scrisse espressamente di derivazione né di origine delle decine di migliaia di lemmi da lui affrontati. Gli bastò esplicitare i due concetti di tanto in tanto, su poche centinaia di voci, conseguendo l’effetto che il lettore se ne convincesse per proprio conto. Fu un processo pressoché surrettizio, come tale poco adatto a risvegliare nel lettore il senso critico, inducendolo ad accettare le sentenze palesi o silenti del Wagner. Nelle altre migliaia di lemmi egli affianca semplicemente la voce iberica a quella sarda, suggerendo ex silentio la prima come origine della seconda.
Da me in quanto glottologo tali sentenze del Wagner sono state percepite da decenni come ingannevoli, ma è da quindici anni che ho rotto gli indugi col mio maestro Wagner, decidendo di contrapporre a mia volta una visione e una procedura metodologica diverse nello studio della lingua sarda. Il lettore sarà mio giudice. Sorge spontanea un’obiezione: se Wagner era convinto che il 90% della lingua sarda deriverebbe dalle parlate iberiche, come conseguenza si deve assumere che il popolo sardo, prima dell’invasione iberica del 1323, parlasse soltanto un 10% di vocaboli. Un glottologo sa che un popolo con tale penuria non può mai esprimere la propria cultura. Ci vuol poco a capire che la “pregiudiziale iberica” del Wagner è sorella della “pregiudiziale latina”: porta alle stesse conclusioni nichiliste, ossia ad ammettere che prima di Roma (in questo caso, prima di Barcellona) il popolo sardo si esprimesse mediante un plancher così misero, che può benissimo essere tralasciato, perché ininfluente nello studio del sardo attuale. Come corollario, va da sé che la lingua sarda attuale dovrebbe considerarsi accattata di recente, quasi al 100%, dai popoli viciniori. Come secondo corollario, si dovrebbe ammettere che la lingua sarda nella sua lunga storia sia stata di una gracilità così eclatante, da infrangersi e sparire ad ogni minimo urto colonizzatore. Si può notare che i filologi che sinora hanno condotto gli studi linguistici in Sardegna hanno tutti la stessa mentalità: credono che i Sardi abbiano una tale disaffezione per la propria lingua da barattarla con la prima lingua che s’affacci alle coste isolane.
Ciò equivale a dire che il popolo sardo, dopo aver vissuto con la propria lingua da 100.000 anni (o da almeno 40.000 anni) e fino al 238 a.e.v., di colpo vi rinunciò. Una volta latinizzati al 100%, i Sardi giunsero al 1323 della nostra Era, ed eccoli di nuovo abiurare alla propria parlata, calpestandola ed assumendo in breve tempo altre parole, altre visioni del mondo.
Invero, i fatti non sono mai andati per quel verso. I Sardi hanno sempre mantenuto la lingua delle origini, salvo le poche contaminazioni che in ogni paragrafo vado dimostrando. Quindi è ovvio che la visione del Wagner va rivisitata con occhio disincantato. La mia visione è semplice: se i Sardi condividono con gl’Iberici il 90% del proprio vocabolario, vuol dire che Sardi ed Iberici lo condividono già da 100.000 anni, o giù di lì. Insomma, rammentando la “presa a tenaglia” che l’Homo, disceso fino al Delta, operò lungo le coste mediterranee, va da sé ch’Egli prima sbarcò a Gibilterra su otri gonfi di paglia, poi dilagò sino alla Linguadoca, alla Liguria, all’Etruria, e di là per la Corsica arrivò in Sardegna. Per questa ragione gl’Iberici sono stati i primi, nel Paleolitico, a parlare il linguaggio nilotico, poi sbarcato in Sardegna; ma tutto ciò avvenne sempre in epoca arcaica, non nel 1323.
Ecco di seguito qualche vocabolo indissolubilmente e pariteticamente iberico-sardo (o sardo-iberico).
Altanèra camp. ‘aquila grande’ (Spano). Wagner deriva il lemma da sp. altanero ‘aplícase a les aves de rapiña de alto vuelo’. In realtà i lemmi sardo e spagnolo hanno base etimologica nell’akk. alītu, elītu ‘altezza, parte alta’ + erûm ‘eagle’, e significò in origine ‘aquila dei luoghi eccelsi’.
Amistáde, amistádi log. e camp. ‘amicizia’; uguale a sp. amistad. L’uno e l’altro vocabolo hanno basi etimologiche comuni nell’akk. a, an, ana ‘per’ (finale) + misu, mēsu ‘washing, purification’ + ṭabtu ‘pace’. Il composto a-mis-ṭabtu significò in origine ‘purificazione della pace’. Questa parola è arcaica. Non può essere vero che derivi dalla Spagna. L’una e l’altra parola sono mediterranee ma autonome, in quanto facenti parte di unica Koiné. L’arcaicità di questa parola si nota dalla combinazione delle tre componenti e indica il momento in cui le famiglie nemiche facevano solennemente la pace, purificandosi con l’acqua (rito uguale a quello dell’ingresso nel Tempio) e tenendosi pubblicamente e reciprocamente la mano.
Arraccáda nuor. e camp., meno frequente nel log.; spesso arreccadas (Cagliari, Villacidro, Iglesias, Sarrok) ‘orecchini pesanti’ = cat. arracada, arrecada; sp. arracada; sass. raccára ‘idem’ (Muzzo): un pággiu di raccári ‘un paio di orecchini pesanti’ (Calvia). Base etimologica è l’akk. raqādum ‘to dance, skip; danzare, saltellare’ (infatti gli orecchini sono l’unico ornamento muliebre che ballonzola liberamente).
Carrogna (carroña) log. e camp. ‘donna di facili costumi’; cfr. cat. carronya, it. carogna (ambedue con identici significati spregiativi, relativi a persona infame raffigurata come carcassa puzzolente). Wagner propende a vedere l’origine della voce sarda dal catalano (e ciò soltanto perché essa contiene …due -rr- come in Sardegna!). L’atto del Wagner, oltre ad essere superficiale per il fatto che confronta lemmi coevi la cui storia non viene approfondita, non si pone nemmeno il problema delle cause che portarono in Italia ad una -r-, e in Catalogna a due -rr-. A lui basta l’evidenza della doppia -rr- per decretare che la Sardegna è debitrice di un ennesimo vocabolo dalla Catalogna. Questo metodo… “audio-visivo” è ascientifico e antistorico, perché, non tenendo conto della pronuncia italiana, si priva dell’opportunità di scendere al fondo dei millenni per individuare il prototipo di tutte queste voci mediterranee.
Soltanto andando alle origini arcaiche siamo in grado di capire il fenomeno, il quale va scomposto in due rami d’indagine per essere meglio inquadrato. Il primo ramo conduce forzatamente alla situazione storica del Mediterraneo nei millenni precristiani, allorché le continue guerre che recavano ad alte perdite tra i maschi, nonché la disuguale organizzazione del lavoro e la disuguale struttura ereditaria, portava a un quadro socio-economico nel quale la vedova o l’orfana – nonostante le ipocrite leggi morali e religiose che suggerivano l’elemosina e la protezione delle vedove e dei bimbi – riuscivano a sopravvivere soltanto prostituendosi. Il secondo ramo d’indagine è quello meramente linguistico, in base al quale scopriamo che la lingua accadica offre la voce karru, kāru(m) ‘quay, port, (river) quay; molo, porto, porto fluviale’. Unire questi due risultati è facile, considerando che le prostitute s’ammassavano principalmente lungo i porti dei grandi fiumi o sui moli dei porti marini. Ragioni ovvie: era lì che convergevano i marinai ed i commercianti di passaggio, era lì che alle donne era consentito di esercitare la prostituzione sacra senza pagare nemmeno il fio della condanna morale.
Quindi carrogna non è un inasprimento morale e linguistico (le due -rr-!) mirante ad equiparare la prostituta alla carcassa puzzolente d’una bestia (ciò sarebbe stato il colmo della contraddizione in bocca a un maschio che prima del matrimonio era invitato dal padre a “farsi esperto”), ma è semplicemente un aggettivo professionale in -nia indicante ‘quella dei porti, quella dei moli’. Si può constatare che in Sardegna e in Catalogna prevalse l’akk. karru, mentre in Italia prevalse l’akk. kāru, da cui le due voci carrogna e carogna. Invece l’it. carogna intesa come bestia in decomposizione ha altro etimo, infatti è lemma precipuamente italico (è aggettivale spregiativo da lat. carō, carnis ‘carne’), mentre in Sardegna s’usa precipuamente mortorzu o ispéigu (vedi).
Ditta2 camp. ‘prétziu crésciu in is compras a s’incantu’: crèsciri ditta ‘aumentare l’offerta o il prezzo’; béndiri a ditta ‘vendere per la maggiore offerta’; cfr. cat. dita ‘lo preu que’l comprador posa a lo qu’es ven y arrenda: postura’. Base etimologica è l’akk. diktum ‘fighting, combattimento’ (tutto un programma).
Inconaresì log. ‘essere di malumore, stizzirsi, affliggersi’; cfr. sp. enconarse ‘irritarse’; (Spano) inconadu ‘adirato, disgustato, sorpreso’. Base etimologica è l’akk. inḫum ‘hardship, trouble; sofferenze, guai’.
Puḍḍu (Missa de Puḍḍu, de Buḍḍu, de is Puḍḍas) in tutta la Sardegna è la ‘Messa di Natale’, celebrata la sera del 24 dicembre in ora tale che il momento della nascita di Gesù corrisponda con la mezzanotte.
Wagner è convinto che tale Messa abbia a che fare con i polli, e cita a rinforzo la corrispettiva misa del gallo spagnola. Ma si sa che i polli (galli, galline) vanno a dormire al calar del sole, e si svegliano all’alba. Orari che non corrispondono a quello della Messa celebrata dai Cattolici. In questo contesto, sembra chiaro che gli Spagnoli si ritrovino il modo di dire moderno come traduzione paretimologica (e omologazione al semantema del lat. pullus) di un termine mediterraneo non più compreso. Così è per il sardo puḍḍu.
L’enigma del sardo puḍḍu inteso come ‘pollo’, e parimenti dello sp. gallo inteso come ‘pollo’, è svelato dall’etimologia, che ha base nell’akk. pūdu, būdu (un genere di festa). Il fatto che il sardo (e sardiano, oltreché mediterraneo) puḍḍu, buḍḍu abbia in origine significato, per antonomasia, una festa, la dice lunga sull’importanza di tale festa, la quale, cadendo al solstizio d’inverno e quindi al Capodanno solstiziale, doveva essere la più importante dell’anno. Infatti tale festa dava avvio ai riti della morte e resurrezione del Dio della Natura, rito che poi dalla nuova religione fu incanalato nel Carnevale. La tradizione cristiana del Natale, sovrapponendosi alla tradizione pagana, non riuscì ad estinguere il termine mediterraneo, che ancora sopravvive in Sardegna.
Tamagnu (Nuoro, Osidda, Goceano) ‘statura, grandezza naturale’ = sp. tamaño. Nel log. sett. occorre come f. temagna ‘qualità, proporzione, dimensione’: Sun totos duos dessa matessi temagna ‘sono della stessa misura’; ladros dessa matessi temagna ‘della stessa specie’ (Casu). Base etimologica il sum. tam ‘to trust, believe; dar fiducia, credito’ + aĝ ‘to measure’. Il composto tam-aĝ (pronuncia: tamagn) significa da sempre ‘misura fiduciaria, standard, ufficiale’. Non varebbe la pena osservare che Wagner opera una doppia operazione subliminale: 1. la prima è di accreditare ex silentio l’origine spagnola della parola sarda anziché assentire sull’origine mediterranea; 2. la seconda è di non proporre l’etimologia, accreditando tale obbligo come superfluo.
Valentía log. e camp. ‘prodezza’. Wagner ha registrato questo vocabolo, prendendolo da due scrittori sardi, ma lo ha corrotto ad libitum soltanto per poterlo accreditare come derivazione da sp. valentía ‘echo o azaña heróica’. In realtà, la voce sarda autentica è balentía, per il cui etimo vai a balente.
Zira log. sett. ‘striscia’ (di tela, di carta, di terreno): Casu = sp. jira ‘tira de tela o jirón’. Base etimologica il sum. zir ‘to break, tear out; rompere, strappare’: esempio tipico della stretta parentela sardo-iberica fin dal Paleolitico.
La pregiudiziale iberica. Nel paragrafo precedente abbiamo riconosciuto che Sardegna ed Iberia condividono fin dal Paleolitico parecchie migliaia di vocaboli, ancora vivi nelle rispettive parlate. Si spiegano anche per questa via i rapporti sempre esistiti tra il popolo catalano e quello sardo, come c’insegna la storia dei giudici d’Arborea e la stessa vita di Eleonora d’Arborea. Ma la visione dei filologi romanzi è diversa: essi pretendono che le voci iberiche in Sardegna siano state importate, cancellando le precedenti voci sarde (…ammesso che ne esistessero…). Questa visione è palesemente miope, ascientifica, indimostrabile. Lo scopriremo discutendo qualche lemma.
Cannutígliu log., canotίgliu camp. è la ‘canutiglia, filo d’argento o d’oro per ricamo’. Wagner sostiene che il termine deriva da sp. cannutillo, cañutillo ‘hilo de oro o plata rizado para bordar’. In realtà, base etimologica è l’akk. ḫanû (proveniente da Hana, città della Mezzaluna Fertile celebre per le stoffe di pregio) + tillu ‘bardatura, bordatura, segno esteriore, applicazione a stoffe cerimoniali’. Quindi ḫanû-tillu in origine indicò la ‘bordatura proveniente da Hana’. Se dovessimo immaginare che le pregiate stoffe di Hana, celeberrime in tutto il Mediterraneo, arrivassero in Iberia by-passando la Sardegna, dovremmo accettare che la Sardegna fu tagliata fuori da ogni commercio, in andata e in ritorno. E ciò non è vero.
Carignátula (cariñátula) ‘tignola, tarma’ (Spano); anche caragnada; voce gallurese; cfr. còrso caragnattu, caragnáttulu ‘specie di ragno’, caragnattula ‘scolopendra’. Per Wagner l’origine è iberica. Invero, la base etimologica è l’akk. kâru ‘to rub’ ‘sfregare’ + naʼdu ‘attento, riverente’: il composto si riferisce all’attento “sfregare”, ‘rosicchiare’ del tarlo.
Immurzare log., ismurzáre centr., immurgiáre centr., smurzái camp. ‘far colazione’, ‘far siesta per mangiare’; immurzu ‘merenda’, sass. immùzzu. Secondo Wagner, che s’accoda al Corominas, dovrebbe essere una forma iberica recente, del XIX secolo, vedi sp. almorzar, cat. esmorzar. Wagner avrebbe dovuto farci capire perché gli Spagnoli, che in Sardegna cessarono la propria dominazione tre secoli fa, abbiano inventato un termine così tardo, lasciandolo poi in eredità ai Sardi dopo aver cessato il dominio, che peraltro negli ultimi secoli fu oltremodo indiretto, poiché i possidenti e feudatari spagnoli amministravano con missive dalla Spagna (o comunque dalle città sarde, non dalle campagne) attraverso i propri fattori. Ancora più arduo è pensare che il termine sia stato lasciato in Sardegna dai Catalani, che governarono l’isola soltanto nel 1300-1400.
È strano che Wagner non si sia accorto che il termine è pansardo, ed è molto utilizzato in ogni paese della Sardegna (non nelle città). Viene usato non tanto per indicare la ‘colazione’ (concetto ignoto ai sardi), ma per indicare una “rottura” dell’attività giornaliera al fine di ricaricarsi d’energia. Semanticamente equivale all’ingl. breakfast ‘rottura del digiuno’, ed indica in particolare il pasto della siesta meridiana. Debbo quindi ammettere che il termine sia molto antico. Infatti è sardiano, con base nell’akk. emṣum ‘affamato’ > *em(u)ṣum (anaptissi eufonica) > immùzzu (forma sassarese). Da qui le numerose varianti di immuzzu, comprese quelle con la classica epentesi di -r- dovuta a una legge fonetica sarda, e comprese le semplificazioni tipo murzu.
Disvelare log. ‘vigilare’; cfr. sp.-cat. desvelar; sost. disvélu, desvélu log. ‘sveglia’ = sp. desvelo. Wagner presenta la dipendenza della voce sarda da quella iberica, ma la verità è diversa, e lo dimostra ad esempio il camp. billái ‘vegliare, custodire, far la guardia’: billai su mortu; billai bona parte de sa notti studiendu (Porru). Bil-lai, privo del prefisso dis-, mostra chiaramente il radicale del verbo dis-vel-are ed acclara la sua origine dall’akk. bêlu ‘detenere (qualcuno), dominare, governare; to rule, take possession of’. In questo caso si evidenzia l’esatta funzione del pref. dis-, che non è privativo ma confermativo. Quindi disvelare significò anzitutto ‘vegliare, dominare, governare con determinazione’.
Irrobbare log., sdorrobái camp. ‘derubare’. Da rifiutare l’origine del verbo da sp. robar ‘idem’, proposta dal Wagner il quale propende per quell’origine anche quando l’evidenza è contraria. Tale voce è denominale da sd. robba ‘gregge, peculio, ‘bestiame’, ‘tutto ciò che uno possiede’. Wagner sostiene che robba derivi dall’it. roba (notisi la contraddizione, visto che prima indica l’origine iberica di irrobbare ‘portar via la robba’). A sua volta DELI registra roba come ‘ciò che di materiale si possiede o che serve in genere alle necessità del vivere’, derivandolo dal francone rauba ‘armatura’, ‘veste’: ma anche qui si cade in errore. Si vede che il termine si è espanso in Europa, ma nessun ha messo in evidenza la base etimologica, che è l’akk. rubbû ‘portato a piena crescita’, ‘incrementare, migliorare’, ‘avere interessi su’. Cfr. ingl. robbery ‘beni acquisiti con la grassazione’, to rob ‘derubare’, robber ‘ladro’; it. rubare.
Madéra-Linna. In camp. sa madèra o marèa (term. de maistu de barcas) funti ‘pezzus de linnámini de barca fattus a guidu po sustegnu de is taulus’ (Porru), = sp. madera ‘legno’. Questo è uno fra mille esempi che Wagner propone, relativo a voci che invece agonizzano o sono morte in Sardegna dopo l’epoca del colonialismo. Il termine largamente più usato in Sardegna non è certo madéra ma linna; ma anche linna per Wagner è coloniale, dal latino, mentre ha la base akk. liginnu (un tipo di tavoletta).
Magalléri camp.; mragalléri (Muravera) ‘giovane dell’anguilla latirostro e del grongo’ (Marcialis). Possibile base etimologica è l’akk. magallum (a big boat, una grossa barca). Se l’intuizione è giusta, qui assistiamo ad un processo in cui dalla barca da pesca si addivenne a nominare un tipo di pesce. Wagner dichiara la sua impressione che la voce sia catalana, “ma che non si trova nei dizionari”. A tanto giunge la pregiudiziale iberica in quello studioso.
Pansíri, pantzíri camp. ‘appassire’; mela pantzída ‘mela aggrinzita’ = cat. pansir-se ‘dessecar per l’acció del sol, per la calor excessiva’. Indubbiamente la voce sarda ha subìto l’influsso fonetico catalano, ma la voce è anche italiana: appassìre ‘idem’, dall’antico participiale passo ‘appassito’ (di erbe, frutta, per mancanza di umore). Base etimologica è l’akk. pa’ṣum, pāṣu ‘disbanded, off-duty; fuori servizio’ (truppa e altro), ‘crushed, broken up; schiacciato, rotto’. Questa è uno dei tanti lemmi da me elaborati nel Dizionario Etimologico senza citare il testo del Wagner (per non appesantire la narrazione), il quale traccia la vita di questa voce traendo gli esempi catalani (parecchi esempi) e quindi inducendo subliminalmente il lettore a credere alle origini catalane o spagnole.
Patranga (Bonorva) ‘finteria’, ‘fatto, cosa inventata’ = sp. patraña ‘mentira o noticia fabulosa’. Possibile base etimologica l’akk. patḫu ‘holed, bucato’ of discarded shoes, di scarpe abbandonate. Ma è più congruo l’akk. paṭārum ‘to loosen, release; allentare, rilassare’, paṭru ‘released’ + anḫu ‘tired, dilapidated; sfinito, dilapidato’ (in composto paṭr-anḫu). Wagner, disdegnando l’analisi etimologica, s’assicura in primis di ricondurre tutto all’iberico, lasciando però la sua proposta senza spiegazioni.
Pedríscia log. sett. ‘soglia, limitare’; pedríscia dessu balcone ‘davanzale della finestra’ (Casu); pedrissa, predissa log.; pedritza (Sennori); pidrissa sass. ‘sedile di pietra addossato al muro, da cui si monta a cavallo’. Per l’etimo vai a préḍḍa, pedra.
Wagner, oltre a considerare la base pedr- di origine greco-latina anziché, più correttamente, di origine mediterraneo-semitica, considera anche il suff. -íscia come non-sardo. E insiste: «probm. dal cat. pedrissa ‘massa de pedra’; pedrís ‘lloc abundant de pedres’; ‘seti de pedra’, ‘banc de pedra al peu de la porta, al pati, etc. per a seure’». Se escludiamo la foglia di fico espressa con “probm.”, da lui (e da altri imitatori) largamente usata per non apparire partigiano, egli non riesce a nascondere il suo filo-catalanismo, e non sa dove altro parare con la sua erudizione “di galleggiamento”. Invero, -íssa, -íscia è formazione tematica molto usata in Sardegna ad indicare un’attività o professione al femminile: crabarìssa ‘caprara’, abbatissa ‘abbatessa’, priorissa ‘prioressa’ e così via. La sua origine sta nell’ass. issu ‘woman, wife’, ebr. iššāʼ ‘donna’ ( אִׅשָּׁה ), bab. iššī ‘ella, she’. In Sardegna la pietra lineare della soglia e del davanzale, nonché il sedile spartano posto a lato della soglia, ricevettero suffisso femminile per il rispetto dovuto alla donna, Poiché la soglia, il davanzale, il sedile laterale alla soglia delle case antiche erano funzionali esclusivamente alle donne, anche perché erano anzitutto esse ad aver bisogno della predella per montare a cavallo. Stessero le case in mezzo alla foresta (come in Gallura) o nella viuzza paesana, questi tre “posatoi” erano destinati alle donne: per parlare a lungo sulla soglia con la vicina, per stare alla finestra in attesa dell’anima-gemella, per sedersi accanto all’uscio a filare, a cardare, fare cestini, salare i pomodori, e tanto altro.
Pendòni m. camp. ‘persona spregevole’; cfr. sp. spendón ‘persona despreciable’. Per l’etimo non si può recepire “pèndere” (come invece pretende Wagner), perché non si riesce a spiegare che cosa c’entri la semantica del “pendere” con la semantica della “spregevolezza”. Wagner, al solito, si soddisfa nell’abbinare due vocaboli foneticamente simili, senza indagarne la comune semantica. Egli fa ciò sempre e comunque, ma si sente particolarmente soddisfatto quando con l’abbinamento di due voci egli crede di “dimostrare” l’origine della lingua sarda da quella iberica. È invece congruo indicare la base etimologica di pendòni nell’akk. pēndu, pēmtum ‘charcoal, carbone’ (da cui anche pendû ‘mole, birthmark on face; neo, macchia scura sul volto’). In tal caso si assume pendòni come aggettivale in -òni, e si può agevolmente identificare questo pendòni come un antico ‘carbonaio’, il quale era sempre annerito per causa di lavoro. Di qui la metafora riferita a un ‘uomo spregevole’.
Poále, puále (Bitti, Posada, Dorgali, Orosei, Macomer, S. Lussurgiu); upuále log. ‘secchio di latta o di zinco per mungere’ = cat. poal ‘galleda’. Wagner rifiuta la proposta del Gröber che upuále fosse derivazione (aggettivale) da sd. úpu < cúppu. A maggior ragione rifiuta l’etimo simile proposto da REW 2409: lat. cuppa ‘coppa’. Fa tutto ciò per inchiodarsi all’origine catalana, quasi a testimoniare estremisticamente che in Catalogna fosse nata la lingua poi trasmessa alla Sardegna. E non s’accorge che la stessa voce catalana partecipa della Koiné Mediterranea < akk. kūbu ‘a drinking vessel’, che diede l’aggettivale *kūbu-ale > (ku)buale > upuale.
Recádu log. e camp. ‘notizia, ambasciata, saluto, ossequio’ = sp. recado. Base etimologica è l’akk. rēqu ‘far, distant; lontano, distante’ + âdu to take notice of’. Il composto rēq-âdu in origine significò ‘ricevere notizie da lontano’. Etimologia lineare per la quale non si può insistere sullo spagnolismo a senso unico proposto dal Wagner, quando è evidente l’origine comune.
Recuíre log. ‘raccogliere’. Cfr. sp. recudir ‘volver una cosa a su sitio’. La voce sarda pertinente al ‘raccogliere’ è gollίre, collίre, goḍḍίre, ingolli. Invece il riferimento spagnolo citato dal Wagner si attaglia soltanto al sd. recuίre ‘ritornare’. Qua, come si vede, Wagner ha raggiunto l’acme dell’assurdo, prendendo una voce spagnola, ritagliandole sopra una voce sarda inesistente, e dando a questa, forzatamente, il significato spagnolo.
Sabanitta (Macomer); banitta log. e camp. (Cuglieri, Busachi, S. Lussurgiu, Milis, Perdas, Escalaplano); sa baίnta (Usellus); ballitta (Fonni) ‘materasso’. Nel CSMB 32 banita è più che altro una ‘coltre’. In origine fu banitta, essendo sa- un articolo concresciuto. A sua volta banitta ha base etimologica nell’akk. banû ‘to become good, look after s.o. kindly; divenire buono, prendersi cura delicatamente di qualcuno’. Va da sé che il concetto originario fu quello del CSMB, e la voce è autenticamente sardiana. Rinvio al DES II 373 per capire l’arte sopraffina del Wagner nel menare il can per l’aia e discutere del sesso degli angeli. Inoltre il suo tentativo di accreditare queste due voci al mondo iberico è ad un tempo patetico e losco: egli infatti opera con argomenti insieme scoperti e subliminali per fissare l’origine del vocabolo nell’Iberia, nonostante ch’esso sia ufficialmente datato al 1242.
Saètta log. e camp. ‘freccia’; anche ‘fulmine’ (log. sett.). Cfr. it. saetta < lat. sagitta ‘freccia’. Wagner pretende senza ragione che la voce sarda sia da sp. saeta, quando è evidente che la voce nacque in ambito tirrenico.
Sumbréri log., sass., camp. ‘cappello’; gall. simbréri (Azara) = sp. sombrero ‘che fa ombra’. Ovviamente Wagner indica la parola sarda come accatto da quella spagnola. Ma ciò contrasta con l’arcaicità del lemma, che fu mediterraneo da parecchi millenni, poiché la base etimologica è il sum. šun ‘sole’ + bur ‘garment, clothing’. Quindi in origine šun-bur (di cui sumbréri e aggettivale di funzione in -éri) significò ‘indumento (copricapo) per il sole’.
Il Corominas volle sancire d’autorità che lo sp. sombra è «alteraciόn del lat. ŭmbra, id., conservado en las lenguas hermanas, y en el deriv. umbrίa, 1739; umbrίo, 1513. La s-, agregada sόlo en portugués y castellano, es probable que se deba al influjo de sol y sus derivados, por ser sol y sombra, solano y sombrίo, solear y sombrear, conceptos correlativos, opuestos y acoplados costantemente. La variante solombra, corriente desde antiguo, h. 1250, en los dialectos leoneses, judeoespañoles, portugueses y occitanos, comprueba la certeza de esta explicatiόn». Nel ragionare del Corominas osserviamo il vertice cui può giungere la perspicacia dei filologi romanzi, la quale, impiccata alla credenza che tutto abbia origine nel latino, si appaga nell’osservare i vari concetti correlati, senza però un sia pur minimo colpo d’ala che gli faccia cogliere le radici profonde dei processi che portarono al misterioso s-, da loro percepito puerilmente quale parente oramai consumato del… s-ole.
Nel capoverso iniziale ho indicato quali sono le vere radici dello sp. sombra ‘ombra’ (< sum. šunbur); mentre il lat. ŭmbra, sd. umbra ‘ombra’ ha diversa etimologia. Semerano (OCE II 599) propone ŭmbra dal sum. umbara ‘riparo, difesa’. Il Pennsylvania Sumerian Dictionary dà però umbara ‘aid, help; aiuto’, per quanto il campo semantico sia lo stesso. In ogni modo, è molto più congrua la base akk. ūmu ‘daytime’ + burûm ‘riparo, copertura, tetto’, dove il composto ūm-burûm in origine significò il ‘riparo dalla luce’.
Traggèra, traggèa, treggèa camp. ‘anici in camicia’ ossia minuscole palline zuccherate che imperlinano la superficie dei dolci. Cfr. it. antiq. treggea ‘idem’, ‘confettura’. La sopravvivenza di questa parola tirrenica è oltremodo indicativa, poiché ha la stessa formazione che ritroviamo in trággiu (vedi sotto): insomma, la traggèra fin dalle sue origini fu una leziosità, un impreziosimento visivo, e non poté mancare di essere abbinata all’idea della cortigianeria, del lusso di corte.
Trággiu (Bosa) ‘coro’. Soltanto a Bosa è così definito «il locale assetto di quattro voci maschili, dislocate secondo nomenclature analoghe a quelle delle altre tradizioni polivocali sarde: bassu, contra, tenore, contraltu»3. Su trággiu è insomma un quartetto, nel quale un tenore intona e canta con un certo ritmo ed una certa melodia, gli altri tre cantano le riprese e fanno l’accompagnamento.
Per Wagner trággiu, trazzu è la ‘foggia, moda di vestire’, secondo lui dal cat. trajo, sp. traje ‘vestito’; denominale attraggiare; log. aer bellu trággiu ‘attillarsi, avere buone maniere’. Quindi trággiu è il modo di ‘presentarsi’ cantando con buone ‘maniere’.
Trággiu-trajo-traje hanno un loro significato profondo, con base etimologica nell’akk. tīru(m) ‘un cortigiano’ + awûm ‘parlare’, ‘riflettere’ su qualcosa, ‘(parole) che sono in uso, che sono in alta considerazione, che sono studiate (per la loro preziosità)’. Abbiamo quindi uno stato-costrutto che produce il composto sardiano *t(i)r-awum > t(i)rággiu, significante ‘cortigiano che recita parole preziose’. In questo caso il riferimento è al tenore del quartetto di Bosa, ma s’estende agli altri significati di trággiu in quanto ‘stile personale dei poeti-cantori’ nelle sfide amebee. Questa etimologia crea un importantissimo squarcio di vita sociale e civile di 4-5000 anni addietro. Sappiamo quanto fosse ricca la letteratura semitica del secondo Millennio prima dell’Era volgare. Quella è la stessa letteratura che ha generato i poemi di Ugarit, i Salmi della Bibbia ed anche l’ineffabile poesia dei Vangeli. Sembra chiaro che a quei tempi un cantante capace di recitare e ritmare in melodia preziose parole poetiche veniva elevato ipso facto al rango di cortigiano (vedi l’esempio di Torquato Tasso, di Baldassar Castiglione, di Ludovico Ariosto, di Ovidio, di Virgilio e di tanti altri poeti del passato, elevati al rango di cortigiani per il talento poetico). È sbalorditivo che dopo 4000 anni il significato di certi termini non sia nient’affatto corrotto. Il log. aer bellu trággiu ‘attillarsi, avere buone maniere’ richiama proprio la figura del cortigiano, che delle buone maniere fece uno stile di vita.
Trettu log. e camp. ‘tratto, spazio, intervallo’; in cuḍḍu trettu (Laconi) ‘in quel luogo’; a trettu ‘a portata, vicino’; (Nuoro, Dorgali) ‘falciata, andana’. Cfr. cat. tret ‘distancia de lloc o de temps’. Manco a dirlo, Wagner lo accredita subliminalmente come vocabolo catalano («Il Salvioni… lo riconobbe come vocabolo catalano, ma opina che si è incontrato con l’ital. tratto, ciò che non è necessario»); e ciò gli basta non solo per omettere l’indagine etimologica, ma per additare l’opzione scartata (l’it. tratto) come ultimo (indiscutibile) approdo d’improbe fatiche culturali. Base etimologica di trettu è invero l’akk. ṭēru ‘terra, territorio’ + ettum, ittum ‘sign, signpost, road marker; indicazione, segnavia, miliario’. Il composto ṭēr-ettum significò in origine ‘tratto di territorio misurato’.
Turráu camp. ‘essere malato’; turráu in conca ‘malato di mente’. Base nel sum. tur ‘ essere malato’, ‘malattia’.
Vissentu Porru, che pubblicò il Dizionariu Sardu Italianu nel 1832, lo considerò tout court un termine catalano, un participio significante anzitutto ‘riarso, seccato, fatto adusto’; caffè turrau ‘caffè abbrostito, tostato’; méndula turrada ‘mandorle tostate’; pani turráu ‘pane arrostito, abbronzato’. Anche l’infinito turrái ebbe ovviamente la stessa origine catalana, lingua alla quale quasi tutto lo scibile sardo doveva origine e dignità, secondo loro. Erano tempi, quelli, in cui già si capiva, illuministicamente, che la lingua sarda doveva essere salvata in un Dizionario, epperò la convinzione “derivazionale”, “coloniale”, tra gli studiosi era monolitica: la matrice della lingua sarda, oltreché nel latino e nell’italiano, per gli studiosi stava esclusivamente nel catalano e nello spagnolo, ossia tra le lingue degli Stati che avevano colonizzato l’isola: la lingua sarda era insomma un’accozzaglia di vocaboli che forse, senza quegli apporti, non sarebbe esistita. Così la pensò pure Wagner, che precisò l’origine del termine sardo nel cat.-sp. turrar, torrar ‘torrefare, abbrustolire’. Anche su turróni ‘il torrone’ ebbe, beninteso, la stessa origine, e DELI viene pomposamente a ribadirlo, da turrar ‘torrefare’ (nonostante che la confezione del torrone stia agli antipodi della torrefazione). La pigrizia mentale fa tutt’uno con l’ignoranza, sua fedele ancella.
In realtà turráu nel senso di ‘malato’, turráu nel senso di ‘torrefatto’, e turròni ‘dolce di miele e mandorle’ hanno tre diverse origini. La prima è stata già vista. Il concetto della torrefazione, dell’abbrustolire, del riarso, bruciato, caldissimo, ha base nel sum. tur ‘ridursi, diventar piccolo’, akk. tūru(m) ‘ritirata, tornare indietro’, poiché l’effetto della temperatura caldissima è di seccare senza incendiare.
Circa il torrone, la semantica di questo friabile, croccante e squisito dolce di miele, mandorle (o noci) e albumi d’uovo va riferita esclusivamente al fatto che per la sua confezione occorre (occorreva) rimestare per almeno 4 ore il prodotto, riportandolo a una pasta dura e filante. Dall’interminabile rimescolare col bastone viene la sua semantica, dall’akk. turru ‘turned, rigirato’, tūru(m) ‘il rigirare’ + sum. unu ‘cibo, pasto’: il composto tūr-runu significò ‘cibo rigirato’.
Unità dei dialetti sardi col dialetto sassarese. La lingua sarda è complessa. Ma più complessa è la fatica di far ragionare su di essa gli specialisti. Ognuno ama rinserrarsi nel proprio particulare, vagheggia sui fumi di teorie mai discusse, accetta fideisticamente le datate “sentenze” dei dotti, e non s’accorge che la lingua sarda è veramente singolare. Purtroppo, è il percepire certi vocaboli come assolutamente peculiari alla propria zona di nascita a rendere partigiano il ricercatore sardo (ahimé, non soltanto lui!). Sì. Perché non è facile padroneggiare 100.000 vocaboli, e non è facile ammettere che tale massa va alleggerita scompartendola tra le varie subregioni. Il che non significa che ogni sub-regione debba curarsi soltanto dei propri vocaboli. Spessissimo molti vocaboli sardi sono identici tra le singole subregioni, ma si distinguono uno ad uno per peculiarità fonetiche. Va da sé che l’esorbitante numero di 100.000 si riduce d’un colpo se unifichiamo a grappolo tutte le voci sotto dei “capifila”, sotto lemmi capaci di raccostare e spiegare le diversità (come spesso faccio io in questo Dizionario, e come seppe fare magistralmente Wagner il quale, nonostante i tanti errori nel tentare di accorparli, riuscì a ricondurre i suoi 20.000 vocaboli entro 7000 lemmi).
La Sardegna ha un retaggio vetusto, parla la sua lingua da decine di millenni, e le sue radici lessicali s’intersecano tra zona e zona pervadendo tutte le aree linguistiche. Chi ignora l’esistenza di una vera e propria rete ignora la complessa unità della lingua sarda. Il concetto della rete è adeguato. E se la rete viene lacerata in un solo punto, ciò basta a far scappare i tonni. La rete è unica, la lingua è unica. Per capire la lingua occorre tenere integra la rete. Altrimenti sfugge un’intera fenomenologia.
La leggerezza culturale (direi la fanciullezza del neofita) che ha portato molti dotti a lacerare questa rete ha creato grossi danni, ivi compreso il danno sul dialetto sassarese. Da almeno 100 anni c’è la “conventiō ad excludendum” del dialetto sassarese, semplicemente perché nessuno degli esperti lo ha voluto studiare contestualmente a tutti gli altri dialetti sardi. Questa cappa di piombo pesa, beninteso, principalmente a causa della sorda opposizione del Wagner, il quale non ammise mai il dialetto sassarese nel novero delle parlate sarde. Ecco l’aristotelismo; ecco l’Ipse dixit! Ma pesò anche la ricerca di Antonio Sanna ai tempi del Wagner, intitolata “Il dialetto di Sassari”. Un ricerca che rinfrancò Wagner e lo stesso Sanna (ch’era nativo dell’Île de France logudorese: Bonorva).
Perché non dirlo?: quelli erano tempi da “Premio città di Ozieri”, i tempi della rivista “S’ischìglia” di Angelo Dettori, tempi in cui la cattedra di linguistica sarda era affidata a un logudorese, allorché le gare poetiche s’esprimevano spesso in logudorese e gli stessi premi di Ozieri toccavano a scrittori logudoresi. Non erano pochi i dotti che giuravano sulla sardità genuina del dialetto logudorese, mentre al campidanese toccava l’onta d’essersi macchiato con le lingue d’Oltre-Tirreno.
Ecco la pretesa purezza, l’ideologia che ha accecato coorti di studiosi, inducendoli a creare scale di valori, ad inventare lo spettro cromatico ai cui limiti la luce svanisce in frequenze non percepibili. Laddove pare che un dialetto sardo si squagli in altri universi linguistici, ecco gli studiosi a dichiararne la liminarità e per ciò stesso l’esclusione dai canoni portanti della sardità originaria. Nemmeno l’insularità della Sardegna è mai riuscita a fare accettare l’insularità della sua lingua, ed ancora oggi dei baldi scouts vanno alla scoperta dell’Arca, di un dialetto più originario del dialetto contiguo, che mai troveranno, almeno sinché i loro canoni ideologici inseguiranno un’idea sortita cervelloticamente, anziché parametrare materialmente una realtà che da decenni aspetta d’essere conosciuta.
In questa mia premessa metodologica ho abbondantemente mostrato (e dimostrerò ulteriormente) gli errori di metodo in cui tali studiosi sono incappati. Ammesso e non concesso che sia possibile parlare di una schiettezza sarda nel senso di una originalità genuina riferita a una precisa zona linguistica, andrebbe poi spiegato di che si tratti, e perché mai si voglia individuare quella zona. Sinora nessuno lo ha fatto, o per meglio dire: ci hanno tentato, senza riuscire. Ma è singolare che, sotto-traccia, il tarlo della schiettezza sarda, della individualità sarda, abbia lavorato e stia ancora lavorando, divorando i migliori cervelli delle nostre Università.
Sulla lingua sarda ognuno è andato liberamente per suo conto, come un “ragazzo sul delfino”, affrancato e sognante in una galoppante e selvaggia indisciplina che nemmeno Wagner ha saputo raffrenare, nonostante il suo ideologico scalimetro che dà la pagella del superiore e dell’inferiore, nonostante che Wagner abbia prodotto una Fonetica Storica del Sardo giudicata la “pietra di paragone” per qualsiasi studio linguistico.
Lo studio di Antonio Sanna non fu di per sé la “pietra dello scandalo”. Tale studio andava fatto, e ringrazio il Sanna per i suoi meriti. Ma al solito i danni sono creati dagli epigoni. Si accampa lo studio del Sanna come un Moloch abbagliante e totalitario, e lo si accetta come un “nec-plus-ultra”, Colonne d’Ercole invalicabili, termine degli spazi consentiti allo studio del dialetto sassarese. È nella contemplazione di quel Moloch che accettiamo (quasi come una tesi che ci affranca da ogni responsabilità) l’incatenazione del dialetto sassarese a quello gallurese → alla lingua còrsa → alla lingua italiana (al toscano, al genovese), creando la centrifuga che proietta Sassari oltre la stratosfera e lo fa atterrare in suolo lunare.
Ma Antonio Sanna voleva fare soltanto uno studio storico, dimostrando il peso dei còrso-galluresi nel ripopolare Sassari a seguito delle due Grandi Pesti. Siamo noi ad aver visto in lui le “Colonne d’Ercole” ed esserci sinora privati della possibilità di tesaurizzare positivamente lo sforzo del Sanna, nel più vasto ambito di una ricerca, sempre possibile, che conduca a capire esattamente il ruolo del dialetto sassarese nella storia linguistica della Sardegna.
È stato proprio lo studio analitico del D.E.S., da me condotto sino all’ultimo lemma, ad aver accertato che il dialetto sassarese condivide con i restanti dialetti sardi quasi il 90% dei vocaboli (salvo una parte della sua fonetica, la quale è condivisa però dall’Alto Logudoro, della cui arcaica sardità ho abbondantemente discusso nella mia Grammatica Storica, al cap. 3.1.10).
In questa Premessa manca lo spazio adeguato a discutere esaustivamente sulla sardità del dialetto di Sassari. Più spazio gli è riservato nel mio Dizionario Etimologico del Dialetto Sassarese, in via di completamento. Qui mi basta anticipare che il dialetto di Sassari condivide con Cagliari più vocaboli (e persino più fonetica) che con la restante Sardegna. Questa sentenza non va vista come némesis da me scatenata contro i detrattori dell’unità linguistica isolana; è però un aspetto che da solo è in grado di fare esplodere tutte le pregresse certezze. E qui chiudo, proponendo soltanto qualche lemma che dimostra l’unità dei Sardi.
Abbastu camp. ‘sufficienza’; di abbastu ‘a sufficienza’; sass. abbáłtu ‘idem’. Vedi sp. abasto, cat. abast; it. abbastanza, bastare ‘essere sufficiente’, che DELI ritiene di etimologia sconosciuta. Invero la base è l’akk. bâštu ‘dignità, sorgente d’orgoglio’; bašû ‘to become ripe, diventare maturo; be available, in safekeeping, essere disponibile; materializzare un profitto’.
Abbauca’, abbacca’ sass. ‘stordire, sbalordire, intontire’: è tuttu abbaucaḍḍu da li midizini ‘è intontito dalle medicine’. Per i tanti lemmi che ne sono coinvolti, rinvio la discussione al quart’ultimo paragrafo (“La dittatura dell’incompetenza”).
Abbundare, -ái log. e camp. ‘abbondare’; anche log. bundare: bundat sa vida in noa giuventura; sass. abbunda’. Wagner considera abbundáre e abbundíri (vedi) come italianismo o spagnolismo, evidentemente collegati al lat. abundantia ‘straripamento, flusso eccessivo’, abundo ‘straripare, traboccare, sovrabbondare’. Vi sono due opzioni: la prima delle quali porta al lat. ab-unda, richiamante il concetto dell’onda che straripa (ab- + unda); la seconda opzione è il sum. bun ‘spingere’ + du ‘to heap up, pile up, accumulare’, onde bun-du col significato sintetico di ‘ammassare’: ciò andrebbe bene al sardo bundáre.
Abbundíri camp. ‘cibo che aumenta di volume in cottura’; log. bundìre. Per l’etimo vai ad abbundáre.
Accabussái, cabussái camp. ‘tuffare, tuffarsi’; cfr. cat. accabussar ‘id.’. Il significato iniziale fu ‘entrare di testa come punta di freccia’, da sd. cabu ‘testa’, sass. ‘idem’. (v. lat. caput ‘id.’). L’origine dei lemmi sardo e latino è l’akk. kāpu, kappu, kāpum ‘roccia, riva, cliff, embankment (of river, of mountain)’. Il secondo membro del lemma cab-utza’ ha base nell’akk. ūṣum, uṣsu ‘punta di freccia’.
Accattái(sì) camp. ‘accorgersi’. Cfr. sass. agattassi ‘idem’. Base etimologica è l’akk. qatû ‘be completed, be achieved, essere completato, essere acquisito’. Vedi log. agattáre, sass. agatta’ ‘trovare’.
Acciappinái camp., ciappináre log. Per l’etimo vai a sass. ciappínu.
Ciappínu sass. ‘incompetente, schiappa, poco capace’; sass. acciaputza’, log. acciaputzáre, inciaputzáre, camp. acciaputzái ‘acciarpare, abborracciare’. Base etimologica di questi lemmi mediterranei è l’akk. ḫapû, ḫepû ‘to break’ (vessel etc.), ‘to ruin destroy’ (city, land, people), ‘to crack, crush, injure’ (part of body).
Accióu camp. ‘chiodo’, sass. ciódu.
Aggaffare log.; aggatta’ sass.; -ái camp. ‘afferrare, acchiappare’; cfr. cat. agafar ‘coger, asir, apañar’, anche accaffiáre log., accaffái, aganfái camp. Base etimologica è l’akk. kappum ‘mano’.
Aláscia camp. ‘mobile’. Wagner lo deriva dallo sp. ant. alhaja ‘mueble, utensilio’. In log. aláscios ‘attrezzi, suppellettili, strumenti di lavoro’. Ma occorre confrontare questi lemmi col log. e camp. calásciu ‘cassetto’ (di un canterano, di un contenitore di biancheria), che è il prototipo, almeno per la Sardegna. A quanto pare, siamo dinanzi a varie forme lessicali con vari esiti fonetici e varie semantiche; ciò reca ragioni valide per vedere i vari lemmi come crescite autonome, ognuna nel proprio territorio, nell’ambito della lingua sarda. In ogni modo la base etimologica di log. calásciu, sass. carásciu è il sum. ḫal ‘basket, pot’, kallu ‘bowl’ + aš ‘bread’; quindi il composto ḫal-aš in origine significò ‘cesta del pane’.
Alloriái camp. ‘turbare l’altrui mente con grida o atti che intronano il cervello in modo che si perde il sentimento e il discorso’. Per Wagner è una formazione espressiva (sic), al pari di log. alloroscáre ‘abbaiare rabbiosamente; gridare con ira’ (vedi).
Ma il termine non è espressivo, è invece la base genetica del log. allorigáre, in formazioni del tipo mi fazzi vinì la lòriga sass. ‘mi sta logorando i nervi’, arrigga’ a la lòriga ‘ridurre all’estremo della sopportazione’.
Lòriga nel senso di ‘estremo della sopportazione’ ha base etimologica diversa dall’altra lòriga (anello); i due lemmi si sono assimilati per paronomasia soltanto nel medioevo. Per capire lòriga ‘estremo della sopportazione’ occorre porre mente allo stato fisico prodotto negli astanti da una persona assillante, o lamentosa, o pedantissima, che siamo costretti a sopportare a lungo. Il nostro eccesso di tolleranza nei suoi confronti viene – per ragioni di educazione – somatizzato, ma opera lo svuotamento delle energie positive; ci si sente infine compressi, o emunti, privi di forze, incapaci di sentire le vibrazioni positive della nostra anima, la quale a questo punto è spenta, violata. Questo è il momento della fuga, o della rimozione della persona che produce tanta negatività; ma può essere il momento di un’esplosione di rabbia e di urla (o di violenza) contro il pedante. Mi fazzi vinì la lòriga ‘mi porta all’estremo della sopportazione’ sembra avere base etimologica nel sum. lu ‘to stir up, risvegliare, fomentare, provocare’ + ri ‘to cry, cry out, wail, complain; urlare, gemere, lamentarsi’. Il composto lu-ri (di cui il log. lóriga è aggettivo in -ca) in origine significò ‘provocare gemiti, urla’.
Ammaccionaisì camp. ‘rannicchiarsi, ripiegarsi su se stesso, seduto o coricato’. Secondo Spano anche ammasonaisì. Wagner non riesce a quagliare l’etimo. Questo è un verbo legato all’estasi, alle sensazioni estreme in fase oracolare’, da akk. maḫum ‘to rave, delirare; dipartirsi (da se stesso)’; maḫḫû ‘esaltato’, da cui sd. maccu ‘matto, scemo, pazzo’.
Aúndi camp. merid. ‘dove’. Il prototipo è il sass. undì (vedi). Wagner osserva: «nel gall. e nel sass. abbiamo úndi (sic, al posto di undì) ‘dove’; ma questo úndi non può essere identico al camp. aúndi, già per la discontinuità geografica (sic!). Esso invece si continua nel còrso, specm. còrso mer., onde (cfr. soprattutto Lichtenhahn, l.c., p. 79, seg.). A torto, sedotta dalla fallace omonimia delle forme gall. e camp. mer., l’Autrice le considera come geneticamente identiche». Il lettore scoprirà in questo pezzo del Wagner un autentico pasticcio, dove emergono due situazioni false. La prima (undì ≠ úndi) è stata qui svelata. La seconda falsità è da lui stesso evidenziata nel considerare il dialetto sassarese una bastardaggine italianeggiante, anziché uno dei tanti dialetti sardi, il cui fondo arcaico ancora oggi mostra migliaia di identità con la parlata cagliaritana.
Guruséle nome della celebre fonte di Sassari, oggi detta Rosello o Ruseḍḍu. Un tempo stava fuori delle mura cittadine, alla base della parete calcarea alta 25 metri. Guru- ha i confronti etimologici con l’ebr. יְרוּ* (*iěru) ‘insediamento’ < sum. iri ‘città’. -Sèle = Šalimu (dio semitico della salute) < akk. šâlu ‘rallegrarsi, godere di qualcosa’, ‘star bene’, salāmu ‘essere in pace’ (ebr. šālom ‘pace, salve!, arabo salām ‘pace’). Cfr. Bruncu Salámu (un monte di Dolianova, dove sgorgano acque ritenute curative); e vedi il monte Guruséle, il più alto dei Supramonte di Baunei, dove si diparte il primo ruscelletto che va a formare il fiume sacro chiamato Ilune. Cfr. comunque l’akk. šalû ‘sommerso’ (> “battesimi”), salā’u ‘spruzzare’ acqua’ (nei rituali di purificazione).
Guru-séle > Ru-séllu = Jerušalaim significò ‘città di Šalam’. La Sardegna è intrisa di nomi che ritroviamo anche nella civiltà ebraica.
Ille, illu, illa ecc. esisteva come pronome indipendente dopo preposizione in sardo antico (CSP 203: Et ego tenninde corona cun ille; 227: Et ego kertainde cun ille; 45: et kertai cun illu; 33: ca non bi abean bias in illos; CSNT 133: sos ci certaban cun illu. Le forme atone sono (i)lu, (i)la ecc. e per il dativo (i)li, (i)lis (CSP 29: et issos derunilos appare, e ccoiuuainusilos; 3: Judicarunili ad issos a destimonius; 31: naraitili iudike; CSNT 49, 50: aprezarunmilas; 74: indulserunmilu; 171: issos kertarunlis, ecc.). Frequentemente occorrono forme in funzione enclitica (CSP 98: et giraitsemi supra’lla; 33: sinde kertat alikis pro ‘llos; CSNT 145: certabat pro’lla; CSMB 149: kertait cu ‘llu; 168: et ego binki de’ llu, ecc.). Nel camp. ant. abbiamo le stesse forme (CV XI, 2: illi illas firmu ego; III, 1; IV, 1 ecc.: ki mi ‘llu castigit; VI, 4: ca ‘lla dau, ecc.); in sede postverbale pare si preferisca ell- (VIII, 4; XVI, 4: dedi ellu; XIX, 3: dau ella, ecc.).
Nel sardo moderno queste forme toniche si usano molto poco cedendo il posto a isse, issu; come forme atone abbiamo in camp. ḍḍu, ḍḍa, ḍḍus, ḍḍas, ḍḍi, ḍḍis; in log. lu, la, los, las, li, lis (queste ultime anche nei condaghes).
Tra le forme logudoresi qua citate, va notato che lu log. e sass. è anche art. det. = ‘il’. Attualmente, il sum. lu in quanto articolo determinativo mediterraneo, sopravvive proprio nel dialetto sassarese-gallurese: es. lu cani, lu pani, la prància ‘il cane, il pane, il ferro da stiro’. Sopravvive anche nell’Italia del sud: es. lu pisci-spada ‘il pesce-spada’. Altri esempi sardi del sum. lu si trovano attualmente nei suffissi cristallizzati dei cognomi sardi in -lu, nei quali confluisce pure il pronome dimostrativo sum. ul. Cfr. il cgn Buttόlu composto dal sum. bu ‘perfetto’ + tu ‘formula magica’ + lu ‘persona’, ‘colui che, colei che’: bu-tu-lu, col significato originario di ‘chi è addetto alle formule magiche’. Da tutto quanto si è detto, si capisce che le forme sd. ille, illu, illa hanno subìto l’influsso del lat. ille, illa, che si è sovrapposto alle forme sumeriche in lu originariamente usate in tutta la Sardegna.
Spaperrottái, spapparottái camp. ‘fueḍḍai meda e sentza neçessidadi’ (Porru), ‘ciarlare, cianciare’. Casu registra ispabarrottare ‘gridare, vociare’. E già l’apporto del Casu dimostra l’unità lessicale tra Cagliari e Alto Logudoro. Wagner le considera voci onomatopeiche, non aiutando così a legare i fili. In realtà, la base etimologica di spapperrottái è la stessa che vale per i ‘rondoni’ (chiamati a Sassari babbarrotti), dal sum. par ‘canale’ (raddoppiato in senso superlativo) + ud ‘bird’: quindi pa-par-rud significò, già 40.000 anni fa, ‘uccello dei canali’ (infatti questo animale si nutre esclusivamente d’insetti, di zanzare, e per questo frequenta i siti umidi dove gl’insetti abbondano). Questo traslato riferito a chi ciarla continuamente è dovuto al fatto che le rondini, i rondoni, quando cacciano a stormo strillano senza sosta, volando a bocca aperta e creando un chiasso festoso. Con ciò ho dimostrato un triangolo lessicale inossidabile tra Cagliari, Sassari, Alto Logudoro.
Tukké sass. ‘sorta di benda che fascia o abbellisce il capo delle donne’. Base etimologica è il sum. tuku ‘acquisto, tessuto, stoffa’. Si capisce che il tukké un tempo fu un oggetto di cosmesi, per i momenti della festa. Vedi anche sum. tuku ‘to acquire, acquistare’ (nei tempi arcaici le cose acquistate costituivano dei veri e propri beni di un qualche pregio); anche tuku ‘to beat, strike of cloth, to weave’ (e qui siamo nel campo semantico della fabbricazione delle stoffe).
Wagner preferisce registrare in altro modo: a dukè ‘a punta, dicesi del modo come le donne si abbigliano il velo in testa’ (Spano). Egli non scrive altro, suggerendo ex silentio che dukè sia un modo, non una cosa, e lasciando subliminalmente intendere che la forma sassarese sia un accatto francesizzante, ignorando del tutto la sua origine arcaica, sardiana.
Forte parentela tra logudorese e campidanese. Oltre ai brevi accenni del paragrafo testè concluso, sono i pochi esempi seguenti a mostrare, a maggior ragione, la strettissima affinità del dialetto logudorese col dialetto campidanese, la quale si esprime in decine di migliaia di voci.
Abbojare, abbojare (Mores) ‘incontrare’. Lungi dall’etimo di attoppare (vedi), questa voce ha base etimologica nel sum. bu’i ‘to face, incontrarsi, mettersi a confronto’.
Abbóju log. e camp. ‘appuntamento’. Per l’etimo vai ad abbojare.
Abborréssere log., abborréssiri camp. ‘aborrire, avere in odio’; sass. abburrissi’ ‘svergognarsi, coprirsi di vergogna, screditarsi’. Per l’etimo vai ad abburrésciu.
Abburrésciu camp. ‘ubriaco fradicio’; burràcciu ‘ubriacone’, burraccera ‘ubriachezza’. Wagner lo fa derivare dallo sp. borracho ‘ubriaco’. Invero i lemmi sardo e spagnolo sono forme metatetiche dall’akk. buḫḫuru ‘cuocere, riscaldare’, ‘tener caldo’; buḫru ‘stato di cottura’. Non a caso in Sardegna cottura equivale semanticamente a sbornia. A dire il vero, le semantiche convergono dall’origine, poiché anche il log. cóttu ‘ubriaco’ ha origini accadiche, da akk. quttû ‘completato’ (ossia riempito, messo KO dal vino). Sembra di capire che mentre la forma abburrésciu ha attecchito soltanto nel sud dell’isola, cóttu ha attecchito nel nord. Abburrésciu s’incrocia, pure semanticamente, col log. sett. abburrare, abburrigare(si) ‘immergersi nel fango o nell’acqua’, ‘infangarsi’, che Wagner ritiene dallo sp. barro ‘fango’: ed è possibile. Ma intanto c’è il confronto con l’akk. barruru ‘con occhi luccicanti’ con riferimento anche alla persona ubriaca. In ogni modo la vera base etimologica è l’akk. burrû ‘prostituto, prostituto sacro’ (tutto un programma).
Alleputzíu, alleputzáu camp. ‘ben vestito’, ma anche ‘ringalluzzito’, ‘allegro’; forse i tre campi semantici in origine furono idealmente più contigui, poiché nei tempi arcaici il ben vestire era tipico delle grandi feste, quindi dell’allegria. La base semantica si riferisce al composto akk. allu ‘puro, chiaro’ + pūṣu ‘bianchezza, candore’: stato costrutto alli-pūṣu, col significato di ‘candore immacolato’. Da respingere la proposta del Wagner di ricondurre queste voci a lèppore ‘lepre’.
Questo part. pass. ha il referente in alleputzare log., alleputzái camp. ‘attillarsi, vestirsi elegantemente, vestirsi con cura, abbigliarsi’.
Attobiái camp. ‘incontrare’. La base etimologica è diversa da quella di attoppare (vedi): attobiái contiene una labializzazione intervenuta per legge fonetica campidanese sul sum. tul ‘well, pozzo’. Nelle età primitive il pozzo era l’unico punto d’incontro certo e diuturno della comunità. Cfr. log. attόliu ‘convegno, appuntamento’; attoliare ‘chiamare, unirsi’ (Fonni): Spano.
La lingua arcaica fu compresa spesso sino al Rinascimento. Può sembrare una boutade, ma sono astretto ad ammettere che la lingua arcaica in Sardegna fu compresa sino a tempi recenti. Con essa, cinque secoli fa, si confezionarono ancora parole nella consapevolezza che si stavano utilizzando radicali primitivi, ancora compresi nella loro essenza e come tali ritenuti portatori di significato, capaci di entrare a buon diritto nella costruzione delle frasi. Anche qui gli esempi possono abbondare, ma limito l’intervento a pochi lemmi.
Allóḍḍu2 nome tabuistico della ‘volpe’. Base etimologica può essere il sum. ala ‘demon’, o alad ‘spirito’ + ud ‘storm demon’; in ogni modo, quel modo d’intendere la volpe transitò anche nell’akk. allû ‘that (one)’ + ūdu ‘distress, affliction’: all-ūdu significò ‘quello dei malanni’, quello che porta malattie, sventure’, etc. Chiaramente, il nome fu satanizzato in epoca bizantina, e questa è una delle tante prove che almeno nell’alto Medioevo in Sardegna si parlava ancora semitico, con una vasta base di vocaboli sumerici.
Cozzorottu (Orgòsolo) ‘tutolo, pannocchia del granturco’. La base etimologica è nel bab. kuṣṣuru(m) ‘zeppo di nodi’.
Mammòne (gatto). Come si è visto ai lemmi gattu e catzu, la figura del gatto subì un radicale capovolgimento tra l’epoca antica ed il Medioevo cristiano. Il gatto per gli Egizi era un dio (in virtù del fatto che liberava i granai dai topi e le piantagioni dai ratti). Nel Medioevo divenne, per influsso dei preti cristiani, una creatura posseduta da Satana. Sacchi pieni di gatti vivi venivano buttati nel fuoco per festeggiare il solstizio d’estate, pratica che continuò in Francia sino al secolo dei Lumi. Il Gatto Mammone, clericale invenzione del Medievo, è un gatto dalle fattezze infernali, terrificanti. Non poteva essere altrimenti, considerata l’esigenza di capovolgere la splendida visione che del gatto avevano gli antichi. La base etimologica è il sum. ma ‘to burn’ + munu ‘scorching, rovente’: mam-munu ‘che brucia al calor bianco’ (un essere demoniaco, insomma). Si noti che questo è uno dei tanti lemmi creati esplicitamente in epoca medievale, in epoca bizantina, ed è testimone del fatto che ancora nei primi secoli cristiani in Sardegna si parlava semitico.
Mangrofa è il cognome di Maria Mangròfa, moglie di Antòni Cracassòni, il favoloso costruttore dei nurághes nominato in tante storielle facete del Nuorese. Mentre lui era un gigante buono, Mangròfa non era gigantessa ma orca, e si cibava di carne umana (Francesco Enna, SS, 98). La sua fine violenta ha varie tradizioni, compresa quella che fu bruciata dai genitori dei ragazzi che divorava. Scrive Dolores Turchi4 che la sua dimora fosse una grotta presso la chiesa di santa Lucia a Oroséi, ma la sua personalità è raccontata in modo diverso secondo i paesi o l’informatore: quindi può essere pure sacerdotessa-maga.
L’etimologia, sempre che il nome attuale non si discosti in modo significativo da quello antico (a noi ignoto), porta alla agglutinazione sum. ma-ḫurum-bu, col tempo aggiustato in maḫ(u)rumbu e metatesizzato in manḫrubu > mangrofa: da ma ‘bruciare, arrostire’ + ḫurum ‘bimbo’ + bu ‘cavità’ = ‘(colei che) ‘arrostisce i bimbi nella grotta’. Si noti che questo è uno dei tanti lemmi creati esplicitamente in epoca medievale, in epoca bizantina, ed è testimone del fatto che ancora nei primi secoli cristiani in Sardegna si parlava semitico.
Mardi. Nel meridione s’intende con mardi la femmina del porco, il cui etimo è universalmente proposto dal lat. mater. Ma è molto strano che un animale così vilipeso in tutta la storia della letteratura abbia tale etimo. Quando non si è trovato di peggio, al momento della gravidanza il suo ventre è stato adattato pure al concetto dell’esecrando cavallo che sconfisse la civiltà dei Troiani: e la scrofa diviene troia, appunto. In realtà mardi, col significato attuale, è nato in epoca bizantina, quando il clero cristiano si dedicava con pertinacia ad estirpare l’antica religione. E così l’akk. wardu (leggi mardu) ‘ministro addetto al culto della divinità’ è diventato nientemeno che una ‘troia’.
Mincidissu camp. ‘demonio’. Questo lemma ha parecchie variabili: log. mintsídiu ‘provocazione, alterco, macchinazione’, mintsidiáre ‘provocare, attaccar brighe, seminar zizzanie’; camp. mincídiu ‘bugia’, mincidiόsu ‘bugiardo’, smincìri ‘sbugiardare’.
Secondo Wagner queste forme hanno base nel’it. omicidio, passato attraverso forme di antico sassarese (Stat.Sass. III, 33 (92 r): tu de menthis). Ma la proposta del Wagner non ha nessun puntello, essendoci una fortissima differenza semantica tra la supposta base ed i supposti derivati. Le forme qui trattate hanno invece la base in una incredibile metamorfosi semantica voluta dai preti bizantini nel primo Medioevo, allorché la polemica antiebraica, per iniziativa dei Padri della Chiesa e dei primi concilii, era divenuta parossistica. La forma di partenza è proprio il sardo minca, mìncia ‘membro virile’ (vedi), che si compose con la forma akk. deššû ‘eccessivamente opulento, dotato’, dīšu ‘sviluppo (del virgulto, della verga)’, dešû(m) ‘essere copiosamente dotato’, dēšû(m) ‘abbondante, fiorente’.
Ai preti cristiani della Sardegna non bastò quindi dissacrare la Minchà (lett. ‘offerta’: la preghiera ebraica del pomeriggio, che s’apre col Salmo 84 e prosegue con un lungo passo tratto dai Numeri 28, 1-8 che parla dei sacrifici quotidiani), facendone addirittura un cazzo; non bastò: si volle identificare la Minchà pure col Diavolo, e con blasfema doppiezza (riferita a un tempo al cazzo ed al Diavolo) si volle presentare la minchà come l’Essere infernale “molto grosso”, “fiorente”, “eretto” (dešû, dīšu) proprio come un cazzo.
Monteleone Rocca Dòria. È l’altura che un tempo fu la più munita della Sardegna. Lassù la Potenza divina discendeva al naturale, senza l’ausilio del genius loci. Lassù c’era la sede naturale del Dio-Toro, del Dio-Fecondatore, ossia ci risiedeva la Potenza che generava il Mondo. Quella rocca ebbe poi il nome dai Dòria che se n’erano impadroniti. Ma in origine fu Monte Leone (e conservava pure l’alternante epiteto di Perda e Tòri, preferita dal Fara). La confusione è evidente.
Cominciamo da Tori, ancora conservato in numerosi cognomi, quale Turi, Toro, Tore, Torre, Dettori. Il Taurum ‘Toro’ per i primitivi Romani era l’emblema dei ‘giuramenti d’amore’. Ma noi sappiamo che il nostro Tori deriva dal sum. tūr, akk. tūru ‘rifugio, protezione’. Quindi Perda e Tori = ‘Rupe della Protezione (divina)’. Quanto a Monte Leone, abbiamo la base akk. līʼum ‘toro’. E così torniamo al Toro, ch’era l’effige vivente del Dio della Natura, il Fecondatore sacro. Tra Leone e Toro, una delle due parole è paradossale. È chiaro che quel “leone” in Sardegna non ha nulla a che fare: i Sardi nei tempi primitivi non conoscevano i leoni. Monte Leone si riferiva certamente a un Toro, al Toro Protettivo (che veniva nominato līʼum in accadico e tūr in sumerico). Da qui il doppio nome Monte Leòne nonché Perda de Tori.
Moriscu (figu moriscu) ‘ficodindia’. In Sardegna c’è un concorrere di linguisti, a loro volta influenzati dai botanici, che sostengono l’origine del termine dalla Spagna, dove l’Opuntia ficus-indica è chiamata higuera de moro (cat. figuera de moro): Wagner DES 128.
Si sostiene che gli Spagnoli chiamarono in tal modo il fico d’India “perché importato dagli Arabi”. Ma tale diceria osta clamorosamente col fatto che gli Spagnoli sono gli scopritori dell’America, gli stessi importatori dell’Opuntia ficus-indica, ch’era espansa in tutta l’America centrale con focus negli altipiani messicani. Come mai avrebbero dovuto chiamarla “fico degli Arabi”, “fico dei Mori”?
Quello della higuera de moro è il più grossolano equivoco della storia della linguistica. Certamente è da pensare che questo fu uno dei primi frutti gustati dagli equipaggi, visto che la scoperta dell’America avvenne il 12 ottobre, quando ai Tropici il fico d’India contiene il massimo della polposità e, specialmente nei luoghi d’origine, si presenta nel massimo vigore.
Va fatta attenzione alla differenza tra higuera de moro / figuera de moro e il sardo figu morìsca. Per quale ragione i Sardi, che a quei tempi erano una colonia catalano-aragonese, avrebbero dovuto tradurre diversamente dai loro dominatori, inserendo quello strano suffisso -ìsca, e per giunta credendo che il prodotto provenisse… dagli Arabi?
Ecco come la paronomasia (o l’equivoco che dir si voglia) ha agito indisturbata sino ad oggi.
È a questo punto che occorre mettere in ballo gli equipaggi di Colombo, gente avvezza all’uso della propria lingua mediterranea. Essi sono la chiave di volta che fa capire l’equivoco. Ma da soli non basterebbero, se non entrassimo nell’ordine d’idee che gli stessi Sardi, e gli Spagnoli, specialmente i Catalani, avevano lingue col sottofondo semitico. In realtà moriscu è aggettivo sardo, che non significa ‘moresco’ ma ha base nell’akk. mūru(m) ‘giovane animale; giovane toro’ + išku ‘testicolo’, col significato di ‘testicolo di torello’. Fu la forma del frutto a colpire i Sardi. A sua volta, higuera de moro significò, per gli Aragonesi, ‘fico del torello’ (sempre riferito ai testicoli).
Perdigònes, -is log. e camp. m. pl. ‘pallini da caccia’ = sp. perdigones ‘granos de plomo para la escopeta’. Ovviamente il prototipo è sd. perda ‘pietra’ (< akk. paṭāru ‘tagliare, fare a pezzi’, ebr. pāṭar ‘to split’, akk. piṭru ‘pezzo’) + akk. gunnu ‘mass, bulk; massa, volume’. Quindi perdi-gònes è uno stato costrutto, col classico -ī- intermedio, e significò in origine ‘massa di pietruzze’. Chiaramente, la voce composta è riferita ai primi archibugi di fine ‘400, allorché s’inserivano delle pietruzze (graniglia marina o fluviale), mancando spesso la disponibilità dei pallini di piombo. Ciò che stupisce in questa etimologia è che persino agli albori del Rinascimento il popolo riusciva a formare in lingua accadica parole nominanti tecnologia avanzata.
Sirimágus. Il Monte Sirimágus fu ritenuto l’abitazione del Diavolo. Vietato portarci le greggi, andare a far legna, avviare coltivazioni. Sta al centro di un triangolo tabuico nell’area collinare tra Carbònia, Tratalìas e Perdáxius. Soltanto le pendici del Monte fanno eccezione, grazie alle sorgenti. L’area è meglio nota come Sa skìna de s’Ifférru ‘la schiena dell’Inferno’. Si dice però (ecco il fatto illuminante) che fino a circa 400 anni fa il Monte fosse meta di pellegrinaggi cristiani: ai canonici che ci avevano eretto una chiesa si portavano cibi e doni. Qualcosa andò storto, e la zona divenne off-limits. Sino a poco tempo fa, le vecchie dicevano che chi si avventurava rischiava di venire schiacciato da massi rotolanti.
La memoria della gestione pretesca delle processioni riguarda, a quanto pare, la volontà della Chiesa cattolica di controllare certe processioni paganeggianti. Che poi tale controllo sia cessato con l’avanzare dell’Inquisizione e della Controriforma, fu soltanto perché si preferì rendere maledetto il sito. Queste notizie, estrapolate da pag. 39 de L’Unione Sarda del 16 luglio 2006 (articolo di Andrea Scano), aprono uno squarcio sui processi di dominio della Chiesa, operati sino ad epoche recenti, considerate le varie tendenze paganeggianti ancora presenti nelle tradizioni popolari.
Il mistero di quelle processioni pagane e della loro logica intrinseca può essere chiarito soltanto con l’indagine etimologica, mediante la quale si capisce che Sirimágus è un composto sardiano con base nell’akk. ṣīru(m) ‘esaltato, supremo, splendido’ di un dìo + maḫû(m) ‘delirare, diventare frenetici’. Si capisce allora che il Dìo venerato sul Monte era il dio della Natura, destinatario delle processioni bacchiche e orgiastiche mirate alla rigenerazione.
Sixiliánu camp.; gigiliánu (Perdas); xixiniáu (Mogoro); sitziliánu (Villacidro) ‘granturco’. Qualcuno lo riferisce al ‘(grano) di Sicilia’. Ma viene ostico tentare di giustificare tali passaggi commerciali per un grano proveniente dalle Indie. Siamo dinanzi a una paronomasia.
Anche qui, come per cíxiri ‘cece’ (vedi), il primo concetto fu quello di ‘grano tondeggiante’ (rispetto alla forma del grano mediterraneo). Ma pare che abbia influito anche il sum. ḫili ‘luxuriant, lussureggiante’, opportunamente raddoppiato (ḫil-hili-ánu) per riferirsi alla grande produttività di una pannocchia rispetto alla spiga del grano.
Il nome di questo moderno tipo di grano è una delle tante prove del fatto che ancora nell’arco del XVII secolo il popolo sardo utilizzava con naturalezza le radici della propria Urspache, che ancora comprendeva appieno quale eredità di un arcaico passato in cui la parola era analizzata a tutto tondo, nella sua forma e nel suo significato. Vedi anche l’altra forma trigu muriscu.
Wagner evita di produrre etimologie. Con riguardo al paragrafo precedente, sento che qualche linguista insorgerà invocando prudenza e ponderatezza. Queste virtù sarebbero i metri di un meritorio atteggiamento obiettivo, se fossero espresse da uno che le esercita nell’affrontare i problemi più scottanti. Ma, diciamolo serenamente, sono virtù spesso conclamate, che suonano sarcastiche quando s’invocano da chi sinora ha fatto esercizio d’immobilità senza dare alla linguistica sarda contributi solidi.
Non disconosco a certi filologi romanzi il prezioso impegno da loro profuso nella studio della lingua sarda, ed è proprio perché sono pronto a riconoscere apertamente i loro meriti che chiedo il corrispettivo del perdono quando la mia franchezza rischia di ferirli. Mi manca l’intenzione. Ferire non è mai stata la mia vocazione, anzi preferirei che le mie constatazioni fossero sempre accettate per amichevoli e concilianti, quando non soffuse d’entusiasmo. Infatti a me interessa unire, non profligare. Ma quà entra in campo la serietà scientifica, una severa maestra di disciplina che non posso celare dietro il velo della timidezza o dell’ipocrisia, a meno che non voglia dichiarare falsa la mia metodologia.
Occorre rivelare un fatto sconcertante, che è persino difficile da fare accettare, ed è che Wagner ha sempre evitato d’impegnarsi nelle etimologie. Parimenti accade a molti linguisti che avrebbero dovuto esserne gli eredi. Detta così, anche quest’affermazione sembra una clamorosa boutade espressa per suscitare nuovo sconcerto e discordie. Ma io, essendo uno studioso della lingua sarda, mi sento fortemente coinvolto nella ricerca della verità, e pertanto sono obbligato a proporre un metodo che rimetta saldamente in piedi ogni tipo di studio sulla lingua. Il DES, capolavoro riconosciuto del genio wagneriano, non individua nemmeno una etimologia. Ho cominciato a spiegarlo nei paragrafi precedenti, sto per spiegarlo in questo paragrafo, proseguirò in quelli seguenti. Se il lettore leggerà coscenziosamente, capirà la verità della mia proposizione. Vediamo all’uopo (tra le migliaia) qualche lemma trattato dal Wagner.
Gammurra camp. antiq. ‘specie di panno: gamurra’ (Porru) = it. antiq. gam(m)urra ‘veste antica di donna, gonnella’. Base etimologica è l’akk. ḫammû (a garment, un vestito) + ūru ‘city’ < sum. Il composto ḫamm-ūru significò ‘vestito da città’ (ossia vestito di buona fattura). Wagner (cfr. voce nel DES) non ha prodotto alcun etimo.
Gana log. e camp. ‘voglia, desiderio, appetito’ = sp. gana; mala gana ‘svogliatezza’. Base etimologica è il sum. gana ‘shackles, ceppi, impedimenti’. Evidentemente il concetto di ‘voglia’ si è evoluto da un significato arcaico che privilegiava l’atto del trattenere, inceppare. Questo vocabolo è un chiaro testimonio di come le idee abbiano acquisito il senso astratto partendo da un fatto concreto. Wagner propone surrettiziamente l’origine spagnola del vocabolo sardo ma non produce alcun etimo, dispensandoci dall’esigenza d’indagare almeno il vocabolo spagnolo. Invero, gana è voce mediterranea.
Grori, groli (Bitti) ‘avannotto di trota’. Base etimologica è il sum. giru ‘fish, pesce’ (da cui it. gir-ino ‘piccolo pesce’) + uri ‘fish, pesce’. Il composto pleonastico (duplicazione semantica) gir-uri in origine ebbe significato moltiplicativo, e nel contempo diminutivo. Wagner considera il vocabolo “probm. preromano”: un’ipotesi gettata così, con nonchalance, tanto per chiudere il discorso senza indagine.
A sa muda log. ‘zitto, in silenzio’; sd. mudu ‘muto’; cfr. lat. mūtus ‘che non ha le capacità fisiche di parlare’. La voce latina fu usata dapprima per gli animali (mutae pecudes), interpretate dal DELI nel senso che «non sanno fare altro che mu». Interpretazione assurda, ovviamente, poiché il mu è solamente tipico del bove. A nessuno venne in mente che anche i saggi preferiscono star zitti. Infatti il sd. istare assa muda significò sin dalle origini ‘stare come il saggio’, da akk. mūdu ‘saggio, sapiente, esperto’.
Pèsame, -i log. e camp.; pèsamu log. ‘condoglianza’; donai su pèsame camp. ‘condolersi’ = sp. pésame, dar el pésame. Cfr. sic. pèsami, pèsamu ‘idem’ (Traina); nap. ant. pésame ‘idem’. Base etimologica è il sum. peš ‘to disappear, scomparire’ + ama’era ‘mourner, parente del defunto’ (composto da ama ‘mother’ + er ‘mourning, essere in lutto’). Wagner tace, soddisfatto nella convinzione che il vocabolo sardo derivi dalla Spagna. Ma il vocabolo è mediterraneo.
Tricca (Nuoro, Fonni); triga (Norbello, Aritzo); trija log. ‘pergola e uva galletta’ (Stat. Sass. I, 128 (42v): pastinare tricla et simiçante uva); trigarzu, trijarzu ‘pergolato’. Base etimologica è l’akk. tīru (a covering) + suffisso mediterraneo -ca. Wagner sull’etimo tace.
Gli equivoci e le paronomasie. O tace, o cade nell’equivoco. Ed anche quando s’accorge dell’equivoco, Wagner purtroppo non lo risolve scientificamente (rinvio, come esempio, alla voce kenábura, già trattata).
Le lingue sono zeppe di equivoci, e la Sardegna non è immune. Essi sortiscono spesso nell’intimo di una singola lingua (o dialetto), ed ovviamente tendono a moltiplicarsi nel confronto tra lingue o dialetti. Così avviene in Sardegna, dove il sintagma camp. Toccamì ainnantis ‘cammina davanti a me’, in log. può essere inteso come ‘tòccami davanti, nelle parti anteriori del corpo’.
In Italia ha preso vigore da molto tempo il sintagma “fare repulisti” nel senso di ‘fare pulizia’ (reale o morale). Evidentemente l’espressione fu inventata da qualche giullare o studente medievale ed il volgo, ignorando il latino, non poteva sapere che quel buontempone aveva stravolto semanticamente il perfetto lat. repulisti ‘respingesti’ (vedi il salmo 44 (43),10: Nunc autem reppulisti et confudisti nos ‘ma ora ci hai respinti e coperti di vergogna’).
Wagner nelle sue opere non trascurò di annotare qualche equivoco, ad esempio citò l’uso del vocabolo centro-merid. suppa ‘niente’: Kirco e non b’agatto suppa; Non ni budìa fai suppa. Egli, più divertito che scientificamente coinvolto, nel DES riproduce la seguente situazione: «rientra nell’inventario dell’italiano maccheronico la frase, riferita al figlio: Non ne posso fare zuppa: è morto bicchierino = ‘non posso cavarne nulla: è molto birichino’». Wagner non s’accorse che quella frase maccheronica sguazzava nella paronomasia. Egli dichiarò ignoto l’etimo del sd. suppa, mentr’esso ha base nell’ass. ṣuppu ‘decorato, rivestito, ricoperto, placcato’, šūpû ‘rendere splendente, visibile’, col significato riferito semanticamente al risultato dell’abbellimento di un corpo bruto, una trasformazione da oreficeria, una decorazione che migliora fortemente lo stato grezzo.
La paronomasia è una legge linguistica, come tale subita passivamente dal parlante; salvo nei casi di umorismo, dove un comico produce la risata attivando l’opposizione dei significati tramite lo slittamento, il doppio senso, la polisemia, l’equivoco tra due identiche formule fonetiche (v. cap. 1.3 della mia Grammatica Storica).
La paronomasia (quindi la conseguente paretimologia) scaturisce ad esempio dal log. janna a bòi ‘porta con i battenti accostati per bloccare e filtrare la luce’, intesa dal Wagner come ‘porta a bue’, mentre la base etimologica è l’akk. apu ‘foro, apertura’; abû, apû ‘velato’ < abû, apû ‘diventare velato, nuvoloso’.
Altro esempio di paronomasia è il camp. arròsa ‘morbillo’, che i ricercatori derivano dal nome di fiore rosa, mentre la base è l’akk. rūšum ‘rossore’.
Altro esempio sono le locuzioni andare esse per essi ‘andare girovagando senza meta’; a pili esse ‘coi capelli scomposti’; craba corressa ‘capra con le corna reciprocamente sghembe’; asse’ tuttu a esse ‘essere smidollato, sbilanciato, sciancato’ (Sassari); barrócciu a esse ‘carro sgangherato’ (Sassari); occi a esse ‘con gli occhi storti’ (Sassari). Wagner, incappando nella paronomasia, ritiene che essi, esse sia un termine video-fono-semantico, dalla lettera S. Invece la base è l’akk. ešeum, ešû(m), ašu, išû ‘confuso, aggrovigliato, arruffato’ di filo, capelli, barba, mente, occhi.
Nella paronomasia s’incappa spesso indagando i toponimi, è ovvio. Ad esempio Pedru surdu, interpretato come ‘Pietro il sordo’, è il nome di un’alta sella rocciosa e selvaggia, improduttiva, vicina alla vetta del Gennargentu, sepolta per quattro mesi dalla neve, dove i pastori s’astennero dal salire, lasciandola alla vocazione selvaggia, a dimora dei mufloni e delle aquile, che sono i veri signori della montagna. Il nome ha base nell’akk. pitru(m) ‘territorio selvaggio’ + surdû ‘falco’ = ‘selvaggio sito di falchi’.
Purtroppo debbo constatare che ai filologi non è bastato impaniarsi nella paronomasia; alcuni sono andati oltre, giungendo a distruggere qualche parola sarda. Lo scempio è stato persino facile, quando il filologo era un ignaro straniero; ma l’effetto non è stato diverso quando alla distruzione hanno contribuito dei filologi sardi. La filologia esercitata sulla lingua parlata non s’addice a dei lavoratori-a-tavolino, a gente che non ha mai vissuto col popolo, nei villaggi, e non ha mai ascoltato l’intenso palpito del linguaggio. Lo scempio è avvenuto come in una commedia degli equivoci, illuminata da un “ipse dixit”, da un moloch di provenienza oltremarina, dinanzi al quale non solo il popolo ma persino i “dotti” paesani, i “dotti” cittadini, per quanto indigeni, hanno flesso la schiena in nome dell’autorità. E così nei dizionari sardi non si trova tadannu! ma ita-dannu!, interpretato ‘quale danno!’. Io, che sono glottologo, che vivo nel popolo e col popolo campidanese da 54 anni, non ho mai sentito ita-dannu ma soltanto tadannu! Quei linguisti, quei dotti, non avrebbero mai osato violentare la lingua sarda, se avessero saputo che l’invocazione di paura Tadannu! non è altro che l’invocazione akk. dandannu ‘Dio Onnipotente!’.
Nello scempio delle parole sarde ritrovo anche l’eponimo Sardus Pater. In questo caso la responsabilità maggiore va agli archeologi. Per la verità Giovanni Ugas (Shardana e Sardegna) ha cominciato a raddrizzare la questione, parlando autorevolmente di un dio eponimo. Però dico che non gli sarebbe stato eccessivo andare oltre invocando una sensata etimologia a supporto di questa intuizione. La dedica Sardus Pater Babay fu gestita dai Romani senza sapere ch’era sumerica. L’architetto di Antas non riusciva a comprendere il significato sardiano, che oggi può tornare finalmente in auge partendo dal sardiano Babay, che ancora nel sd. attuale si pronuncia babbáy, babbu ‘babbo, padre, Padreterno’, con tutte le conseguenze del caso. Va osservato che Babay o Baba fu una grande divinità femminile sumerica, da babaya ‘old man’ (il vocabolo era originariamente maschile, e tale rimase in Sardegna; soltanto dopo, e soltanto in Mesopotamia, esso fu proposto al femminile per la trasposizione al femminile del culto di Baba). E così in suolo sardo ancora una volta sveliamo le radici arcaiche della lingua sumerica. In Sardegna in origine questi vocaboli dovevano essere composti nella sequenza Šar Dū Padr Babay, col significato di ‘Terribile Signore Creatore dell’Universo’ (Šar ‘totalità, mondo’ + dū ‘Creatore’ + Padr ‘distruttore’ + Babay ‘Signore, Kýrios’).
Lo stesso epiteto, evidentemente corrotto dall’intervento del clero bizantino, ritroviamo nel Monte Santu Padre, una montagna visibile da mezza isola, il cui nome desta immediato sospetto perché in Sardegna dovrebbe dirsi Monte Babbu Santu (padre non esiste). L’epiteto è una paronomasia: in origine doveva essere Monte Sardu Padr. La dedica corrotta del tempio di Antas, il nome corrotto di questa montagna, sono prove concorrenti a dimostrare che Sardu è l’arcaico Dio eponimo dei Sardi. Insomma, questa figura sacra era lo Jupiter sardo.
Ma torniamo a suppa, che fece ridere Wagner. Non so s’egli abbia riso anche nel voler tradurre pilu e titta ‘mastite’ come ‘pelo nella mammella’. Non c’è nessuno che abbia inteso diversamente questo malanno, nemmeno il medico che affrontò scientificamente questo sintagma, S.A. Zonchello (v. Bibliografia). Nessuno potè accorgersi che la base stava nell’akk. pīlu, pēlu ‘calcare, pietra calcarea, blocco di calcare’ + ‘nutrimento, cibo’ (tîtum): pertanto pilu e titta, da almeno 5000 anni, significa ‘pietra della mammella’.
Adesso ci tocca sostare su log. pazza, ‘idea presumida ki unu tenet de iss’etotu, comente canḍo si daet bàntidos kentza méritu’ (Puddu); palla camp.; páglia sass. Questo vocabolo è stato compreso da Wagner come ‘bugia’, ma non è così. Esso si applica ai presuntuosi che si esibiscono, si sovraespongono, fanno spacconate, millantano: pazzósu, pallósu, paggiósu, palléri. Sarebbe una contraddictio in terminis assumere a base di questa voce proprio la paglia, una sostanza umilissima. Va da sé che ci troviamo dinanzi a una paronomasia, e di palla, pazza si sono ignorate le origini. Base etimologica è il sum. pala ‘a royal garment, un vestito da re’. La plurimillenaria parola rimane quindi viva per indicare chi vuole assumere vesti regali anche quando è un pollo da batteria. In collegamento c’è il log. ispazzare ‘millantarsi’; cfr. nap. paliúsǝ ‘vanitoso’; pagghiuse ‘fanfarone, millantatore’. È fuorviante che Wagner inglobi in questo lemma l’it. battere la paglia ‘vagare col discorso’, ted. leeres Stroh dreschen ‘batter la paglia senza ricavo, fare discorsi a vanvera’. Infatti il sintagma del Wagner è autodimostrativo: nel senso che non si ricava nulla dal battere la paglia, come non si ricava nulla dal battere l’acqua: sono follie di gente che ignora il valore del tempo e fa perdere tempo agli altri. Dobbiamo ammettere che i campi semantici del vanitoso e di colui che fa discorsi a vanvera sono radicalmente diversi.
Penultima voce da me proposta è pittiracca log. sett. ‘viottolo incastrato, incassato, ossia scavato nella roccia o nelle alluvioni’. Secondo Wagner, la voce «si spiegherebbe bene come pettúri + acca ‘petto di vacca’ (indicando un viottolo talmente stretto che ci passa solo il petto di una vacca)». Ma questa è una puerile contraddizione, non tiene conto che lo scavo delle strade (tali erano i viottoli nell’antichità) richiedeva grande impiego di braccia e perenne manutenzione; quindi nessuno si sarebbe sognato di realizzare vie così anguste e inutili. I viottoli furono sempre realizzati a misura del carro tirato da 2 buoi, larghi almeno 3-4 metri. Invero, la base etimologica è l’akk. petû(m) ‘aprire + raqqum ‘thin, fine; sottile’. Il composto significò ‘scavo angusto’, ma ciò non giustifica l’interpretazione del Wagner in relazione ai viottoli (evidentemente la definizione nacque per altri scopi). Tantomeno aiuta quando l’insigne studioso intende rafforzare la sua interpretazione con la locuzione sa janna est a unu bòe ‘la porta ha i battenti socchiusi’ (dov’egli intende bòe come bue, annotando che janna a bòi «si dice di una porta socchiusa, che lascia passare un solo bue» (sic!). Egli non si è reso conto che un solo bue nelle porte contadine non riusciva nemmeno a infilarsi, o le infilava danneggiandole, anche se spalancate. La base del sintagma a bòi è stata già spiegata.
Valverde. Ecco una delle più assurde paronomasie della Sardegna, talmente espansa e corruttiva, da avere infestato pressoché l’isola intera. È doloroso che nessun filologo se ne sia accorto. Cominciamo dalla dorgalese (Nostra Sennora de) Balu Irde o Palu Irde. Quel Valverde, tipico delle più antiche chiese campestri dove si adora una Madonna cristiana sconosciuta fuori dell’isola, non è altro che la paronomasia di Ba‛al Irdu (akk. Bēlu Irdu, Bēlu Išdu), epiteto sacro col significato di ‘Signore Base-del-Cielo’, ‘Ba‛al Base-del-Cielo’. Ba‛al è attestato in Sardegna e in tutto il Vicino Oriente: in arabo, ugaritico, fenicio, punico, aramaico, nabateo, palmireno, amorrita, babilonese, accadico. In ug. fa bʽl ‘signore, proprietario’, amorr. baʽlum, bab. ba’lu ‘grande, maggiore’, akk. bēlu ‘signore, proprietario’, e così via.
Questo dio, particolarmente onorato in Cartagine dal V sec. a.e.v. assieme alla compagna Tanit, fu onorato in Sardegna allo stesso modo. Onde il suo nome è sotteso a tutti i toponimi o nomi sacri echeggiati in Sardegna col nome Palu o simili. Furono talmente importanti le onoranze a Ba‛al, che la Sardegna ha lasciato in suo onore persino dei cognomi: anzitutto Palùma, Palùmu, Palomba (quest’ultimo storpiato e indirizzato alla semantica di ‘colomba’). La loro base etimologica è l’akk. palûm ‘bastone, phallos, palo sacro’ (riferito a Ba‛al “Fecondatore”) + ūmu ‘giorno’, significando ‘Giorno del Palo’, ‘Festa del Palo’. Ricordo ad es. Su Palu di Santu Lussùrzu, celebrato al colmo del Carnevale. Vedi anche i cognomi Pala, Palitta, Paliotta (gli ultimi due significano ‘Seguace di Ba‛al’), Palimoḍḍe (epiteto = ‘Saggezza di Ba‛al’). Vedi inoltre i vari toponimi rimasti in Sardegna: Balláo, Paláu, Baláy, Punta Palái, etc.
Onomatopee. Spero si sia capito che in questo lavoro non ho avuto mai intenzione di sminuire il prestigio universale che Wagner si è meritato nell’indagare con dedizione ineguagliata la lingua sarda. Prima di lui nessuno lo aveva fatto, mentre agli studiosi posteriori non venne alcun uzzolo di cimentarsi perché ai loro occhi il monumento eretto da Wagner era compiuto e perfetto, e sembrò sciocco smantellarlo per ricostruirlo su altre basi. Anche da me la statua del Wagner fu sempre considerata come perfetta. Ciò per 31 anni dopo la mia laurea in glottologia. Mi si perdonerà se da soli 15 anni sto tentando di delineare una nuova via d’interpretazione della linguistica sarda. Dal mio punto di vista, lungi dal voler dissacrare il pater noster, ogni mia osservazione rivolta al pater non è altro che un fraterno memento rivolto ad filios. Sono i ricercatori posteriori, quelli già morti e quelli viventi, a non aver capito che i tempi stavano maturando verso orizzonti più scientifici. Quanto ai ricercatori ancora viventi, vorrei comunicargli che il più grande omaggio che possiamo fare al grande Wagner è di rimetterci a studiarlo con la prospettiva di rinnovare almeno l’intonaco della sua grandiosa piramide.
Se è vero – come sto dimostrando per tutta questa premessa metodologica – che a Wagner difettava il metodo e, come corollario, ch’egli non trovò mai il modo di approfondire le etimologie, allora corre l’obbligo di perseverare nella dimostrazione affinché i posteri capiscano. In questo paragrafo mi soffermo sull’onomatopea, da Wagner pretesa per almeno il 20% dei suoi lemmi. Con tutta evidenza, egli propose un numero altissimo di onomatopee tanto per chiudere la discussione, trovandosi nell’impossibilità di proporre l’alternativa di un etimo credibile. Vediamo gli esempi.
Per Wagner è onomatopea il log. e camp. racca ‘rantolo del moribondo’, mentre la base etimologica è il sum. raḫ ‘disease’, ‘to beat, kill; battere, uccidere’. Altra pretesa onomatopea è tzoccare ‘battere’; tzoccu ‘scoppio’. Noto intanto l’affinità fono-semantica con l’it. ‘toccare (delle campane etc.)’. Su tzoccu o toccu (cfr. it. tocco) indica una gamma di suoni od azioni: il tocco della campana, il tocco o tatto. Base etimologica il sum. tuku ‘to beat, battere, dare un colpo’.
Affine a tzoccare è tzaccare, tzaccái log. e camp. ‘fendere, spaccare, scoppiare, crepitare, crepare’ e per estensione ‘screpolare’ e simili; tzaccadùra ‘fessura, scoppio, crepitio’ ma anche ‘ragade della cute o dei capezzoli’. Wagner, seguito dai ricercatori seriori (Zonchello e altri) ritiene che la voce sia rigorosamente onomatopeica. Invece ha base nell’ass.-bab. ṭaḫadu(m) ‘fiorire, sbocciare, divenir lussureggiante’, anche ‘scoppio, esplosione, rottura’; ‘spaccare, cedere’ (riferito specialmente al foruncolo)’.
La quintessenza della (falsa) onomatopea, contaminata dalla pregiudiziale latina, si percepisce nel sd. páperos (donnos páperos). Nel medioevo sono i ‘vassalli’ del giudice o i ‘membri della famiglia reale’ (e genericamente il ‘patrimonio della corona’). Una sola volta nei codici si legge pauperos, ed ecco affiorare la precoce confusione che già ne stava tarlando la semantica. Tale confusione entrò anche in un documento cagliaritano del 1119 (CDS I, p. 198b), che in latino scrive: servos de pauperum. Questa parola s’incontra solo in documenti del sec. XI o dei primi del XII (Bonazzi, ed. CSP, p. 156). I donnos paperos ricordati dal CSP 34 sono precisamente i monaci di S. Pietro (pag. 58 dell’estratto). Ma ecco il tarlo del diavolo!: Wagner non capì che in tutta questa situazione si era insinuata la confusione, ed imprudentemente scrisse una ovvietà, ossia che la voce pauperes indica in numerosi documenti i poveri ed i degenti (CDS, p. 226b, anno 1164): ad sustentationem pauperum; ibd p. 244a (sec. XII): sa eclethia paupera; p. 251a, 252b (anno 1182): ab alimentis istorum pauperum (Solmi, Cost., p. 47, n. 4).
Però Wagner percepiva che qualcosa non combaciava, quindi il termine páperu applicato ai ricchi del Giudicato continuò a sembrargli strano. A noi sembra persino più strano che un linguista della sua levatura si lasciasse intrappolare da una banalissima somiglianza di vocaboli: le somiglianze fonetiche sono normali in qualsiasi vocabolario. Egli non si scosse nemmeno al sapere dai giuristi delle materie medievali che a quei tempi tre classi sociali si contrapponevano ai ricchi (ai majorales): i servos, i liberos, i pauperos (ma non i paperos!). Egli si chiedeva disperato «In séguito a quali circostanze i liberos si identificarono con i pauperos?». Lo stesso equivoco-confusione persiste ancora oggi tra gli aggettivali pauperile e paberile (quest’ultimo interpretato oramai (e ci mancava!… dopo il tarlo del diavolo!) come “terreno proprio dei pauperes, da loro posseduto a titolo collettivo”: «Erano precisamente i terreni che si chiamavano anche terras de páperos» (Wagner). Assurdo. Queste confusioni inqualificabili gravano sugli studiosi contemporanei come un macigno, e nessuno si scuote nel constatare che in sardo moderno l’aggettivale paborile, paberile significa semplicemente ‘pascolo, maggese’, e che soltanto qualcuno (es. Guarnerio, Solmi) lo identifica col lat. pabŭlum (sbagliando però anch’essi).
Invero, su paberìle era la terra coltivabile di un villaggio: era il vidatzone messo a riposo annuale o biennale (maggese), e diventata prato domestico (che è diverso dal pardo naturale) a disposizione, in comunione gratuita, degli abitanti ad uso pascolivo. Si trattava di campi non riseminati, dove si poteva pasturare il bestiame controllato da speciali incaricati (i maiores de pradu o pradàrgios). Questi diritti reali pubblici assunti per consuetudine si chiamarono, in epoca iberica del Regno di Sardegna, ademprìvi, e furono aboliti in epoca sabauda con la legge sulle chiudende.
Quando si dice incantesimo… Tornando al pl. páperos, Wagner s’impuntò a tal punto sulla identità di sd. páperu con lat. pauper ‘povero’, che chiuse tre lunghissime pagine di disamina del problema con una dichiarazione ultra-salomonica, giungendo a squartare con una sciabolata il bimbo che Salomone aveva solo minacciato: «Come già fu detto, l’accezione giuridica di páperu si è perduta, ma nel senso ordinario di ‘povero’ la voce vive tuttora nel camp. rustico come pábaru, páburu. È diventata ormai rara, ma l’abbiamo notata a Cabras; e cinquant’anni fa, l’abbiamo sentita giornalmente da un povero cieco, nativo del Campidano di Oristano, il quale, sulle Scalette di Santa Chiara a Cagliari, mi soleva chiedere l’elemosina con la sua cantilena monotona, ma molto chiara: Po s’amòri de Déusu, sa garidari po unu báburu tsurpu». Questo è il livello infimo al quale non avremmo mai voluto che Wagner scendesse.
Al fine di rompere l’incantesimo di tale immarcescibile equivoco-confusione, dichiaro che l’aggettivale paberìle, poborìle, paborìle ha base etimologica nel sum. pa ‘fronda’ + be ‘tagliare’ + ri ‘camminare lungo (pascolare)’ + li ‘fronda, germoglio’: pa-be-ri-li. Il significato originario fu ‘pascolo per brucare i germogli’. Tutto qui. Gli armenti del villaggio avevano un anno di tempo per brucare i germogli di quei terreni, sortiti dai semi delle coltivazioni dell’anno precedente (grano, ortaggi). Quello del paberìli era dunque un pascolo speciale, molto diverso da quello del saltu, sartu (vedi), quest’ultimo composto di flora selvatica meno appetita dalle pecore: infatti a su sartu si mandavano soltanto capre, maiali, bovini, che si consolavano con le frasche della macchia e con le fronde degli alberi.
Quanto all’etimologia di (donnos) páperos, essa si basa sul sum. pap ‘primo e più importante’, ‘preminente’ + era ‘leader (dell’assemblea)’: pap-era. Il significato è ovvio: gli antichi “nobili” erano chiamati páperos né più né meno come i pennuti che avanzano sicuri, dondolanti, pettoruti e schiamazzanti. Anche Wagner l’avrebbe capito, se non si fosse incagliato sulla pregiudiziale latina. Mentre DELI e la stessa Treccani considerano papero, papera di origini onomatopeiche (sic!).
Voci imitative, formazioni scherzose. Indubbiamente, Wagner appare poco credibile nell’aver disseminato il suo DES d’inesistenti “onomatopee”, anche quando, cambiando il vocabolo, decise di nominare le presunte onomatopee come “voci imitative”, oppure come “formazioni scherzose”, o “formazioni infantili”. Si segua il grande groviglio di lemmi accorpati dal Wagner sotto il seguente vocabolo.
Accuccaresì log. accuccaisì camp., accuccassi sass. ‘accoccolarsi, accovacciarsi’; ‘appiattarsi, nascondersi’. Secondo Wagner queste sono voci fonosimboliche, e porta l’esempio dell’it. accoccolare, sic. ncuculari, sp. acucularse, astur. encucase. Wagner reca molti altri esempi, tentando una catalogazione che però diviene un guazzabuglio, dov’egli propende per considerare tutta la folla di questi lemmi sardo-italo-iberici come onomatopee (DES 49-50). Mi rincresce constatare che Wagner, qua e là, dà poca importanza alla legge della polisemia. Ora ne avremo un saggio.
Considerando il significato di accuccaresì come ‘appiattarsi, nascondersi’, la base etimologica è il sum. kukku ‘buio, tenebre’, ciò che consente l’azione della civetta (Athena noctua), in sd. detta cuccu, che s’aquatta nel buio e poi aggredisce repentinamente; vedi akk. ḫua ‘civetta’, da cui sd. a cùa ‘al modo della civetta, nascostamente’.
Considerando invece il significato di accuccaresì come ‘accoccolarsi, accovacciarsi’ (detto anche dei cani che si rannicchiano ai piedi del padrone o che si sottomettono al cane più forte), entra in campo l’akk. akû ‘weak, powerless, humble; debole, senza potere, umile’, ripetuta per potenziarla (akû-aku-), e si riferisce ai gesti rituali che gli antichi accattoni, o prigionieri, o bisognosi, facevano in atto di sottomissione chiedendo protezione.
Questo discorso relativo all’it. accoccolarsi è talmente serio e imponente, che corre l’obbligo di soffermarsi a dipanare il grande groviglio culturale creato dal suo uso. Infatti ci sono varie parole con fonetica simile che han fatto delirare (letteralmente: uscir dal solco) il fior fiore degli etimologisti.
E allora comincio dall’it. còccola, il ‘frutto del ginepro’. DELI ne registra la prima apparizione nel sec. XIV: la voce avrebbe l’etimo nel lat. cŏccu(m) ‘nocciolo dei frutti’. Ma ciò è assurdo, ed è in compagnia con altri etimi assurdi apparecchiati per gli altri lemmi affini, quali coccolàre, cocco (uovo di gallina), còccolo (bambino paffuto, bambino prediletto), il cognome sardo Coccolòne, e così via. In questo guazzabuglio occorre mettere ordine, poiché ogni termine ha una precisa e distinta etimologia, radicalmente diversa da quelle proposte.
Iniziando da còccola, il lemma non ha affatto l’etimo su citato, anche perché la còccola non è un nòcciolo, ossia non ha un guscio duro come quello della noce, ma è uno dei tanti frutti morbidi. Questo frutto viene usato moltissimo dagli uccellatori in Sardegna (si può immaginare che nei tempi andati fosse d’uso comune nel Mediterraneo) per attirare e catturare al laccio gli uccelli da passo. Còccola ha base etimologica nel sum. ḫu ‘bird’ + kul ‘meal’, col significato di ‘cibo degli uccelli’.
Analizziamo adesso l’it. coccolare ‘vezzeggiare’, ritenuto dal DELI voce infantile da confrontare con cocco ‘uovo di gallina’, considerato onomatopea da confrontare con coccodè (sic!). A fronte dell’inadeguatezza delle etimologie proposte, preciso che coccolare si basa sull’akk. kukku(m) ‘(un genere di) dolce’ + ul ‘frutto’, col significato di ‘frutto-dolce’, ovvero ul ‘qualsiasi cosa’, col significato di ‘qualcosa di dolce’; ma può andar bene anche ul ‘gonfiarsi, ingrossarsi’ (riferito in questo caso ai bimbi paffuti), col significato originario di còccolo come ‘dolce polposo’.
Cocco in quanto ‘uovo di gallina’ è considerato onomatopea, imitazione del coccodè emesso dalla gallina quando sta per espellere l’uovo (sic). Ma un suono con la sequela di fonemi c-o, c-o, d-e non viene mai emesso dalla gallina, e nemmeno viene emesso il più semplice c-o, c-o, trattandosi invece di un rumore indistinto emesso dalla strozza a causa dei dolori dello sfintere. L’uovo fu chiamato cocco dall’akk. kukku(m) ‘dolce’, poiché di esso la gente è sempre stata ghiotta; e coccodè (che indica propriamente la ‘gallina’, anziché il suo verso) non è termine onomatopeico, non corrisponde ad alcun rumore, ma è l’esito dell’akk. kukku + sum. de ‘versare, emettere’, come dire, ‘emettitrice di dolci’. Ma tanto per attenerci unicamente alla lingua sumerica, possiamo proporre per la ‘gallina’ anche la seguente etimologia: kuĝ ‘scala a pioli’ + deg ‘radunarsi su’ (kuĝ-deg > kug[u]-deg > kugudè), col significato di ‘(colei che) si raduna sulla scala a pioli’: è infatti nota la tendenza della gallina a dormire di preferenza sulle scale a pioli, in difetto a dormire sugli alberi, che raggiunge svolazzando goffamente: tutto ciò per sfuggire alle volpi.
Quanto al cognome sardo Coccolòne, Coccollòne, preciso intanto che non è italiano, come vorrebbe Pittau DCS 223, poiché non è recepito dal De Felice; circa l’etimologia, essa non si basa sul fatto che il coccolone “ama farsi coccolare” (Pittau), ma si basa integralmente sull’accadico, essendo un raddoppiamento fonetico di ḫullu(m) ‘collana (in quanto ornamento)’, quindi ḫu-ḫullu + suffisso sardiano -ne (ḫu-ḫullu-ne), col significato di ‘(colui, colei che) si impreziosisce con le collane’: riferito a chi si agghinda per le feste, o riferito alle prostitute sacre ed ai prostituti sacri.
Di seguito propongo altre etimologie relative a voci che escono dal groviglio appena discusso.
Pimpirínu nelle frasi a pimpirínu (Fonni); assu pimpiríu (Milis); appimpirinare, -ádu log. sett. (Casu); a pirpirínu o a pirpirináos (Nuoro); apirpirináu (Dorgali): apprippieḍḍádu (Desulo); istare appispirináu (Orani); istare assa pispirináta (Siniscola); a pispirinádu (Macomer); a culispíspiri (Bitti); a culispíspidi (Nule); appippirináu (Norbello); a pippiniáu (Mogoro); a bibbirínos, a bibbirináu (Baunei, Busachi, Tonara, Belvì, Laconi); abribiḍḍáu (Tortolì); istáe a sa rbibiḍḍincáda (Villagrande); a culimpípiri log. gen.; a curimpíparu sass. ‘accoccolarsi, accolato alla beduina’. Per Wagner queste sono formazioni infantili e scherzose. Ma egli non può sentirsi autorizzato a classificare a modo proprio tutto ciò che non comprende! Invero, la base etimologica è il bab. parû ‘to excrete, defecare, cagare’. Da cui si evince che in Sardegna il prototipo fu la forma sassarese, ovviamente reduplicata per esigenze icastiche con le formalità dello stato costrutto (dove la -a- intermedia diviene -ī-), onde culu in pī-paru ‘culo nella posa di defecare’.
Altro esempio: straùllu ‘grido, urlo emesso per spaventare, chiasso sconvolgente’, deverbale di straullái ‘strillare, urlare, far chiasso’, che deriverebbe dal corrispondente it. strillare. Gli etimologisti non hanno ancora trovato accordo sull’etimo dell’it. strillare, e comunque è azzardato accostargli il sd. straùllu. Per Wagner quella sarda è “voce imitativa”, ma non spiega che cosa ci sia di “imitativo” tra il vocabolo e la voce scomposta di chi urla (la quale, fonicamente, è nient’altro che un iii!!!, aaa!!!). Invero, la base etimologica di straùllu è il sum. tar ‘to cut down, abbattere, tagliare’ + uli ‘lamentation’. Il composto tar-uli, reso icastico dall’accrescitivo s- e sottoposto a metatesi (s-tra-uli), in origine indicò un lamento straziante (lacerante, dirompente)’.
Zariθθu, giaríθθu «si chiama nella Barbagia una specie di ritornello bizzarro che accompagna la chiusura di certe canzoni e che difatti rassomiglia al nitrito del cavallo» (così Wagner). Ma si osservi il collaterale verbo zarridare (Nuoro, Orgosolo, Mamoiada, Orani); giarraspidare (Oliena); garrizzare (Gavoi) ‘nitrire’. Base etimologica è il sum. zara ‘concern, preoccupazione’. Ma può essere anche il sum. zaraḫ ‘wailing, lamentation’. A proposito del ‘ritornello’ su citato, G.M. Cabras (Vocaboláriu baroniésu p. 400) scrive a un dipresso le stesse cose del Wagner, attingendo da lui a piene mani acriticamente. È invece sensato credere al linguista baroniese Andrea Deplano – il cui metodo non ha mende – quando afferma che a lui in Baronia non sono noti i vocaboli zarridare e zariθθu; e tantomeno gli sarebbero noti coi significati addotti dal Wagner.
Omofonie. Le false “onomatopee”, le false “voci imitative”, i falsi “fonosimbolismi”, riguardano complessivamente il 30% dei lemmi studiati dal Wagner. Sono una percentuale eclatante a dimostrazione della sua assenza di metodo. Un altro 30% riguarda più propriamente le omofonie (e siamo così al 60% dei lemmi: una enormità). Pretendere di risolvere le questioni etimologiche soltanto in forza dell’omofonia tra due elementi, senza alcun rispetto per gli aspetti storico-semantici, pone l’etimologista al difuori del metodo scientifico. Non si riuscirà mai a risolvere le etimologie, senza un approccio che proietti la parola sullo sfondo socio-culturale dei tempi primitivi. Purtroppo è solita del Wagner la pratica di accorpare le parole aventi fonetiche identiche o simili entro un solo campo semantico, senza tener conto della legge della polisemia e quindi senza prendersi la briga d’isolare ogni vocabolo per tentare di rinverdirne l’originaria indipendenza fono-semantica. In tal modo sfugge al Wagner la possibilità di far pulizia entro i propri sistemi logici, e gli sfugge anche l’esigenza prìncipe di non confondere e fuorviare il lettore. Nel paragrafo precedente abbiamo testè discusso di accuccaresì, sotto la cui voce Wagner ha preteso di accorpare, per semplice omofonia, concetti enormemente diversi. Passo ad altri esempi, che ho contenuto nel numero, nonostante ce ne siano migliaia.
Allughinzare log. ‘sporcare, annerire’; alluxingiái ‘sgualcire, sporcare i vestiti’; lughinzósu log., luxingiósu camp. ‘sporco, lurido, sudicio’. Wagner pretende come base lukinzu, lughinzu, luxίngiu ‘lucignolo’ (omofonia), ed è assurdo, poiché la base delle sue tre voci è lughe, lùere (vedi). Egli non è in grado di osservare che la vera base etimologica di allughinzare è il sum. luḫum ‘charcoal, carbone’.
Astra ‘ghiaccio’. Il gelo, il ghiaccio è un elemento che i pastori sardi hanno sempre temuto. Le transumanze esistettero fin da Età paleolitica proprio per evitare le morie del bestiame. I Sardi inventarono ben otto parole per indicare il gelo, il ghiaccio (altre cinque seguono qui appresso). Ma astra in origine indicava l’idea del tremare. Infatti la base etimologica è il sum. ašru ‘che fa rabbrividire dal freddo’, una metonimia per ‘frost, gelo’. Va da sé che gli altri vocaboli sardi àstragu, àstrau, astròre, astraòre, indicanti il ‘ghiaccio’, sono aggettivali di astra. Che poi i filologi romanzi propongano l’origine del sardo astra dal lat. astra ‘stelle’ (che invece hanno etimo nettamente distinto, come vedremo), la dice lunga su chi si fida soltanto dell’omofonia.
Attoccare log. ‘abbaiare, latrare; urlare come i cani’; attoccu, attόkkida ‘abbaio, canizza’; dare s’attoccu ‘emettere un grido a intervalli’. Base etimologica è l’akk. tukkum ‘alarm, warning’. Va da sé che va respinto l’assurdo invito del Wagner di vedere in questo verbo una variante fono-semantica di toccare ‘toccare’ in tutte le accezioni italiane.
Tzóu log.; accióu camp., ciódu sass. e gall. ‘chiodo per ferrare i cavalli’, ‘chiodo per le ruote piene’, ‘chiodo per le scarpe’. A Nuoro si dice cravu < lat. clāvus ‘chiodo’. Wagner crede tzóu accatto italianistico da chiodo, ma sbaglia, poiché ambedue sono voci tirreniche aventi base nel sum. zu ‘tooth, dente’. Si può notare che la voce logudorese è assai più vicina al sumerico che non la voce italica, quindi sembra il prototipo delle voci che poi si sparsero nel Tirreno.
Dissíbulu (Osilo) ‘diavoletto, ragazzo irrequieto, discolo’. Base etimologica è l’akk. dešû ‘to sprout, flourish, let prosper, be copiously supplied; germogliare, essere fiorente, far prosperare, essere copiosamente dotato’ + būlum ‘animals, livestock; bestiame di proprietà’. Dal composto si nota che le qualità positive elencate riguardavano il bestiame di proprietà, e costituivano l’orgoglio del proprietario. Va da sé che l’uso sopravvissuto ad Osilo riguardò nel passato i bambini assai vivaci (quanto a intelligenza, agilità, forza) e poi dilatò verso ulteriori specificazioni. Quindi è da rifiutare la pretesa del Wagner di ricondurre la voce osilese a discípulu ‘discepolo’ (di Cristo).
Fraitzínu (tussi) o tussi molentìna ‘tosse asinina’. Puddu ricorda che per fraίtzu e l’agg. fraitzίnu si è conservato il significato di ‘furbesco, astuto’. Wagner traduce la voce come ‘traditore, imbroglione, fuoriuscito, bandito, ladro’, e ritiene che il campo semantico sia prodotto, nientemeno, dall’it. fra’ ‘frate’, col significato quindi di ‘frataccio’. Ma questa interpretazione è miope. In realtà la base etimologica è l’akk. parriṣu ‘criminale’, da cui metatesi prai-, frai-. Vedi in ogni modo il lemma faurratzίnu, per capire la deriva paronomastica cui può portare un termine oramai incompreso.
Frazare log., frazza’ sass., fragia’ gall. ‘corrodere, consumare’; mancarri ki sia frazzàda ‘anche se è consumata’; male cuádu, frazu de pubiḍḍa ‘male nascosto, rodimento di moglie’; cfr. genov. frażżâ ‘consumare, sciupare’; romanesco frajasse ‘guastarsi, andare a male’; irpino e calabr. fraiá ‘abortire’; tosc. dial. frazzo ‘avanzo, frammento’. L’analisi etimologica del Wagner è un classico esempio della metodologia corrotta dalla pregiudiziale latina. Egli infatti produce anzitutto l’ipotesi del Romanisches Etymologisches Worterbuch, ossia che il termine derivi da un lat. fractiō, fragium, da un inesistente *fragulare (dove si cita un camp. *fragiare che parimenti non esiste: parole del Wagner); poi lo stesso Wagner riprende le distanze dal *fragulare del REW. Altra tesi da lui esposta è che il nostro termine derivi in ultima analisi da lat. (nau)fragium. Quanto al fragiu degli Statuti Sassaresi, e quanto alle forme odierne, esse sono tutte relegate in Logudoro, e, mancando nel resto dell’isola, per Wagner «sono sicuro indizio della provenienza forestiera» (sic). Il lettore, da quanto precede, ha agio di notare che Wagner non prende esattamente posizione, ma lascia intuire ex silentio d’essere d’accordo col lat. fragium attraverso forme quali (nau)fragium. Al che noi osserviamo anzitutto la tesi miope e colonialista secondo cui un lemma presente esclusivamente nel Logudoro «sia sicuro indizio della provenienza forestiera». Osserviamo poi l’arroganza del credere all’esclusiva origine latino-romanza. Osserviamo infine che è metodologicamente anormale avvicinare due campi semantici descriventi, rispettivamente, il logoramento (putacaso, di una stoffa) ed il naufragio!, il quale, si sa, ha il corrispettivo nel lat. frangere ‘rompere’.
Ciò accade perché non sono stati scrutati i dizionari semitici, dove per frazzare troviamo l’akk. parāṣu(m) ‘sbrecciare’ una parete’; parā’u(m) ‘affettare, tagliare di netto’; onde da p(a)rāṣu > frazzáre.
Gutta2 margh. ‘sincope, paralisi’. Per l’etimo ci possiamo riferire alla base bab. akûtu ‘invalidità’, da akû ‘debole, senza forze’, specialmente ‘zoppo, sciancato’; anche uqqu ‘paralisi’ (voce apofonetica in u-). Ma vedi l’ampia discussione a proposito di agottiadùra ‘vitiligine’. Spiace osservare che i linguisti precedenti hanno interpretato anzitutto per assonanze, traducendo gutta come ‘gotta’ (Spano, Wagner): mentre quest’ultima è malattia diversa. Spiace anche osservare che spessissimo Wagner accorpa le voci similari o identiche sotto un unico lemma, creando notevole confusione. Tale destino ha avuto anche gutta2, che è stata abbinata a gutta1 ‘goccia’ nonostante l’evidente discrasia semantica.
Igumarras (Laconi), irgumarras (Desulo); vigumarras (Mogoro, Escalaplano) ‘lampi secchi, il lampeggiare parossistico e senza pioggia durante certe perturbazioni sciroccali di settembre’. Questo termine meteorico, il cui prototipo pare irgumarras, ha base nell’akk. irḫu ‘aggressiveness, insolence’ + marrum ‘bitter’ (of wind). Il composto irḫu-marrum in origine indicò la ‘paurosa aggressività’ (del temporale). Immagino che la sequenza ininterrotta di migliaia di saette aria-aria fosse vista come dimostrazione della rabbia del Creatore. Wagner inserisce queste voci tra quelle legate a vicru marinu (v. vicru ‘vitello’) ossia alla ‘foca monaca’, tentando di accreditare fantastiche sarabande di foche eccitate dai temporali di fine estate. Ma vicru ha tutt’altro etimo rispetto a quello ora esposto.
Imbòrvita (Bitti), imbòrvida (Nuoro) «si chiama il pane che si manda ai vicini e ai poveri il settimo o il nono giorno dopo la morte di un familiare». Secondo Wagner è così detto perché “coperto da un panno”, quindi da imbόrvere ‘involgere’. Wagner, a mio parere, sbaglia su tutti i fronti. Occorre tener presente che in Sardegna l’assistenza alla famiglia del morto è un obbligo morale. Per s’imbòrvita non è la famiglia del morto che invia ma anzi è quella che riceve dai vicini i beni eduli. Anche se è vero che in Campidano la famiglia del morto dopo 30 giorni dona un pane a coloro che hanno assistito alla messa di suffragio. Ma è s’imbòrvita come parola a destare forti sospetti sull’operato del Wagner, poiché non ha attinenza né con l’involgere né col celare il dono. La base etimologica è il solito in- mediterraneo (complemento di moto a luogo, oppure dativo) + akk. bu’’ûm ‘to look for, cercare qualcuno; look after, prendersi cura di’ + wêdum ‘sole, solitary, alone; solo, solitario’. Il composto in-bu’’ûm-wêdum in origine significò ‘prendersi cura delle persone sole’.
Incappare it. ‘essere irretito, preso da una situazione impediente, spesso malevola’. Cfr. log. incappare, camp. -ái ‘capitare’: tristu a kin’incappat ‘sfortunato colui al quale succede’. Base etimologica è l’akk. kappum ‘palmo della mano’. In questo caso il concetto basilare è quello d’essere afferrato da una mano rapace. Sbagliato l’etimo del DELI da cappa ‘mantella’. Wagner (DES I 622), senza immischiarsi in questioni di etimologia, sostiene che la voce sarda è un accatto dall’it. incappare.
S’incappat. Dopo l’azzardo di incappare, Wagner rafforza la sua idea accreditando la stessa origine all’avverbio di dubbio: s’incappat. Quindi traduce Ómine pipadore s’incappa non ‘nde leo ‘uomo fumatore, se capita, non lo sposo’. Invece sincappat è voce log. ‘forse, probabilmente, mi pare che, secondo me’; sincappat appo intzertáu ‘mi pare d’avere indovinato’; sincappat mi lu faghes iskìre ‘spero me lo farai sapere’; sincappat l’as cumpresa ‘mi pare che l’abbia capita’; sincappat lu fricas tùe! ‘stai fresco che lo freghi tu!’. Questa è un’antichissima invocazione del genere di quella araba (inshallàh ‘che Dio voglia’),ed ha base etimologica nell’akk. Sîn ‘la Dea Luna, la Dea Madre Onnipotente’ + kapātu ‘mettere insieme, riunire’ (dei segni portentosi, segni d’auspicio). Quindi sincappat significò in origine ‘che Sîn mostri dei segni positivi’.
Inférias log. ‘pastoie’. Cfr. tosc. ferie ‘idem’; cal. férgia ‘pastoia di ferro da cavallo’, abruzz. ferge. Wagner ne propone la parentela col ferro, evidentemente attratto dalla “pastoia di ferro” qui citata, alla quale non credo in linea di principio. Infatti una cosa è la ‘pastoia di ferro per uomini (manette)’, applicata ad esseri intelligenti per ammonirli a star calmi e non farsi male inutilmente, altra cosa è ‘impastoiare col ferro un animale’ che, non essendo intelligente, auto-distrugge le proprie gambe, condannandosi alla morte e producendo un danno economico al padrone. Questo lemma è uno dei tantissimi che denuncia la scarsa acribia del Wagner, il quale risolve le sue etimologie soltanto in funzione delle assonanze (inférias/ferro), senza considerare la semantica. Invero, la base etimologica più congrua per inférias è il sum. birig ‘to sneer at, farsi beffe di qualcuno; contract oneself, contrarsi, rattrappirsi; roll up, arrotolare, rimboccare’, da cui si può evincere un campo semantico dove domina l’atto d’imperio o di violenza ed il concetto di mettere attorno (appunto: i lacci ai piedi).
Ingenium in CSMB 93: Ismendarunt su condage suo in corona de logu, ki aviat factu ad ingenium (ch’egli aveva falsificato) et segarunt illum. La traduzione è del Wagner. Egli riconduce il sd. ingenium ad irghenzu nuor., abbenzu, aenzu, enzu ‘difetto fisico o morale; debolezza, macchia’; e deriva irghenzu e tutte le voci ad esso legate dal lat. ingĕnium ‘natura, qualità, indole, inclinazione’. Non si rende conto che la vera base etimologica di irghenzu è l’akk. irḫu ‘aggressiveness, insolence; aggressività, insolenza’. L’interpretazione del Wagner è ascientifica, e in quanto tale incappa in tre errori: il primo quando rifiuta l’approccio semitico; il secondo quando prende come base una voce latina senza alcun criterio, poiché tra irghenzu e ingenium c’è troppa differenza fonetica ed anche semantica; il terzo quando pretende che si accetti il lat. ingenium come “falsificazione” anziché come ‘natura, qualità, indole, inclinazione’. Detto con rispetto, questo è un imbroglio oratorio che induce subliminalmente il lettore ad accettare la proposta come vera, omologando ingenium ad irghenzu e ponendo l’origine di quest’ultimo in ingenium medesimo! L’imbroglio va svelato: la proposizione subordinata ki aviat factu ad ingenium è da tradurre ‘che aveva fatto (scritto) secondo le proprie intenzioni (e non secondo verità)’.
Istuvada log. ‘colpo di coltello al fianco; percossa’ (Casu). Contrariamente a quanto propone Wagner, questa voce autenticamente sardiana non ha alcuna relazione con tuvu (agg. ‘cavo, profondo’ detto d’alberi, per estensione ‘spelonche’, base etim. bab. ṭubû ‘un genere di canna’). Base etimologica di istuvada è il sum. tub ‘to strike down, colpire’.
Là locuzione esortativa camp., usata in frasi quale Là ki ti partu de conca! ‘Sta attento che ti parto di testa, che ti dò una testata!’; Là ki ses fendi su scimpru! ‘Attento a te che stai facendo lo scemo!’. La base etimologica è l’ug. l-, /la/ ‘o’ (interiezione). Il camp. là funziona esattamente come nell’ugaritico, prefisso alla parola o al verbo seguente come interiezione vocativa. Ma vedi anche l’akk. di Emar la = ingl. to, it. a, lat. tibi. Come base etimologica primaria abbiamo il sum. la ‘mostrare, esporre’, col significato quindi di ‘guarda!, attento!’; si noti l’interiettivo sum. a-la-la, che riappare nella interiezione camp. là là là, per richiamare l’attenzione di qualcuno su qualcosa: ‘guarda, guarda, guarda!’. In Campidano s’usa la particella là anche col significato similare di ‘tieni, afferra!’ (uso pure italico). Ma altrettanto spesso la particella campidanese è strettamente agglutinata nella più complessa forma infinitiva labái.
Non è lecito considerare il camp. labái ‘osservare’ come avente base nel sum. la ‘mostrare, esporre’ + ba ‘colà, là’ (prefisso dativo-locativo): la-ba, con significato di ‘guarda là’. Oggi i linguisti percepiscono là – in quanto particella isolata – come forma imperativa dell’infinito camp. labái ‘guardare, mirare, osservare’. Ma si noti che la voce labai, essendosi oramai consolidata come supposta da un sd. *labai, *labare, riceve anche le forme congiuntive di rispetto lebi, lébidi ‘guardi’. In realtà la forma labái ‘guardare’ è già di per sé corrotta, ed ha base nel camp. la + bá(d)-. Non a caso c’è il corrispettivo log. ab-baid-áre (con a- dat. prefissato): cfr. badiáre (Olzai, Ovodda, Gavoi) ‘guardare’; it. bad-àre ‘osservare, mirare a’.
Il camp. la-bái è quasi sempre impiegato all’imperativo, dove abbiamo il semplice là! ‘guarda, osserva!’, ma pure il composto labbáḍḍu!, labbaḍḍu innòi! ‘mìralo, védilo qua!’ (da là baḍḍu…). La base etimologica di bad- è il sum. bad ‘fortezza’ ossia ‘luogo alto d’osservazione’. Ultima osservazione: Wagner (DES II 1) cita questo lemma sotto la voce italianistica labare ‘lavare’, principalmente ‘cercare i pidocchi in testa’ (e le pulci sul corpo), pretendendo l’origine etimologica di là, labái dal lat. lavāre. Un modo di ragionare che esula da ogni approccio scientifico.
Maiòre log. ant. ‘titolo comune significante la preminenza assunta da un uomo sui suoi dipendenti’; pl. anche maiorales. La base etimologica è la stessa di magistru, maistru, mástriu, mastru log. ant. ‘maestro’ (vedi). Questa voce è passata attraverso il lat. magister (da magis, majus), ma ha base etimologica nel sum. maḫ (cfr. it. maiùscolo ‘di proporzioni maggiori’) ‘grande, potente’; il suff. -yo-, -yu- ha basi semitiche: ug.-ebr. jṣ’, aram. j‛a, akk. aṣû ‘salire; to rise, to grow’. È inammissibile che Wagner abbia preteso di porre come base di maiòre il camp. mòri ‘viottolo di campagna’. Infatti tra l’aggettivo connotante il maggiore ed il nome riferito al sentiero passa un abisso semantico. Wagner non potè capire che mòri ‘sentiero’ ha base etimologica nel sum. mu ‘good’ + rub ‘to go, andare’: mu-rub indicò in origine il ‘buon andare’ ossia la possibilità di muoversi senza attraversare né selva né sterpaglie.
Mudróxu (Sarrabus) ‘orifizio dell’alveare, unico ingresso delle api’. Base etimologica è il sum. mud ‘cavità’ + uru ‘dwelling’. Il composto mud-uru in origine indicò il ‘buco dell’abitazione’. Da scartare l’assurda proposta del Wagner che indica l’origine nell’it. mordere.
Muldidòri (Teulada) ‘ragno’. Base etimologica il sum. mul ‘insect’ + de ‘to winnow, vagliare, discernere’ + dur ‘to dwell, abitare’. Il composto mul-de-dur in origine significò ‘insetto che abita dentro il vaglio’ (per la forma della ragnatela). Da respingere l’interpretazione del Wagner, che lo considera ‘il morditore’, da it. mordere.
Oru log. in leare όru ‘aver sentore’ (Spano). Base etimologica il sum. ur ‘to smell, sentire odore, annusare’. Purtroppo Sanna e Wagner lo derivano dal log. orettare ‘guardare dalla soglia della porta’.
Pibaratzu agg., detto di un cavallo screziato o di pecora bianca a macchie rosse (Sarrabus). La voce non deriva dall’it. vipera (serpente velenoso viviparo), come suggerisce assurdamente Wagner, ma dal sd. píbere, píbiri ‘pepe’. Quindi significa peperato.
Pistoccu log. e camp. ‘pane biscottato e scisso in due sfoglie’. Wagner lo considera metatesi dell’it. biscotto ‘pane cotto due volte’, ‘pasta dolce cotta lungamente al forno’ (< lat. biscŏctum ‘cotto due volte’). Questa interpretazione ha lasciato il segno tra i “dotti” e nel volgo. Invero, la voce sarda è totalmente autonoma, avente base etimologica nel sum. piš ‘bank, shore, rim, quay, bancata, riva, costa’ + tuk ‘to break off, cut, scratch, staccare, tagliare, incidere’. Il composto piš-tuk in origine indicò un ‘(pane) piatto e secco che si scinde in due’.
Pasticci e funambolismi. Come abbiamo constatato, purtroppo, sono migliaia i pasticci ed i funambolismi esibiti dal Wagner in fangose, assurde, lunghissime discussioni entro le quali egli macina voci latine o “neolatine”, condite dalle leggi fonetiche della Scuola Indogermanica (da me rifiutate: vedi Grammatica Storica), le quali creano una cortina fumogena adeguata a sfinire il lettore ed indurlo ad accettare fideisticamente ogni proposta. Comincio la breve sequenza con un esempio sardo-italico.
Aquà = it. ‘qua’ = sd. innòi, innòghe. Questo è termine del gergo ramaio di Isili. Il lemma è una spia del fatto che i ramai di Isili in origine ebbero rapporti stretti con i ramai d’Italia. Infatti quest’avverbio in Sardegna non viene usato, ed è evidente che il lemma acuà (o aquà) è lo stesso lemma italico qua, da cui però il gergo ramaio si distingue in virtù del ridondante prefisso locativo a-.
Stando al DELI, l’italico qua ‘in questo luogo, in questo posto’ dovrebbe avere la base etimologica nel lat. (ěc)cu(m) hāc ‘ecco pur di qua’. Ma non occorre grande acribia per notare l’ybris …creativa del DELI: quel Dizionario infatti ci fa assistere dapprima alla distruzione di una parola intera (ěccum), poi alla religiosa delicatezza con cui se ne preleva un pezzetto (-cu-), infine all’azzardo da Frankenstein che appiccica -cu- al lat. hāc e crea il minotaurico -cu-hāc, senza più curarsi della fine che possano aver fatto tutti gli altri membri, compresa la velare finale (-c) che, non si sa mai, poteva anche essere un pezzo importante.
A me, incapace dei vertiginosi e avveniristici esperimenti del dottor Frankenstein, resta un’unica, arcaica, risorsa: attingere al dizionario sumerico, dove trovo ku ‘to place, collocare, mettere, porre’ + -a (suffisso locativo con valore ‘in’): ku-a significò ‘in questo luogo, in questo posto’, proprio come in italiano.
Berríle, verrίle, errίle log. ‘vernino’: anzone verrile. Per l’etimo vai a iverru ‘inverno’. In ogni modo, per questa voce occorre molta cautela. Infatti il giusto prototipo di essa è barrίri agg. sass. ‘agnello grande’, propriamente del mese di aprile. L’interpretazione, qui postata dopo essere stata semplificata (dove si mescolano i concetti dell’inverno, dell’agnello grande, del mese di aprile), è del Wagner, non mia: io non la condivido affatto. Persino Bazzoni si périta di accreditare l’incredibile certezza del Wagner. Invero, base etimologica di barrίri (a quanto pare anche di berrίle) è l’akk. barûm ‘to be on the market, available; essere disponibile per il mercato’ ossia essere grande abbastanza per valere come carne da vendere.
Cadattu ‘cardo stellato’ (Centaurea solstitialis L., Centaurea calcitrapa L.). Inserisco, tra quelle trattate dal Wagner, una voce trattata espressamente dal Paulis NPPS 78-80 in relazione alla calcitrapa. Nel ricordare che Wagner ne ignora l’etimo, Paulis propone tale fitonimo come contrazione di kardu ed al contempo continuazione di un inesistente lat. *atractulus, forma basata su atractylis (che però secondo Plinio è il Cartamo lanato) quale imprestito d’epoca bizantina (sic!), il quale in Sardegna avrebbe prodotto – secondo lui – una serie contorta e defatigante di assimilazioni, dissimilazioni, semplificazioni, complicazioni, rinvii, obliterazioni, contrazioni, anaptissi, epentesi, dilegui, aferesi, metatesi, analogie produttive… e quant’altro si voglia pescare da un trattato di tecnica fonetico-stilistica. Alla fine Paulis, irrimediabilmente perduto nel labirinto da lui stesso creato, non produce alcun etimo, lasciando il lettore stanco e frustrato dopo aver letto tre pagine col desiderio di scorgere una soluzione. I miei lettori sono vivamente pregati di ripercorrere quelle pagine.
In realtà cadattu è un composto sardiano con base nell’akk. kādu(m) ‘sentinella’ + atû(m) ‘portinaio’. Per capire questo sintetico appellativo significante ‘guardiano degli usci’, basta leggere tutti gli altri consimili significati dati dai Sardiani alla calcatreppola, pianta d’elezione con cui si fanno delle effimere “porte”, “cancelli” per impedire alle bestie di rapina di entrare negli ovili.
Féstina centr., gall. designava originariamente le scale a intagli, oggi inesistenti. Oggi il vocabolo si usa per la ‘scala a pioli’ (Nule, Dorgali), in Gallura anche per il ‘tronco d’albero coi rami sporgenti e sfrondati al quale s’appendono utensili o bestie scannate’, altrove chiamato anta. Base etimologica è il sum. peš ‘to slice, affettare, to cut into, tagliare in…’ + ti ‘rib, stecca’ + nug ‘plant’. Il composto peš-ti-nug in origine indicò una ‘pianta resecata a stecche’. Esemplare l’affanno indagatore del Wagner (DES I 514), che abbina la nostra voce a questa e a quella, arrecando soltanto danni; es.: l’abbina al lat. infestus ‘ostile, aggressivo, nemico’; allo sp. enhiesto ‘alto, levantado’; al lamant. injiestro ‘ognuno dei quattro pali ai capi del carro’. Egli vi assomma anche il berbero tafesna ‘scala’ (voce del tutto diversa), ch’egli ostinatamente pretende ravvicinare al nostro féstina.
Fúndere log., fúndiri camp. ‘fondere, liquefare’. Cfr. lat. fundere ‘sciogliere, spargere, disperdere, volgere in fuga, sconfiggere’; infundibulum ‘imbuto’; fūtis ‘vaso per mescere’; fūtilis ‘che si versa o si disperde’ < base apofonica corrispondente ad akk. pādum ‘to set free, liberare’. Vedi DES I 556 per capire la disastrosa e confusissima operazione con la quale Wagner riesce ad unificare l’etimo di due lemmi assai diversi, fúndere e infúndere.
Ineḍḍa centr. ‘lì, in quel preciso punto’, ‘là, colà, lontano’; anche inḍeḍḍa: mirare sa luna de ineḍḍa ‘guardare la luna da un punto preciso’; in cuḍḍa biḍḍa ineḍḍa ‘proprio in quel villaggio’; ineḍḍa andet sa fama ‘la fama si levi alta’ (cfr. sum. ed ‘to go up, salire in alto; to come forth, uscire’). Wagner sbaglia a dare a ineḍḍa il significato di ‘lontano’, tout court. Parimenti sono insufficienti le traduzioni date dal Puddu 865: ad es. prist-inneḍḍa ‘prestu a un’ala’ (peráula po kizire su cane) ha un significato assai distante da quello dato dal Wagner, e Puddu questo non l’ha chiarito.
A mio avviso, la base etimologica di alcune di queste locuzioni sta nel sum. ed (vedi l’esempio citato), per altre nell’akk. eddu(m) ‘punto, appuntito’ < edēdu ‘essere appuntito’. Per non impegnare spazio, non riporto la fangosa, lunga discussione del Wagner (DES I 629), che ruota sulla manipolazione di alcune voci latine, condite dalle leggi fonetiche inventate dalla Scuola Indogermanica, le quali, partendo da basi irrimediabilmente sbagliate e compromesse, creano soltanto pasticcio.
Osca log. ant. ‘poi, dopo’. Frequentissimo nei condaghes, in séguito cede il posto a posca (vedi) ‘poi, appresso, dipoi’ (avverbio), che però spunta ogni tanto anche nei documenti antichi. Nella CdL posca è l’unica forma. Facile arguire che osca è la forma arcaica della parlata sardiana. Infatti, base etimologica è il sum. us ‘to follow’ + ca log. e camp. ‘che’ come introduzione delle proposizioni dirette (accusative) e in applicazioni varie, da sum. ka ‘to talk, parlare’. In pratica us-ka anticamente ebbe il significato di ‘poi che’. Wagner, convinto della priorità temporale di posca, ha scritto tre pagine nel disperato tentativo di scoprire un arcano per lui inscrutabile.
Regra (Nuoro, Dorgali, Orune, Nule); rega (Bono); règia (Oschiri, Buddusò, Mores); sa regge (Sennori); règgia (Berchidda); rèja, melarrèja (Luras, Ozieri); melarèggia (Pattada); arrèga camp. ‘favo di miele’. Regra e simili sono retroformazioni dal prototipo melarrèja. Per l’etimo vai a méli, mela + akk. rēyûm, re’ûm ‘shepherd, pecoraio, pastore’. Nell’alta antichità melarrèya significò ‘miele dei pastori’.
Impossibilitato a riscrivere e riproporre l’intera pagina da cui ho preso le mosse, rinvio a DES II 346 affinché i futuri linguisti percepiscano il guazzabuglio prodotto dal Wagner il quale, paralizzato nella ricerca di un etimo qualsivoglia (salvo poi parare a un lat. reg(ŭ)la ‘regola’: sic!), s’impelaga in una cabalistica manipolazione delle leggi fonetiche da lui stesso inventate, confrontandole con quelle altrettanto inventate della linguistica indoeuropea. Inoltre introduce anche rèya ‘traversa del cancello’, oltre a voci similari basso-italiche aventi tutt’altri significati, quasi che tali voci abbiano a che fare con la nostra. Il risultato è, purtroppo, una pagina allucinata.
Resare log. (rasare: Nuoro, Mores); arresái, arrasái, arrosái camp. ‘recitare il rosario’; ‘fare orazione’, ‘dire il breviario’; fagher (fai) su résu, s’arrésu ‘la preghiera quotidiana del prete’. Cfr. sp. rezar ‘recitare orazioni’, rezo ‘preghiera’; arreséndu (Mogoro, Terralba), arreséndi (Cagliari), arroséndi (Villacidro) ‘Credo’ (la preghiera-cardine del cristianesimo). Quanto precede è scritto dal Wagner, e si può notare ch’egli ha fatto un po’ di confusione, mettendo assieme il Rosario, il Credo, ed una poco chiara ‘preghiera quotidiana del prete’. Wagner è partito da sp. rezo ‘preghiera’, credendolo l’origine delle altre parole spagnole nonché di quelle sarde. Ma, a parte che non dà l’etimo di rezo, rezar, egli ha fatto dei grossi errori. Base etimologica di rezo è, invero, l’akk. rēṣum ‘helper (god, goddess), che soccorre’; ‘to help, soccorrere’: Sîn-rēṣam ‘Help me, Sîn!; Dea Luna, soccorrimi!’ (usato come invocazione nella preghiera, ed anche come nome muliebre). Quindi è inadeguato quanto propone Wagner, che il verbo sia riferito al rosario, alla ‘preghiera quotidiana del prete’ e pure al Credo. Possiamo invece notare che oramai a livello popolare ed a livello colto la confusione ha prevalso, mentre al fondo rimane l’akk. rēṣum che tramanda intatta sino ad oggi una parola che denuncia una incredibile sopravvivenza della religione pre-cristiana.
Scrikkillònis m. pl. camp. (Escalaplano); scrikkillôis (Mogoro); cicillònes (Villagrande); sciscillònis (Cagliari); pripixònes (Laconi); spripillôis (Usellus) ‘racimoli’. Base etimologica di scrikkillònis ed affini è il sum. kirkir ‘bird’ + lum ‘drinking vessel’, anche ‘fruit’. La Sardegna nel periodo della vendemmia sta ancora nel pieno della siccità estiva, e gli uccelli sono in grande sofferenza per assenza d’acqua. Pertanto il composto kirkir-lum in origine dovette significare, più che ‘frutta degli uccelli’, ‘acqua degli uccelli’. [Questo è l’esempio di come devono essere trattate le etimologie, con un occhio agli antichi vocabolari e l’altro all’ambiente del luogo. Invece Wagner DES II 394 satura le proprie ipotesi con parole inventate (con l’asterisco) e con depistaggi epistemologici operati mediante la presentazione d’una serie di vocaboli travianti, quale sd. kiskizza ‘vagliatura del grano’, sp. cencerrón ‘racimolo d’uva’, sd. pipiòne ‘acino d’uva’].
Séru log. ‘sentore’: leare su séru ‘aver sentore’ (detto specialmente dei cani da caccia); cane de séru ‘cane dal naso fine’; fig. ‘persona molto accorta’ (Casu), ‘giudizio, riflessione’ (Soro); leare séru ‘subodorare’ (Spano); ista in séru! ‘mantieni il senno!’; serare ‘sentir la preda’ (detto dei cani); riflessivo ‘ravvedersi, rinsavire’; anche seriare: l’apo seriadu in cussu logu ‘l’ho visto in quel luogo’.
Leggendo in DES II 411 si apprendono le angosce dei linguisti nell’indagare questa voce. Antonio Sanna, non sapendo che fare, tentò di sentenziare che Spano, Soro e Casu avevano registrato parole inesistenti (sic); ciononostante s’arrovellò paradossalmente nel sostituirvi verbi e significati d’altri campi semantici, tipo it. segregare (operazione illecita e assurda, la sua, seguita dal Guarnerio che tentò d’intruppare quelle voci nell’it. sceverare ‘discernere con la vista’). Il Meyer-Lűbcke rigettò il tentativo del Guarnerio ma se ne lavò le mani. Il Salvioni dubitò del Guarnerio e propose in cambio l’origine dal lat. verus ‘vero’ (sic). Wagner rigettò salomonicamente tutti quei rovelli, per andare at random e pescare infine la parola sostitutiva dal sintagma leare oru (dallo Spano), che considerò sinonimo di leare séru. Invero, Wagner nel suo cieco brancolare cadde bene, in quanto leare όru ‘aver sentore’ ha base etimologica nel sum. ur ‘to smell, sentire odore, annusare’. Ma rimane il clamoroso smacco di quattro luminari della filologia romanza, che preferirono by-passare il problema di séru, dispensandosi dall’indagare la sua base etimologica, che poggia nel sum. sir ‘to be pointed, essere acuto’.
Súmere, sumίre log.; sumίri camp. ‘trasudare’ (detto delle botti e altri recipienti). Base etimologica il sum. sumun ‘soaking vessel, vaso bagnato, inzuppato’. Rinvio a DES II 444 affinché si capiscano gli assurdi funambolismi del Wagner e dei suoi colleghi nel tentare di accreditare un qualsivoglia etimo.
Supuzzare nuor.; suguzzare log.; sumbuzzare (Ghilarza); sumbullái, sciumbullái camp. Wagner dà a supuzzare, ed a quelle presentate come varianti, quattro significati collegati (vedi di seguito). Ma è tale il caos da lui creato nell’esporre la questione (v. DES II 446), che porvi rimedio è arduo. Il lettore, dopo aver letto pazientemente nel DES l’esposizione del Wagner, adesso dovrà seguire con la stessa pazienza i miei tentativi di sbroglio.
1) ‘sconvolgere, scompigliare’: tengu su stόgumu sciumbulláu, camp., anche sciamballáu ‘scompigliato, sciamannato ossia sciatto o maldestro’; cfr. lucch. sciambugliare ‘muovere lo stomaco, suscitare nausea’ (Nieri); anche ‘rimescolare, intorbidare l’acqua’. Quanto precede è esposto dal Wagner, senza che fornisca esempi fraseologici di supuzzare, che invece ritroveremo ai punti 2 e 3. La forma sciumbullái sembra parente di it. subbuglio ‘confusione tumultuosa, scompiglio’ (che DELI suppone dal tardo lat. subbullire ‘bollire un poco’ [assurdo!] mentre deriva dall’akk. šūbu ‘rush, affollamento, ressa; to flatten, abbattere, spianare’).
2) ‘portare di notte le pecore al pascolo’ (come si fa nella stagione calda). Il rumore e lo scompiglio che ne nasce si chiama supúzzu, suguzzu, sciumbullu (cfr. it. subbuglio), ciò che spiega l’applicazione del verbo al trasporto notturno delle pecore. Il sostantivo e il verbo si usano anche per un qualsiasi rumore: inténdu sciumbúgliu ‘sento rumore’; (Mogoro) s’áqua sciumbúllada mei sa brocca ‘l’acqua diguazza nella brocca’. Tutta questa esposizione è fatta dal Wagner, ed è caotica, anzitutto nell’abbinare allo scompiglio il pascolare delle pecore (che è quieto e mansueto, anche di notte: esperienza mia personale); poi nel forzare subliminalmente il lettore a considerare l’origine di sciumbullu (subbuglio) da tale idilliaca quiete. Nel tentativo di mettere ordine, dico che suguzzu deriva dal sum. suḫ ‘to confuse, confusion’ (supuzzu è l’effetto di Lautverschiebung: v. la mia Grammatica); per sciumbullu ho dato l’etimo al punto 1.
3) log. suguzzare(sì) significa anche ‘svegliarsi presto’ (Mores, Bonorva), e così anche camp. sciumbullái: sciumbulla! ‘svegliati!’ (Domus de Maria). Questo significato deriva dall’anteriore: i pastori che portano le pecore al pascolo di notte, si devono lavare presto. Perciò si chiama nel Logudoro Suguzzadora la ‘costellazione d’Orione’ (Spano, il quale osserva: “con esso i pastori chiamano la prima stella di Orione, quando di mattina spunta nell’estate e muovono dalla mandra le pecore per pascere un’altra volta”). Il Canonico dà come etimo del nome il lat. sequor, ma ciò è impossibile.
Quanto precede è esposto interamente dal Wagner, e si noterà un incredibile pasticcio dove si mescolano i concetti dello “svegliarsi presto” (all’alba, di notte?); del “pascolo notturno”; del “pastore che si lava presto” (all’alba o di notte?, ma a che serve introdurre l’idea balzana del lavarsi?); della costellazione di Orione (la quale, osservo io, non sorge durante il pascolo estivo-notturno ma d’inverno, e sorge dopo il tramonto, non di mattina); del “muovere il gregge di mattina” (mentre Wagner era partito dicendo che il gregge viene mosso in piena notte). Wagner, insomma, concatena cinque concetti che fanno a pugni, ed il lettore rischia d’impazzire davanti a un’esposizione folle.
4) per il log. sett. il Casu dà sumuḍḍίre, simuḍḍίre con tutte le accezioni essenziali di supuzzare: ‘muoversi, menar le pecore al pascolo’, inoltre ‘nascere, spuntare (di erbe)’ (tutto ciò è registrato dal Wagner). Invero, la base etimologica è il sum. sub ‘to go’ + ud ‘goat’, udu’l ‘sheep, fat sheep’, udul ‘herdsman’. Da queste radici potè nascere il significato del ‘condurre le pecore, o le capre’ (sub-ud o sub-udu’l), relativo al sd. supuzzare, e pure relativo a sumuḍḍίre o simuḍḍίre interpretati come nasalizzazione di sub-ud.
5) Quanto alla costellazione di Orione, Wagner non ha spiegato perché essa sia chiamata Suguzzadora, da lui intesa come ‘colei che risveglia presto (la gente)’. Invero, il tentativo di trovare l’etimo passa per il sum. šugi ‘senior, elder, old person’ + za ‘man’ + duri ‘male, virile’. Il composto šugiz-za-duri significò in origine ‘uomo anziano dall’aspetto virile’ (ed abbiamo l’idea della costellazione di Orione).
Tiváni ‘corvo’ a Baunei, Villagrande, Arzana, Gairo, accanto a crobu: esattamente crobu-tivani, specialmente nella locuzione ancu ti nḍi lè tivani! ‘che tivani ti porti via!’. Quanto precede è riportato da Wagner DES II 492, dove l’Autore insiste ad affermare che tiváni è l’arcaico nome ogliastrino del corvo. A parte che, come suo solito, non opera l’indagine etimologica, egli nemmeno si pone l’obbligatoria domanda: Per qual ragione un minuscolo corvo sarebbe in grado di rapire un uomo? Invero, la base etimologica di crobu-tivani è l’akk. kurūbu (a bird) + tībum ‘attacco, insurrezione’; quindi kurūbu-tībānu (-ānu è suff. aggettivale) indicò in origine un ‘uccello d’attacco, di rapina’ (evidentemente si riferì all’Aquila reale, la quale ha la forza di sollevare persino una capra adulta; oppure si riferisce a s’ingurtosu). Tivani s’impiega anche nel senso di ‘ingordo’: quindi a maggior ragione restiamo nel campo semantico di s’ingurtόsu (‘gipeto o avvoltoio degli agnelli’). Rafforza questa impostazione il fatto che esistette anche il cognome medievale Tiuani (CV XIC) e Tifani (CSMS), il quale indica chiaramente un arcaico nome maschile correlato proprio all’avvoltoio (nome di guerriero). L’impenitente protervia ideologica del Wagner lo induce a scartare persino il bèrbero siwân, che in tutte le varietà di quella lingua designa vari uccelli di rapina, per lo più il gheppio o l’avvoltoio. Ma Wagner preferisce la forma marocchina tsiouânt, perché essa indica il corvo e ciò conferma la sua convinzione ideologica!
Tutare centr; tudare, tudái log. e camp. ‘coprire il fuoco con terra o cenere’, ‘sotterrare, seppellire’. Base etimologica è il sum. tun ‘to cover’ + tab ‘to burn, fire; bruciare, infiammare’. Il composto tun-tab in origine significò ‘coprire la fiamma, il fuoco’. Rinvio a DES II 537 per apprendere le assurde evoluzioni nel tentativo di giustificare un (inesistente) lat. *tutare e persino un’origine dal fr. tuer ‘uccidere’.
Visèra, bisèra, isèra log. ‘figura, apparenza’. Rinvio a DES II 580 per osservare il guazzabuglio creato da Wagner, il quale ha abbinato arbitrariamente a questa voce anche iseriare ‘nauseare, schifare’, nonché isèria, bisèra ‘beffa, trastullo’, sostenendo che «da ‘maschera, viso contraffatto’ si spiega l’idea di ‘contorcere la faccia per effetto dello schifo o della beffa’» (sic). Invero, le basi etimologiche sono tre, molto distinte.
Tzira camp. ‘sa natura de is vitellus, mascus e angionis’; ‘verga, natura, nervo’ (Porru); sa sίra (Iglesias) ‘pene’; sirìle, serìle log. ‘membro genitale del toro, del verre, dell’uomo’. Base etimologica nel sum. šir ‘testicolo’, di cui sirìle è aggettivo. Vedi anche tzirogna. Rinvio a DES II 595 affinché si apprenda direttamente l’assurdo discorso del Wagner, il quale coinvolge il Guarnerio, il Rolla, l’Alessio in fuorvianti ipotesi sull’origine di queste voci.
Voci spurie (per Wagner) o voci da lui stesso inventate. Dopo la segnalazione dell’enorme congerie di errori di traduzione fatti dal Wagner, non può mancare la segnalazione di un altro fenomeno osservabile nel DES, cioè le cosiddette “voci spurie” (interpretate così dal Wagner ma che spurie non sono). Ci affianco anche le voci che lo stesso Wagner inventò ma che non trovano riscontro nel vocabolario sardo.
Carrubba camp. ‘carru sentza rodas po trasportai perdas etc, ki is bois trascinant po terra’ (Porru). Era, insomma, un ‘slitta’ (per la quale cfr. tracca). Base etimologica è il sum. ḫara ‘wagon, carro’, akk. ḫarû ‘contenitore supportato da un carro’ + ubûm ‘misura di capacità’. Quindi è da tenere in non cale la meraviglia del Wagner per questa parola, ch’egli ritiene sbagliata, una voluta deformazione popolare al posto di carrùca (vedi).
Cardanéra nuor. e camp., cordonèra (Busachi) ‘cardellino’ (Carduelis carduelis). Base etimologica è l’akk. qardum ‘valiant, heroic, coraggioso, prode, eroico’ + nēru (a bird). Quindi qardu-nēru ‘uccello valoroso’ fu il primo nome del cardellino in Sardegna. Sussiste anche il cat. cadarnera, cadernera, di cui Wagner (DES 299) non ha saputo dare alcuna spiegazione, negandone addirittura l’esistenza.
Ducu (Ghilarza) ‘frana’ (Spano). Wagner, non avendo conseguito conferme etimologiche, la considera “voce dubbia”, come dire che la dichiara spuria. Invece, a quanto pare, la base etimologica è il sum. du ‘to build, heap up, accumulate’ + kud ‘to cut, break off; tagliare, rompere a pezzi’. Il composto duk-kud in origine significò ‘rottura del cumulo’.
Lareḍḍa camp. ‘piattola’, voce registrata solo dallo Spano. Wagner, dopo adeguata discussione, dubita molto della correttezza di questa voce, ed attribuisce allo Spano un errore, che con ciò s’assomma ai molti errori che lo Spano avrebbe fatto nell’interpretare il dialetto campidanese. Ma la questione non sta nei termini delineati dal Wagner, e va detto che Spano, specie per le parole da nessun altro registrate, è invece molto preciso. A mio avviso, lareḍḍa ha base etimologica nel sum. la ‘to hang, agganciarsi’ + rig ‘to eat, mangiare’ + dab ‘to seize, overhelm; afferrare, sopraffare’. Il composto la-rig-dab in origine volle significare il tipo di attività delle piattole, le quali succhiano il sangue attaccandosi tenacemente alla parte puberale.
Pádriu log. ‘chiaro, articolato’; ispadriare ‘parlare chiaro, articolare bene i suoni’. Wagner ne ignora l’etimo, pur dichiarando pádriu, per principio, “non indigeno” (spudoratezza di chi, non riuscendo a trovare un etimo, dichiara spurio il vocabolo la cui fonte gli è ignota). Egli cita anche l’interpretazione del Salvioni (lat. pātrius ‘paterno’) e del Rolla (lat. practicus). Come al solito, i miei predecessori scavano soltanto nel latino, anche se poi, come spesso, e come in questo caso, la loro riuscita è fuorviante. Invero, base etimologica di pádriu è il sum. padr ‘rompere, fare a pezzi’. Pádriu è un evidente aggettivale in -iu dall’originario padr, e si riferisce alla capacità del parlante di spezzare bene la catena parlata evidenziando i singoli vocaboli e facendoli intendere pianamente all’ascoltatore.
Pádulu camp. rust. (Sarrabus: corra bádua ‘corna divaricate’): questa citazione è del Wagner (DES II 204). Ma osservo che pádulu è voce inventata al posto di ádulu, bádulu. La b- di bádulu è concresciuta come spesso accade nell’intera Sardegna davanti a vocale (peraltro in Sardegna accade anche l’opposto: es. berbèke > erbéke). Base etimologica di ádulu, bádulu è il sum. ad ‘crippled, zoppo’ + ul (pronome dimostrativo: ‘quello’). Il composto ad-ul in origine significò ‘lo zoppo’ (per l’andamento poco armonioso); evidentemente col tempo s’inventò la metafora anche per le corna scomposte, altrimenti dette in Sardegna corressas (vedi).
Voci tradotte alla carlona. Abbiamo quindi che Wagner talora inventa anche voci inesistenti. Altre volte, inopinatamente, le traduce alla carlona. Faccio un solo esempio tra tanti, per non tediare.
Irrancare log. ‘arrivare, giungere’. Questa è traduzione del Wagner, il quale non solo non mostra alcun etimo, ma prende, come suol dirsi, “fischi per fiaschi”. In realtà le frasi dove si trova questa voce sono le seguenti: irrancare a pisciare ‘pisciare con ostentazione’; irrancu, irrancada ‘pisciata’; unu irrancu e pίsciu ‘un grande arco d’urina, un ponte di urina’ (Casu). Base etimologica è l’akk. reḫû ‘versare, inondare’.
Voci trattate da Wagner sotto un solo lemma. Infine annoto che Wagner praticò il particolare metodo d’intruppare molte parole sotto lo stesso lemma (onde io parlo di “lemmi a grappolo”) per il solo fatto di trovarle molto simiglianti nella fonetica (di ciò ho scritto qua e là nei precedenti paragrafi). Ma il lettore avrà capito che le simiglianze fonetiche tra parole (omofonie) non possono di per sé autorizzare quest’operazione. Tantomeno possono portare a un etimo. Affinché questo possa accettarsi, serve che le parole messe a confronto abbiano in comune un’arcaica antenata che ne comprovi la parentela fono-semantica. L’operazione, insomma, deve disegnare una sorta di triangolo, mettendo ai vertici di base le due voci a confronto, e ponendo al terzo vertice un’altra voce (quella più antica) che riesca ad unirsi semanticamente con gli angoli di base.
Per dare almeno un esempio, elenco quattro voci trattate dal Wagner sotto il lemma soru, dove purtroppo egli ha prodotto un pasticcio. Si noterà invece che le quattro voci sono legate a coppia da due diversi etimi.
Sóru ‘siero’ (del formaggio, della ricotta); (Urzulei) suru ‘ciò che resta dopo la produzione del formaggio’. Wagner ovviamente non dà l’etimo. Il lemma ha base nel sum. sur ‘premere, pressare’ e pure ‘gocciolare, piovere’ (metonimia dove s’indica l’effetto al posto del processo di caseificazione).
Assorare1 log. ‘ingrassare il maiale con siero’. Per l’etimo vedi soru.
Assorare2 (Bitti) ‘essere puzzolente’: ovos assoratos; (Talana) όu assuráu; insuríri camp. ‘idem’: pisci insuríu ‘pesce guasto’. Wagner, con nonchalance, lo apparenta a soru ‘siero (del latte)’, ignorando che il siero non si guasta mai e semplicemente si trasforma. La base etimologica è il sum. šurum ‘litter, dung; immondezza, merda, letame’.
Insuríri camp. ‘guastarsi’: pisci insuríu. Wagner lo apparenta parimenti a soru, mentre la base etimologica è la stessa di assorare2.
La dittatura dell’incompetenza. Il porkeḍḍìno. La Questione della lingua osservata dal basso (ossia, osservata a mente libera da un qualsiasi parlante capace di mettere a fuoco il pensiero dei persuasori che dall’Accademia inventano le regole), viene spesso vista come una dittatura. Nel dire ciò non intendo “politicizzare” il fenomeno linguistico, anche se altri ci hanno tentato e ci stanno tentando, come quei dotti che vorrebbero imporre una Limba de Mesanìa intesa ad unificare i vari dialetti della Sardegna.
Leggendo i primi tre paragrafi, specialmente il terzo (“È possibile sopraffare una lingua?”), il lettore avrà capito com’è difficile sopraffare una lingua. Ciò vale anche per i dialetti (o lingue regionali, o sub-regionali) che la lingua-corifea (o dialetto-corifeo) vorrebbe omologare …o sopprimere. Nel considerare la Questione della lingua, non è affatto secondario il problema dei maestri di cappella. Quanti di loro hanno esperienza e nozioni adeguate ad esercitare il mestiere? A mio avviso, quelli sinora succedutisi non erano buoni emuli di Bach ma orecchianti, gente spaesata che per caso si è ritrovata sul podio a far cantare il coro.
I vari paragrafi di questa premessa metodologica hanno evocato gran parte degli errori di metodo prodotti, a mio avviso, dai miei predecessori in rapporto alla lingua sarda, in rapporto a quella italiana ed in rapporto alle lingue mediterranee. Per far capire meglio che cosa significhi dittatura dell’incompetenza, propongo di analizzare ancora altri due lemmi.
Abbàcchio it. ‘agnello di uno, massimo due anni’; anche ‘agnello arrosto’. La voce entra nei migliori dizionari italiani per il suo prestigio, maturato dall’essere usata in Roma e dintorni; la si introduce nel novero italiano col previo marchio di “romanesca”; per ciò stesso, nell’ambito della lingua italiana essa è individuata quale “civis minoris juris”, perché non è propriamente “italiana”. Adesso assumiamo come ipotesi di lavoro che tale parola fosse soltanto sarda, parlata da 1,6 milione di persone; ebbene, essa non sarebbe nemmeno entrata nel dizionario italiano, neppure se barattata come “civis minoris juris”. Due pesi e due misure.
Questo esempio bipartito basterebbe a far risaltare l’inadeguatezza di un dizionario che vuol essere “nazionale”, che accetta il romanesco e non accetta il sardo. Quale tipo di “nazione” vagheggia quel dizionario? Ed è giustificata l’apartheid riservata ad abbàcchio classificato come “romanesco”? Quale tipo di “scavo archeologico” è stato fatto per accettare infine (sia pure con riserva) abbàcchio tra le voci “italiane”, mentre poi, paradossalmente, lo si è relegato tra quelle “romanesche”? Quanto all’etimo, il DELI acquisisce la proposta che abbàcchio derivi dal lat. ăd băculum ‘presso il bastone’, «dato che, come ci informa Varrone, De re rustica II, 2, 15-18, gli agnellini, dieci giorni dopo la nascita, vengono legati a un palo di modo che, saltando qua e là tutto il giorno, non si facciano male tra loro, e così sono allevati fino al quarto mese, allorché sono svezzati e sono immessi nel gregge». Quindi essa sarebbe voce prettamente latina. In realtà abbàcchio, a parte quell’interpretazione peregrina che qualunque persona sensata rifiuterebbe, è parola mediterranea, italiana, romana, persino sarda, ed ha base nell’akk. bakkā’um ‘belante, lamentoso’. Questa radice si ritrova nella voce greca Baccanti, e pure nel personale sd. Bakis, come altrove ho già specificato nelle mie etimologie. E non serve fantasia ad intuire un certo legame tra l’abbacchio e le Baccanti le quali usavano sbranare ritualmente i giovani animali vivi.
Ancora più eclatante è il seguente esempio relativo a una voce dalla fonetica simile.
Abbauca’, abbacca’ sass. ‘stordire, sbalordire, intontire’: è tuttu abbaucaḍḍu da li midizíni ‘è intontito dalle medicine’; una tzanda abbauccada ‘un papavero appassito’. In log. e camp. abbaccáre, abbaccái ‘rallentare, calmare, calmarsi (es. del vento, del dolore)’; su bentu abbacat. In sass. anche abbraca’ ‘diminuire, scemare’. Cfr. sic. abbacari ‘calmare, cessare, abbonacciare’; calabr. abbacare ‘stare in ozio, avere tempo libero’; così anche a Molfetta, in Abruzzo, nei dialetti italici settentrionali, es. lomb. balcà; in provenzale moderno c’è (a)baucà; cat. (a)balcar. Tutte le citazioni sono di Wagner, il quale respinge l’origine catalana soltanto perché in Alta Italia i Catalani non dominarono. Bontà sua: stando alla sua interpretazione, se i Catalani ci avessero messo il piedino per qualche anno, avrebbero potuto confermare il proprio marchio in tutta Italia, oltreché sulla Sardegna. Modo miope di studiare una etimologia, quello del Wagner. Invero, la parola è mediterranea, con base etimologica nell’akk. baḫû ‘to be thin, be scarce’, anche ‘to make emaciated’. Vedi it. abbacchiato, bacchiato ‘depresso fisicamente o moralmente’.
La vicenda di abbàcchio e di abbacchiare (abbaucca’) lascia comprendere quanto l’Italia sia zeppa di parole recanti la dignità che dovrebbe autorizzare ad usarle nel Vocabolario Italiano senza discriminazioni, senza le ascientifiche distinzioni tra “italiana” e “rurale”, tra “italiana” e “sarda” o “sicula” o “piemontese”.
La lingua italiana ha disperato bisogno di gente che ne comprenda l’esaltante, immensa, folgorante ricchezza perché, oltre a essere italiana, tale lingua è stata primamente mediterranea, e nei tempi arcaici il Mediterraneo era anche, se non principalmente, un mare sardo. Le parole che i Sardi hanno contribuito a forgiare in tanti millenni, sono ancora vive nella lingua sarda, e moltissime sono vive anche nella lingua italiana, sia pure con lievi modifiche di forma o significato. Spesso furono gli stessi Sardi ad introdurle in Italia, ma ciò è ben lungi dall’essere riconosciuto.
È metodicamente deplorevole che la lingua sarda (una lingua con 100.000 voci) sia da troppi considerata minore, mentre quando i Romani presero a forza l’isola essa era ancora in grado di collaborare attivamente al vocabolario mediterraneo. La sua vitalità è stata tale, da riuscire a mantenersi viva sino ad oggi, nonostante cinque colonizzazioni. I radicali comuni a tutto il Mediterraneo ed alla Sardegna lo testimoniano. I Romani hanno continuato per millenni ad usare le parole sarde. Nel mentre arrivò il Medioevo, superato il quale, l’Italia (+ la Sardegna) si scoprì zeppa di lingue (che ora gli studiosi, per disfarsene, chiamano dialetti). Nessuno più è in grado di capire che l’Italia era ed è composta da 32 lingue + la variegata lingua sarda + quella siciliana. Occorrerebbe gestire queste lingue in una visione unitaria ed inclusiva, se è vero che si pretende l’unità politica degli Italiani. E che fanno invece i dizionari italiani? Continuano a distinguere senza criterio, e persino ad escludere senza criterio, senza nemmeno sapere quanta vita in comune abbiano avuto le parole distinte od escluse. I dizionaristi operano alla cieca. Quando si dice dittatura dell’incompetenza…
È tale e tanta la dittatura dell’incompetenza, che l’imposizione e la conta delle parole accettate e di quelle rifiutate è una moda alla quale si applicano le migliori accademie, a cominciare dall’Accademia della Crusca. Alla quale – per quanto nata agli inizi del ‘600 per tutelare esclusivamente la lingua toscana – nessuno si sognerebbe di negare autorità e meriti. Nessuno oggi si sogna di obiettare alcunché a tale Accademia, anche perché il suo lavoro è diventato sempre più inclusivo sino alla quinta edizione ed oltre.
Ma che significa oggi includere, quando l’inclusione riguarda soltanto l’uso scrittorio anziché badare all’uso parlato delle numerose lingue italiche nell’ambito di un’unica nazione?
È tale il disastro fatto dalle Accademie, che troppi Sardi avvertono disagio nel parlare l’italiano, nell’usarlo senza remore. Avvertono di essere dominati da processi porkeḍḍìni, maccheronici. Nessuno si rende conto che un tempo tali processi erano non solo ammessi ma favoriti, essendo spesso gli unici processi che appianavano l’incontro tra portatori di idiomi diversi nell’ambito di una sola Koiné.
Porkeḍḍínu log. e camp.; puχeḍḍínu log. e sass., agg. ‘bastardo, maccheronico’ (riferito al modo di parlare, al discorso); itariánu puχeḍḍínu ‘italiano maccheronico’, fabiḍḍa’ puχeḍḍínu (avverbio) ‘parlare in maccheronico’. Il termine non è registrato nei dizionari, anche perché risulta ostico ai linguisti questo termine paronomastico riferito stranamente ai ‘maialetti’ (porkeḍḍus).
La base etimologica è invece l’akk. puḫḫu(m) ‘scambiare, sostituire’ < pūḫu ‘scambio, sostituzione’ + (w)ēdu(m) ‘singolo, solitario; hapax’: stato costrutto pūḫ-ēdu, col significato di ‘singola sostituzione (di vocabolo)’; vedi pure akk. pūḫizzaru ‘scambio equivalente’. Quindi il sass. itariánu puχeḍḍínu significa ‘italiano sostitutivo’ ossia parlato sostituendovi una o alcune parole della lingua sarda.
Ebbene, il rifiuto e la demonizzazione del porkeḍḍìno devono cessare immantinente! Il porkeḍḍìno deve essere ammesso!, anche dalle Accademie!, come procedura strutturale nella comunicazione verbale. Nessun sardo deve sentirsi discriminato. Anche perché, focalizzando l’uso che si fa dell’italiano non in Sardegna ma nella Penisola, notiamo che tutti i Continentali (sos Terramannésos) si esprimono reciprocamente tra di loro senza alcuna remora, nonostante che si percepisca molto spesso il loro ancoraggio indefettibile alla lingua del proprio territorio. Nessuno di essi se ne vergogna, e nessuno dei “puristi” s’adonta nell’ascoltarli. Anche loro, tra Italiani, parlano porkeḍḍìno.
Nell’osservare e mettere a confronto il fenomeno dell’incompetenza e dall’altra quello del porkeḍḍìno, percepiamo soltanto i cachinni degli idioti, i quali credono d’essere aquile mentre sono ridicoli polli. Gli idioti sono facilmente identificabili tra certi giornalisti o certi attori i quali, avendo ricevuto un’educazione stringente e rigorosa all’uso di quella che gli è stata additata come “lingua italiana”, mettono sempre alla berlina la gente più in vista (parlamentari, ministri, uomini e donne di successo) per la loro “alienità”, per la distanza tra la loro parlata e la cosiddetta “lingua italiana”.
Io chiamo ciò dittatura dell’incompetenza, poiché questi giornalisti ed attori sono stati assoggettati alla dittatura del buon dizionario, della buona vocalità, alla dittatura di una grammatica e di una sintassi ritagliate su misura. Con tale formazione, quei saputoni non si rendono conto che l’avverbio KE usato al Sud Italia al posto del SE toscano ha lo stesso valore, ed è identico al KI campidanese (segno di una Koiné mediterranea plurimillenaria). Parimenti, quei giornalisti sono lungi dall’avvertire d’essere immersi nel brago dell’ignoranza allorché criticano la gente del Sud Italia per il fatto che “maneggiano male” la sintassi italiana. E non sanno che la sintassi “italiana” ricalca la falsariga della sintassi latina (la sintassi del latino ciceroniano), mentre gli Italiani del Sud, eredi della lingua greca, non subirono mai una sintassi così rigorosa e limitante, visto che l’antica lingua greca preferì la massima libertà d’espressione, la quale spessissimo si risolveva, persino nei massimi scrittori antichi, con forme sintattiche molto simili a quelle dell’attuale inglese, saltando a pie’ pari le forme congiuntive e condizionali. Imporre a quelli del Sud una grammatica e una sintassi ancorate al latino, è una violenza.
La purezza della lingua. Il campidanese rustico. I due paragrafi precedenti sono legati in certo qual modo alla “purezza della lingua”, la quale a sua volta non può scindersi da tutte le considerazioni sin qui fatte in questa premessa metodologica. Stiamo imparando che i dotti che pretendono padroneggiare la questione della purezza sono molti ma alquanto impreparati.
Paradossalmente, Wagner fu il più grande scopritore della “purezza” sarda. Dico paradossalmente, perché anche lui fu legato alla moda prevalente di chi vuole abbandonare le lingue minori alla libera invasione da parte delle lingue dominanti, senza alcuna cura di proteggere il patrimonio storicamente costruito nei millenni. Oggi migliaia di parole inglesi s’introducono nella lingua sarda, nella lingua italiana, nelle lingue non più egemoni nelle faccende internazionali. L’inglese è fenomeno che tarla da 60 anni. Ma l’italiano tarla il sardo da 3 secoli. Certamente le accademie (ad esempio la Crusca) hanno fatto del loro meglio per scacciare il tarlo dalla propria lingua. Ma sono voces clamantis in deserto, nel bene e nel male. Epperò è una fortuna che l’Italia abbia una accademia. Mentre la lingua sarda non ha alcuna protezione accademica (mi rifiuto di chiamara “accademici” gli attuali linguisti delle due Università sarde). La Sardegna non è Israele, che difende la propria lingua ed i propri vocaboli con tutti i mezzi possibili: fare buona politica significa anche questo. Ma occorre attenzione e distinzione, poiché Israele fonda la propria accademia con degli scopi peculiari. Noi in Sardegna, se vogliamo puntare a una nostra “Crusca”, dovremo farla operare solo ed esclusivamente nel vasto e fruttuoso ambito che ho tracciato in tutti i paragrafi precedenti. Altrimenti quell’accademia produrrà soltanto… crusca.
Il mio compito di etimologo non può affatto prescindere dalla difesa del patrimonio linguistico consolidato dai Sardi. Nel far ciò, mi sono chiesto quale sia il patrimonio da difendere e quali vocaboli spuri da “rispedire al mittente”. Anch’io ho dovuto fare una scelta, cominciando ad espellere dal Dizionario del Wagner 690 voci, che ho messo a disposizione, per il controllo da parte del lettore, nell’Appendice a questa premessa (v. infra).
Di questo “taglio” (pari al 10% dei lemmi trattati dal Wagner) mi assumo piena responsabilità. E dichiaro, addossandomi anche qui la responsabilità, che lo smalto della lingua sarda con tale operazione non è stato del tutto rilucidato. Rimangono ancora delle opacità. In quest’ottica, mi sono assunto la responsabilità di dichiarare come accatti almeno il 15% tra i vocaboli da me risparmiati entro il corpus del Wagner e trasferiti entro il mio Dizionario. E così siamo al 25% dei lemmi che furono accolti dal Wagner e da me rifiutati (o accettati col marchio). Insomma, io dichiaro accettabili nel patrimonio consolidato della lingua sarda soltanto i ¾ dei lemmi proposti dal Wagner, oltre a qualche migliaio di voci sinora indagate per mio conto.
A giustificazione dell’operazione da me condotta, dichiaro di ritenere assurdo l’introdurre in un vocabolario le voci spurie, appartenenti più propriamente a un altro vocabolario. So perché Wagner le introdusse nella lingua sarda: egli le considerava acquisite dall’uso sardo. Ma è proprio a questo punto che s’erigono le barricate e si scatenano i conflitti. Un conflitto che non si placa barattando la percentuale degli accatti (mille in più, mille in meno, come dire che Wagner avrebbe sbagliato per eccesso o per difetto): non siamo al mercato delle vacche. Io dichiaro che Wagner eccedette per una ragione ben precisa: la sua conoscenza diretta della lingua sarda parlata dalle genti paesane e montagnine era poco profonda. Voglio dire che Wagner peccò d’ignoranza (nonostante la sua grande erudizione), non avendo indagato a sufficienza la lingua sarda, ed avendo tralasciato l’indagine diretta in numerosissimi villaggi. Ciò si evince anche dal DES, dove egli cita come fonti dirette meno di 40 villaggi, quelli un tempo serviti da strade percorribili con mezzi a motore. Ne rimane fuori il 90%.
Per intenderci, Wagner svolse la seguente operazione: prima dell’indagine diretta trasferì nel DES tutti i vocaboli acquisiti (e tradotti) dai suoi predecessori nelle loro indagini, in qualsiasi forma condotte. Per il campidanese egli acquisì, oltre ai lemmi delle Carte Volgari, tutto il Dizionario del Porru, senza tener conto che Porru, cent’anni prima, aveva già infarcito per suo conto il proprio Dizionario con una gran massa di vocaboli italianeggianti. Questo fu il primo errore del Wagner, poiché il Porru non aveva infarcito il Dizionariu con gli accatti liberamente adottati dagli indigeni. No, non lo aveva fatto. Porru aveva infarcito la sua opera di voci italiane scelte da lui (non dal popolo) con l’intento ideologico di spurgare la parlata campidanese dai vocaboli che considerava troppo rustici o popolani. Porru fece un gigantesco errore metodologico, una “pulizia etno-linguistica” che io ho già denunciato al cap. 1.1 della mia Grammatica Storica; a sua volta Wagner trasferì nel DES quel macroscopico errore, nonostante che ne fosse avvertito, poiché il Porru aveva dichiarato esplicitamente il proprio intento nella prefazione al Dizionariu.
Potrei continuare indicando le altre fonti del Wagner, anch’esse nutrite d’inserimenti spuri ed ideologici, sia pure non dichiarati con sicumera secondo lo stile del Porru. Davanti a tale sfacelo metodologico, mi è stato forza intervenire sul Wagner con tagli o esplicite avvertenze.
Oltre agli italianismi, Wagner introdusse nel DES anche numerosissimi catalanismi e spagnolismi. Molti di questi sono accatti (valutabili al 15% dei lemmi del DES). Ma qui è più arduo stabilire se l’accatto sia stato operato dal parlante sardo, oppure sia stato Wagner ad aver forzato la situazione, inserendolo nel DES con atteggiamento ideologico, replicando il comportamento ideologico del Porru. Infatti sappiamo con quanta protervia Wagner sostenne che la lingua sarda fosse stata iberizzata fino al midollo. Il suo “derivazionismo” filo-iberico non è accettabile, e l’ho già dimostrato e discusso in alcuni dei paragrafi pregressi, specialmente in quello intitolato “La pregiudiziale iberica”.
Al riguardo, l’unico grimaldello in grado di evidenziare, schiavare e mettere “con le spalle al muro” i troppi accatti del Wagner è la considerazione che l’indagine fatta dal Wagner sulla lingua sarda partì sempre dalle città, specialmente da Cagliari quale “capofila” del Campidano meridionale; Oristano quale “capofila” del Campidano centrale; ed anche Nuoro come “capofila” della parlata nuorese. Una cartina di tornasole privilegiata, per lui, fu sempre Alghero per la testimonianza della pervasione catalana sulla lingua sarda. Operazione scorretta, quella di Alghero. Ma furono scorrette anche le altre “basi” di partenza, che invece per lui costituivano dei veri capisaldi culturali, le fonti da cui la lingua sarda s’irradiava contaminando il contado, il mondo dei villaggi, il mondo delle montagne. Un’operazione, la sua, che fu esattamente contraria a quanto una indagine scientifica sulla lingua sarda avrebbe dovuto fare. Questo è almeno il mio parere.
Infatti, tenuto conto che la lingua sarda esiste viva e vegeta da almeno 40.000 anni grazie al diuturno uso dei montagnini, dei pastori, degli agricoltori, pretendere di considerare le città (specie quelle costiere) quale base d’irraggiamento della lingua sarda verso l’interno significa dimenticare che le città furono prese e ripopolate ab imō dapprima dai Romani, poi da Pisani e Genovesi, poi dai Catalani, poi dagli Spagnoli, poi dai Torinesi e dagli Italiani. Wagner non tiene conto che furono invece le città a ricevere volta per volta la genuina linfa dell’autoctonia da is biḍḍáius, dai biḍḍíncuri che via via le ripopolarono di elementi genuinamente sardi, scacciando gradatamente, se non tutti, almeno parte degli elementi coloniali.
Oggi non è più tanto facile, se non in pochi casi, distinguere tra accatto operato dai Sardi e accatto operato dal Wagner. Però nel mio Dizionario ho tentato – molto prudentemente – di farlo. C’è peraltro un macro-elemento che aiuta la mia cernita ed àncora la mia indagine alla procedura scientifica: è l’elemento del “campidanese rustico”, patrimonio prezioso che spesso è testimone dell’antichità (e sardità) del vocabolo. Wagner distingue spesso tra “campidanese” e “campidanese rustico”. Fa questa distinzione nella presunzione che il prototipo sia sempre quello “campidanese” (la parlata del Campidano di Cagliari), al quale affianca con pari dignità il “cagliaritano” parlato in città. Insomma, la parlata del Sud viene da lui tripartita, e da tale operazione si apprende che il “campidanese rustico” per Wagner rimane sempre un sotto-tipo, un elemento corrotto, una dimensione retrograda vissuta da gente poco capace di fare la storia di una lingua.
Io, come si è visto, la penso al contrario del Wagner, anche se nel presente Dizionario ho preferito spesso intruppare sotto l’unica qualifica “campidanese” i lemmi marcati dal Wagner come “campidanese rustico”. Tenuto conto che il cosiddetto “rustico” ha inflessioni particolari, difficili da rendere graficamente (specie per San Vito), ho evitato di scrivere gli strani caratteri usati dal Wagner, poco utili alla percezione da parte del lettore. Ho preferito invece scrivere quei vocaboli come ho scritto i consimili del Campidano di Cagliari, senza contrazioni né “colpi di naso” (operazione che ho replicato anche quando ho dovuto evitare i “colpi di glottide” del nord-Barbagia). Il fatto che la maggior parte dei vocaboli sarrabesi e gerreini siano condivisi anche dal Campidano di Cagliari (poiché condividono le stesse radici), può considerarsi quasi sempre una reciproca garanzia di autenticità. Nei rari casi in cui il vocabolo appaia solamente come “campidanese rustico”, a maggior ragione l’ho registrato per la sua preziosità. Tutto ciò è bastante per un etimologo.
Tutto quanto precede, però, sarebbe stato incongruo dirlo per la difesa della lingua italiana; tanto più incongruo lo sarebbe per la difesa della lingua inglese, oggi dominante nel mondo. Le lingue, purtroppo, non convivono tutte paritariamente. Non è vergogna ammettere che tra di esse c’è una scala, e la lingua dominante tende inesorabilmente a comprimere, erodere, annebbiare, sminuire, infine abolire la lingua minoritaria contigua. È un po’ lo stesso fenomeno della foresta. Le piante nobili sono tali perché crescono sotto la protezione del sottobosco. Ma poi s’evolvono, superano in altezza il sottobosco, ricoprendolo infine con una vasta chioma. È quindi il sottobosco ad essere dominato e “tenuto a bada”, quando non impoverito per l’assenza della luce catturata dalla chioma dominante.
Fuor di metafora, va detto che una lingua minoritaria non ha bisogno di una vaga “liberta”, impossibile da gestire al confronto con le lingue egemoni; ha bisogno invece di protezione (da non configurare come una campana di vetro!). Pertanto sono da condannare sotto ogni punto di vista le assurde “libertà” cui le sottopongono certi dottori in Lettere, i quali hanno della lingua (di qualunque lingua) una nozione gracile e bettolesca, priva di rigore scientifico. A maggior ragione le lingue minoritarie sono nemiche di ogni tipo di slang, poiché l’invenzione dello slang da parte di buontemponi incapaci di mettere a valore il proprio tempo libero, è perniciosa, deleteria. Infatti lo slang viene orecchiato e imposto proprio dai parlanti meno motivati all’uso e alla salvezza del “thesaurum”.
Il “thesaurum” della lingua sarda c’è, è cospicuo, è saldamente ancorato a radici plurimillenarie che ancora oggi si lasciano esattamente comprendere. Andare a inventare di sana pianta forme “sradicate” (lo slang, appunto) è operazione demenziale che porterebbe prestissimo alla sparizione della Lingua. Lo slang medesimo è di per sé una miserrima operazione anti-culturale prodotta da chi non ha alcun amore né rispetto per la cultura, da chi, per intenderci, ha già resecato il cordone ombelicale con la lingua-madre e di essa si fa sarcasticamente beffe con segni di dispregio e di commiato definitivo.
L’ortografia sarda e sa Limba Sarda Comuna. Nella lingua inglese esistono circa 40 suoni fondamentali, ma le forme ortografiche per rappresentarli sono oltre 500; non è un caso che i bambini inglesi siano molto più soggetti di quelli italiani alla dislessia: un disturbo neurologico non da poco. La complessità del sistema di scrittura anglosassone rende incapaci molti residenti di leggere e comprendere un intero scritto pur comprendendo ogni singola parola. In Italia la situazione è notevolmente migliore perché la differenza tra pronuncia ed espressioni ortografiche è meno astrusa, e semmai capovolge il rapporto numerico.
La Sardegna, dopo 1000 anni di anarchia ortografica, si pone soltanto oggi il problema del rapporto tra espressione fonica e corrispondenza ortografica, e con le regole della LSC (Limba Sarda Comuna) vorrebbe mirare a semplificare ulteriormente, rispetto all’italiano, il rapporto suoni/ortografia. Senza però riuscirvi appieno. Infatti il sistema LSC incorpora parte del sistema italiano (e parte del sistema spagnolo), lasciando nel caos – per fare un esempio – la grafia delle velari e delle palatali. In questo Dizionario il mio sistema tenta di sanare almeno in parte quelle discrasie normative della LSC.
A scanso di equivoci, avverto il lettore che i singoli lemmi del mio Dizionario non vengono scritti utilizzando i caratteri fonetici internazionali (i quali sommano a circa 300), anche perché essi mancano sulla tastiera del computer e comunque genererebbero nel lettore più confusione che rilassatezza. In omaggio a Wagner, concedo eccezionalmente alle dentali sonore sarde l’espressione grafica -ḍḍ-. I miei lemmi sono di regola scritti con i pochi caratteri storicamente attestati nel Mediterraneo centro-occidentale, al fine di agevolare il lettore a capire istantaneamente la parola espressa, evitandogli d’impelagarsi in un sistema tecnico inventato dai fonetisti, del quale è destino che siano gli stessi fonetisti a rimanerne fruitori unici. Ho inoltre scelto, stavolta in omaggio al sistema della LSC, di non scandire i lemmi col sistema accentuativo internazionale (quindi non in-kendere ma inkèndere; non inkime-rare ma inkimerare).
Il sistema grafico da me adottato, disancorato dalla pletora delle grafie internazionali (e con l’occhio indulgente alla ridotta disponibilità della tastiera), si trascina pur sempre delle imprecisioni residue. Ma questa maledizione perseguita anche i grammatici di buona volontà, non essendo tecnicamente possibile ridurre a tre decine i 300 caratteri fonetici, senza che ciò comporti delle “sbavature” grafiche rispetto alla pletora dei suoni idiomatici, che in Sardegna superano largamente i 30. Ma spero di avere proposto, rispetto alla LSC, un numero di caratteri che, per quanto pari a quelli della LSC, giungano a un climax più equo, tale da permettere all’utente di comprendere meglio il testo sardo, senza alcun disturbo percettivo.
Termino le avvertenze sulla grafia con un cenno alle consonanti rafforzate (le doppie). La LSC tende a renderle tutte scempie, salvo eccezioni che rendono ondivaga la scelta, dal momento che prende a modello le forme latine ed al contempo se ne libera a piacere, senza criterio. Notiamo che la LSC giustifica la sua originale “aspirazione alla semplificazione” con (non meglio chiarite) “esigenze etimologiche”. Esprimo sconcerto dinanzi a quelle affermazioni, dal momento che la fonte etimologica della LSC rimane saldamente ed unicamente il latino, il quale peraltro nel proprio sistema contiene sia le scempie sia le doppie.
Al riguardo ho ampiamente fatto osservare in questa premessa metodologica che delle etimologie, in Italia e in Sardegna, è stato fatto un autentico vituperio. Anche sulla vicenda delle scempie/doppie sarebbe ora di stendere un velo pietoso.
Tocca a me, a questo punto, dichiarare responsabilmente la mia scelta al riguardo. Ebbene, al contrario della LSC, dichiaro di utilizzare le doppie, ma limitatamente ai momenti in cui ciò serve veramente. In tal guisa, spero che la mia scelta non presenti alcun carattere ondivago, avendo legato le eventuali doppie al vero etimo della voce. Per l’occasione ho tenuto conto di un fatto a un tempo storico e tecnico, ossia che le doppie, almeno nella tradizione italiana, sono spessissimo il risultato dell’incontro di due consonanti differenti appartenenti a sillabe differenti (es. -c-t-, -p-t-, -d-c-). Tale ragione storico-tecnica m’induce a non sottovalutare la tradizione scrittoria dell’italiano, dalla quale attingo fintanto ch’essa non debordi dal quadro di coerenza appena citato.
Peraltro nessuno ha mai criticato l’uso di scempie e doppie fatto dal Wagner (un uso anch’esso trascurato, quindi ondivago). Come unico esempio indicherei fittianu, che in base alla vera pronuncia ed in base alla vera etimologia deve essere scritto fitianu.
Presento di seguito l’elenco dei 30 segni grafici da me adottati. Parecchi di questi meritano delle precisazioni per i problemi che pongono alla lettura dei testi in lingua sarda.
Elenco: A, B, C, D, E, F, G, GH, GL, GN, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, SC, T, U, V, X, Θ, Z, TZ.
Precisazioni
1) Il segno B non si presta a molte varianti, tranne che nel logudorese settentrionale e specialmente nel sassarese, dove esprime non soltanto la /b/ vera e propria ma anche molte voci dove la /b/ s’avvicina alla /v/ e spesso sosta in una terra di mezzo, svanendo in una spirante bilabiale appena soffiata (quasi come fanno i cubani per pronunciare La Habana).
2) Il segno C
Wagner usa questo segno, espresso però con /č/, soltanto per indicare la consonante palatale o comunque per esprimere la consonante seguita da vocali palatali. Esempi: dίccia (che Wagner scrive dίčča), dispacciare (Wagner: dispaččare), ciorixeḍḍa (Wagner: čorižèḍḍa), círcuri (Wagner: čírkuri).
Io, come si noterà, seguo l’esempio italiano, usando c-, -c- sia per le velari sia per le palatali nei vari casi che ora vado ad esplicare:
- anzitutto con c-, -c- marco la palatalità sia della consonante sia della sonante successiva (es. cibíu);
- con c-, -c- esprimo anche le velari nei casi in cui la sonante seguente non sia palatale: es. casu, cosa. Escludo l’uso della c-, -c- per le velari seguite da -u- + sonante (per questo gruppo uso qu-: vai al punto 11).
La mia scelta semplificante ha una ragione storica importante ed unificante, cioè che C è grafema latino di estrema antichità, avente lo stesso valore (ed essendo la semplificazione grafica) del gr. K. Non solo, C è lo stesso segno della velare ebraica kaph (scritta a rovescio: Ͻ). Quindi la tradizione dell’uso di questo segno è plurimillenaria e mediterranea. Che poi dall’Alto medioevo la C sia usata anche per le palatali, è segno che la cultura latina non sentì mai il bisogno di sdoppiare questo grafema.
3) Il segno D
Tutte le volte che una parola sarda esprime un’alveo-dentale rafforzata, Wagner scrive /ḍḍ/, come in biḍḍa. In ciò ho seguito fedelmente Wagner. In certe sub-regioni o in certi villaggi c’è qualche leggera variazione nella pronuncia della consonante /d/. Wagner lo fa osservare, e pertanto scrive moltissimi vocaboli in -đ- (es. biđale ‘ditale’; io scrivo bidale).
4) Il segno G
È scritto dal Wagner con ğ quando esprime l’affricata prepalatale sonora, come nell’it. gente. Es. gáğğu (Dedola: gággiu). Altre volte è scritto col suono velare sonoro fricativo: es. fóiǥa (Dedola: fóiga).
5) Il segno GH
Viene espresso dal Wagner col segno occlusivo velare sonoro davanti ad e, i: ĝiníperu ‘ginepro’ (Dedola: ghiníperu). Altre volte è scritto col segno velare sonoro fricativo: diǥitale (Dedola: dighitale).
6) Il segno GL
Wagner lo scrive col carattere l’ (palatale, come in it. figlio). Io preferisco l’uso italiano gl.
7) Il segno GN
Wagner scrive /ñ/: es. diñu (Dedola: dignu), diéñu ‘zimbello’ (Dedola: diégnu). Altre volte Wagner scrive n’ (da leggere come in it. vigna). Io preferisco sempre -gn-, perché la -ñ- manca nella tastiera del computer, e perché n’ non appartiene alle tradizioni mediterranee.
8) Il segno J
Questo segno è da me preferito rispetto ad -y- che invece è usato a piene mani dal Wagner. La ragione è semplice: i vocaboli del Wagner in -y- sono soggetti a frequenti metafonesi che li fanno pronunciare con -j- (come j francese o inglese). Di qui la mia preferenza. Es. yáyu ‘nonno’ (Dedola: jáju, poiché la prima semiconsonante in sardo è pronunciata spessissimo -g- come in it. gente).
9) Il segno K
È da me usato per le velari precedenti le palatali /e/, /i/, e soltanto per queste. Ciò per non sottostare al doppio carattere italiano ch- -ch- preferito invece dalla LSC. La mia preferenza è in linea con l’identica pratica dei condaghes e di altre carte antiche della Sardegna. Peraltro questa scelta rispetta la natura velare del carattere, nonché l’identico uso presso gli anglosassoni.
A sua volta Wagner, nell’esigenza di evidenziare qualsiasi tipo di velare, usa largamente la /k/ davanti ad ogni vocale; quindi kaduffu (Dedola: cadduffu), kasu (Dedola: casu), kena (= Dedola), kida (= Dedola), kokka (Dedola: cocca), kras (Dedola: cras), kunnu (Dedola: cunnu), kuḍḍu (Dedola: cuḍḍu).
10) Il segno L
Oltre agli usi normali della grafia italiana, questo segno è da me proposto talora nell’uso sassarese con grafia Ł, ł, ogni qualvolta io intenda esprimere la /L/ fricativa laterale, quella che precede -t-, -d- esplodenti dopo il “fregamento” laterale della lingua (v. fałta, fałdetta). Gli stessi grafemi sono da me utilizzati, sempre per il sassarese, per esprimere l’incontro di -r-t- o -r-d-; es. lardu log. e camp. ‘lardo’, sass. lałdu.
11) Il segno Q
Intendo fermamente proseguire nell’uso di Q, nonostante che le norme della Limba Sarda Comuna (ed. 2013, p. 17) lo vietino favorendo al suo posto lo spagnolesco C (es. cuadru, cuatru, ácua). La velare Q si trova primamente nell’uso delle lingue semitiche (accadico etc.: le quali addirittura hanno quattro segni per distinguere quattro velari: q, k, ḫ, ḥ); poi la stessa Q si ritrova nell’uso latino, e passa nell’uso grafico italiano. Ciò basta ed avanza per rifiutare l’imposizione della LSC, che va nella direzione di nobilitare acriticamente la moda spagnolesca inaugurata partigianamente dal Wagner.
12) il segno S
L’orecchio del Wagner era indubbiamente addestrato a percepire le minime differenze fonetiche. In tal guisa, il vocabolo da me scritto sderroccái da lui è scritto śderroccái (ś alveolare); il vocabolo da me scritto dismajare è scritto da lui diśmayare. (Per meglio comprendere la y del Wagner vai a j).
13) Il segno SC
Wagner scrive sempre š. Io ho preferito la complicata sc, sci (all’italiana). Quindi: Wagner šorroccái (fricativa dentale), Dedola sciorroccái; Wagner šorái, Dedola sciorái. Peraltro š non esiste sulle mormali tastiere del computer.
14) Il segno X (= gr. χ)
Giusto l’ampio uso fàttone dal Wagner, c’è bisogno d’introdurre questo grafema al fine di rendere meglio i suoni del dialetto sassarese, che del grafema hanno bisogno per esprimere il log. o sd. -rc-, -sc-. Quindi: log. barca → sass. baχa; log. áscamu → sass. áχamu.
15) Il segno X (= fr. j)
Wagner lo rende con ž-, -ž- (es. čorižèḍḍa, ážina), mentre io preferisco la -x- (es. čorixèḍḍa, áxina). La mia preferenza è dovuta al fatto che da parecchi secoli in Campidano si usa la grafia -x-, ed inoltre quest’uso è identico a quello degli Etruschi; storicamente è tramandato anche dai Catalani. Quindi nel Mediterraneo questo carattere non fu affatto sconosciuto, e non c’è bisogno di sostituirlo con una innovativa ž, peraltro inesistente sulla tastiera del computer.
16) Il segno T
Anche questa esplosiva interdentale, che sembra pulita e inconfondibile, in Sardegna presenta qua e là qualche variante fonica che la riconduce agli usi da me raggruppati sotto il segno θ. Vedi le alternanze rilevabili per uno stesso omo-semantema, quale sd. tanda/tzanda ‘papavero’; sd. tumu/gr. θύμος ‘timo; sd. tura < sum. zur ‘nerezza’.
17) Il segno Θ
Segno greco introdotto da Wagner per distinguere certi fonemi appartenenti ad unica radice, da lui espressi variamente per le varie sub-regioni coi simboli tz, z, zz, th, tt. Esempio: aθθéθθu (Bitti, Nuoro, Dorgali), θénθu (Baunei), distinti da atténtu, attéttu log., atzentzu (S.Lussùrgiu), séntzu camp. ‘assenzio’ (Arthemisia absintium). Wagner con la lettera θ volle indicare l’esplosiva dentale simile alla th inglese. Ho accettato di scrivere la θ quasi le stesse volte del Wagner, pur non condividendo la sua rigorosa esigenza distintiva; esigenza peraltro non necessaria, bastando volta per volta l’uso di una o dell’altra consonante da me qui riprodotte per esprimere la reale pronuncia espressa nelle singole sub-regioni.
18) Il segno Z
Indica esclusivamente la z-, -z- sonora come in ziru ‘orcio, giarra’, eventualmente rafforzata (-zz-) come in azzu ‘aglio’. Wagner la esprime con dz-, -dz-, rafforzata in ddz-, -ddz-.
19) Il segno TZ
Indica esclusivamente la tz-, -tz- sorda (in italiano: z- -zz-) come in tzaccare ‘fendere, spaccare’, o atzárgiu ‘ferro, acciaio’.
La tz (esplosiva dentale sorda) è stata espressa nella lingua sarda in vari modi, anche con i caratteri ts: vedi log. ant. dirittsadores (Stat. Castels.: diriçadores). Sembra che Wagner prediliga proprio la forma ts, tts, con la quale egli ha scritto moltissimi vocaboli da me espressi invece con la tz.
APPENDICE: Elenco lemmi del D.E.S. esclusi dal No.F.E.L.Sa.
Abate, abbáttiri, applikare, appoggiai, apporkai, apostadamente, appraniare, appresare, appretziare, appuntare ‘cucire leggermente’, aranguitzu, arantzu, arkette, arkibusu, arcione, ardidu, arengu, arghentu, arghidda, arguire, argudzinu, arma, armigoddu, arrabbiare, arrancare2, arrapillai ‘ripigliare’, arrappiare ‘rapire’, arrecabai ‘ricavare’, arrefa, arregordai, arrembumbare, arremusulla, arrèndirisi, arrenomenai ‘nominare’, arrepentire, arrivare, arritzare, arruffare, arrughire, arrustire, arte1, ascultare, ásinu, asma, asperges, aspersorio, aspettare, aspu (e naspu), assaltare, assazzare, assembrare, ássidu ‘acido’, assistere, assuntu, asta, astile, ástiu, astutu, asurru ‘azzurro’, ascendere, ascensione, asciugare, asciuttu, asuttu, attaccare, attediare, attenticare, atterrire, attilladu, attuffare, atturdire ‘stordire’, ausente ‘assente’, autu ‘atto’, avarìa, avaru, avemaria, avidu, avvalirisì, avvértere, atzéndere, azzuttare ‘aiutare’. Totale 81
Baccánu, bagamundu, baia, baiu, balaustru, baldanza, baleriana, balire ‘barile’, balordu, baluardu, banchina, baraunda, barbaridadi, barbéri, barbugliai, bardadura, bardottu, barella, bártziga (gioco di carte), basìlica, bassottus, basta, bastarda, bastardu, bastimentu, bastinu, battazzu, báttere, battéu, beccàccia, beffa, belare, belladonna, benignu, benzìna, berrùga ‘verruca’, bessare ‘versare’, béstia, beta ‘bietola’, bicicletta, bidriólu ‘vetriolo’, bile, bìglias ‘biglie’, binistra ‘ginestra’, biscottu, bisquadru, bistorinu ‘bisturi’, bistrattare, bizzarru, blandu, blusa, bóccia, boda ‘botte’, boga (pesce), bomba, bonatza, bòo, borbottare, boscu, botta ‘colpo’, bottáju, bravata, bravu, brίcola1, briglia, brindare, brogliatzu ‘brogliaccio’, bróu, bruncu1, brunu, bruscu, bùccia, búcculu, bugliólu, bùiu, burdellu, burdone ‘contrabbasso’, buriàna, burίnu ‘bulino’, burò ‘canterano’, burrasca, burru ‘gioco di carte’, burtsu ‘polso’, buttìglia. Totale 80
Cabanna, caffè, calafattare, calamari ‘calamaio’, calamidade, calancà (sorta di tela), caldaròne, caldu ‘brodo’, calìgine, calma, calmúk, calòre, calùra, calvu, caltzare1, caltzettéri, caltzoláju, caltzones, camúsciu ‘camoscio’, canavácciu, cannétu, cannocciale, cantârida ‘cantaride’, caparra, capigliè, capitanu, capòccia, cáppara!, cappella, cappellanu, cappone, cappuccínu, carabinéri, caramella, cárdine, carésima, carestìa, caríssia ‘carezza’, carreyone ‘carnagione’, cartúccia, casacca, casána, cáspita, cassarola, càssula, castorru ‘cappello di castoro’, cáttara!, cautela, cavessa ‘cavezza’, céfalu, centáura (Centaurium), cérnia, cértu ‘certo’, cicculatta, cimitériu, cinematόgrafu, cipressu, ciuffu, ciurma, cognakki ‘cognac’, collana, còllera, colore, colostru, comunigare ‘comunicare’, congeniái ‘convenire’, coniurare, conkistare, conservare, contentu, contestura, controvérsia, coraḍḍu ‘corallo’, corággiu, coroḍḍa ‘corolla’, corrèggere, corrugái, coscίnu ‘cuscino’, crésima, crespu ‘tela di seta’, criantza, cricca2, cricca3, crίmene, crine, crista, cristallu, cristèle ‘clistere’, cristianu, Cristu, crosta, cuaglia, cuartu, cubare ‘covare’, cullega, culpa, cumbattàre, cumbáttere, cumpagnu, cumparare, cumprèndere, cundennare, cunduttu. Totale 110
Damascu, dantsare, debusciau, deféndere, déntike ‘dentice’, determinare, devastare, dilúviu, din ‘danaro’, discípulu, discretu, dispéndiu, dispettu, donzella, dossu ‘dorso’, dottrina, duana ‘dogana’, dulcamara. Totale 18
Ecclisse, èdera, érpice, escluíri, esécuias, esigíre, esímere, espressare ‘esprimere’, estínghere, estremuntsiòne, evangéliu. Totale 11
Faccenda, fagottu, falcone, fangu, fantasma, farina, fellone, feluga ‘feluca’, fiancu, fiera, fiducia, filone ‘astuto’, flanella, flemma ‘spurgo del catarro’, fléttere, fluíre, fluttu, folada ‘folata’, fonte, forgiái ‘foggiare’, forma, formica, frana, frángia, frotta, fundare, furtu, furúnculu, fuscu. Totale 29
Gábbia, gabella, gabellottu, gaḍḍína, galibardìna (varietà di gallina), gagliardu, garitta, gasetta ‘gazzetta’, gelosu, gentziana, ghiácciu, ghirlanda, giallu, giarrettéra, giassintu ‘giacinto’, gilè (relativo a un gioco di carte), girándula, giubiléu, glòria, gobba, golfu, gonfalone, graduare, graffiare, gressinu ‘grissino’, grida, gríglia, grillu, grúccia, grúe (uccello), grumma, grumu, grunda, gualdrappa, guante ‘guanto’, guarnire, guastare, guérciu, gúmena. Totale 39
Imbastire, imbáttere, imbidai ‘invitare’, imbraga ‘imbraca’, impedire, impiastru ‘cataplasma’, impicciare, importunare, imposta ‘tassa’, impostore, impostura, improverare ‘rimproverare’, imputare, incabigliare ‘accapigliarsi’, incarnadu ‘incarnato’, incastrare, inclinare, inclúiri, increadu, incuadernare, incensu, ìndigu ‘indaco’, indìvia, infermedadi ‘malattia’, insalada, intantu, intempèrie, intermesu, intimare, inzegnéri, isbáttere, isbirru, iscansìa, iscartafógliu, iscartare, iscassu ‘scarso’, iscátula, isciallu, isfarzu ‘sfarzo’, iskeda, iskiera, iskiffu, iskitzare, ismarrire, isopu ‘santoreggia’, ispásimu, ispilórciu, ispinatzu ‘spinacio, spinaci’, ispinette ‘spinetta’ (strumento musicale), ispitale ‘ospedale’, isprolokkiare, ispuntare ‘spuntare’, istabilire, istincu, istίtigu, istivare, istoccu ‘stocco’, istrapatzare, istrappare, istrapuntu ‘strapunta’, istraviare ‘togliere dalla via’, istringa, istufare, ίsula, isvalorire, iumentu, iustu. Totale 80
Kidru ‘cedro’, kimera, kìmighe ‘cimice’, kina ‘chinino’, kìnghere ‘cingere’, kintàna ‘quintana’, kitáde ‘città’. Totale 7
Labare ‘lavare’, lambiccare, lanterna, lapida ‘lapide’, lastra, latrina, latta, lavamanu, lavandinu, legùmene ‘legume’, leίtimu, letanìas, lìnia ‘linea’, lίttera, lizzadru ‘leggiadro’, lordu, lucru, lupu, lusingare, lustrare, luttare, luttu, luttsu ‘luccio di mare’. Totale 23
Magestade ‘maestà’, malandrinu, mandίbula, mangerίa, mániga, manovra, manzu, marcurella ‘mercorella’, maretta, margherita, mariólu, marionetta, marmotta, marramáu, martsapane, massacru, masserίtzia, masticare, mattone, mattutίnu, mélica ‘medica (erba)’, melissa, mendicare, mendίgu, mentirosu ‘bugiardo’, merenda, mermelada ‘cotognata’, méru ‘puro’, mèsse, méstruu, minestra, moda, molare (dente), mòrdere, morίa, muččačča, muffa, mustarda. Totale 38
Natzione, negare, negru-de-fumu ‘nerofumo’, nervόsu, néspula. Totale 5
Oca, occiales, odore, offèndere, olfátu, onta, όnus ‘peso, carico’, opprίmere, ordίre, orίna, òrma, òro, osare, òstia, ostinare, ottanta, ottòbri. Totale 17
Pa ‘bacio’, pacotίglia, paccioccòne, padiglione, paèse, palitsada, páncia, paòne ‘pavone’, pappagallu, parággiu, paralίticu, paramánu ‘nettatoio dei muratori’, parente, parláta, parrocchiánu, passatiémpu, patata, pattúglia, paúra, pérgula, Perú, piastra, picocuán(n)a ‘ipecacuana’ (radice di pianta americana), picciòne, pidemìa ‘epidemia’, pioppu, pipίta de sant’Ignátsiu (albero), pistòla, pitanza ‘pietanza’, placca, placare ‘intarsiare’, impiallacciare’, porru (Allium porrum), porta, portante ‘ambio’, portare, posare, postitzu ‘posticcio’, precettare, prelatu, prevaléssiri ‘prevalere’, primavèra, prim(m)èra ‘primiera’ (gioco di carte), priváda ‘cesso’, prostrare, provulòne, prúa, prudíre ‘aver prurito’, puéstu ‘posto’, pugnale, pula, pulcinella, puntale, puntéḍḍu ‘puntello’, puttsolána ‘pozzolana’. Totale 56
Rampa, rapίna, rappare ‘tosare’, rastréllu, reale ‘schietto’, rebárbaru ‘rabarbaro’, recúsa ‘ricusa, rifiuto’, rédina, redingottu ‘cappotto’, refittulèra ‘che lavora nel refettorio’, repente, rettsètta ‘ricetta’, risu (cereale), ròdere, ròre ‘rugiada’. Totale 17
Sabadίglia (erba esotica), sábia, salámu ‘salame’, saldare, salsa, sandália ‘sandalo’, sangrare ‘salassare’, satanassu, sciábica, sciacca-méndula, sceša (lettera x), scumbru, sériu, siática ‘sciatica’, sigillu, silίssiu ‘cilicio’, sòttanu. Totale 17
Tabaccu, taccágnu, taccòne, tafanáriu ‘sedere, deretano’, taffettánu ‘taffettà’, taitái, talèa, taléntu, talίsu, tan, tángheru, tassa ‘imposizione’, tassellu, tassu (Taxus baccata), tatà ‘bussa, percossa’, tèndine, tentazione, terna, terraplénu, tertzu, tesòru, tèssera, testa, tikki (tic), timbru, timòne, tinca, tipu, toppa, torbadu (torbato), tòrcia, tortu ‘torto’, tòtanu ‘totano’, tramuntana, trankillu ‘tranquillo’, trapassare, trementina, trikkitracca, trot(t)a, truffare, truppa, tulipani, turba, turbare, turrione ‘torrione’. Totale 40
Úlcera, últimu, úmidu, úmile, usùra. Totale 5
Vakketta, vagare, variare, vassallu, vata (voce sospetta), vendicare, ventágliu, viola, visu2 ‘faccia’, visúra ‘visura (di atti)’, vittu, volante (lakkè), vueccelléntzia ‘vostra eccellenza’. Totale 14
Zambayòne, tsipolla ‘nodo del legno che è a spicchi come la cipolla’. Totale 2
Totale generale: 690
ISTÉRRIDA METODOLÒGICA A SU “NOU FAEḌḌARZU ETIMOLÒGICU DESSA LIMBA SARDA” de Barore Dedola
I venticinquemila lemmi di quest’opera analizzano mediante la tecnica etimologica l’origine di altrettante parole. L’elenco arriva abbondantenente a un quarto dei 90.000 vocaboli inseriti nel più completo dizionario della lingua sarda, quello di Mario Puddu. Il mio scopo, evidentemente, non era di eguagliare i numeri del Puddu; invece ha inteso ricalcare uno per uno, e riesaminare ab imo, i lemmi trattati da Max Leopold Wagner nel “Dizionario Etimologico Sardo”, aggiungendone altri la cui analisi è già stata resa nota nella mia “Collana Semitica”.
Un’opera linguistica non si misura a numeri ma a contenuti. Peraltro l’opera del Puddu è diversa: egli ha ottimamente raggiunto lo scopo di ogni completo e buon “dizionario dell’uso” ed ovviamente non ha affrontato la questione etimologica; mentre il mio lavoro non solo dichiara nel titolo lo scopo etimologico ma lo assume a pivot dell’intera opera.
Sinora nessuno al mondo aveva studiato massivamente le etimologie del vocabolario sardo, salvo Max Leopold Wagner (stando almeno alle sue dichiarazioni). A parte sta l’impegno “classicista” di Giulio Paulis sulle voci pertinenti alla flora, al quale ha fatto seguire altri sporadici tentativi. Non metterebbe conto citare altri studiosi che ci hanno tentato, poiché i risultati sono stati assai discutibili (Massimo Pittau), o addirittura pessimi (Eduardo Blasco Ferrer); ovviamente non menziono certi altri appassionati, totalmente privi di formazione glottologica e pure di talento.
La revisione totale dei lemmi del Wagner è stata operata per la necessità d’illustrare con metodo più attuale e più incisivo la storia della lingua sarda, che lui aveva tracciato nelle sue opere. Applicarmi a questa impresa non è stato facile da nessun punto di vista, primamente perché si trattava di rimettere in discussione l’opera di un grande; non solo, ma nella discussione ho dovuto coinvolgere, direttamente o indirettamente, i lavori di numerosi professionisti colleghi o precursori del Wagner o che in lui hanno visto un maestro.
Il riesame dell’opera del Wagner non è stato intrapreso soltanto con questo Dizionario: è cominciato anni fa in alcune mie opere, ed ha raggiunto un punto di non-ritorno con la mia Grammatica Storica, intitolata “Grammatica della Lingua Sarda Prelatina”, la quale al cap. 3.1 (Fonologia) riesamina ab imo la Historische Lautlehre des Sardischen (edizione italiana proposta, con commento, da G. Paulis), confutandone uno ad uno tutti i risultati. Va da sé che la dimostrazione della vulnerabilità delle tesi wagneriane e delle stesse leggi fonetiche fondate sulla sua autorità non poteva rimanere isolata: aveva bisogno di quest’opera di completamento che – rivedendo tutti i lemmi proposti dal Wagner – li ricollocasse su un nuovo piano metodologico.
I miei predecessori nelle ricerche etimologiche hanno battuto una sola pista, la quale ha portato a collegare le parole sarde ad una presunta radice latina. Io invece apporto delle prove scientifiche che sconvolgono quel quadro, e dimostrano che il sardo, il latino e le altre lingue mediterranee hanno radici comuni, sono lingue sorelle, le quali vanno ancorate ad una matrice molto più antica, la quale ci è nota, è disponibile ed è facile da esaminare: si tratta del bacino sumero-accadico (con tutte le lingue strettamente legate a quell’ambito).
Penso non sia da addebitare del tutto al Wagner, tantomeno agli etimologisti che gli avevavo aperto la pista, il fatto che sinora nessuna pubblicazione sarda, italiana, straniera abbia raggiunto lo scopo di restituire correttamente l’etimo dei vocaboli sardi. I tempi trascorsi non erano perfettamente compiuti, non consentivano altissime percentuali di dimostrazioni. Invero, dopo oltre un secolo di sforzi e pubblicazioni, è soltanto da un decennio che l’élite dei ricercatori dell’intero orbe terracqueo ha terminato di contribuire al completamento di un’opera di base del linguaggio umano, che è il Chicago Assyrian Dictionary (CAD), un’opera in 25 volumi. Considerando i dizionari sumerici già completati grazie agli apporti di molte università di vari continenti, oggi possiamo dichiarare più agevole qualsiasi indagine storica sulle lingue mediterranee, nonostante che, purtroppo, oltre il 10% della lingua sumerica e di quella accadico-assiro-babilonese non risulti ancora tradotto; senza contare alcune opacità che rendono ancora insicuro financo il linguaggio biblico.
Per queste ragioni sino a un quindicennio fa anche l’etimologista più dotato – persino un sommo come Giovanni Semerano – ha lasciato qualche menda tra le proprie pagine, poiché le Università del mondo intero che già avevavo pubblicato dizionari sumerici o accadici palesavano più di una incertezza nell’interpretare varie voci.
La storia passata condiziona negativamente il metodo. Oggi possiamo ripartire sereni. E tale serenità può giocare finalmente un ruolo determinante, affrancando gli etimologisti da paure, limiti, sospetti e portandoli a riconsiderare più rettamente la complessa storia linguistica del Mediterraneo.
Però, oltre che dell’insicurezza dei dizionari del passato, occorrerebbe esser coscienti anche della futilità delle correnti filosofiche che hanno dominato negativamente sulle vicende degli studi linguistici. Volersene dichiarare immuni sarebbe ingenuo. Dopo la laurea in glottologia, io stesso mi sono dibattuto per 31 anni in un gigantesco garbuglio di problemi linguistici che non riuscivo a dipanare; e fu soltanto dopo aver deciso di “resettare” l’intera questione, riaggiustando i punti cardinali che orientavano il mio pensiero in relazione alla lingua sarda ed alle lingue mediterranee, che ho potuto riconoscere gli errori che bloccavano ogni iniziativa. Quegli errori avevano posto me e, beninteso, anche i miei maestri, in una condizione d’impasse. Mi accorgevo che il lavoro linguistico dei miei maestri, che da me furono seguiti disciplinatamente e senza discussione per 31 anni, era dominato dall’ideologia. Occorreva liberarsi da quella camicia di forza.
Si parla spesso delle correnti filosofiche, alcune delle quali passano nel breve trascorrere di una-due generazioni. Per converso, altre correnti filosofiche non hanno maestri conclamati, e tuttavia sono talmente imponenti da essere rimaste immobili e indiscusse da tanti millenni, divenendo i pilastri dell’intera storia umana. Non ha maestri, ed è immobile da tempo infinito, la “filosofia della superiorità” tra i popoli. Ad essa, come corollario, s’allacciano in modo indistricabile altre mode di pensiero le quali, tutte insieme, compongono una cultura che influisce negativamente persino sugli studi linguistici.
Posso citare, derivati dalla filosofia della “superiorità”, alcuni corollari storici che risultano negativi persino per gli studi etimologici: 1. le invasioni inaugurate dai musulmani “in nome di Dio”, che oggi sono rivitalizzate ad opera di due grandi Stati medio-orientali i quali dal 1945 stanno destabilizzando il Vicino Oriente, la Russia, l’Europa, l’Asia; 2. cito l’atrocità delle Crociate scatenate in nome di un “Dio superiore”; 3. cito le colonizzazioni post-colombiane dilagate negli oceani contro gli aborigeni ch’erano considerati “sub-umani” anzitutto in forza della pregiudiziale religiosa; 4. cito l’Inquisizione romano-ispanica, anzi le Inquisizioni condotte da ogni setta cristiana (e musulmana) nel proprio ambito, in nome dell’intangibile purezza della propria religione; 5. cito l’indegna appropriazione dell’Africa da parte di certi Stati europei, che la governarono “in nome della superiorità razziale”; 6. cito due apocalittiche guerre mondiali, generate ogni volta dall’unico Stato che si vantava del gene della “superiorità ariana”.
I corollari non si limitano a quelli indicati, e comunque sembrano tutti legati “a grappolo”. Nel grappolo rientra anche un tarlo incredibilmente vitale, che ha prodotto millenni di oscurità culturale nell’Occidente. È l’Aristotelismo. La sua scadenza è scritta nei manuali di filosofia, e viene fissata ingenuamente ai tempi di Dante Alighieri. Ma ancora oggi è tragicamente presente, producendo immani disastri ovunque vi sia una Università, ovunque il pensiero ambisca ad assurgere ad Accademia.
Purtroppo sono le Accademie a governare ogni e qualsiasi movimento di pensiero in relazione agli studi linguistici, e sono state soltanto esse ad avere voluto sinora la separatezza degli studi semitistici da quelli chiamati “indogermanici”. A me questa appare una pregiudiziale.
Ognuno di noi vive il proprio particulare subendo, spesso inconsciamente, la forza del pensiero impartito dalle Università. Tutto ciò è umano, è ovvio. Sarebbe assurdo il contrario, poiché le Università sono considerate le “forze armate” della ricerca e del libero pensiero.
Però osservo educatamente che negli studi linguistici oggi dovrebbe considerarsi inaccettabile che uno studioso di una lingua mediterranea ometta di consultare anche i dizionari e le grammatiche antiche della Sponda Sud, ivi compreso il dizionario e la grammatica egizia, poiché oggi dovrebbero essere caduti quei vincoli negativi che, sebbene surrettiziamente, sebbene non ravvisati e tantomeno conclamati, trattenevano ideologicamente gli studi entro le barriere concettuali di malintesi nazionalismi, e addirittura istigavano a negare ex silentio, o ignorare, gli apporti che ogni singolo popolo navigante o transumante ha reciprocamente dato al Mediterraneo fin dal più arcaico passato.
Oggi, finalmente, dovrebbesi dichiarare il declino della “pregiudiziale imperiale”, della “pregiudiziale di superiorità”. Oggi dovrebbe essere normale la condanna del mito “ariano” inventato durante il Romanticismo, che tante menti ha avvelenato, e ancora oggi avvelena sotto-traccia, financo nelle Università, financo tra gli eruditi che si millantano illuminati, quando non “di sinistra”.
Nel campo della glottologia il declino dell’arianismo, se fosse veramente avvenuto come bugiardamente si declama, avrebbe dovuto affievolire quel preconcetto accademico che induce a credere nella possibilità di cancellare una lingua in forza della sopraffazione armata o coloniale. Se veramente ci fosse stato il declino dell’arianismo, si sarebbe dovuto riconsiderare in toto quel monolitico pensiero accademico che, in nome di una “stirpe ariana” inventata dagli stessi intellettuali che architettarono il Nazismo, da 150 anni ha imposto nelle ricerche etimologiche la pregiudiziale di una immensa lingua ”indo-germanica” mai esistita, con al centro il popolo tedesco. Parimenti, si sarebbe dovuta riconsiderare in toto la bislacca teoria che l’Impero romano abbia soppresso le lingue mediterranee inaugurando la nuova era “neolatina”. Il declino di queste ascientifiche eredità tarda a cominciare, ed i conseguenti errori accademici non mostrano alcun cedimento.
Non ci fu mai catastrofe linguistica. Invero, nel Mediterraneo non ci furono mai rotture linguistiche traumatiche e le spinte imperialiste non poterono giammai decretare la morte di una lingua. Le dimostrazioni abbondano. Ad esempio:
1) Nel II-I sec. a.e.v., oltre un secolo dall’invasione romana, Cleone sente bisogno di scrivere un testo in greco-latino-punico (colonna bronzea di S.Nicolò Gerréi), per essere certo che i Sardi lo capissero almeno tramite la lingua punica.
2) Duecento anni dopo l’invasione, Cicerone denuncia (Pro Scauro) che la Sardegna non ha nemmeno una città amica del popolo romano. Se le città erano ancora ostili all’invasore, cosa dovremmo dire delle campagne e delle aspre montagne (che costuiscono il 70% del territorio sardo)?
3) I censimenti e la ripartizione dell’Italia ai tempi di Cesare Augusto mostrano una penisola composta da 32 popoli, che fino a prova contraria usavano 32 lingue. Numero che aumenta se sommiamo le lingue della Sicilia e quelle parlate in Sardegna dalle macro-ripartizioni tribali dei Balares, Corsi, Iliensens.
4) È famosa l’affermazione di Saulo di Tarso il quale, naufragando nell’isola di Malta, fu salvato dai residenti che parlavano una lingua barbara (ossia non greca né latina). Era una lingua semitica che tra quel migliaio di marinai e coltivatori durava in purezza nonostante che Malta fosse diventata romana da centinaia d’anni. I Melitesi si rifiutavano, forse persino inconsciamente, di adottare la lingua di Roma, nonostante che fossero così pochi e così esposti, che per i Romani sarebbe stato facilissimo imporglielo.
5) Altro episodio è quello del De Magia 98, in cui Apuleio, difendendosi dall’accusa di aver indotto con arti magiche la vedova Pudentilla di Oea (l’attuale Tripoli) a sposarlo, apre uno squarcio impressionante sulla società africana del tempo (siamo nel 159 e.v.). Infatti colloca da una parte Pudentilla, donna ricca e colta, che scrive e parla correntemente non solo la lingua latina ma pure quella greca; dall’altra mette il figlio di questa, Sicinio Pudente, che non solo non sa il greco pur essendo stato allevato nella cultura, ma che addirittura balbetta continuamente nel tentativo di esprimere, durante il processo, qualche frase in latino: non gli riesce per il semplice motivo che ha trascurato lo studio delle lettere latine, preferendo vivere come il resto della popolazione, la quale parla esclusivamente il punico. Dall’affermazione di Apuleio veniamo a sapere che nell’Africa latina, occupata da Roma nel 202 a.e.v. dopo la battaglia di Zama (Naraggara), ancora 360 anni dopo si parlava quasi esclusivamente il punico, nonostante che fosse stata romanizzata al massimo. Agostino, cittadino berbero, aveva imparato il suo ottimo latino, ma egli era uomo urbanizzato, apparteneva alla minoranza di cives cui era rivolta in esclusiva la predicazione cristiana, anch’essa espressa in latino.
6) Altra testimonianza: nel VI secolo e.v. i Barbaricìni adoravano ancora ligna et lapides (Lettere di papa Gregorio): solo le città avevano cominciato a recepire il verbo di Gesù, e tuttavia molti cittadini pagavano l’imposta per continuare ad adorare liberamente il Dio degli avi. Si badi, erano passati 3 secoli dalla liberalizzazione del cristianesimo, 5 secoli e mezzo dal suo esordio. Qualcuno dovrebbe riflettere sul fatto che i Barbaricini di Ospitone (ossia i ¾ dei Sardi, tutti residenti nell’immenso territorio montano), erano ancora pagani, e a maggior ragione non erano entrati stabilmente in contatto con i predicatori latini. Solo la religione è in grado di operare, con lento processo di secoli, dove non riesce il potere politico. La religione ha bisogno di essere predicata con somma circospezione, poiché i soggetti accettano il nuovo verbo soltanto se viene trasmesso nella lingua materna. Così fece Wulfila nel IV secolo e.v., il quale trascrisse la Bibbia ed i Vangeli greci nella lingua gotica, della quale inventò pure l’alfabeto. Così fecero Cirillo e Metodio, che per evangelizzare la Russia ebbero persino l’esigenza di creare un apposito alfabeto nazionale. Operò similmente Martin Lutero, che impose la propria Riforma traducendo la Bibbia in tedesco, previa correzione di numerosi passi.
Se questi episodi vengono traslati in un’isola grande ed aspra come la Sardegna, allora l’esempio di Malta, ancor più l’esempio dell’Africa romana, ma pure l’esempio di Ospitone, possono rendere bene i processi linguistici che s’instaurano presso un popolo di vinti. La chiave per comprendere il problema si trova proprio nella conquista delle città e nella netta frattura che nella storia del mondo si è sempre creata tra città e campagna, tra città e montagna. Infatti le montagne sarde rimasero libere dall’occupazione romana.
Beninteso, una religione può attecchire anche rapidamente: basta operare un genocidio (come fece Cortez). I sopravvissuti aderiscono, eccome! Ma i territori montuosi della Sardegna non furono mai conquistati con le armi, almeno fino al VI secolo, allorché l’esempio di Cortez ebbe un luminoso precedente nelle armi bizantine. Ospitone dovette salvare il proprio popolo: aderì al cristianesimo. In compenso la lingua sarda rimase indenne. Perché mai un popolo avrebbe dovuto cancellare la propria lingua a vantaggio di quella dell’invasore, un invasore che peraltro ai tempi di Ospitone cominciava ad esprimersi con la lingua greco-bizantina e non con quella latina?
È possibile sopraffare una lingua? Nel mondo abbiamo avuto varie prove di quanto fosse miope e incongrua la pretesa di un conquistatore di sopraffare persino la lingua del popolo soggetto. Ad esempio, lasciando da parte la famosa deportazione degli Ebrei a Babilonia (i quali conservarono in purezza la propria lingua), possiamo citare la politica dell’Impero assiro, le cui deportazioni avevano primamente lo scopo dell’unificazione linguistica. All’uopo, gli Assiri deportavano i vinti Cananei verso l’Assiria o verso altre province assire, e all’incontro deportavano gli Assiri, o i provinciali parlanti assiro, verso Canaan. «Scopo finale era l’assimilazione linguistica, culturale, politica, il più possibile completa, tale da trasformare i vinti in assiri. L’assimilazione completa la conquista, trasformando un regno ribelle e alieno in una nuova provincia del cosmo alle dirette dipendenze del re e del dio di Assur».1
«In questo contesto di rimodellamento demografico e territoriale al servizio degli interessi assiri, e sotto attento controllo di guarnigioni e funzionari assiri, la pratica della “deportazione incrociata”, che coinvolse qualcosa come 4,5 milioni di persone in un arco di tre secoli, svolse un ruolo essenziale. Il racconto biblico della conquista di Samaria narra dapprima la deportazione degli Israeliti:
il re d’Assiria prese Samaria e deportò Israele in Assiria, stabilendoli a Halah, sul Habur fiume di Gozan, e nelle città della Media. (2Re 17:6)
e poco dopo narra l’arrivo dei deportati alieni:
il re d’Assiria fece venire (gente) da Babilonia, da Kuta, da ‘Awwa, da Hamat e da Sefarwayim e li stabilì nelle città della Samaria al posto degli Israeliti. Costoro s’impossessarono di Samaria e si stabilirono nelle sue città. (2Re 17:24)
«Dai testi di Sargon II sappiamo che deportò in Samaria anche degli Arabi:
I Tamudi, Ibadidi, Marsimani, Khayapa, Arabi lontani abitanti del deserto, che non conoscono sorvegliante o funzionario, che a nessun re avevano mai portato tributo, per mandato di Assur mio signore io li abbattei, e il loro resto deportai e insediai in Samaria (ISK, p. 320).»2
Ma l’assimilazione non avvenne mai. Negli stessi passi della Bibbia è scritto che le nuove popolazioni di Samaria finirono per logorarsi e sfinirsi a vicenda. Non per altro, ma perché le guerre di conquista lasciavano delle scie d’odio e di revanche talmente grandi, da condizionare e trattenere per secoli o millenni i singoli popoli entro la propria lingua originaria, l’unico segno identitario salvabile. Il destino di Samaria è confrontabile – ma solo per farne risaltare le differenze di fondo – col destino della città sarda di Alghero. Ad Alghero nel 1353 era stato operato un innesto adamantino, un solo popolo e una sola lingua; ma quel popolo straniero rimase incastonato, “assediato” entro le mura cittadine come elemento spurio in un territorio parlante lingua sarda; e ancora oggi la situazione è invariata; la lingua catalana dopo 700 anni non ha mai varcato le mura di Alghero. A Samaria invece la questione fu pasticciata dal melting pot creato con la mescolanza di cinque popoli; e l’aggiunta del sesto popolo, gli Arabi parlanti una lingua più vicina a quella ebraica, non potè che esacerbare la situazione e mettere gli uni contro gli altri. Era questo il risultato che volevano gli Assiri? Non credo. Essi volevano mettere certamente gli uni contro gli altri, ma soltanto secondo la prassi del divide et impera. Invece quel seminare odio a piene mani fu foriero di declino economico.
Così andarono le cose nel Mediterraneo da quando Assiri e Babilonesi (poi Hittiti, Medi e Persiani, e infine Greci e Romani) tentarono di prevalere ed espandersi con la forza delle armi. Soltanto la libertà, la parità, la collaborazione pacifica, la dignità dei liberi commerci può fare integrare i linguaggi. È ciò ch’era accaduto per tanti millenni nel Mediterraneo, prima che gli Assiri e i Babilonesi inventassero la “persuasione” degli impalamenti di massa e quella delle deportazioni.
Il livello temporale. Le prospettive. L’Homo Sapiens. Tutto ciò acquisito, rimangono in piedi altre due fangosità da cui il pensiero accademico non riesce a depurarsi.
La prima fangosità colpisce nel vivo la tecnica dell’indagine etimologica condotta nell’ambito degli Istituti universitari di glottologia e di filologia romanza, nei quali si stabilisce a priori il livello temporale dove l’indagine debba cessare. Sinora la storia delle lingue tirreniche attuali e di quelle della costa nord-mediterranea è stata indagata a ritroso sino ad attingere al piano della lingua latina (salvo poi considerare l’apporto collaterale delle lingue germaniche, nonché una vaga citazione di “residui celtici” dei quali non si dice nulla sul piano scientifico). Ma ciò non è bene, poiché lo scavo etimologico è simile a quello archeologico, e non può eludere il proprio metodo, che è quello di toccare il livello più basso nel quale si ritrovino dei manufatti (per l’archeologo) nonché il livello più arcaico cui può condurre la manifestazione dei radicali di un vocabolo (per il glottologo). In linguistica occorre operare confronti lessicali e morfemici sino al più arcaico vocabolo che, in un’area indagata a raggio adeguato, possa credibilmente confrontarsi col vocabolo di oggi. Stabilire che il livello-base delle lingue tirreniche sia la lingua latina, significa rinunciare al criterio storicistico; equivale ad ammettere che prima di Roma la storia nel Mediterraneo non si sia mai svolta oppure (che è lo stesso) ch’essa sia obiettivamente inconoscibile. Invece la storia del Mediterraneo e dintorni è nota, con soddisfazione generale, fin dai millenni pre-greci. Mentre la conoscenza delle lingue ad essa correlate affonda ancora più lontano nel tempo e nello spazio.
Dalla prima fangosità deriva la seconda fangosità, concernente le prospettive. Affermare de imperio che la storia delle lingue tirreniche ed alto-mediterranee abbia una prospettiva di soli 2000 anni significa rinunciare a capire l’evoluzione del linguaggio mediterraneo, il quale è arcaico quanto può essere arcaica la presenza dell’Homo in questo bacino. I dati archeo-antropologici confermano la presenza del Neanderthal e poi del Cro-Magnon; e giacché quegli uomini lasciarono dei manufatti, è ovvio che parlassero, che scambiassero informazioni, che dessero i nomi alle cose, alle persone, al territorio, che usassero quindi la lingua, che avessero un vocabolario condiviso. L’idea nichilista ch’essi comunque parlassero lingue inconoscibili è generata dalle stesse pregiudiziali “latina” ed “ariana” su citate: pregiudiziali liquidatorie che bloccano ogni nuova spinta ad una seria indagine etimologica.
In verità, gli uomini mediterranei del Paleolitico parlavano. E parlavano una sola lingua: appunto la Lingua Mediterranea, per quanto essa fosse pluri-articolata secondo l’antichità e il radicamento degli stanziamenti nei singoli ambiti geografici. Questa lingua è perfettamente conoscibile mediante una semplice induzione, che è la seguente: la Scienza Glottologica ha sempre messo in evidenza un fatto elementare, intuitivo, cioè che le prime formazioni lessicali dell’Homo furono essenzialmente monosillabiche. Questa osservazione è così palmare, che tentarne una dimostrazione (peraltro facile) è ozioso. Ebbene, dalle età arcaiche è sopravvissuta, restituita a noi grazie alla riesumazione delle tavolette cuneiformi, una lingua che si articolava proprio a monosillabi: è la Lingua Sumerica, a tutti resa nota tramite vocabolari e grammatiche pubblicati da numerose Università. Quegli scavi, quelle scoperte hanno messo a disposizione dei glottologi odierni “l’altra metà del mondo”. Perseverare a non indagare quanta storia linguistica mediterranea sia ancorata alla lingua cosiddetta sumerica, non è più accettabile.
Infatti lo scrivente non accetta più di perpetuare la muta ostilità (ch’egli per 31 anni ha purtroppo condiviso) a conoscere l’altra “metà del mondo”. Lo scrivente da 15 anni ha cominciato ad indagare in ambo le sponde, ed ha scoperto che la Lingua Sarda è arcaica, aborigena, risale alle origini del linguaggio, e condivide con la Lingua Sumerica molto più della metà del proprio vocabolario. Come si noterà leggendo oltre nonché nel corpo dell’intero Dizionario, la mia scoperta è scientificamente dimostrata e rimane in attesa di prove contrarie. Come attende prove contrarie lo stesso dizionario egizio, il quale condivide metà della lingua sumerica.
Insomma, si perviene alla dimostrazione che la lingua (cosiddetta) sumerica era parlata ab origine in un’area molto vasta avente perno nel Mediterraneo centrale, ed entro l’ampia circonferenza roteavano già dai tempi arcaici la lingua egizia, le lingue che poi vengono riesumate in Mesopotamia, la lingua di Canaan compreso l’ugaritico, il fenicio, l’ebraico; inoltre quella araba, le lingue ad ovest del Nilo (es. il punico), la lingua che ancora oggi sopravvive in Sardegna, le lingue italiche compreso il latino, le lingue celtiche meridionali comprese quelle iberiche.
Questi vasti ambiti vanno considerati per difetto. Ma è uopo fermarsi per capire intanto la ragione di tale vastità. Per quanto in certi rami scientifici nulla possa considerarsi ultimativo, in relazione all’antropologia s’individua agevolmente un primitivo focus della Ursprache mediterranea. Che il focus possa essere l’Altopiano Etiopico o che altri lo pongano in Croazia (come qualcuno recentemente suggerirebbe), la questione non muta poiché si scopre che dal focus ci si è mossi lungo le coste per racchiudere a tenaglia l’intero Mare Nostrum.
Attenendoci alla corrente antropologica che narra della progenitrice Lucy, l’uomo (ed il linguaggio che ancora oggi ci appartiene) discese dall’Altopiano Etiopico lungo il Nilo, e da lì prese a tenaglia le coste Mediterranee, ad ovest verso la futura Cartagine ed alle Colonne d’Ercole, ed oltre in Andalusia, in Catalogna, in Linguadoca. Ad Est mosse verso Canaan e la Mezzaluna Fertile, e da lì lungo le coste anatoliche, ai Dardanelli, in Grecia, Dalmazia, Italia. Chiusa la tenaglia, toccò alle isole centrali del Mediterraneo. Erano tempi di glaciazioni, e l’arrivo in Corsica-Sardegna avvenne con mari bassi e molto transitabili nella direttrice dell’arcipelago toscano.
La remota antichità delle radici. Alcuni antropologi dichiarano la scoperta di un Neanderthal con osso o cartilagine glottale, anziano di 230.000 anni, ed ovviamente pensano che l’osso glottale favorì l’articolazione della lingua. Ma altri archeo-antropologi del Sud-Africa accampano la scoperta di una Dea-Madre vecchia di 700.000 anni: chiaramente, gli scultori di quella Dea-Madre parlavano ancor prima di questo Neanderthal citato. Comunque la mettiamo, l’Homo cominciò ad articolare parole e pensieri molto presto; e tentò di risalire sempre da sud a nord (verso l’enorme calotta glaciale che occupava l’Eurasia sino al livello delle Alpi, dei Carpazi, dei bassi-Urali, della Mongolia).
L’idea di un idioma “indo-germanico” sortito sulle pianure ghiacciate a nord dell’Ucraina e del Kazakistan, con improbabili rincalzi dal Pamir e dintorni, non tiene conto che l’Homo provenne sempre dalle zone non soggette a glaciazione. Quindi è forza immaginare soltanto pressioni da Sud, risalenti i vari corsi dei fiumi, lungo le antiche valli glaciali del Rodano, del Danubio, del Dnepr, del Don, del Volga, dell’Ural e forse – al dilà dell’Hindukush-Karakorum – del Brahmaputra, del Mekong.
Furono le genti che risalirono le valli glaciali a costituire poi – millennio dopo millennio – il fenomeno dei Popoli delle Steppe. E furono questi ultimi, a loro modo, che rifluirono a ondate verso Ovest nelle pianure centrali dell’Asia, nella Pianura Sarmatica, facendo capolino nella storia mediterranea col nome greco di Popoli Barbarici, quelli che affrontarono Mario, Giulio Cesare, l’Impero romano, ecc.
Financo la questione della Civiltà di Andronovo (the Indo-Iranians di Elena E. Kuz’mina) può ricevere ulteriori lumi se la inquadriamo in queste prospettive. Parimenti, si capovolge la prospettiva dei famigerati “popoli indoeuropei”, allorché andiamo a rivelare che pressoché ogni parola a loro attribuita è di origine sumero-accadica. Ad esempio, si pretende l’origine indoeuropea dei Persiani, ma intanto i loro nomi sono accadici, come Dario, nome d’imperatore persiano, dall’akk. dāriu(m), dārû(m) ‘lasting, eternal, eterno’ riferito agli déi, ai re (tipico appellativo di cui si dotavano i re delle origini, per marcare la propria forza e la nobiltà davanti al popolo).
Tornando al Mediterraneo, ci rendiamo conto che pure la questione delle lingue celtiche è fortemente zoppa, fintanto che non si tengono nel dovuto conto gli apporti millenari da sud. Se vogliamo, anche gli artisti contribuirono a dimostrare quanto sto affermando, come quell’uomo (ma immagino fosse una donna che attendeva il ritorno del marito dalla caccia) il quale (la quale) 32.000 anni fa dipinse la grotta di Chauvet con splendidi rinoceronti.
Sono migliaia le parole che noi consideriamo “nordiche” e invece provennero dal Bacino sumero-accadico. Di seguito, per ragioni di spazio, elenco poco più di venti lemmi.
Aggraviái camp. ‘ingiuriare, oltraggiare’; aggráviu ‘ingiuria, oltraggio’ = sp. agraviar, agravio. It. ant. aggravio ‘ingiuria, oltraggio’, che ritroviamo anche in Corsica. Base etimologica accadica, da garbu, garbānu ‘lebbroso’. Il termine penetrò tanto, da arrivare anche tra i Germani: cfr. ags. garbage ‘immondezza, porcheria’.
Alpi, ted. Alb. Il nome della catena montuosa che scompartisce mezza Europa ha lo stesso radicale di it. e lat. alba < akk. ḫalpû ‘frost, ice’, sd. alb-éskida, arb-éskida ‘alba’. Il nome più antico, conservato nelle due radici sarde, si ricava dal sum. ar ‘praise, preghiera’ + bar ‘to burn, bruciare’, anche ‘to open, aprire’. Il composto ar-bar in origine significò ‘preghiera al Folgorante’ (il Sole), o ‘preghiera dell’apertura (del giorno)’. È noto il “saluto al Sole” che molti popoli ancora oggi si tramandano, fin dal Paleolitico, al momento dell’aurora. Un tempo non era un “saluto” ma una preghiera, come vediamo al lemma Sud.
Bind (to bind) ingl. ‘legare’; cfr. log. bindellu ‘legaccio, nastro’, specialmente per legare i capelli; cfr. piem. bindel ‘nastro’. Base etimologica è l’akk. binītu ‘creation, structure’. A quanto pare il concetto è arcaico, proviene dall’Alto Paleolitico, allorché l’uomo, strappando le prime erbe tenaci, cominciò a intrecciarle facendone legacci, con i quali cominciò a fissare tra di loro i primi rami d’albero ed a costruirsi una capanna. Questa fu la prima barriera di difesa dai pericoli del mondo ferino, ed anche dalle intemperie.
Sud è il nome del punto più alto toccato dal sole nel suo spostamento est-ovest. Base etimologica è il sum. šud ‘preghiera’ (una preghiera con proscinesi, ovviamente rivolta al dio Sole, stavolta quando sta allo zenith). E ricordiamo il nome dell’Alba. Tale preghiera ci è noto tramite il cognome Sciùto, Sciuti, di area italica ma di sicura base tirrenica, con etimo anche nell’akk. šūtu, sūtu ‘sud’.
Ovest. Per indicare l’Ovest gli Šardana-Tirreni impiegarono addirittura due termini, l’uno e l’altro eternati, eccezionalmente, in due cognomi sardi. Il primo è Murru, con base nell’akk. amurru(m) ‘ovest’. Il secondo è il cogn. Erbì con la variante Erba, base nell’akk. erbu(m), erebu ‘tramonto, ovest’ (da cui poi il gr. Érebos, indicante il Regno delle Tenebre, il Mondo dei Morti, dove sprofonda il Sole). Del nome internazionale Ovest, West (creduto anglosassone) s’ignorò sempre l’origine, mentre la base è il sum. u ‘universo, universale’ + eš ‘shrine, sepolcro’ + de ‘creatore’ (ossia Dio Creatore dell’Umanità). Il composto u-eš-de, divenuto west tra gli Anglosassoni anche in virtù della nota Lautverschiebung germanica, in origine significò ‘sepolcro del Creatore dell’Universo’. La definizione si concilia con quella del Nord.
Est, altro nome del punto dove sorge il Sole, ha base etimologica nel sum. eš ‘shrine, sepolcro’ + tuk ‘to break off, rompere’. Il composto eš-tuk in origine significò ‘rottura del sepolcro’ (vedi le osservazioni per gli altri punti cardinali). In Italia certi popoli chiamarono altrimenti quel punto. Un indizio lo cogliamo dal cognome italico Zito, con base nell’akk. ṣītu(m) ‘uscita del sole’, ossia ‘Est’. Si può notare che i vari nomi per uno stesso punto d’orientamento mostrano l’autonomia dei vari linguaggi antichi.
Nord è il punto cardinale più citato, dal sum. nu-ra-du (nu ‘creatore’ + ra ‘limpido, chiaro, splendente, Dio’ + du ‘to hold, keep in custody, tener prigioniero’. Nura indicò il ‘Dio creatore’, quindi ‘Creatore della Luce, Sole’; Nura-du significò ‘prigione del Sole’ (perché negli antichi miti il Sole al tramonto veniva imprigionato dal Dio della Notte); cfr. sp. norte, ingl. north, norveg. nord, ted. Norden, della cui origine ogni etimologista ha sinora discusso invano.
Norge è il nome della lontana Norvègia, che non significa ‘terra del nord’ sibbene ‘Terra dei bagliori, delle aurore boreali’, da sum.-akk. nūru ‘bagliore’ + sum. ki, gr. gê ‘terra’ (in composto nurki). Cfr. il cognome sd. Nurki, che può sembrare un mistero finché non accettiamo che qualche Normanno tra quelli che raggiunsero la Sicilia dovette recarsi anche in Sardegna a fini di commercio trans-isolano. Con tutta evidenza, una bella vergine sarda lo ammaliò, ed egli s’insediò trapiantando un “cognome di origine”: ‘quello della Terra delle Aurore boreali’. Forse i Normanni arrivati in Sardegna per commercio furono numerosi. Un loro sia pur minimo contributo può senz’altro giustificare le molte teste bionde del centro-Barbagia, nonché gli occhi di certi barbaricini (es. ad Ovodda), spesso di un affascinante verde-smeraldo. Capisco l’imbarazzo di chi ragiona “a palmi”, ma questa etimologia s’affianca a molte altre della Sardegna acclaranti un fatto che sconcerta i più: in Sardegna ancora 500 anni fa si pensava in sumerico, come dimostrerò al paragrafo “La lingua arcaica compresa fino al Rinascimento”.
Mont Blank, noto in Italia come Monte Bianco, si dice abbia radice dal germ. blank ‘ripulito, lucente’; ma anche quella voce germanica proviene da sud, base etimologica è il sum. bar ‘bianco, libero’ + an-gal ‘cielo, cielo grande’ = ‘cielo limpido’. I cognomi sd. Barranca, Branca conservano ancora l’arcaico significato del bianco, che si espanse con fonetiche similari fino alla Mittel-Europa.
Monte Rosa è un oronimo italico persino banale. Ma tale banalità va spiegata, poiché quel magico colore rosa viene percepito soltanto dai Padani quando da Est il sole illumina di colpo l’altissima vetta, mentre il mondo se ne sta ancora avvolto dalle tenebre. È un momento di grande fascino, che riceve nome dall’akk. rûšum ‘rossore’, voce conosciuta bene dai Celti.
Monte Cervino è un altro oronimo italo-celtico, un aggettivale col suff. mediterraneo -ínu < akk. ḫerebū ‘torre’ (quindi ḫereb-inu). Nome antonomastico. Si badi che questo concetto riferito alla torre si ritrova esclusivamente nelle fonti accadiche relative agli scacchi (i quali testimoniano in tal guisa la loro arcaicità culturale, senza bisogno di coinvolgere nella loro invenzione gl’Indiani, e nemmeno gli Iranici).
Bàita è un’altra voce celtico-mediterranea abbarbicata sulle Alpi. Indica la ‘casa alpina’, specie quella isolata negli alpeggi, ma ritroviamo la voce nell’ebr. bait ‘casa, tenda’, akk. bītu ‘casa’, sd. bide ‘vite’, lat. vitis ‘idem’. Che provenga da sud, lo testimonia proprio il nome sardo della vitis. Infatti qualsiasi parola, sino a prova contraria, è arcaica, e l’ebr. bait ha un senso se lo leggiamo primamente come ‘tenda’; ha ulteriore senso se lo leggiamo anzitutto come ‘tenda’ (prodotta dalla vitis, dalla bide, che in certe zone mediterranee, crescendo nella foresta, crea un tendaggio enorme che fece concepire la primitiva idea della copertura).
Giorni della merla. Questo sintagma italo-celtico è legato ai giorni più freddi dell’anno nel nord-Italia, ed evoca le tempeste gelide da nord. Base etimologica il sum. mir-la ‘vento del nord’ (mir ‘chilly wind’ + la ‘to carry, portare, recare, apportare’). Dunque mirla significò ‘apportatore di tramontana, apportatore di tempeste’ (tutto un programma). Cfr. it. merletto ‘pizzo ricamato applicato a stoffe pregiate’, originato dall’osservazione dei fiabeschi ricami del gelo sulle superfici lisce. Da qui anche il merlo in quanto ‘sopraelevazione merlata delle mura difensive’, di cui i filologi hanno sempre ignorato le origini, confondendolo con i merli (uccelli) senza però riuscire a raccapezzarsi.
Hütte ted. ‘capanna’ ha il perfetto corrispettivo nel babibolese ḫuttu (a storage vessel, un recipiente per la conservazione). Va da sé che gli alimenti furono sempre ben protetti e immagazzinati contro le intemperie e contro gli animali. Dagli alimenti dipendeva la vita dell’uomo. Questa considerazione è sufficiente a capire la causa prima della creazione di robuste capanne presso i Germani.
Pò. Uno sguardo ai sistemi fluviali è d’obbligo, poiché il nome celtico del fiume più lungo d’Italia ha base nel sum. pû, akk. pû(m) ‘bocca’; cfr. akk. pāʼum ‘bocca’ da cui celtico Padum, altro nome del Pò. Il sum. pû, akk. pāʼum s’intese per antonomasia come ‘sorgente, scaturigine’. Cfr. poi il lat. Danubium, da akk. dannu ‘potente’ + bī’um ‘opening, outlet; apertura, fuoriuscita, sorgente’, col significato di ‘sorgente, fiume potente’.
Adda è nome di un grosso affluente del Pò, dal sum. adea ‘flooding’.
Arno è il nome del fiume toscano, idronimo celtico che però si ripete in Renania (Arnel), Svizzera (Orne), Catalogna (Arnon), Francia (Arnon, Arn), Transgiordania (Arnon).
Reno è nome di un grande fiume della Renania, da akk. reḫûm ‘versare, scaturire’ + ēnu ‘sorgente’.
Tina è nome di un fiume britannico = Tino, fiume sardo presso Tìana.
Normanni. Quanto ai popoli a nord delle Alpi, gli stessi Vikinghi erano detti Normanni, voce sumerica da nuru ‘luce’ + man ‘companion, compagno d’arme’. Il composto nur-man significò ‘guerrieri della Terra della luce’ (ossia ‘Quelli delle aurore boreali’). Pertanto dobbiamo smettere d’interpretare l’ags. man come ‘uomo’, poiché in origine indicava il ‘guerriero’, l’uomo ‘portatore di armi’.
Germani. Conosciamo benissimo questo popolo che diede filo da torcere ai Romani < akk. gērum ‘ostile’ + mānu ‘bosco’. Il composto gēr-mānu in origine nominava il ‘fiero popolo delle foreste’.
Danesi. Tutti i popoli del Nord erano conosciuti, prima ancora che apparissero le cosiddette “civiltà avanzate” del Mediterraneo. E non dobbiamo titubare anche se i primi a citare i Danesi furono Procopio di Cesarea e Giordane. Anche i Danesi, come i Normanni, come i Germani, erano noti per la forza temeraria. Infatti il nome ha origine dall’akk. daʼānu ‘potere, forza’.
Taurini. Non si può dire che tutti i popoli a nord dell’Italia non abbiano ricevuto il nome più appropriato, secondo la caratteristica più notevole. Ad esempio, i Taurini erano un popolo dimorante negli Alti Tauri, tra Austria e Italia. La paronomasia giocò il proprio ruolo, e gl’interpreti li collegarono al toro, lat. taurus, termine invero alquanto ostico da giustificare, per quanto esso provenisse da sud, dove il toro era adorato. Invero la base etimologica è l’aram. tur ‘monte’ (cfr. lat. turris ‘torre’). Con ciò dagli Alti Tauri passiamo al Monte Turu-séle il monte più alto del Supramonte di Baunéi, in Sardegna; questa pletora di nomi è mediterranea.
Per concludere, può essere utile uno sguardo agli oggetti preziosi, tenendoci sempre ancorati alle Origini, al Paleolitico, ai tempi in cui le lingue si formarono, allorché la meraviglia dell’Homo s’appuntava all’apparizione di pochi e rari reperti di superficie, ch’emergevano soltanto in qualche plaga.
Ambra. Facile immaginare che l’ambra del Nord fu il primo oggetto raro e prezioso dell’antichità, e se ne fece subito un proficuo commercio. Ci chiediamo donde sorse questo nome. Lo troviamo nell’ar. anbar, che però ha base nel sum. an-bar ‘cielo cotto’ (an ‘cielo’ + bar ‘cuocere alla fornace’ (pottery, vetro). Lo storico Tacito la indicò come “resina che trasuda dagli alberi”, mentre il nome latino dell’ambra fu glesum, anche questo dal sum. gilesi ‘tesoro d’albero’ (gil ‘tesoro’ + esi, eš ‘albero’). Ma ci accorgiamo che tale nome è uguale al germ. glass, Glas ‘vetro’. Con ciò intuiamo che questo fu il primo nome che i popoli nordici diedero all’ambra. Insomma, senza l’ambra oggi il nome del vetro non esisterebbe, sarebbe un nome diverso.
Vitrum. Ma com’è naturale, anche questo vocabolo latino, corrispondente al camp. bidri, ha origini arcaiche. Le scopriamo nell’akk. bitrûm ‘vedere attraverso, to see something through’.
Silk. Infine, chiudiamo con un nome nordico riferito alla ‘seta’. Essa, beninteso, fu conosciuta molto tardi. Non per questo i popoli germanici ed anglo-sassoni erano giunti impreparati all’impatto con le pregiate stoffe orientali. Disponevano già di un aggettivale appropriato derivante dal sumero: sikil ‘puro’.
La pregiudiziale della “barbarie” e l’intuizione del mondo arcaico. Il paragrafo appena chiuso dovrebbe far riflettere sulle civiltà arcaiche e sulle millenarie commistioni linguistiche impellenti da sud. Molti rifiutano a priori il parametro della remota antichità, perché applicano ad essa il giudizio negativo di una barbarie la cui indagine sarebbe infruttifera. Ma anche qui la questione è mal posta. I dipinti di Altamira pare stiano in Ispagna da 39.000 anni; essi indussero Pablo Picasso a sentenziare: “Dopo Altamira tutto è decadenza”. Figuriamoci s’egli avesse visto i dipinti della grotta di Chauvet (datati a 32.000 anni). Quei dipinti sfatano un altro luogo comune: che l’arte sia nata soltanto da 2,8 millenni in Grecia e che prima ci fosse solo barbarie. Francamente, soltanto Michelangelo e Rembrandt hanno posseduto la potenza espressiva dell’uomo (o della donna) di Chauvet. Basterebbe ciò per rifiutare la pregiudiziale della “barbarie”, che impedisce di capire serenamente le civiltà del passato e la formazione delle loro lingue.
Fu in quella remota fase arcaica, decine di migliaia d’anni fa, che nacque il toponimo Gibilterra, anzi due toponimi, com’è usuale nelle terre di confine. Da una parte fu Calpe, dall’altra Gibraltar. Chi s’attiene alla “pregiudiziale latina” (una pregiudiziale appena addolcita dal flirt con la civiltà greca) e crede alla inconoscibilità dei linguaggi precedenti, sostiene che Calpe è nome greco, e nemmeno lo traduce. Mentre la lingua sumerica agevola la comprensione, fornendo due monosillabi: ḫal ‘to divide; to open’ + pû ‘mouth’. Calpe, non meno di 40.000 anni fa, era nota come ‘opened mouth’. Dall’altra sponda, la tribù che l’aveva raggiunta la chiamò col tempo Gibraltar, che la “pregiudiziale latina” induce a interpretare come Jabal Tāriq ‘Mountain of Tariq’ (riferendola al conquistatore arabo ch’entrò in Andalusia, e tenendo in non cale quel fastidioso -iq). Ma è proprio il sovrabbondante -iq a far capire che la traduzione “araba” è forzata. Invero, anche questo nome è sumerico, da gi ‘to turn, return, change status’ + bar ‘to cut open, split’ + al ‘fencing’ + tar ‘to cut’: gi-bar-al-tar = ‘barrier cut, split, changing the destiny’. Si nota l’enfasi tautologica nella ripetizione concettuale bar ‘aprire’ + tar ‘to cut’.
Dall’etimologia di Calpe/Gibraltar il lettore, i giovani glottologi cui mi rivolgo, avranno capito che spesso l’etimologia non può proporsi pianamente se non ci si riporta, quando possibile, ai tempi arcaici, assunti come parametro scientifico (non sempre necessario, beninteso, ma pur sempre scientifico) allato al parametro della identità o simiglianza fono-semantica tra i radicali attuali e quelli originari. Il bisogno di corrette intuizioni non è soltanto mio, beninteso. Fu lo stesso Wagner nel DES a dare sfogo alle più svariate intuizioni, che il lettore è gentilmente pregato di giudicare in questo Dizionario, e di confrontarle con le mie.
Faccio l’esempio di ammurrare, -ái che in log. e camp. significa ‘legare le vacche per mungerle’. L’intuizione del Wagner è la seguente: ammurrare = ‘legare il muso’ (murru). Una volta supposta tale equivalenza, Wagner crede appagata e conclusa la sua indagine etimologica. Ma a mio avviso essa non può ritenersi conclusa, e penso che nemmeno il lettore possa soddisfarsi appieno, se non altro perché manca una conferma: l’etimo di murru. E allora vediamo quest’etimo, che poggia sull’akk. murrûm ‘uno che scopre, che scoperchia’. Il riferimento originario è ai suini, che usano il grugno per grufolare, ossia per “arare” e “scoperchiare” in cerca di radici e insetti. Da quest’etimo comincia a balenare che la radice -mur- di ammurrare e di murru non parte dal Neolitico ma dal Paleolitico, da quando l’uomo cominciò ad osservare il meticoloso grufolio dei suini dopo le piogge, che scoperchiano la terra rendendola fertile, e per ciò stesso fornendo l’idea rivoluzionaria dell’aratro. Secondo la mia intuizione, quindi, l’operazione del Wagner con la sua lineare equivalenza non aiuta, poiché nel Paleolitico, allorché le vacche erano ancora poco domite, e non si era nemmeno in grado di confezionare corde, l’unico modo per nutrirsi del prezioso latte era accattivare la vacca fornendole abbondante foraggio, in modo che stesse ferma. La base etimologica che poi rinveniamo “incistata” nella lingua accadica proviene da lontano, dal sum. mur ‘fodder, foraggio’. Ovviamente il significato sumerico s’attagliò in origine non solo al foraggio dei bovini ma anche al cibo esumato dai suini grufolanti. Da ciò s’apprende che il radicale del sd. murru in quanto ‘muso’ è molto arcaico e fu capace, già da decine di millenni, di configurare concettualmente sia il ‘foraggio’ sia il ‘muso’ che lo procacciava. In tal guisa nacque la metonimia sarda murru, a quanto pare non condivisa nel restante Mediterraneo.
Beninteso, in certi casi è possibile che l’indagine etimologica non riesca a discendere al disotto dello strato romano (o greco). È il caso del camp. pantéus nella locuzione portái a unu in pantéus ‘portare uno di peso’ (Porru); vedi anche log. in pantéus ándias. Casu propone a ppantèa ‘di peso’: lu giughίan a pantèa ‘lo portavano di peso’, ed anche ‘in trionfo’. Wagner in questo caso rinunciò a indagare l’etimo, poiché non riuscì a trovare addentellati. Dal mio punto di vista, invece, l’etimologia di questo sintagma è chiara, ed offre due opzioni; la prima è l’akk. bāntiš ‘like a mother’, bāntu ‘mother’ (in tal caso il significato del sintagma sarebbe ‘portare come porta una madre’, ossia in braccio). Una seconda opzione può soddisfarsi discendendo soltanto al livello bizantino, a 1400 anni fa, allorché le antiche processioni pagane vennnero progressivamente sostituite con quelle cristiane. In tal caso s’arguisce facilmente che il sd. pantéus non è altro che il biz. πάν-θειος ‘affatto divino, augustissimo’ (epiteto rivolto alla statua di Dio, della Madonna, del Santo portati a braccio in processione). Quest’esempio mostra la possibilità di fermare l’indagine etimologica al solo livello latino (o greco, in questo caso), senza bisogno di discendere oltre. Ma tale possibilità si appalesa soltanto a posteriori, dopo avere indagato anche gli strati lessicali più arcaici. In ogni modo, il lettore noterà che Wagner non potè giungere all’etimo nemmeno quando gli si presentò l’occasione di accreditare con certezza l’opzione greca, della quale non seppe approfittare.
Ciascuno di noi glottologi è conscio delle obiettive difficoltà dell’indagine etimologica. Ci accorgiamo di muoverci in un ambiente indefinito con l’onere di renderlo finito; e troviamo nell’intuizione uno strumento che – a seconda di come lo indirizziamo – può essere un prezioso alleato, che però può rivoltarsi contro di noi al minimo errore di prospettiva, ad ogni insufficienza nelle opzioni.
Prendiamo il caso del log. Cammínu de Roma ‘Via Lattea’. Essa fu mitizzata anche come un immenso sentiero incendiato. Wagner s’appagò nell’interpretare la locuzione nel suo significato apparente: ‘Cammino di Roma’, senza avvertire che tale soluzione è insufficiente e gravida di contraddizioni. Non mi sento obbligato a riempire oziose pagine dimostrative, e invito direttamente ciascun lettore a spiegare che significhi, secondo lui, ‘Cammino di Roma’: Cammino verso Roma?, Cammino appartenente a Roma?, Cammino inventato dagli antichi romani?, Banda luminosa che forma un ponte apparente tra Logudoro e Roma? O cos’altro? E che c’entra Roma con la Via Lattea? Forse che fu Roma ad aver indicato ai Sardi l’esistenza della Via Lattea? Forse che i Sardi prima di Roma non avevano alcuna nozione di astronomia? Chi vuole intendere in questo modo l’antica civiltà della Sardegna, avvalla la credenza che i Sardi nel passato fossero una nullità antropologica, un buco-nero della storia. In ogni modo, da questa situazione di stallo bisogna uscire in qualche modo; il ricercatore deve decidersi e giungere ad una soluzione, stando attento alle interpretazioni che lo immergerebbero nel ridicolo. A mio avviso, si esce dall’impasse assumendo quell’idea generalizzata su citata, che la Via Lattea sembri un immenso sentiero incendiato, e confrontando tale visione con la base sum. rub ‘to go, andare’ + ma ‘to burn, bruciare, incendiare’. In tal caso rub-ma indicò proprio un ‘cammino incendiato’, e l’aggiunta di log. cammínu non è altro che una replica dell’arcaico rub. Questa soluzione è una spia eclatante di come il sumerico sia stato la base del linguaggio sardo.
Senza la giusta intuizione è spesso impossibile pervenire al concetto primitivo che dimostra la giusta etimologia. Lo vediamo nel lemma pèttene nuor. e log. ‘pettine’. È giusto planare sul lat. pecten, ma poi occorre procedere sino all’ultimo livello, che è l’akk. peḫû ‘to close up, seal; bloccare, sigillare’ + ṭênu ‘to grind, macinare’. Per capire appieno quest’etimo occorre risalire all’era in cui la macina fu una pietra mossa avanti-indietro sopra una pietra fissa (quasi come il pettine viene mosso sulla testa). Il composto peḫ-ṭênu in origine significò ‘macina che blocca, sblocca (un corpo estraneo)’. Anticamente infatti il pettine era il migliore ausilio per ripulire la testa dai pidocchi.
Non sono mai sprecate le raccomandazioni al massimo rigore ed alla massima acribia nell’indagine. Esempio, il sd. tzimitóriu, cimitóriu ‘terreno destinato ad inumare i morti’, nel tardo lat. si chiamò cimitērium e lo si volle derivare da gr. κοιμητήριον ‘luogo dove si va a dormire’. Ma questa è una paronomasia, poiché l’arcaica base lessicale si rintraccia ai tempi in cui in tante parti del Mediterraneo vigeva l’incinerazione. Vedi akk. ḫimṭum ‘burning, abbruciamento, incinerazione’. Quindi un tempo cimitóriu fu il luogo dove si portavano i morti per incinerirli. Cfr. log. tziminèa ‘camino, il posto dove si arrostisce la carne’.
Unità delle lingue mediterranee. Il metodo sinora suggerito vale per tutte le contrade mediterranee.
Prendiamo il log. ant. carrúgiu ‘viuzza stretta’ (Stat. Castels. 155). È un evidente accatto dal gen. carroggio, carùggiu. A sua volta però la voce genovese mostra un’origine antichissima e interessantissima, legata al fatto che l’antica Genova, molto prima dell’avvento dei Romani, non aveva alcun sito pianeggiante: era un villaggio di pescatori abbarbicato sulla scogliera. I successivi piani alluvionali che pavimentano l’attuale città si crearono nei millenni col trasporto di ghiaioni durante le piogge rovinanti dai monti incombenti. Furono i ghiaioni, che avanzarono nel mare con ripetuti apporti, a dare fisionomia alla striminzita piana attuale. Per ovvie ragioni le prime case dei Genovesi nacquero con file perpendicolari al mare, allungandosi al disopra dell’erta dei canaloni che recavano acqua dalla montagna. Anche le case allungate ai bordi dei torrenti minori e dei ruscelli dovettero avere fin dall’inizio questa ubicazione, una direzione finalizzata a convogliare al mare senza ostacoli ogni moto d’acqua, la quale spazzava anche le deiezioni rilasciate lungo i carruggi. Di qui il nome carrùggiu, avente base etimologica nell’akk. ḫarru ‘water channel, water canal’ + uggu ‘rage, fury’. Carrùggiu indicò quindi, dall’origine, la ‘furia dei canali d’acqua’, ossia i condotti che convogliavano senza danno la furia dell’acqua piovana. Fu questa intelligente topologia ch’evitò le devastazione di Genova, in quanto non ostacolava i torrenti. In seguito, la fame di spazio portò ad edificare dentro gli originari carruggi, entro la golena dei torrenti principali, strozzandoli, o coprendoli, e sottomettendo parte della città ai capricci del tempo.
Aḍḍurare (Planargia), atturai(sì) camp. ‘fermare, fermarsi, rimanere’ = cat. aturar(se). Voce mediterranea con base etimologica nell’akk. dūrum ‘permanenza, eternità’, ‘stato permanente’. Cfr. it. durare.
Ammattái camp. ‘guarnire una nave dei suoi alberi’. Wagner lo confronta col tosc. livorn. ammattare ‘alberare, attrezzare una nave’; còrso ammattà ‘alberare, alzare all’aria antenne e sim.’, di conseguenza ne suggerisce subliminalmente la derivazione da quei lemmi italici. Invero questi lemmi sono tutti mediterranei, con base etimologica nel sum. ma da ‘to sail a boat’.
Angiulottus m. pl. camp. ‘sorta di ravioli’, che sono anche specialità della cucina piemontese (añulot). A quanto pare il termine è mediterraneo, con base nel sum. an ‘cielo’, akk. Anu ‘Dio sommo del Cielo’ + ḫul ‘gioire’, col significato di ‘Gioia di Anu’.
Aspro antroponimo medievale, il quale fu autenticamente sardo, sardiano, senza contatti col lat. Asper, come vorrebbe invece Pittau (UNS 144), che ci vede il solito latifondista romano. Aspro aveva base etimol. nell’akk. ašpû ‘tizio, individuo’ + urû ‘di Ur, nativo di Ur’: composto ašp(u)rû, col significato di ‘individuo nativo di Ur’. A questo riguardo occorre precisare che in Sardegna la nostalgia per la città di Ur fu tale, che se ne fondò una con lo stesso nome, il quale è rimasto identico fino ad oggi: è Uri, nel Logudoro nord-occidentale, che riprende il nome della biblica Ur (detta Uri in sumerico), per quanto dell’antica Ur questo villaggio non abbia ripetuto le glorie e gli sfarzi. Sarebbe faticoso convincere i renitenti che in Sardegna, attraverso gli attuali cognomi (molti dei quali sono antichi epiteti), siamo in grado di fare la casistica di quanti furono i luoghi di origine di certa popolazione antica insediatasi alla chetichella nell’isola; più che altro furono dei commercianti che poi, insediandosi stabilmente, furono chiamati col nome della città o della regione d’origine. Esempio: il cgn Assóru, Soru, Soro, è relitto aggettivale che denotò qualche commerciante assiro che costituì un fondaco in Sardegna: da ass. aššurû ‘Assiro’; bab. surû ‘a foreigner, uno straniero’. Altro esempio è il cognome Catte, Catta, da akk. ḫattû ‘Hittita’: esso mostra che nel primo millennio a.e.v. il commercio inter-mediterraneo era intenso, che c’erano pure dei commercianti hittiti, e qualcuno di essi, com’è naturale, andò a dislocarsi nell’isola di Sardegna. Ma andiamo oltre nella nostra indagine mediterranea.
Assu, sd. e it. asso ‘figura nelle carte da gioco o punto sulla faccia di un dado corrispondente al valore uno’. DELI lo crede dal lat. ăsse(m) ‘persona che eccelle’, e comunque non produce l’etimologia. In realtà la base sta nel sum. aš ‘uno’, hitt. aš ‘uno’.
Assussèna log. ‘giglio bianco’ (Lilium). Wagner, nonché Paulis NPPS 207, ne pongono l’origine nello spagnolo azucena; nelle laudi della Vergine e dei santi, è applicato alle sante (senza che il popolo conosca il significato della parola), e vale ‘qualcosa di estremamente puro e bello’: Candidissima assussèna (per Santa Greca). Quest’epiteto è variante del più noto Susanna, nome muliebre.
L’epiteto iberico, lo stesso nome muliebre, sono originariamente anche sardiani, ed hanno base etimologica nella lingua ebraica. Il muliebre Susanna significa ‘donna originaria di Susa’ (la capitale dell’antica Persia). Lo ritroviamo nell’ebr. Šušan ( שׁוּשַׁנ ). Pure il noto frutto del susíno ha la stessa origine: ‘originario di Susa’. In Italia abbiamo due cognomi ebraici italiani: Susin e de Susen. Dante Alighieri usa già prima del 1321 il nome del frutto, da ant. ebr. שׁוּשִׁין (šušin ‘nativo di Susa’), e s’affianca a Šošannah שׁוֹשַׁנׇּה (‘(fiore) di Susa’: Susa שׁוּשַׁה ).
Astru sd. ‘stella’. Cfr. lat. āster, gr. ἀστήρ ‘stella’. Se ne ignorò l’origine. La base etimologica è l’aram. Aštar, fen. Aštart, bab. Ištar ‘paredra del Dio sole (Anu)’. L’astralismo della religione babilonese simboleggiava la dèa con la stella Venere, con la quale fu identificata sin da tempi preistorici (OCE II 40); v. akk. aštaru ‘goddes, dèa’ (per antonomasia).
Karallu. Questo è un altro vocabolo mediterraneo, detto in it. ‘corallo’, in lat. corăllum, corăllium, in gr. κοράλλιον. Se ne ignorò l’origine, e nessuno s’accorse ch’esso fu pure il nome arcaico della città di Càgliari, detta in lat. Karalis ma citata da Tolomeo come Καράλλι. Il babilonese karallu è anzitutto il ‘gioiello’ (per antonomasia), ma l’assoluta antichità fa capire che questo gioiello fu inizialmente proprio il corallo rosso, di cui la Sardegna era zeppa. Facile arguire perché Cagliari fu chiamata ‘Gioiello’: non solo perché era il porto d’imbarco dell’intenso commercio del corallo nell’antichità, ma perché Cagliari stessa era incastonata nel sito più incantevole del Mediterraneo.
Cabillu camp. è un termine oscuro e incompreso. Lo si è considerato, da parte di moltissimi, dalla gente comune e, a quanto vediamo col Pittau, pure da certi linguisti viventi, come un aggettivo etnico indicante ‘chi è del Capo di Sopra’ ossia chi è della Sardegna settentrionale. Ma i dizionari sardi non recepiscono il lemma; in più, non si è dato conto di quel tema in -íllu. Peraltro, se cabíllu significasse realmente ‘quello del Capo di Sopra’, ci aspetteremmo che quanti risiedono a nord dell’isola usino anch’essi un epiteto reciproco per indicare “quelli del Capo di Sotto”. Ma non c’è reciproco. È un dato reale che questo epiteto sia usato soltanto nel sud dell’isola. Si risolve il problema esclusivamente se mettiamo in campo il vocabolario semitico, dove abbiamo l’akk. ḫābilu, ḫabbilu ‘criminale, malfattore’. Il significato non ha bisogno di commenti. Ma si pone il problema di quando sia potuto nascere un tale epiteto. Poiché il lemma è arcaico, sembra di poter affermare che sia nato in epoca prelatina, addirittura prefenicia. Cfr. ad esempio i Cabìli, i ribelli che stavano sull’Atlante a fronteggiare l’avanzata romana, e poi l’avanzata araba.
La durata della parlata accadica in Sardegna non è ancora cessata, e si può supporre che questa sia stata usata – con piena e reciproca comprensione da parte dei residenti – almeno fino all’anno 1000 di questa Era, nonostante lo sforzo del clero orientale mirante a omologare la parlata sarda a quella di Bisanzio.
È verosimile che l’epiteto sia nato durante l’epoca buia dei quattro Giudicati, allorché i quattro regni si combatterono tra loro senza esclusione di colpi in vista della supremazia allo scopo di unificare l’isola. L’epiteto, viste le premesse, è nato sicuramente nel giudicato di Càlari. I Barbaricini, coloro che transumavano in pianura da Désulo, Villagrande, Gavoi etc., erano i classici Cabilli, intesi come “malfattori”. Ma nella storia mediterranea ogni popolo errante si meritò un simile epiteto dalla popolazione residente, che male li sopportava. Anche Gli Ebrei furono chiamati inizialmente Habiru (la /r/ al posto della /l/ è tipica della fonetica espressa dagli antichi Egizi e dai Cananei del Sinai); tale parola significava proprio “malfattori, banditi”, perché essi erano nomadi e perché davano assiduamente fastidio alle città cananee attorno alle quali essi, tornati dall’Egitto, portavano le greggi al pascolo e organizzavano azioni di disturbo. Dall’antico Habiru abbiamo in seguito Hebrew, Ebreo (la stessa pronuncia, appena modificata).
Cadalettu log. ‘pagliaio’. Stando al Baldacci, è un annesso relativamente recente delle case anglonesi, è sopraelevato e vi si accede da fuori mediante scala a mano. In altre case tipiche sarde esso, quando veniva creato, stava al difuori dell’abitazione. Questa parola sarda è una delle tante prove viventi dell’espansione e omologazione mediterranea degli antichi linguaggi. A dire del DELI, la parola cataletto (‘sostegno della bara durante il trasporto’), significherebbe… ‘sotto il letto’, poiché viene interpretata dal gr. katá ‘sotto’ + it. letto. Questo è il miserrimo livello delle ricerche etimologiche in Europa. In realtà, questa parola sarda ha base etimologica nell’akk. qâdu ‘to ignite, incendiare, accendere, dar fuoco’ + littum ‘stool, sgabello’; quindi qâdu-littum indicò in origine la funzione sacra – tipica del Mediterraneo, del mondo greco ma anche del mondo indiano – di dar fuoco alla pira sopra la quale veniva posto il morto. Da quella figura, abbiamo il termine sardo cadalettu, vista la somiglianza delle forme e la stessa sostanza di ciò che viene posto nel cataletto.
Cadíra camp., barb., nuor. ‘sedia’; cfr. cat. cadira. In log. si dice cadrèa (vedi), a Bitti catrèa. Base etimologica è il sum. kad ‘to tie, weave a mat, fabricate’ + ri ‘to lay down, place’. Il composto kad-ri (+ suff. aggettivale -ca) significò in origine ‘(oggetto) intrecciato per riposarsi’.
Castòne. Tanto per restare in argomento, notiamo che la voce it. indica la ‘sede della pietra preziosa’; cfr. germ. kasto ‘scatola’ < akk. kasû ‘legare, trattenere, incapsulare, imprigionare, afferrare’, e simili, il cui sostantivo kasû ‘captivus, trattenuto’ ha il femm. kastû. Il tutto deriva dal sum. kasu ‘calice’, ḫaštum ‘buco’.
Altra voce mediterranea è dòga (Fonni) dòva, dòa log. e camp. ‘doga’, = it. e lat.; base nel sum. dug ‘pot, vaso’, duggan ‘leather bag, borsa di pelle’. Per metonimia, col passare dei secoli in Italia e in Sardegna si passò a indicare soltanto il fasciame ligneo della botte (innovazione tecnologica), mentre agli inizi il contenitore era considerato per intero, quale che fosse la materia di cui era fatto, ivi compresi i sacchi di pelle, ossia gli otri.
Varie metonimie ha subìto anche il sd. fetta, vetta ‘nastro, nastrino, fettuccia ornamentale’. Base etimologica l’akk. betatu (plur. tantum di un *betu evidentemente sopravvissuto in Sardegna), che fu una ‘decorazione usata sui vestiti’; in accadico ha pure il significato di ‘oggetti di pelle’ (che sono opere d’artigianato). Con questa etimologia togliamo d’imbarazzo il Dizionario Etimologico della Lingua Italiana (in seguito DELI), che annaspa nell’impossibilità di offrire un etimo dignitoso alla parola italiana fetta ‘parte di cibo sottile separata di taglio dal corpo principale’. Infatti già da epoca arcaica le fette di cibo furono assimilate alle fette ottenute da altri oggetti, ad iniziare dalle pelli sottili, utilizzate per vestiti, scarpe, cosmesi.
Di metonimie è zeppo il Mediterraneo, ivi comprese tante metafore poetiche come Tirana, nome di città, dal sum. tir-an ‘arco del cielo, arcobaleno’. Per contro, nel Mediterraneo condividiamo anche voci ferali, come sd. buggínu aggettivale in -ínu < sum. ugu ‘morte’ (che nei millenni fece fiorire persino il cognome piemontese Bogino ‘carnefice’).
Il sd. Déu, Déus ‘Dio’ equivale al lat. dĕus ed al gr. Ζεῦς < sum. de ‘creare’ + u ‘totalità, universo’: de-u ‘Creatore dell’Universo’. Questa parola è fissa da almeno 100.000 anni, ed è sciocco pretendere che i Sardi l’abbiano importata.
Altra fissità si ritrova nel gr. δίκη ‘giudizio’ < sum. diku, dikud ‘giudice’; cfr. lat. dicō. L’appartenenza al campo sumerico è palmare, e dimostra l’arcaicità di questa parola, legata all’atto stesso del parlare, ai tempi in cui una parola equivaleva a un sasso, ogni parola era sacra, ogni parola era conferma di un fatto o di una cosa, era un giuramento inviolabile. Da lì questo venerando vocabolo mediterraneo.
Domu sd., lat. domus, gr. domos ‘casa’ è un’altra voce di estrema antichità mediterranea. Con tutta evidenza, nacque sul finire del Paleolitico, allorché l’uomo, che pure continuava a dimorare nelle caverne o nelle capanne di frasche, decise di erigere qualcosa di duraturo agli déi, facendo tesoro delle numerosissime fratture che notava nelle pareti rocciose, che gli diedero la prima idea delle sovrapposizioni litiche. Infatti la voce domu ha base etimologica nel sum. du ‘costruzione’ + mu ‘crescere’: du-mu = ‘costruzione in altezza’.
Il lat. niger, nigrum è parola mediterranea arcaica. Oggi il parlante occidentale, infatuato dalle mode americane, non vuole più usarla, allertato da una moda beghina secondo cui qualsiasi uomo “di colore” se ne deve adontare (guai a proporgli il contrario!). Ovviamente i negri appena sbarcati in Italia con provenienza centro-africana non accetterebbero mai un tale aggettivale, perché arrivano già imboniti dalla propaganda americana, rivolta al feticcio della parola in sé anziché a un rispetto democratico tutto ancora da condividere (anche in Italia!). Eppure in Italia questo aggettivale fu usato senza ipocrisia da sempre, persino in varie canzoni recenti (es. “Pittore ti voglio parlare”, “Mamma negra”, “Hully-Gully”). Ma oggi l’ipocrisia ci sta affogando, e finora – guarda caso – si è ignorata la base etimologica di negro, che è il sum. ni gur ‘che incute timore’.
Questo aggettivale latineggiante a sua volta ha un riscontro nell’it. nero, che – guarda un po’! – deriva dal sum. neru ‘nemico’.
Il discorso si chiude a triangolo col sd. nieḍḍu ‘nero’, la cui base non è un inesistente lat. *nigellus ‘nereggiante’, come invece qualsiasi latinista va proponendo senza criterio, ma è il sum. ni ‘fear’ + e ‘far entrare’ + dub ‘tremare’ = ‘paura che fa tremare’, ossia ‘paura tremenda’.
Il triangolo tirrenico niger/nigrum-nero-niéḍḍu, da qualsiasi parte lo assumiamo, sarebbe un affronto per i negri. E noi tirrenici, terrorizzati (resi niéḍḍi) dalla “dittatura dell’ignoranza”, non sappiamo più come trattare i nostri fratelli di pelle diversa, e ci lasciamo dominare dalle ideologie razziste, rendendole ancora più abiette da una catastrofica debolezza nell’uso del linguaggio degli avi.
È del tutto normale che moltissime parole sarde siano rimaste fisse dal primo remotissimo gemito sino ad oggi, quale può essere il log. pertúnghere, camp. pertúngiri ‘bucare, forare’: indubbia corruzione dal lat. pertŭndere ‘forare, bucare’, da cui anche sd. pertuntare ‘traforare, corrodere’, infine pertusare, -ái ‘bucare, forare, pertugiare’. Il pref. mediterraneo per- indica il passaggio da parte a parte, e la base etimologica passa per il lat. tundō ‘batto, pesto’, planando sul sum. tud ‘to beat, hit; colpire, battere’.
Territorialmente più percepibili sono certe sopravvivenze come pilótu camp. ‘palo da palafitta’ = sp. pilote ‘madero rollizo armado frecuentemente de una punta de hierro, que se hinca en tierra para consolidar los cimientos’ (cfr. it. mod. pilotis ‘colonna in cemento armato dei moderni palazzi’ < fr. pilot ‘palo’, pile ‘pilastro’). Wagner si soddisfa nel proporre la discendenza della parola sarda da quella iberica, e lì si placa, senza ulteriore indagine. Eppure queste voci sono di estremo interesse. Per quanto a qualcuno possa apparire astruso, la circolazione culturale che rinsaldò la Koiné Mediterranea fece viaggiare anche i termini che un popolano non avrebbe mai potuto formare direttamente ma soltanto accettare in virtù degli approci reciproci. Un sardo non conobbe mai la proboscide e nemmeno l’elefante, ma quel nome circolava culturalmente nel Mediterraneo. Pertanto gli fu facile condividere con iberici e provenzali la voce pilótu, pilote, dall’akk. pīlu, pīru ‘elephant’ (metonimia: ‘proboscide’) + ūttu-, āttu- ‘belonging to, relativo a’. Che la formazione pil-ótu, pil-ote sia stata formalizzata nell’ambito del Mar di Sardegna, lo si capisce dal fatto che ūttu- in accadico veniva prefisso, mentre in Sardegna ed in Ispagna venne suffisso.
La Koiné Mediterranea, a bene intenderla, fa capolino con decine di migliaia di parole sparse qua e là, che nessuno però accetta di percepire come fenomeno unitario. Purtroppo, senza questa percezione non si arriverà mai a padroneggiare questa Koiné, e sfuggirà un fenomeno come pitarra (Oristano), nome della ‘gallina prataiola’ altrimenti detta ‘otarda minore’ (Otis tetrax Cetti). Cfr. salent. pitarra, sic. pitarra ‘idem’; it. sett. pita ‘gallina’. Premetto che il nome sd. più usuale dell’otarda è pidráxu, che però ha la stessa forma basica di pitarra (pidr-). Wagner si limitò a segnalare le coeve presenze di pitarra ad Oristano, nel Salento, in Sicilia, in alta Italia, e suppose che pitarra in Sardegna fosse un accatto, cadendo nel deviante preconcetto del colonialismo. Tale preconcetto, proprio perché deviante, gli tarpò le capacità critiche, come ora vado a evidenziare. Infatti Wagner (DES II 284) si era meravigliato del fatto che pure in Italia sopravvivesse il suffisso -àrra da lui considerato di “origine preromana”. Tale fantasma era emerso in luoghi per lui insospettabili, poiché Roma, secondo lui, aveva latinizzato gl’Italici fino al midollo. Se solo avesse percepito la superiore presenza della Koiné Mediterranea, si sarebbe rilassato, riuscendo persino a scindere meglio la voce pitarra. Infatti l’etimologia deve partire dal prototipo sd. pieppìa ‘gallina’ (dove ritroviamo la base pi- < akk. pīum ‘becco’, opportunamente raddoppiata ad indicare il frenetico uso del becco fatto dalla gallina nel razzolare). Il secondo membro di pitarra non è quindi -arra (immaginato come suffisso) ma -tarra < akk. tarru (a bird); e pitarra in origine significò ‘uccello che razzola’, indicando genericamente vari tipi di gallinaceo.
Ragùsa toponimo italico e dalmata (anche cognome italico: Ragosa). Termine sacro mediterraneo, con base nel sum. ra ‘luce, splendore (riferito al Dio Sole)’ + guza ‘trono’, col significato di ‘trono di Ra’: segno che nell’area sorgeva il tempio al dio Sole.
Occorre ammettere che noi, figli di un Mare chiuso, siamo eredi di lingue fortemente innervate dalla potente Koiné Mediterranea. Ammettere ciò comporta la dissoluzione istantanea della pregiudiziale “latina” e di quella “ariana” (sia pure quando quest’ultima è camuffata da indogermanica), tenute in vita nelle orangeries delle varie Università. Se non dissolviamo quei preconcetti non riusciremo mai a capire perché Sirèna sia un antichissimo cognome sardo, mentre lo si riteneva nome prettamente greco poi emigrato a Roma. Omero (Od. XII) ci fa conoscere quelle creature marine che affascinavano col canto. Infatti Sirena (gr. Σειρήν) significa ‘Colei che affascina col canto’ < sum. šir ‘cantare’ + en ‘incantesimo, fascinazione, opera di magia’. Il dover ammettere che il nome sia sumerico equivale a riconoscerlo come mediterraneo.
Scampiái camp. ‘cessare di piovere’, ‘schiarire’ (del cielo) = cat. escampiar ‘asserenar-se, aclarir-se el temps’; sp. escampar ‘dejar de llover’; anche in tutta Italia meridionale scampare ‘idem’. Wagner con questi raffronti da lui fatti (e miranti a validare l’idea dello ‘scampare, salvarsi da un male’) non ha indicato un’etimologia di appoggio alle sue proposte, che pertanto appaiono surrettizie.
Indubbiamente, il verbo scampare in quanto ‘salvarsi da un male’ ha base nell’akk. kappum ‘wing, ala’, ‘hand, mano’, dove il suff. s-, es- ha la funzione di far percepire l’apertura della mano che libera la cosa afferrata (questa figura etimologica, a ben vedere, rende perfettamente lo scampare). Ma nel caso sardo ed iberico il campo semantico si allarga notevolmente e mira anzitutto all’akk. kappum ‘harness, finimenti, bardature’, dove il suffisso s-, es- offre il concetto della privazione, liberazione. Vedi anche akk. kapārum ‘to wipe clean, ripulir bene’. Quindi è grazie a queste tre voci accadiche che il sd. scampiái ed i due verbi iberici tessono il proprio campo semantico.
Di questo passo nella lista dei nomi mediterranei potremmo annoverare centinaia di migliaia di voci, e non è utile proporli in questa sede. Serve però qualche esempio affinché il lettore capisca la situazione linguistica entro cui ci muoviamo. Quindi gli propongo anche il sd. seḍḍa = it. ‘sella’ < sum. šed ‘to rest, poggiare, riposare’: si può notare l’appartenenza della voce sarda al vocabolario sumerico nonché la differenza grafico-fonetica di quelle italica e latina. Il lat. sĕlla valorizza il significato di ‘sedia’ < akk. sellu ‘archivolto’ (an architecture feature: tutto un programma), ma per il resto la voce latina è precisa alla parola italica. La differenza fono-grafica tra seḍḍa-sedia-sella nonostante l’unità del campo semantico, deve far meditare sulle sottili differenze tra le lingue tirreniche, sulle minime convergenze-divergenze dovute all’autonomo maturare dei processi linguistici, senza che ciò richiami l’assurdo principio della “origine” o della “derivazione”. Questa opposizione fono-grafemica deve far meditare pure sull’inaccettabile modo di affrontare il problema della cacuminale sarda -ḍḍ- (presente anche in sud-Italia), la quale si differenzia dalle liquide -ll- del centro-nord Italia. Non è questa la sede per discuterne, anche perché questo problema è stato illustrato e risolto nel cap. 3.1.5 della mia Grammatica Storica (intitolata Grammatica della Lingua Sarda Prelatina).
Eccoci giunti all’avverbio si log. e camp. ‘se’, ‘nel caso che’, ‘nell’eventualità che’: indica esitazione, incertezza, dubbio, condizione. Di questa voce mediterranea s’ignorò l’origine. Ha base nell’akk. Sê’, Sîn ‘Dea Luna’. Nel lontano passato entrò in qualsiasi invocazione rivolta alla Luna. Si deve assumere per certo che questo onnipresente Se, Si fosse a capo di quasi ogni frase, così come ancora oggi Insciallah tra gli Arabi. Nella lingua italica medievale il se era usatissimo nel senso di ‘se, voglia il Cielo che…’, e ciò è una spia di quanto vado affermando.
L’esempio del monosillabo si, se rintuzza anche un’altra illusione pollonata assieme a quelle già esaminate: è l’illusione (o la scorretta prospettiva) della “evoluzione” delle lingue. Certamente l’evoluzione avviene, è innegabile, ma il lettore deve capire una volta per tutte ch’essa è molto più lenta di quanto s’immagini, e per moltissimi vocaboli è più apparente che reale. Diciamo pure che moltissimi vocaboli non si sono mai evoluti sin dal momento in cui (40.000?, 100.000 anni fa?) furono formulati. Rifacendoci all’agglutinazione prediletta dalla lingua sumerica (ma non solo da essa), possiamo affermare che moltissimi vocaboli mediterranei non sono altro che agglutinazioni di monosillabi sumerici. Prendiamo l’it. singulto ‘singhiozzo’, lat. singūltum ‘idem’. Base etimologica è il sum. sim ‘to swallow, inghiottire’, ‘deglutizione’ + gul ‘to destroy’ + tu ‘incantation, incantesimo’. L’agglutinazione sim-gul-tu in origine significò ‘incantesimo che distrugge la deglutizione’.
Lo stesso processo vediamo nel sd. tambùru, it. ‘tamburo’. Nel Mediterraneo il termine esiste da tempi arcaici; il nome dello strumento primordiale che rimbomba con la percossa ha origine primitiva, ed è facile ricavarlo dal sum. tun ‘contenitore, cassa, sacco, stomaco’ + bur ‘albero’ (tun-bur), col significato originario di ‘cassa d’albero’ ossia ‘albero cavo’.
Medesima fissità ritroviamo nel sd. zéru, it. zèro, fr. zéro, sp. cero. Rinvio al Dizionario per leggere le lambiccate e scorrette etimologie proposte dai più illustri etimologisti per una parola mai compresa. In realtà zero deriva dall’akk. zēru ‘seme’, ant. ebr. zeraʽ (זֶ֫רַע). Con ciò gli Accadici (Babilonesi), grandi cultori di matematica, volevano intendere che dallo zero, come da un ‘seme’, origina la sequenza dei numeri.
Altra parola inalterata è il sd. tzilléri ‘bettola, taverna’, sp. cillero, cat. celler ‘bodega’. Base etimologica di questo aggettivale in -éri è il sum. zil ‘to boil, peel; bollire, sbucciare’. Questa voce sardo-iberica ancora oggi indica il posto dove si cuoce (il cibo), ossia la taverna dove un viandante o un pellegrino poteva fermarsi a mangiare.
Molte voci sarde sono presenti sia in sumerico sia in accadico, com’è per toróju log. ‘urlo, grido, pianto scapigliato, mortorio, piagnisteo’; pránghere a toróju ‘piangere dirottamente’. Base etimologica l’akk. turu’u ‘a cry’ da sum. tur ‘to be ill, star male’. Cfr. gallego aturujar ‘ulular, berrear’ e altre voci simili.
Altre voci sarde si riesumano soltanto dall’accadico (e dall’assiro-babilonese), come il citato zéru. Consideriamo all’uopo vánuva, fánuva camp.; fánua, fáuna log. ‘coperta da letto imbottita’; cat. vànova ‘frazada’; è un aggettivale s’ignorò l’origine. Base etimologica è l’akk. banû ‘make good (object); look after s.o. kindly; render buono (un oggetto), prendersi cura di qualcuno delicatamente’. La presenza e consistenza di rarissimi oggetti di lusso tra le popolazioni del Neolitico rendeva una coperta imbottita (di lana di pecora) assai confortevole. Le pretese del Wagner che questa voce sia nata in Catalogna e poi esportata in Sardegna sono miopi e fallaci. Se fossero state scientifiche, egli avrebbe dovuto indicare la base etimologica della voce catalana.
Con l’ausilio dell’intuizione (dell’intuizione utile…) possiamo chiarire il mistero del sintagma italiano “sbarcare il lunario” ossia ‘riuscire a campare sia pure stentatamente’. Si crede il sintagma esclusivamente italiano, senza considerare i radicali sottesi alle due parole, che sono mediterranei, in uso quasi ovunque, anche in Sardegna. I radicali indicano lo stesso concetto, uno accadico e l’altro sumerico: s-barcare < akk. warḫu ‘moon’; lunario < luna (agglutinazione sum. lu ‘to flare up, divampare’ + nu ‘creator’: lu-nu ‘Creatrice divampante’, ossia ‘Dea Luna’, ‘Dea Madre’). Quindi “sbarcare il lunario”, con s- che precisa il valicare, l’andare oltre, indicò l’azione di “superare il mese” (quello lunare, ovviamente). La barca non c’entra nulla.
Altra voce mediterranea incompresa è il sd. casu ‘formaggio’. Perché gli dò importanza? I fautori della “pregiudiziale latina” lo derivano dal lat. căsĕus e non s’accorgono che căsĕus è aggettivo, quindi seriore rispetto al vocabolo sardo. La base etimologica è l’akk. kasû ‘rappreso, legato’ (e siamo al formaggio). Vedi anche akk. kāsu ‘cup, bowl’, ‘misura di capacità’ < sum. kasu ‘calice’ (e siamo alla ‘scodella che dà forma’, quindi nuovamente al formaggio, ‘quello che prende forma’). Però il cognome sd. Casu non significa ‘formaggio’ ma ha base nell’akk. ḫašû astron. ‘scuro’, gr. Χάος ‘immensa buia cavità che accoglie le acque primordiali’. Ebbene, sì, il Χάος greco in Sardegna si chiamava Casu, in virtù dell’autonoma elaborazione delle radici e dei suffissi mediterranei.
Buon penultimo è il sd. pilla ‘denaro, soldi’ (parola che riemerge anche in sud-Italia: vedi la mia Grammatica Storica). I cosiddetti “puristi” la considerano voce di slang, ed ignorano che la base è il sum. pil-la = ‘unità di pagamento’: pi ‘unità di misura’ + la ‘pagamento’.
Conscio d’essermi concesso molto spazio (ma la situazione lo reclamava, essendoci innumerevoli casi), chiudo l’elenco, illustrando brevemente la questione del sardónios ghélōs o sardánion ghélōn, ossia del ‘riso sardònico’. Non intendo affatto inserire l’argomento nel paragrafo seguente relativo alle voci autoctone del vocabolario sardo, poiché questa voce non è autoctona: è solo martoriata. La prima apparizione scritta collegabile a questa espressione è in Omero Od. XX 301-302, allorché Odisseo schiva la zampa di bue lanciata da Ctesippo e “ride sardonicamente” (μείδησε δε θυμῷ σαρδάνιον μάλα τοῖον ‘sorrise in cuor suo, però dolorosamente’). L’unica ricostruzione arcaica cui è possibile agganciare l’aggettivo avverbiale greco è il composto sum. sa ‘to burn’, ‘to sting, pungere’ + raḫ ‘disease’, ‘to beat, break, crush’ + du ‘to push, thrust, gore; spingere, attaccare, incornare’ + niḫuš ‘terrifying appearance’, che agglutinandosi (sa-raḫ-dú-niḫuš, poi contratto in sardúniḫuš) porta al significato compatto di ‘dolorosissimo, sconvolgente’.
Ma tanti seriori autori greci e latini, nel tramandarsi a vicenda un’incompetenza culturale sull’omerico σαρδάνιον, sono andati a parare su altri significati, a loro parere legati a un’erba speciale che fa morire tra spasmi di labbra e digrignar di denti; senza peraltro aver mai pensato che Omero con l’aggettivo σαρδάνιον volle descrivere lapidariamente un Odisseo muto e serio, che non aveva sorriso apertamente per la provocazione di quel prepotente ma aveva soltanto rimuginato nel proprio animo la vendetta.
Sul riso sardònico si potrebbe scrivere un libro, ma sarebbe sprecato, perché parlare dell’erba sardònia o del riso sardónio è come parlare del sesso degli angeli. Nella storia di questo appellativo ognuno degli autori è stato coinvolto in un vortice di traviamento collettivo, condito da ignoranza, da presunzione e dalla fiabesca distanza tra Grecia e Sardegna, un’isola che i Greci non avevano mai visto ed alla quale, considerata la sua dislocazione nel mitico Occāsŭs Sōlis, potevano conferire a man salva tutti i misteri mediterranei covati dalle civiltà dell’epoca. Tutto ciò portò poeti e pensatori a girare su se stessi sino a parare in una messe di paronomàsie che si stratificò ed ammuffì col passare dei secoli. Il riso sardónio puzza di stantio.
In ogni modo, il gr. sardónio può anche essere inquadrato nel sum. šar ‘vacca’ + du ‘imprigionare’: šar-du ‘imprigionare entro la vacca’. Era l’urlo lacerante emesso dai moribondi nel ventre metallico di questo arnese inventato dai Cretesi e surriscaldato. Altri lo chiamano Toro di Faláride, perché donato al tiranno Falaride di Agrigento da Perillo ateniese. Il sardónikos ghélōs fu una cosa orribile che oggi, con cinica metonimia, possiamo intendere come ‘risata smodata, plebea, esagerata, chiassosa, urlante’.
Se invece vogliamo mutare il gr. sardónios in gr. sardonicós, la voce sarebbe un po’ seriore, essendo da inquadrare in un composto sumero-accadico cui sarebbe da aggiungere l’akk. niqû ‘sacrificio’. A sua volta ghélos < sum. gi ‘giudizio’ + lu ‘divampare’, ossia ‘giudizio del fuoco’. Pertanto sardonicós ghélos, nella sua commistione di sumero-accadico, presenta una pari sovrapposizione di concetti, e andrebbe a significare nel complesso ‘sacrificio dell’imprigionamento entro la vacca’ o ‘giudizio del fuoco entro la vacca’.
Arcaicità della lingua sarda. Il breve saggio sui vocaboli mediterranei non deve far pensare che ai singoli popoli rivieraschi mancasse la possibilità e l’estro per invenzioni autonome (vedi il già citato Karallu). Ogni popolo ha sempre usato la lingua secondo il proprio genio, ed i fenomeni d’isolamento – macroscopici in Sardegna – impulsero a “far da sé”, senza per questo che si smettesse di collaborare al proficuo scambio culturale al quale la Sardegna non si è mai sottratta. L’enorme massa di radicali sumerici (ed in seguito accadici) fu la banca-dati da cui attingere sia per usare il vocabolo nella sua purezza sia per elaborare filiazioni, o “ricamare” concetti autonomi. Quindi non deve far meraviglia che la stessa radice sumerica o sumero-accadica abbia dato corso a voci diverse nei singoli popoli rivieraschi. I suffissi, i prefissi – eredità del plancher sumerico – sono l’ingrediente che arricchisce i processi della fantasia individuale; cui si somma l’abitudine alla metatesi (es. craba anziché capra), alla diversa accentazione (es. càmpana anziché campàna), all’apofonesi (citerò più oltre qualche sporadico esempio latino, italico, sardo, accadico, sumerico di mutamenti -a- > -i- oppure -a- > -u-). Questi processi sono stati da me studiati e illustrati nella Grammatica Storica, e qui non m’attardo.
Sta di fatto che, per ovvie ragioni, i singoli popoli hanno elaborato i propri vocabolari secondo esigenze peculiari, e pertanto non tutti i vocaboli rintracciati per l’ampio bacino costiero sono identici tra i popoli. Molte voci appartengono ad un solo popolo.
Di seguito propongo un breve elenco di vocaboli (tra le migliaia) che appaiono formati unicamente dal genio sardo.
Áere log. ‘avere’; camp. ái; sass. abe’. In sardo antico si usava come verbo transitivo. Oggi s’usa più che altro ténnere, ténniri, jùkere, al di fuori del centro-isola dove invece prevale ancora áere. Il sd. áere, ái ha sempre vissuto in autonomia senza ricevere influssi diretti dal lat. habēre, it. avère. La spia di tale separatezza è l’assenza nel verbo sardo di h-, la cui presenza avrebbe postulato tutt’altra radice di formazione, come ora vedremo.
A mio avviso, il sardo áere, ái ha base etimologica nel sum. ab ‘cow’, mentre il lat. habeo ha base nel sum. ḫabum ‘animal’. Ambedue le basi fanno riferimento ad animali (si presume d’allevamento), specialmente alla vacca, da sempre considerata il peculium per antonomasia. Così come ancora oggi accade presso i popoli pastori del centro-Africa, considerati “possidenti”, “benestanti”, contrapposti a coloro che non posseggono bestie, anche per gli antichi Sardi e Latini il destino dovette essere uguale: il possesso di bestiame li rendeva liberi e ricchi. Di qui la nascita del verbo avere, riferito alle vacche o agli animali in genere.
Agarrutu in una pergamena arborense del sec. XII, pubblicata secondo l’originale in AStSa II 426 dal Besta, che interpreta ‘qualità di terra, forse brughiera’ (p. 429). Il passo suona: Et ego donna Nibata ponioiue saltu de Suberiu et pauli de Figu e fenu e pastu e perra de bilbicesos e bau de bodes e agarrutu. (Nell’apografo pubblicato nl CDS I, 164, che formicola di errori, si legge: e pezza de bilbiusos, abandecodes e agarratu). Niente giustifica l’interpretazione del Besta e il passo non permette di dire niente di sicuro.
Tutto quanto precede è stato scritto dal Wagner nel DES. Posso sollevare Wagner dall’angoscia facendo notare che agarrutu ha il perfetto corrispettivo in accadico: agarrūtu ‘bracciante salariato a giornata’.
Alguatzíle, -i log. e camp. ‘usciere, sbirro’; Wagner lo considera ormai fuori uso, ed in ogni modo non evidenzia l’etimo. Base etimologica è l’akk. āliku ‘goer, traveller, messenger’ + aširi (person of a special status). Pare evidente che ālik-aširi nell’alta antichità in Sardegna fosse un messo con poteri ispettivi.
Allegare, -ái log. e camp. ‘discorrere, parlare’; allèga ‘diceria, discorso’. Wagner lo crede verbo dell’uso giuridico, da it. ‘allegare, addurre ragioni, argomentare’. Ma la forma-base del lemma sardo è composta da ad (particella sardo-mediterranea di moto a luogo) + sum. ligin ‘tavoletta d’argilla con excerpta scolastici da imparare’, ligtum ‘selezione, raccolta di materiale’. Va da sé che allegáre è verbo sardiano risalente alle antichità sumeriche, indicante l’azione del “trasmettere nozioni per l’apprendimento; parlare insegnando”.
Allégru log., allirgu camp. Questo termine sembra derivare dall’it. allegro ‘lieto, giocondo’, per il quale si accampano strane e incomprensibili etimologie: fr. allegre (1130) dal lat. alacrem (DELI). Quella voce francese va bene, fa parte dell’uso mediterraneo, mentre è la voce latina ad essere discorde. Penso che la base etimologica dei lemmi sardo, italico, francese sia il sum. lugura ‘reaper, mietitore’. Si può rendere giustizia a questo termine soltanto se ci mettiamo nella condizione di capire gli antichissimi mietitori, i quali entravano nei campi cantando le lodi dell’Altissimo, felici perché stavano partecipando al rinnovo annuale del dono della vita.
Alòre log. ‘caldo lento’ (Spano). Secondo Wagner è probabile derivazione dall’it. alidore ‘siccità, stagione alida’. Invero, base etimologica è il sum. alur ‘to bake, cuocere al forno’.
Attonare, -ái log. e camp. ‘ristorare, mettere in sesto’; attonare su stόgumu ‘ristorare, rifocillare’. Anche in Italia si dice attonare lo stomaco. Ma non siamo di fronte a un cultismo, come purtroppo crede Wagner, poiché la parola è mediterranea, avendo per base il sum. tun ‘stomaco’, ‘sacca’, ‘contenitore’.
Aúra log. ‘spirito misterioso, spettro’, ‘paura’; bonaúra ‘fortuna’, disaúra ‘disgrazia, sciagura’; auradu log. ‘spaventato, atterrito’; anche ura ‘evento cattivo’ (nel senso di ura mala). Wagner non sa trovare l’etimo. Invero la base etimologica è il sum. ur ‘liver, fegato’, quello che nell’alta antichità veniva sezionato per ricavarne gli auspici (buoni o cattivi).
Aúrghere log. ‘muoversi, sforzarsi, piegarsi’ (Sanna, StaSa XII-XIII parte II, p. 441); aúlghere ‘muoversi, sgranchirsi’ (Casu). L’etimo ha base nell’akk. urḫum ‘via, sentiero’. Wagner ne indica insensatamente la dipendenza dal lat. indulgeō ‘sono ben disposto’.
Avra log. indica la ‘brezza fredda nociva alla frutta’. La sua base arcaica sta nel sum. a ‘acqua’ + bar ‘to burn’: a-bar, per metatesi avra, indicò in origine l’acqua che brucia. Evidentemente siamo in quelle rare giornate di pieno inverno quando piove acqua sopraffusa, pressoché invisibile ma capace di lasciare un millimetrico strato di gelo dappertutto, distruggendo le piantagioni.
Bi, be sd. avverbio di luogo. Cfr. ug. b ‘in’, ebr. be- ‘in’; l’avverbio di luogo cananeo è sempre agglutinato alla parola retta (es. B-ŠRDN ‘in Sardegna’, dalla Stele di Nora). L’avverbio di luogo ugaritico-fenicio-ebraico b (be) è anche sardiano. Si ritrova in molte indicazioni di luogo nelle forme be, bei, bi; indica sempre un luogo, non sempre preciso, lontano dal parlante: ‘lì’, ‘in quel luogo’, ‘a quel luogo’: siéntzia bei keret, no bestire!; a contos male fatos si bi torrada; ite b’ada?; in s’isterzu de s’ozu non be podiat aer ke murca; de listincu be nḍ’aìat prus de una molinàda; a campu bi anḍo déo; bazibbéi a domo sua; a bi sezis, si benzo a domo bostra?; in su putu bi at abba; no bi creo!
Biscaccàda ‘lentiggini’. Zonchello ignora l’etimo ma azzarda derivi da biscaccu ‘conchiglia, patella’. Sbaglia. Base etimologica è l’akk. biṣu, biṣṣu(m) gocciolina’ + kakkû(m) ‘lenticchia’. Lo stato-costrutto significa, letteralmente, ‘pioggia di lenticchie’.
Cambiare, -ái log. e camp. ‘cambiare’. Verbo presente già nei condaghes, che secondo Wagner sarebbe un evidente apporto dal tardo lat. cambiāre, di origine gallica secondo DELI. Non sono d’accordo né con l’uno né con l’altro. Base etimologica è il sum. kam ‘to alter, modificare, cambiare, mutare’ + ba ‘to distribute, ripartire’. Queste sono le stesse radici sumeriche che determinarono la nascita della parola sd. camba, da cui l’it. gamba, la quale è l’arto degli animali e dell’uomo che ha la funzione di ripartire e mutare continuamente il peso durante il movimento.
Catóiba sass. ‘prigione’. Base etimologica è l’ant. akk. ḫaṭû, ḫaṭṭû, ḫaṭ’um ‘criminal, criminale; to do wrong, commit crime, agir male, commettere crimine’ (towards someone) + ewûm ‘to impose on, imporre’. Quindi il composto ḫaṭṭû-ewûm significò in origine ‘imposizione, pena per il criminale’. Col tempo ewûm fu pronunciato -ebu, -ibu, per legge fonetica tirrenica. Questo vocabolo non esiste in nessun altro dizionario sardo, tantomeno italico.
Cùa è voce assente nei dizionari mediterranei. Dovette essere l’antico nome sardo della ‘civetta’ e del ‘gufo’, sopravvissuto grazie al cognome Còa, registrato nel condaghe di Bonarcado 57. La locuzione log. fàghere assa cùa significa ‘agire di nascosto’. Cùa, cuba è l‘atto del nascondere. L’infinito cuare ‘nascondere’ è un chiaro denominale, essendo cùa il sostantivo originario, da akk. ḫū’a ‘civetta, gufo’.
Débile, débili log. e camp. ‘debole’; cfr. lat. dēbilis ‘che manca di forza’. In Sardegna sarebbe arrivata dalla Spagna (débil) secondo Wagner. Invece la voce è decisamente sardiana, prima ancora che latina e spagnola: esattamente è l’opposto di ábile, che ha base nell’akk. ābilu ‘trascinatore’ (detto della professione di chi trascinava le navi lungo i canali o i fiumi, e detto anche dell’aquila in Logudoro).
Ábile log., ákila, ákili camp. ‘aquila’; áe (Nuorese). È proprio questa serie di vocaboli sardi (uno per ogni macro-tribù preromana) a testimoniare la scaturigine autoctona del su citato débile. L’etimologia di ákila ha base nell’akk. ākilu ‘divoratore’ (cfr. lat. aquila). Ma in Sardegna un’altra tribù utilizzava un secondo (e doppio) registro, che è āgilu, ābilu ‘trascinatore’ (detto della professione di chi trascinava le navi lungo i canali o i fiumi). Infatti destò sempre ammirazione il fatto che l’aquila con la sua forza poderosa sia in grado di sollevare e portar via persino un animale di media stazza come una pecora o un muflone. La controprova dell’autoctonia di ábile si ha in barbaricino col terzo vocabolo áe, indicante l’Aquila del Bonelli, il cui nome si riferisce parimenti al “trascinatore di navi” (dal sum. aʼu ‘towman’). Non fa meraviglia che il nome dell’aquila abbia migrato dalla Sardegna a Roma, e non viceversa: la Sardegna è fortemente montuosa e selvaggia, mentre il Lazio è fortemente pianeggiante, o leggermente collinoso, quindi totalmente arabile: luogo difficile per la dimora delle aquile.
Dogare centr., doare, addoare log. ‘scavare un fosso intorno ai terreni da debbiare’: fákere sa doga (Nuoro) ‘dissodare la terra in modo che il fuoco non passi’. Base etimologica è il sum. dub ‘to go around, encircle, turn, surround’. Col tempo, evidentemente, il termine sumerico fu omologato foneticamente al radicale sum. dug ‘pot, vaso’. Notiamo anche l’evoluzione di dogare nel significato di ‘ripararsi dal fuoco’ (fattende dogas), poi in generale ‘ripararsi’, ‘scansare’, anche ‘ripararsi (dalla pioggia)’.
Forru log. e camp. ‘forno’; cfr. lat. furnus. Base etimologica il sum. bur ‘to glow, abbagliare; to light, accendere, infiammare; to shine, risplendere, brillare’ + ru ‘architecture, costruzione’. Il composto bur-ru significò in origine ‘costruzione per accendere (il fuoco)’. La sardità della voce si percepisce per l’assenza del riempitivo -n- esistente invece nel lat. furnus. Mio malgrado, debbo segnalare DES I 536 affinché il lettore conosca le prolisse e allucinate elucubrazioni scritte su forru, ammannite come fossero ragionamenti scientifici.
Francusìna orist. ‘colica’, ‘mal di pancia’. Cossu 151 ricorda che quando uno restava a lungo col broncio gli dicevano: Pigáu sa francusina t’esti? ‘t’ha preso la colica?’; e per una persona che s’intristiva alquanto (s’affringillonàḍḍa) e non aveva voglia e forza di fare dicevano: Paris cun sa francusìna ‘Sembri con la colica’. Ma è veramente strano che per francusìna s’intenda proprio la colica, considerata la sua etimologia.
Per Wagner sa francusìna è una formazione scherzosa. Replico di no, poiché francusìna ha un proprio etimo, l’akk. parāku(m) ‘giacere di traverso, ostruire’, ‘impedire, ostacolare’ + sînu ‘luna’ col significato di ‘avere la Luna (il dio Luna) di traverso, ossia contrario’. Ora sappiamo quale è la locuzione più antica, e da dove ha origine la frase italiana tanto nota, relativa a una persona (donna prevalentemente), momentaneamente asociale, che appunto “ha la luna di traverso”, da parāku(m) > p(a)raku > franku + sînu.
Fruttòsa (Bitti) ‘piccola spazzola per pulire l’aia’. Wagner dichiarò d’ignorare l’etimo, essendo rimasto sconcertato da questo vocabolo evocante un frutto. Invero, la base etimologica è la stessa di bruttu ‘sporco’, bruttèsa ‘immondezza’; centr. bruttáre, log. imbruttáre, camp. imbruttái ‘sporcare, lordare, imbrattare’. Per la discussione e l’etimo vai a bruttu.
Gangorra ‘svasso maggiore’ (Podiceps cristatus) (Campidano); in camp. indica anche la ‘strolaga minore’ (Colymbus septemtrionalis). Base etimologica è il sum. gan ‘child-bearing, to bear young’ (infatti lo svasso maggiore porta i neonati sul dorso) + gur ‘bearer’: gan-gur ‘colei che porta i bimbi sul dorso’. L’analisi di questa voce portò Wagner fuori pista inducendolo ad associarla a gangas ‘tonsille’ (sic), e proponendola addirittura come onomatopea (sic).
Génti arrùbia ‘fenicotteri’ < sum.-akk. enti rubû ‘uccello re’ (v. akk. rubû ‘re’).
Grillu camp. ‘germoglio delle patate invecchiate, di semi, frutta, cipolle, aglio’ < sum. gir ‘erbaccia’ + lu ‘spuntare’: gir-lu > met. grillu = ‘germoglio che spunta, che fiorisce’.
Gutta1 camp. ‘goccia, gocciola’; cfr. lat. gutta ‘goccia’; centr. gúttiu ‘goccia’; log. búttiu, úttiu ‘idem’. Base etim. nel sum. gu ‘pulse, polso, vibrazione; bean, chicco, grano’ + tar ‘to untie, scatter, disperse, decide; disfare, sciogliere, slegare, spargere, sparpagliare; disperdere; staccare’. Quindi il legame gut-tar in origine indicò il ‘chicco che si stacca (dalla massa idrica)’. Da qui l’it. goccia.
Ibi, ibe barb. ‘costà, colà’ (Oliena: a ibe ‘là’; CSP 62: iui iumpat ribu; 63: aue sa foke a derettu ad iui; 220: e ccun sa uinia ki est iui; CSP 30: ki ui fuit curatore; ecc.). Si badi che questa voce è latina, e fu portata in Sardegna dai preti che scrissero le pagine dei condaghes (vedi più oltre). La propongo soltanto perché si capisca ch’essa a sua volta fu una rielaborazione latina della seguente voce autenticamente sarda.
Ingòlliri camp. ‘cogliere, incogliere’: questa traduzione è del Wagner, ed è riferita a una voce italiana alquanto omofonica ma non omosemantica. Ingòlliri indica invece il ‘colpire, ferire’: si podit ingolli ‘si può ferire’ (Villacidro). Base etimologica è il sum. gul ‘to destroy, break, flatten; distruggere, rompere, abbattere’. Il verbo è autoctono. Purtroppo quel significato di ‘cogliere, incogliere’ è messo in primo piano dal Wagner (DES 583) per evidente incapacità di comprendere il fenomeno sardiano. Il nostro filologo insiste nell’indicare la base italica di tale voce, anche a costo del ridicolo, nel centr. goḍḍìre ‘cogliere, raccogliere’, un significato che va in rotta di collisione con quello di ‘colpire, ferire, distruggere, abbattere’. La procedura d’inventarsi dei significati inesistenti e (ciò che è peggio) legarli d’autorità al campo italiano (o iberico) è frequente in Wagner.
Ísola cognome sd. < bab. is lê, iš lê ‘le fauci del Toro’ (ossia costell. delle Hyadi). Alìsa è lo stesso cognome Ísola ma rovesciato. Notisi che l’akk. is lê, iš lê in sd. è usato pari pari oppure è capovolto in al isu, ma il composto si traduce ancor sempre ‘le fauci del Toro’ (Hyadi) < alû ‘Toro del Cielo’ [ossia costell.] + isu ‘fauci’. Quanto precede è un luminoso esempio di come tra i Mesopotamici ed i Sardi in quel periodo, pur usufruendosi di una stessa Koiné linguistica, si aveva agio di “personalizzare” la combinazione degli elementi.
Kenábura, cenábura, cenábara. La Sardegna è l’unica regione mediterranea dove il ‘venerdì’ ha nome kenábura, sd. ant. kenápura.
Wagner (La lingua sarda p. 72) ricorda che già S.Agostino afferma la presenza della locuzione cena pura nella Bibbia precedente la Vulgata (locuzione sparita poi, stranamente, proprio dalla Vulgata): e qua notiamo la prima confusione del Wagner. Egli non spiega perché la “locuzione latina” fosse già presente nella Bibbia (ebraica o greca?) prima ancora della sua traduzione in latino; dice soltanto – senza dimostrarlo – che corrispondeva al gr. δεῖπνον καθαρόν ‘cena pura’. «Gli Ebrei lo adottarono per designare la vigilia di Pasqua, durante la quale ogni traccia di lievito doveva essere rimossa dalle case». La denominazione cena pura indicava, insomma, per Wagner, la vigilia della Pasqua ebraica, ed oltre a ritenerla locuzione del rituale pagano (sic!) egli confonde ancora il discorso, introducendo παρασκευή (parascève) come corrispondente alla voce cena pura (sic!), mentre noi sappiamo che παρασκευή significò ‘preparazione’ (preparazione al sabato, shabbat)’, e solo in seguito giunse a significare tout court ‘venerdì’. A Wagner sfuggì che il sd. kenàbura, kenàpura non deriva dal lat. cena pura ma da un composto sd.-ebr. kena-pura, forma cananea indicante la ‘cena di Purim’, che è la grande cena che il popolo ebraico fa il 14 ed il 15 del mese di Adar in commemorazione della propria salvezza dallo sterminio rischiato in terra babilonese prima della definitiva liberazione (la celebre congiura di Amàn); essa cade per caso abbastanza vicina alla Pesah. In tal guisa si è confusa Purim con la purificazione dai lieviti attuata prima della Pasqua. Ma tale confusione fu introdotta nel medioevo dai preti bizantini. Fatto sta che kenábura in terra sarda è un lascito ebraico precristiano. Non esiste né in Israele né altrove. Si può calcolare che la parola sia nata in Sardegna dopo il 500 a.e.v., ossia dopo la liberazione degli Ebrei, la cui strabiliante fama si espanse immantinente presso gli Ebrei che avevano già operato le prime diaspore mediterranee durante le grandi persecuzioni degli Assiri e dei Babilonesi. A meno che la parola non sia nata tra i 4000 ebrei trasferiti in Sardegna da Tiberio nel 19 e.v. Sta di fatto che la parola nacque in terra sarda, tra ebrei che si erano perfettamente fusi con la popolazione sarda. Quindi kenábura è la testimone più recente della produzione lessicale dei Sardi prima o a ridosso dell’Impero romano.
Kida, kita, kèḍḍa, ceḍḍa, cida ‘settimana’< sum. kid ‘staccare, spezzare, rompere; tagliare’. Con tutta evidenza, già dal Paleolitico i Sardi avevano capito il vantaggio di sezionare in quattro settimane il ciclo lunare, per scopi non solo astronomici ma anche calendariali. Questa parola sarda non ha alcun riscontro nel bacino, ma l’arcaica Koiné Mediterranea rispunta prepotentemente nell’anglosass. cut (to cut) ‘tagliare’ < sum. kud ‘tagliare’. E si noterà in kid/kud l’apofonesi i/u (poi vedremo quella a/i) da me citata nell’incipit, che operava nella grammatica sumerica e dilagò per tutti i popoli mediterranei (cfr. lat. faciō-efficiō, it. faccio-feci).
Miále, Miáli log. e camp. ‘Michele’; nei documenti antichi Mical, Michali, Migali, Miali = gr. biz. Μιχάλη(ς). Si può notare la caduta della velare già nel Medioevo. Poi questo processo ha preso il sopravvento in base alla legge fonetica sardiana che fa cadere le velari, specialmente nelle sillabe accentate. Questo processo infine contagiò l’altra sponda tirrenica.
Nuráki sd. ‘nuraghe’ < sum. nu ‘creatore’, ‘sperma (divino)’ + ra ‘puro’, ‘ fulgido’, ‘splendente’ (v. eg. Ra ‘Sole che splende’) + ki ‘place, earth’ = ‘sito di Ra Creatore’. Questo vocabolo è autoctono della Sardegna, al pari di log. nuraghe dove si sostituisce -ki con -ghe, evidenziando così il radicale sum. ĝa ‘house’, ge ‘shape’ (leggi ghe; ‘an architectural term’); quindi nel caso del Logudoro il significato fu ‘forma, edificio di Ra Creatore’. Insomma, i nuraghes erano dei monumenti al Dio Sole, epifania di Ra (egizio), di Eli (semitico), che rappresentavano il Dio Sommo.
Parissùos log. ‘Diavolo, Satana’. Base nell’akk. parriṣu ‘criminale’ o parīsu ‘colui che divide’. Wagner gli dà il significato di ‘(da) pari suo’, al medesimo livello’ «perché il diavolo vuol farsi pari a Dio» (sic!). La sua forzatura è suggerita dalla “pregiudiziale latina”, poiché Wagner non si volle mai misurare con le lingue semitiche. Invero, questo vocabolo è strettamente sardiano.
Piréḍḍu (Siniscola) ‘ugola’. Può essere diminutivo di pira ‘pera’ o di piru ‘cavicchio di legno’ (vedi). Però debbo rimarcare un fenomeno già chiarito nel paragrafo precedente (alla voce pilótu). In akk. pīru significa ‘elefante’ (questa è la traduzione del CAD e del CDA), mentre nelle attestazioni sarde il vocabolo prende l’inequivocabile significato di ‘proboscide’ (metonimia). Se sono nel giusto, traduco il sd. piréḍḍu come ‘piccola proboscide’ (per il modo come l’ugola si muove). Quella di piréḍḍu è una delle tante prove dell’autonomo svolgimento della lingua sarda rispetto al sumerico e all’accadico, al dilà della vasta condivisione dei radicali.
Reusare log.; arreusái camp. ‘rifiutare’: sa morti ki no podéis reusari (A. M. di Esterzili); arreúsa ‘rifiuto’; (Nuoro) su mare no rebusat abba (con -b- estirpatore di iato). Cfr. it. ricusare, sp. rehusar. Si cita come fonte il lat. recusāre voce dotta col senso di ‘fare opposizione (contro una causa giudiziaria)’, considerata dai latinisti (e da Wagner) derivante da re- + cāusa. Ma le cose non stanno così. In ogni modo, la voce sarda è autoctona, la sua base etimologica è il sum. ri- (vedi: con valore di contrarietà) + uš ‘to shut off, block up; rinchiudere, bloccare’. Chiaro quindi il significato d’origine: ‘chiudere contro’, ‘non accettare qualcosa’.
Sinnare, -ái log. e. camp. ‘segnare’, anche nel senso di ‘marchiare’ il bestiame; sinnu ‘segno, marca’; sinnadorzu log., sinnadróxu camp. ‘sito dove si marcano le bestie’, e siccome ciò si suole fare nel giorno dell’Ascensione, si chiama così anche l’Ascensione.
Base etimologica di sinnare, sinnu è l’akk. šiknum (lat. signum) ‘figura, immagine’, gr. ἴχνος ‘orma, traccia’, originariamente ‘segno, figura’. Si può notare l’evidenza della legge fonetica sarda, che fin dalle origini assimila in -nn- le consonanti estere -kn-, -gn-.
Talu cognome sardo che pare riprodurre il gr. Talos (Simonide), mostro metallico che abitò in Sardegna e traslocò a Creta. S’immergeva nel fuoco prima d’abbracciare i nemici < sum. tal ‘cry, clamor; battle cry’.
Trattalía camp. ‘frattaglie, busecca’; tartalía (Nuoro) ‘idem’; tattaréu sass. ‘coratella, vivanda preparata con interiora di agnello o di capretto infilzate allo spiedo e avvolte dalle budella dello stesso animale’. Secondo Wagner queste voci sono deformazione dell’it. frattàglia ‘interiora degli animali macellati’ < fratto ‘spezzato, frazionario’. Ma la situazione non sta in questi termini, derivando fratto dal lat. frangō ‘rompo’, mentre le voci sarde hanno base etimologica nel sum. tar ‘to cut, tagliare a pezzi, resecare’, ripetuta (tar-ta-) a indicare la molteplicità dei pezzi. Anche questa è una parola sarda in purezza.
Arcaicità del linguaggio del centro-Sardegna. L’ultimo lemma su citato coinvolge anche il Nuorese. Invero, sono una caterva le voci nuoresi conservate anche in log. e camp., per quanto poi ogni sub-regione abbia le proprie varianti fonetiche. Non mette conto osservare che il linguaggio del centro-Sardegna è né più né meno arcaico degli altri linguaggi sardi, ma è un po’ più conservativo (quasi un’isola nell’isola) – considerate le più difficili comunicazioni nel passato –. Questa osservazione va ovviamente sostanziata, poiché sui linguaggi nuoresi (e in buona quota barbaricini) si sono affermate delle idee contraddittorie che nella diffusione della cultura hanno arrecato confusione e sconcerto. Tutto nacque quando un primo intellettuale dei secoli recenti osservò che il Nuorese, tenendo Bitti come pivot, manteneva in purezza la lingua latina, al punto tale che si ritenne più conveniente prendere a misura il linguaggio bittichese per svelare alcune leggi fonetiche del latino. L’esistenza esclusiva di molti vocaboli latineggianti nelle inaccessibili aree centrali suscita indubbiamente dei problemi, ma a ben vedere sono problemi creati dagli stessi intellettuali, i quali contro ogni logica hanno imposto la falsa teoria dell’integrale colonizzazione latina delle Barbagie e del Nuorese; ne sarebbe corollario la teoria della tenace sopravvivenza del lessico e della fonetica latini in virtù dell’isolamento. Non intendo destare il riso del lettore, ma la questione suscita l’idea di un temerario generale il quale penetra profondamente in territorio nemico, rimanendone intrappolato. Mutatis mutandis, sarebbe come la situazione di Alghero: una parlata nemica incistata entro la parlata sarda.
Ma la Barbagia non fu mai colonizzata dai Romani (l’ho dimostrato nel mio “Toponomastica in Sardegna”); l’ampio territorio montano fruì (tacitamente?) di uno statuto di “libero-scambio” con le aree granarie, minerarie, portuali dell’isola, ed i montagnini continuarono imperterriti le loro millenarie transumanze tra monte e piano, senza disturbo alcuno per il collaterale commercio dei loro prodotti, a cominciare dai formaggi, dal bestiame, dai prosciutti, dalla lana, dalle pelli, dal miele, dal legno delle foreste.
Prendiamo l’esempio del verbo bittichese verberare, (Nuoro) berberare ‘percuotere, picchiare’. Cfr. pis. berberà ‘idem’. Il prototipo sembrerebbe a tutta prima il lat. verberāre ‘battere, percuotere’ < verbera ‘verghe, frusta, colpi di verga’. Ma attenzione!: la base etimologica è il sum. bir ‘to shred, strappare, trinciare’ (ripetizione icastica: bir-bir-). Si può notare che è proprio Nuoro a mantenere in purezza l’eredità sumerica, e nessuna ragione dimostra la nascita di questa parola nelle contrade laziali. La forma pisana può essere anch’essa, con tutta tranquillità, un accatto dalla Sardegna, visti i rapporti tenaci (non solo nel Medioevo) tra Sardegna e Pisa.
Occorre accettare un’evidenza scomoda per alcuni, e cioè: la sopravvivenza di sd. verberare è la dimostrazione che nella conservativa Barbagia l’arcaica Koiné Mediterranea dei tempi preromani ha mantenuto sinora più saldi caratteri, proprio in virtù dell’isolamento montano. Quindi occorre accettare che il lat. verberāre sia verbo seriore, un imprestito dal sardo.
Ci sono inoltre dei vocaboli nuoresi la cui unicità è lampante. Prendiamo bisenda ‘settimana’ (Bitti). Wagner, fisso nella pregiudiziale latina ed italica, lo volle derivare dall’it. vicenda ‘serie di fatti che si succedono alternandosi’, ed aggiunse, a rafforzo della propria intuizione: «Campus crede che si tratti di un termine pastorale, che in origine doveva indicare quel periodo di tempo in cui una persona doveva badare al bestiame in campagna in attesa che un’altra la sostituisse; ma forse si riferiva al turno settimanale per fare il cacio». Ma tutto ciò è assurdo. Wagner non sa che i pastori un tempo (e sino a ieri) facevano il formaggio ogni giorno per impedire il deterioramento del latte. Inoltre si noti il fatto imbarazzante che, mentre i due linguisti derivano la voce sarda dall’italiano, gli studiosi della lingua italiana non si sono ancora raccapezzati sulle vere origini dell’it. vicenda (DELI). In tal guisa, tutti questi linguisti non si sono accorti che è il sd. bisenda ad essere stato il prototipo dell’it. vicenda, e non viceversa.
Ciò si capisce bene osservando la base etimologica di bisenda (poi di vicenda), che è l’akk. wīṣum ‘alcuni, few’ (giorni) + emdu ‘sovrapposto’ < emēdum ‘to lie on each other, add; adjoins’. Il composto wīṣ-emdu significò in origine ‘pochi giorni affastellati; gruppo di pochi giorni’. Era un modo primitivo ma efficace per indicare i giorni della settimana, che si affastellano in gruppo per servire come base di conto dei quarti di luna. La settimana sarda chiamata bisenda è l’eredità accadica ancora conservata in rari recetti della Sardegna montana. Ma sappiamo, e vedremo oltre, che la lingua accadica è seriore rispetto a quella sumerica: penetrò in Sardegna meno di 5000 anni fa, promuovendo parole nuove, formazioni nuove, ivi compreso lo stato-costrutto. Il fatto che bisenda sia conservata proprio nel Nuorese ripropone l’idea da me evocata, quella del condottiero temerario che poi rimane intrappolato. Oggi bisenda è trattenuta soltanto sull’area montuosa, mentre dappertutto nell’isola è conservata l’arcaica voce sum. kida, cida (già citata), ch’ebbe il vigore di tenere segregata ed isolata nel Nuorese la sopravvenuta voce accadica.
È sempre dall’accadico che riceviamo la chiave del misterioso pilósu, piloséḍḍu (Fonni) ‘bimbo in età tenerissima’. Per Wagner l’origine è dal lat. pilōsus poiché, scrive, fino all’adolescenza i bimbi non si tagliavano i capelli. Ciò è ridicolo. Invece la base etimologica è il bab. pelû(m) ‘uovo’. Questo aggettivale è veramente arcaico, risale al Paleolitico o comunque al primo Neolitico, allorché s’affermo l’idea dell’Uovo Cosmico Primordiale nella mitologia di numerose civiltà, la cui forma ritroviamo in vasi elladici, in crateri minoici, in piatti moldavi (3700-3500 a.C.), nella religione egizia, ecc.
Aímu (Posada) ‘vicino’ (Spano). Wagner lo considerò lemma sospetto, inaffidabile, ma sbagliò. La dimostrazione proviene in linea indiretta dala lingua italiana, dove s’usa la parola vicìno < lat. vicῑnus < vῑcus, indicante ‘quello che vive nello stesso gruppo di capanne’, da cui it. vìcolo ‘stradetta stretta’ (luogo dove tutti fanno vita in comune). Parimenti, a Posada scopriamo la più antica parola mediterranea indicante ‘colui che vive sull’altra sponda del fiume’. Ricordo che Posada sorge sulla foce di un fiume ad estuario. Con tutta probabilità, in origine su ambo le rive c’erano due villaggi, due gruppi di capanne, onde si formò un epiteto riconducibile ad akk. aḫû ‘to fraternize, diventare fratelli’ + mû ‘acqua’ (del fiume): il composto di stato costrutto aḫῑ-mû significò in origine ‘fratello del fiume’, ‘dirimpettaio del fiume’.
Ammadeskinzu (Dorgali) ‘un cibo che si ferma nella gola e vorrebbe tornare su’. Base etimologica è l’akk. ma’dû ‘large quantity’ + ešqu ‘solid, massive’.
Azírima nella frase sunt azírima ‘sono opposti’ (Orotelli: Spano); éssere azìrima ‘essere in discordia’ (Casu). Wagner ignora l’etimo. Base etimologica è l’akk. zīru ‘hate, odio’ + emmu ‘hot, bollente’. Quindi a zírima in origine significò ‘’(essere) in odio al calor bianco’.
Tornerò più volte e in altro modo sui “latinismi” del Nuorese e della Sardegna, poiché serve riproporre su basi nuove l’intera questione.
Le prevaricazioni dei preti nel Medioevo. La storia è feconda di notizie sugli scontri religiosi, ma non riesce a narrare minutamente gli avvenimenti a causa delle lacune prodotte dall’uso perverso della damnatio memoriae. Si conoscono pure altri tipi di silenzi plumbei. Siamo indotti ad intuire che molti silenzi della storia celino, in quanto tali, delle trame significative; l’assenza di documenti dovrebbe costringere lo studioso a un supplemento di sforzo per individuare un metodo capace d’interpretare le verità che non ebbero cronisti.
La procedura da me suggerita è normale tra gli archeologi. Purtroppo i tempi in cui il clero cristiano prevaricò le culture precristiane e cancellò le religioni patrie hanno focalizzato gli storici soltanto sulla documentazione emersa: edicta, historiae, epistulae, anecdota; però è mancata la curiosità per le modifiche forzose del vocabolario, non foss’altro: perché mancano le fonti scritte, e laddove scripta deficiunt lo studioso spegne le luci, venendo meno alla propria funzione. Per fortuna, la lingua (il vocabolario di un popolo) è capace, per sua natura, di superare d’un balzo millenni di silenzi. E qui subentra il glottologo. Per fare il balzo, però, egli deve operare col massimo rigore, con metodo etimologico indiscutibile, che sia veramente capace di riesumare le verità del passato. Basta un passo falso, e l’oggetto della ricerca, anziché ricomporsi, si frantuma.
Si può immaginare che durante i “secoli bui” del Medioevo sardo i preti cristiani operassero di gran lena per capovolgere la situazione religiosa a loro vantaggio, e lavorassero decennio dopo decennio per imporre al popolo analfabeta, abitatore dei villaggi, vari giochini di parole i quali travisavano, distorcevano, capovolgevano i significati originari, lasciando quasi intatte le fonetiche. Dopo lo tsunami di Saulo che aveva stravolto i vocaboli greco-romani facendogli maturare nuovi concetti universali, era il tempo del lessico dei singoli popoli. Quello fu l’unico aspetto incruento della rivoluzione cristiana, che avanzò lungo il sentiero dell’evoluzione semantica, coniata a tavolino da chierici dotti, impartita dai pulpiti e accettata lentamente e supinamente dai fedeli. Un metodo anch’esso combattivo ma subdolo, che sovvertì parte del patrimonio lessicale dei popoli.
Tutti questi aspetti sono stati da me trattati scientificamente nel 2° volume della Enciclopedia della Civiltà Shardana, oltreché nel libro Monoteismo Precristiano in Sardegna. Qui non m’attardo.
Latinismi veri e latinismi degli amanuensi. I preti che hanno travolto l’universo religioso dei Sardi erano di origine e formazione bizantina, e tra di loro usavano la lingua greca. Guarda caso, di grecismi la lingua sarda è totalmente e paradossalmente scevra, nonostante che quei preti si siano avvicendati (o siano rimasti) nell’isola per cinque secoli. I famigerati “latinismi” del vocabolario sardo, che tutti suppongono nati ad opera dei preti bizantini nell’Alto e nel Basso Medioevo, sono invece di epoca pregressa, non appartengono affatto al periodo medioevale (tantomeno al periodo romano), e quindi vanno ben spiegati. Di essi s’era già accorto Dante Alighieri, il quale nel De Vulgari Eloquentia I, XI scrive: Sardos etiam, qui non Latii sunt sed Latiis associandi videntur, eiciamus, quoniam soli sine proprio vulgari esse videntur, gramaticam, tamquam simie homines imitantes: nam domus nova et dominus meus locuntur ‘…e rigettiamo anche i Sardi, i quali non sono italici ma agli italici sembrano doversi associare, perocché questi soli ci appaiono privi di un loro proprio volgare, e imitano la grammatica [ossia il latino] come le scimmie imitano gli uomini; essi dicono infatti: Domus nova e Dominus meus’.
Ma i Sardi non hanno mai scimmiottato i Latini. Sulla questione, non c’è stato un solo dotto che non abbia preso un abbaglio. Il lettore appassionato che abbia la possa di leggere tutto intero questo Dizionario Etimologico, apprenderà che i vocaboli sardi derivanti direttamente dal latino sono molto meno del 10%. A chi vuol dichiarare tale residuo un’eredità della colonizzazione romana, glielo concedo, ma stupirei se dicessi che i Romani a loro volta hanno ereditato dalla Sardegna molto più del 10% di vocaboli.
Sino a che non cambierà il punto di vista dei dotti sulla questione, sino a che non si accetterà che la lingua latina e la lingua sarda fecero parte della grande Koiné Mediterranea, non potrà mai cadere la funesta “pregiudiziale latina”. Essa deve cadere a maggior ragione, se si considera che migliaia di parole che i più considerano latine erano parlate dai Sardi in piena età nuragica, ossia almeno 1000 anni prima che sul Palatino sorgesse la prima capanna di frasche. Com’è che il popolo laziale era riuscito a saturare di latino la lingua dei Sardi, se a quei tempi Roma stava ancora “in mente Dei”?
Questo fenomeno apre un ulteriore spiraglio che aiuta a capire la conservativa parlata nuorese e la conservativa parlata barbaricina del nord, che somigliano molto più al latino rispetto alle parole consorelle parlate nel resto della Sardegna. Beninteso, con ciò non sto concludendo il discorso accennato al paragrafo “Arcaicità del linguaggio del centro-Sardegna”. Anzi, sto allargando la visuale; ma preferisco rivelare gradualmente, lungo tutta questa premessa metologica, come dev’essere considerata l’intera questione.
In questo paragrafo mi preme affrontare i latinismi profusi a piene mani nei più antichi documenti sardi, ossia nei condaghes e nelle carte coeve. Non ho mai letto alcuna indagine da parte di nessun linguista, che illuminasse tutti quei latinismi con l’unica ragione che può giustificarli: a quei tempi nei quattro Regni sardi c’era un altissimo tasso di analfabetismo che coinvolgeva anche parte dei nobili (i quali furono per lo più i dettatori dei documenti dell’epoca). Non intendo dire che i majorales fossero una massa di analfabeti. Però posso affermare che non erano fior di letterati. Al punto che s’affidarono docilmente agli amanuensi che registravano ufficialmente le loro dettature. Ma chi erano quegli amanuensi? Presto detto: erano gli stessi preti di formazione latina che periodicamente andavano e venivano tra i monasteri, abitando ora in cenobî del Continente, ora in quelli sardi, e viceversa. Non era gente stabile (esclusi pochi), tantomeno nativa della Sardegna; in più, il latino era la loro lingua principale, anche per capirsi reciprocamente, visto che ai monasteri convergevano preti di varia origine, del profondo Sud e del profondo Nord italiano. In certi monasteri dimoravano i preti francesi. Qualcuno sa dire con quanta facilità quei preti dominassero la lingua sarda, anzi i vari dialetti esistenti nell’isola?
Non mette conto allungare la spiegazione: quei preti scrivevano sotto dettatura o sulla traccia di un papier scritto rozzamente dal proponente; e nell’esigenza di rendere nel modo più perspicuo il pensiero del proponente, spesso e volentieri innestavano qua e là i propri latinismi. Di latinismi arbitrari sono zeppi i condaghes. Ciò che fa male in questa vicenda è che i filologi votatisi a tradurre le antiche carte della Sardegna abbiano creduto che i latinismi appartenessero alla parlata sarda.
Di seguito faccio qualche esempio, tra le migliaia che impellerebbero (ma si vedano per questo i lemmi nel Dizionario). In ogni modo, approfondirò la questione nei due paragrafi successivi oltreché, passim, in tutti gli altri paragrafi.
Auinde log. ant. (CSP 5: et falat su ualliclu derectu ad riuu, auinde riuu falat isc’a badu de preuiteru et cludet; CSNT 290: auinde toctuve via a derectu ad rivum de gulpe). Cfr. lat. ăb-inde ‘di là’ (moto da luogo). Questa voce antica è tratta di peso dal vocabolario latino ad opera dell’amanuense che scrisse il documento sardo. Di questo procedere “disattento” sono colmi i testi antichi della Sardegna (nota, qua stesso, ad rivum, costruzione inequivocabilmente latina). Per ulteriore nota, faccio seguire il lemma-base inde.
Inde log., indi camp. avv. ‘ne’ (traduzione del Wagner). Questa è una delle tante voci sarde discutibili. Esiste anzitutto nelle carte antiche. Sono troppi gli indizi che denunciano una certa “scioltezza” nelle redazioni dei testi antichi, i quali quasi certamente, o quasi sempre, erano scritti sotto dettatura, e venivano arrangiati secondo la dottrina linguistica dell’amanuense, al fine di evitare le oscurità o le asperità del linguaggio sardo, percepite come tali dall’amanuense stesso.
L’avv. di luogo lat. in-dě (ant. im-dě) significa ‘di là, di lì, da quel luogo’ (moto da luogo): inde reversus ‘tornato di là’; provenienza sociale: ‘da lui, da loro’: inde oriundus erat ‘derivava da lui’; fig. ‘da ciò, quindi, per conseguenza’. Questa voce latina ha per base il sum. im ‘to run, uscire di corsa’ (moto da luogo) + de ‘to bring’. Il composto im-de significò in origine ‘uscire portando, recando’.
Riporto al riguardo le citazioni antiche prodotte dal Wagner: CSP 207: derun inde su saltu de Ualle de Cucke; CV XV 4: pro su ki apat indi proi sanctu Antiogu. Spesso indě si esprime encliticamente: ‘nde, ‘de (CSP 204: non tinde do; ca ui andai e ‘nde la leuai; CSMB 48: Comporeilli a Petru Zote terra in Pubusone et fegindelli sollu).
Carnattu (St. Sass. I, 69) è un altro tra le migliaia di testimoni: dessos qui fachen carnattu et dessa bructura de cussu. A quanto pare la frase si riferisce ai macellai che manipolano la carne per fare salsicce e altro, producendo inquinamento. In Sardegna, oltre a petza, l’altro vocabolo indicante la ‘carne’ è carre (vedi per l’etimo); in Sardegna manca la parola-base carne. In questi documenti medievali, inevitabilmente composti da scribi di estrazione pretesca e formazione latina, sono molte le parole influenzate dalla cultura latina e italiana.
Famígiu Stat. Castels. 179: gasi su iuuargiu, famigiu i ouer figiu dessu pupidu; 232: ouer roba de alcunu famigiu ‘servo’. Cfr. it. ant. famiglio. Questa voce è un esito eclatante della libertà con cui i preti di formazione latina, arrivati in Sardegna nel Medioevo dall’Italia o dalla Francia, maneggiarono le parole autenticamente sarde che gli venivano dettate per i testi ufficiali.
Fizzastru log., fillastu camp. ‘figliastro’ (CSP 31: cun sos fiastros; CSNT 29, 200, etc.: filiastru, filastru). Questa voce è influenzata dal suffisso italico di figliastro < lat. filiaster (REW 3297).
Gotantu, gatantu log. ant. = it. antiq. cotanto. Il vocabolo è l’ennesima spia del fatto che i preti e gli altri amanuensi scrivevano la lingua sarda con una certa disinvoltura, impaniati dalla propria formazione di base.
Infra log. e camp. ‘fra, infra’ (Stat. Sass. I, 27: infra dies XX; infra de otto dies; Liber Jud. Turrit., cap. 8: infra sa ottova de Pascha Manna; Cod. Sorres, cap. 20: infra dies XV). Questa voce in Sardegna si usa ancora; ma è italianismo dotto dal lat. infra. Anzi, qui siamo al latinismo puro.
Patre log. ant. ‘padre, babbo’ (CSP 15, 38, 262); patri (CV V, 3); padri (CV III, 3; V, 3; XIV, 9; XIX, 5). Accatto dall’italiano padre < lat. pāter. Questa parola non è mai stata usata in sardo (del Monte Santu Padre discuterò oltre). Questo è uno dei segni macroscopici che gli amanuensi latini dell’epoca rimaneggiarono ad libitum il linguaggio sardo nella registrazione delle carte; lo fecero, a quanto pare, persino sotto dettatura diretta.
Pecuiu sd. ant. CSP 231: II sollos de pecuiu; CSMB 43: in tremisse de pecuiu), scritto anche peculiu (CSMB 41: et sollu de peculiu) ‘sostanza, peculio’. Nelle CV XX, 2 figura nell’antico significato di ‘animali’ (bollant pasquiri cum peguliu issoru, bollant arari…). Chiarissimo esempio del fatto che molto spesso gli amanuensi (preti) di formazione latina acquisiti ai vari monasteri dei giudicati si esprimevano, quand’era possibile o necessario, con vocaboli estratti dal proprio bagaglio culturale, per quanto il vocabolo fosse estraneo alla tradizione sarda. Vedi anche pecuiare e pegugiare.
Termen log. ant. (CSP 187; CSNT 43) ‘confine’; pl. termenes. Per l’etimo vai a tremma. Questa voce è palesemente raccordata al lat. termen. Attualmente si preferisce trèmene.
Turpe log. ant. in faker turpe ‘fare un torto, offendere’ (CSP 43: ca minde aueat fattu turpe duas uias; 73: e cca ui li feki turpe). La voce è un classico accatto dal latino.
Uske a, log. e camp. ant.; usca a (CV, IX, 2) = lat. usque ad. Voce dotta latina.
La pregiudiziale latina. A mio avviso i latinismi delle antiche carte sarde sono stati sottovalutati a causa dei pregiudizi, perlomeno a causa degli equivoci che da sempre hanno covato sulla questione. A quanto pare gli equivoci sono sorti persino prima che Dante prendesse la celebre posizione nel De Vulgari Eloquentia, considerando i Sardi scimmiottatori dei Latini. Forse gli equivoci risalgono addirittura agli antichi Romani. Non ci possiamo meravigliare più di tanto. Si dice che Giulio Cesare fosse poliglotta, e fosse tanto geniale da saper dettare in una sola seduta più lettere in diverse lingue straniere. Io ho grande ammirazione per il genio di Cesare, ma penso che le dettature parallele e simultanee gli riuscissero facili per il fatto che i popoli celtici ai quali scriveva parlavano lingue molto simili a quella latina (ed a quella sarda), ancora prima di essere colonizzati da Roma. Io sono convinto di questa asserzione, la quale va a ribadire la verità di quanto ho asserito nel primi paragrafi di questa premessa.
Insomma, la Koiné Mediterranea era tanto forte proprio perché univa molte lingue tra loro simillime. Wagner ai suoi tempi non potè restare immune da tali equivoci oramai cristallizzati da millenni. Peraltro l’educazione da lui ricevuta nella natia Germania non era in grado – in quei tempi di odio e di revanche – di ribaltare quella poderosa corrente di pensiero che proprio partendo dal focus germanico stabiliva “scientificamente” che ogni lingua del Mediterraneo fosse stata cancellata dal poderoso intervento romano e poi dalla “tabula rasa” operata dai popoli germanici con le Invasioni barbariche.
Wagner credette in buona fede ed acriticamente a questi millenari pregiudizi, incancreniti con l’avvento del Romanticismo, assumendoli come verità, e non è un caso che quasi ogni lemma del DES evidenzi in primo piano le voci bittichesi, o quelle nuoresi, rispetto a quelle logudoresi e campidanesi. Egli era convinto – e lo ribadì apertamente nella “Fonetica Storica del Sardo” – che le voci bittichesi e nuoresi fossero i prototipi (latini) del vocabolario sardo, e che le voci consimili del Logudoro e del Campidano fossero semplici derivati adattati foneticamente secondo il genio delle singole parlate sarde.
Anche i vari linguisti che avevano preceduto Wagner erano stati abbagliati dai “latinismi” del Nuorese, e Wagner, ereditando il pensiero dell’accademia, ne fu corifeo entusiasta. I tentativi del Wagner di formalizzare le sue credenze entro la “Fonetica Storica del Sardo” sono stati da me denunciati, come spiego nel cap. 3.1 della mia Grammatica Storica. Fu tale l’arbitrio dei linguisti del passato, che hanno addirittura inventato delle “leggi fonetiche” le quali dovrebbero dimostrare la derivazione del sardo dal latino.
Ad esempio, Wagner sostenne che il log. abba deriverebbe dal lat. aqua, in virtù dell’esito lat. -q- > sardo -b-. Nella mia Grammatica io dimostro che -q- = -b- non è prova di alcun processo derivativo; non siamo di fronte ad un fonema derivato diacronicamente dall’altro, bensì di fronte a due fonemi sincronici, operanti ognuno per proprio conto prima dell’invasione romana. Abba esisteva già nel vocabolario accadico: abbu ‘palude, pantano’; abbû ‘fauna acquatica’; bā ‘acqua’; sum. a’abak ‘(acqua del) mare; sea (water)’, a-ab-ba ‘idem’ (< a ‘water’ + ab ‘sea’ + ba ‘marine creature’). Il sd. abba, in tal guisa, non ha concesso niente alla lingua latina, rimanendo inalterato fino ad oggi ed ignorando il lat. aqua, il quale invece riuscì ad insinuarsi nel dialetto campidanese (áqua). In origine la Sardegna aveva un doppio registro, che poi lasciò in eredità due lemmi: abba a nord, áqua a sud. Al secondo registro appartiene l’akk. agû, egû ‘onda, corrente, flutto’. Fenomeno di Lautverschiebung nord ≠ sud, come spiegherò nel successivo paragrafo.
Stesso discorso vale per il suffisso sardo -u, che Wagner fa derivare dal lat. -us, mentre esistevano entrambi nella stessa epoca, ognuno operante nel proprio campo linguistico prima dell’invasione romana. Per il sardo -u non c’è da accampare un supposto influsso romano, poiché già le lingue mesopotamiche (sumero-accadico-assiro-babilonese-cananeo) mantennero per migliaia d’anni il proprio suffisso -u al quale possiamo e dobbiamo riferire una -u sarda originaria.
Percepiamo ancora le arcaiche desinenze cananee in -ū per il nominativo anche nell’antico ebraico (1Sam 2,10 ‘ālū “l’Altissimo”, corrispondente a Yahweh del primo stico; Sal 140,9 yārūmū “l’Eccelso”, anche esso in parallelo con Yahweh del primo stico). Parimenti percepiamo ancora nell’antico ebraico le arcaiche desinenze cananee in -ī per il genitivo (Sam 22,44; Ez 5,3; Os 11,4; Sal 26,10). Altro che genitivo di formazione latina! Il genitivo latino non è altro che un genitivo mediterraneo con basi etimologiche semitiche!
Tornando alla Sardegna, era tipicamente sardiano, quindi originario, pure il suffisso femminile -a, per il quale non c’è da accampare la colonizzazione romana, come pretende Wagner, essendo tale forma, di per sé, latamente presente nel Mediterraneo, comune, ad esempio, ai Latini, agli Šardana, agli Aramei. Ed è proprio l’identità o similitudine di certe leggi fonetiche tra Sardiano ed Aramaico che lascia capire l’autoctonia di molte forme della lingua šardana, preesistite all’invasione romana e coeve alla celebre Koiné aramaica esistita prima delle falangi di Alessandro e prima dei Cesari.
Pari discorso riguarda le velari sarde k, ĝ, che Wagner crede derivati dal lat. c, g, mentre esse preesistevano nella lingua sardiana, con un impianto confrontabile alle velari accadiche k, g, ḫ.
Questa certezza scientifica è corroborata da un fatto celebre ancorché strambo, che è il seguente: dalle leggi fonetiche del sardo attuale (e del sardo medievale) i cattedratici hanno derivato le loro certezze sulle leggi fonetiche latine, non viceversa! Infatti per dimostrare che il latino ciceroniano aveva le velari non si è fatto di meglio che supporne l’esistenza (altrimenti indimostrabile) attraverso l’attuale parlata di Bitti, in Sardegna. Ma quei “linguisti” non sono gli stessi che pontificano l’origine del sardo dal latino?
Insomma, quei cattedratici hanno preso al guinzaglio la lingua sarda per andare in soccorso della lingua latina intesa come Ursprache mediterranea. Si badi, è stata soccorsa la lingua latina: nessun’altra! Come dire che la “trasfusione di sangue” è andata ad una sola lingua da loro prescelta. Mentre tutte le altre lingue italiche e quelle mediterranee lato sensu non hanno meritato le loro attenzioni. Perchè? Ovvio: essi sono partiti dall’ideologia secondo cui tutta la civiltà mediterranea oggi percepibile avrebbe l’incipit nell’Urbe. Da qui il “soccorso” della lingua sarda nei confronti della propria… “madre”! Ma vediamo di seguito qualche esempio che meglio illustri la questione.
Accásu log. ‘per caso, forse’; cfr. sp. acaso. Wagner deriva accásu dal sardo casu, e questo direttamente dall’it. caso ‘avvenimento fortuito, imprevisto’, considerandolo dunque non solo un prestito ma anche un cultismo italianizzante. A sua volta, occorre badare che tutti i linguisti sinora hanno considerato la base di it. caso, ossia il lat. cāsus, come cultismo che fu tale già nella fase latina. Non hanno saputo fare altra considerazione davanti al verbo da loro considerato come incipit, che è cădere ‘cadere, cascare’. Il cultismo sortirebbe – secondo loro – dalla fusione (o confusione) della semantica del “cadere” con quella dell’ “accadere”. Questa confusione dura da oltre 2500 anni, ma è confusione confezionata “a tavolino”, freddamente, senza meditazione, quindi idealistica, ed è ora di dare un colpo a tale nodo gordiano. La vera base etimologica del lat. cāsus, it. caso, sd. casu è l’akk. ḫašû ‘frantumare’, anche ‘to become dark, diventar buio’, ‘suffer darkness, essere cieco’. Insomma, tutto rinvia alle origini dell’Universo e all’arcaico cognome sardo Casu, identico al gr. Χάος, che identificano l’immensa buia cavità che accolse le acque primordiali. Pertanto il riferimento non è alla caduta ma al caos.
Avu it. ‘nonno’, apparso in Italia prima del 1374 col Petrarca; al pl. ‘antenati’ (1581, T. Tasso); vocabolo ritenuto dotto dal DELI, originario dal lat. āvu(m), a sua volta considerato di origine indoeuropea col sign. di ‘anziano’. Non discuto, per spirito di carità, che l’origine possa essere quella, ma la voce è condivisa anche nel campo semitico, dall’ebr. āv ‘padre’ ( אׇב ).
Cartu log. ‘misura di grano, di fave, ecc.’. Cfr. it. quarto ‘idem’ (che soltanto foneticamente corrisponde al lat. quartum ‘quarta parte’ aggettivale di quattru: vedi). Wagner non dà l’etimo, sembrandogli ovvia e bastante la derivazione latina. Invero, base etimologica è l’akk. kārtum ‘prezzo corrente’. Cfr. akk. qa ‘misura di circa 1 litro’; karāṭum ‘(merce vendibile), da cui it. carato (misura per pietre e metalli preziosi).
Para camp. ‘frate’. Wagner lo deriva dal cat. parə ‘padre’ (padre in ogni senso, anche come sarcerdote o mestierante del sacro). Anche in altri dialetti italiani abbiamo gli stessi esiti. Ma in ciò Wagner è generoso, perché ogni volta che cita l’origine catalana vuole sempre intendere che il catalano stesso a sua volta ha origini latine, quindi le parentele con analoghe voci italiane sono già messe nel conto. Ovviamente questo modo di andare per etimologie è incongruo, quindi mi tocca subentrare precisando che para potrebbe forse allinearsi con l’uso akk. di pāru, accus. pāram (un ufficiale). Ma ci viene incontro una migliore opzione, l’akk. pâru(m) ‘cercare, andare a cercare’. Per decidere quale delle due opzioni s’attagli alla voce sarda, dobbiamo osservare che i primi monaci che diedero impulso alla costruzione della Cristianità (non parliamo poi dei frati minori francescani) erano anzitutto frati “cercatori”, per aver fatto voto di assoluta povertà. Nonostante tale vocazione, i frati non sono mai stati indicati come “pitocchi” ma in altro modo, almeno in Sardegna; il Sardo aveva un tale rispetto della povertà, che anche il classico mendicante non veniva chiamato così, sibbene mazináiu ‘venditore d’immaginette sacre’, con riferimento a ciò che lo caratterizzava. Così fu per i primi frati cristiani, che vennero catalogati come ‘cercatori’, dall’akk. pâru(m).
Párdula. In Campidano è il corrispettivo della casatìna del nord Sardegna, ma al posto del formaggio si preferisce la ricotta. La base etimologica è l’akk. parû ‘base’ + dulû ‘secchiello’ (stato costrutto par-dulû > párdula), col significato di ‘(dolce sostenuto da una) base a secchiello’. Secondo Wagner questa voce può risalire a lat. quadrula «siccome le pardulas sono di forma quadra». Invece le pardulas sono tutte di forma tonda. Sale a galla l’ennesimo intento ideologico d’indovinare anzitutto la fonetica latina più consona, proporla come fosse una base etimologica cogente, e ricondurre ad essa il significato della parola sarda, con plateali stravolgimenti della realtà.
Pesáre1 log., pesái camp. ‘pesare, bilanciare’ (Stat. Sass. I, 30 (13r): Sa mercatantia et issas cosas qui si aen uender sas quales se pesan, neuna persone uendat ouer peset ultra libras .X. si non cum sa istatea dessu cumone); fig. ‘apprezzare, giudicare il carattere, l’indole di una persona, ponderare’: l’appo pesadu bene. Cfr. lat. pendere ‘appendere, pesare, pagare’. Se ne ignorò l’origine, che è dall’akk. pedû, padûm ‘to set free, absolve, be merciful; liberare, assolvere, esser pio’. Questi concetti sono strettamente legati alle pratiche dei dazi reali ed anche alla pratica della decima data al tempio: da una parte il concetto della assoluzione, affrancamento del cittadino che ha fatto verificare la produzione, cedendo una parte come tributo al re; dall’altra, parimenti, la giustezza del tributo dovuto al tempio, dimostrazione di pìetas, di correttezza nel rapporto con Dio.
Piatza sass. (nell’agglomerato urbano è il luogo alquanto largo creato per ampiamento d’una via, d’un sito). Termine paneuropeo ed eurasiatico, del quale uno dei riferimenti sta nel gr. πλατύς ‘largo, ampio’, fem. πλατεῖα ‘via ampia nella città’; cfr. lat. plătēa ‘via ampia, cortile’. Pompeo Calvia: Li Candaléri fàrani in piàtza / cu li vétti di rasu trimuréndi… ‘I Candelieri scendono in piazza (ossia nella via più larga di Sàssari), con i nastri di raso tremolanti…’. Vedi anche sp. plaza ‘piazza’, fr. place ‘piazza’ ma anche ‘posto, sito’ = ingl. place ‘luogo, sito’ (le ultime tre voci sono latinismi da plătēa).
Il lemma sardo piatza, pratza, paltza e simili, così semplice e così complesso, ha numerose parentele semantiche oltre a quelle viste, ad iniziare da it. pertùgio ‘stretta apertura naturale o artificiale’, sd. paltùsu, partùsu ‘foro’, per estensione ‘ano’; camp. pratzìri, log. paltìre ‘dividere, staccare’, lat. partior ‘divido’; it. partìre ‘dare origine al moto di allontanamento’.
Il termine sardo non è un latinismo, non lo è nemmeno il termine italico, e nemmeno lo sono i derivati sardi come pratzìri, paltzìri ecc. Il termine è arcaico, mediterraneo, primamente sumerico: appunto da sum. pad, padr, par ‘rompere, spaccare, dividere’ + zu ‘lama o punta dell’aratro’: par-zu ‘spaccare con l’aratro’, oppure par + tab ‘compartire in due, suddividere’: par-tab ‘rompere in due’.
Pilu1, filu. In log. e camp. significa ‘pelo, capello’. Viene proposto dal lat. pĭlus. Ma se ne ignorò l’origine. In analogia con pūbēs ‘peluria’ dei giovanetti, la -l- è una originaria -r- mediterranea: cfr. ebr. pera ‘pelo’, akk. per’u ‘bud, shoot’; vedi sass. péru ‘pelo’.
Pisciòni camp. ‘polpaccio’. Ancorato alla pregiudiziale latina, Wagner segnala come base il lat. piscis ‘pesce’, senza badare all’assurdità dell’accostamento. Invece la base etimologica è il sum. peš ‘topo’ + unu ‘(animale) selvaggio’, col significato di ‘topo selvaggio’ (ossia Rattus). Questa voce è autoctona della Sardegna. Ma la circolazione culturale nel Mediterraneo non è mai cessata; pertanto anche i Latini vollero comparare il muscolo (ad esempio, quello del braccio) a musculus ‘topolino’, causa l’atteggiamento tipico dei topi d’ingobbire la schiena quando stanno fermi.
Ragno (voce italiana). Ma vedi sd. ranzόlu, aranzόlu, arranzόlu ‘ragno’ (Araneum species). Cfr. lat. arāneum, gr. αράχνη ‘ragno’. Base etimologica il sum. raḫ ‘to kill, uccidere’ + nu ‘to spin (thread), tessere (fili)’. Il composto raḫ-nu (> it. ragno) significò ‘assassino che tesse’. In Sardegna ritroviamo la stessa base mediterranea ma col suffisso aggettivale -lu. Questo è uno dei tanti esempi di false origini latine.
Siḍḍu2 (Bitti) ‘moneta antica’; (Desulo) ‘occhio di pernice’ (callo); (Cagliari ‘stella di mare’ (echinoderma), ‘cerniera, cardine delle ostriche e delle arselle’ (Marcialis); ‘coppetta, ventosa del polpo’. Nel CSNT figura col senso di ‘sigillo’; armentariu de sigillu (88, 115, 240); maiore de siillu (129). Wagner propone sbrigativamente per tutte queste voci l’origine dal lat. sigillum. Ma quest’operazione è ametodica, poiché le semantiche sono molto diverse e vanno spiegate una a una.
La prima voce, relativa alla ‘moneta antica’, ha base etimologica nel sum. šid ‘to count’. Quella relativa alla ‘ventosa’ del polpo può avere base nel sum. sidug ‘cavity, cavità’. Il significato di ‘stella marina’ può corrispondere al sum. si ‘horn, corno’ + du ‘to go, andare’ (col significato di ‘corni che camminano’. Il significato di ‘occhio di pernice’ può essere dal sum. si ‘horn, corno’ + dun ‘to dig, scavare’ (col significato di ‘corno che scava, che infilza’).
Sitzillu camp. ‘quarzo, silice’; sa pedra sitzía ‘pietra focaia’ (Mogoro). Base etimologica il sum. zi ‘life, vita, soffio’ + zu ‘flint, pietra focaia’ + illu ‘source, sorgente’. Il composto ziz-z-illu significò ‘pietra (focaia) sorgente di vita’. Tale fu il grande significato iniziale. Voler derivare questa voce dal lat. siliceus ‘di silice’ (come propone Wagner) significa storpiarne la vocalità e dare alla voce sarda un marchio d’accatto immeritato.
Suspirare log. ‘separare il siero dal latte’ (Spano). Base etimologica il sum. peš ‘to be thick, essere spesso’. Il latte nella cagliata s’ispessisce. La definizione dello Spano è infelice, poiché il siero non è un bi-componente separabile dal latte ma è un prodotto di trasformazione, diventato tale dopo l’inserimento del caglio. Wagner a sua volta s’intromette aggravando la situazione (DES II 252), poiché origina suspisare da un inesistente lat. *suspe(n)sare, quasi un ‘sospendere’, ignorando peraltro il contesto della caseificazione e rinunciando a interpretarlo.
Lautverschiebung. L’Accademia degli indogermanisti presenta la Lautverschiebung come problema esclusivamente germanico, mentre invece essa pervase (in parte ancora pervade) mezzo mondo, ed è vivissima anche in Sardegna. La Lautverschiebung (“rotazione consonantica”) divide la Sardegna metà per metà. Quindi a sud égua, a nord ebba. Se si chiedono lumi all’accademia, la risposta è che la /b/ del nord è fenomeno indotto dal latino (Wagner e Paulis), e non si va oltre: si legga per intero la Fonetica Storica del Wagner, con annesso l’ampio commento del Paulis.
In realtà, la “Rotazione consonantica” sarda è fenomeno arcaico, che vige nell’isola da almeno 40.000 anni (dai tempi Cro-Magnon), se non da prima, in ogni modo da quando si parla la lingua sumero-sarda. Il tutto è collegato strettamente a un fatto non considerato, ossia che in Sardegna sin da allora si svilupparono due fortissime tribù e, come accade in ogni divisione tribale, esse sono vissute sino a pochi millenni fa combattendosi (quando necessario) o almeno separandosi. Peraltro il 70% dell’isola è montagnoso, e già il Lamarmora indicava nei vertiginosi sprofondamenti tra le montagne un problema immenso che favorisce le reciproche separazioni.
Le separazioni tribali, e la scelta di starsene l’uno separato dall’altro, determinò anche la perdita dell’indipendenza sarda, a ben notare. La libertà delle tribù sarde finì con Josto, nel pessimo indimenticabile momento in cui Amsicora tentava disperatamente di far scendere a valle contro i Romani qualche squadrone di Barbaricini. Ebbene, non ci riuscì perché i Barbaricini si sono sempre sentiti un corpo separato. La disfatta portò Amsicora al suicidio. L’unità linguistica della Sardegna non si era mai potuta fare, ed ancora oggi si parlano vari dialetti. Problema immenso. Ma la lingua mediterranea parlata dalle genti sarde (il sumero dapprima, poi il sistema accadico, che si sovrappose e finì per convivere e imbozzolarsi entro il sumerico) avevano già determinato anche la scelta di vocaboli diversi per uno stesso concetto. Questo è evidente con abile “aquila” contrapposto ad ákili (fenomeno discusso più su).
Modelli del genere sono centinaia in Sardegna. Ed è da questi modelli, non da altro, che prese avvio la Lautverschiebung, in modo che la /b/ del nord fu letta /k/ o /g/ nel sud (o viceversa), persino in assenza di parole sumero-accadiche che consentissero di operare in tal senso, distinguendone i significati-base.
Égua/Ebba. Sul modello di ábile, l’originario égua (corrispondente al femminile lat. di equus) produsse al nord ebba (ma ciò accadde millenni prima dei Romani). Ebba non corrisponde ad alcun vocabolo originario del campo sumero-accadico (come invece abbiamo visto per abile/akili): è pertanto un perfetto esempio della Lautverschiebung, che opera a prescindere, essendo una legge fonetica.
(Tra parentesi, se qualcuno osasse dire che i cavalli arrivarono in Sardegna soltanto con i Punici, è pregato fraternamente di andare a vedersi i cavalli dipinti nelle Grotte di Lascaux, 32.000 avanti Era volgare, dimostrazione che i cavalli erano di casa anche con l’Homo Cro-Magnon). Ma vediamo di seguito alcuni altri esempi di Lautverschiebung.
Abbattare log. ‘schiacciare’; anche ‘sbattere le uova’; nasigattâdu ‘che ha il naso schiacciato, camuso’. Osserva anche il frequentativo abbattigáre ‘calcare, premere, pigiare (l’uva)’. Base etimologica è, per il significato ‘schiacciare’, l’akk. watārum ‘to be outsize, surplus, in excess, greater’. Respingo l’etimologia del Wagner (da lat. coactāre) perché foneticamente distante e priva di metodo. Wagner nella presentazione di abbattáre ripropone la falsa teoria secondo cui il sardo /b/ deriverebbe dal lat. /c/, pertanto sbaglia l’etimo di abbattáre, proponendo un analogo cattáre da catta, e da catta arbitrariamente egli fa risalire l’infinito abbattáre. In realtà, abbattáre e cattáre sono due verbi distinti nella forma e nell’etimo, ed è un puro caso che abbiano significati convergenti. Per l’etimo di cattáre e catta vai a cattigáre (ma catta significa pure ‘frittella’, e in quanto tale ha un terzo etimo: l’akk. kattu ‘che corrobora’).
Abbentinnare, abbintinnare log., agghentinnare nuor. ‘contrassegnare il manto del bue o del cavallo’; a Nuoro anche ‘rassomigliare’ (parlando delle bestie): processo di Lautverschiebung. Base etimologica l’akk. binītu ‘shape, appearence; forma, apparenza’.
Abbénzu log. ‘difetto fisico o morale, debolezza, macchia’. Per l’etimo vai ad irghenzu.
Abbuttinare log. ‘calpestare, investire, travolgere’ (detto specialmente dei cavalli e dei buoi); fig. ‘danneggiare, rovinare, disonorare’. Wagner propone l’etimo dal lat. coactare ‘schiacciare’. Ma tra le due parole c’è un abisso fonetico. La vera base è il sardo botta ‘scarpa’. La voce sarda indicante la ‘scarpa’ corrisponde all’ingl. boot ‘stivale, stivaletto, scarpetta’ < ant. fr. bote, ed ha base etimologica nell’akk. uttû(m) ‘ghirba di pelle, otre’, per estensione ‘scarpa’ (in origine la scarpa non fu altro che un rifascio di pelle, poi rafforzato dal cuoio).
Fitiánu, vitánu ‘comune, di ogni giorno’: bestíres fitiános ‘vestiti di ogni giorno’, dìes fitiánas ‘giornate di lavoro’ (non festive); ‘necessario, regolare’: sa proènda fitiána ‘la razione di biada’; ‘avventore assiduo’: fitiános dessu tsilléri ‘frequentatori della bettola’; a fitiánu ‘nei giorni di lavoro’: custa beste mi la ponzo a fitiánu ‘questa veste la indosso nei giorni di lavoro’, filende fitiánu ‘filando assiduamente’. Wagner, convinto che la p (f) sarda non sia altro che un derivato automatico dal lat. q, c, non trovò di meglio che far derivare il lemma sardo dal lat. cotīdiānus, quotīdiānus ‘di ogni giorno’, per quanto ammettesse poi, prudentemente, che lo sbocco sarebbe dovuto essere b- anziché p- o f- (bontà sua!). L’inadeguatezza degli studi passati ed attuali è dimostrata dalla vera etimologia di fitiánu (di cui il camp. vitánu è normale lenizione): sta nell’akk. bītu ‘casa’, bītānu ‘di casa, interno, familiare, casareccio’, bītānû ‘intimo, personale’. Da questa b- semitica ebbe origine la lenizione /v-/ del campidanese.
Báttica (Orosei) ‘la parte di un orto riservata alla coltivazione dei cocomeri e dei poponi’. Pittau (Studi Sardi di Linguistica e Storia, Pisa 1958, p. 98), approvato dal Wagner, sostiene che la voce derivi da un lat. aquatica, che produrrebbe la famigerata trasformazione q > b. Invece la base etimologica sta nell’akk. batqu ‘cut (off), tagliar via’. Infatti, poiché báttica è parola arcaica, vecchia di parecchi millenni, non occorre fantasia per capire che le antiche coltivazioni irrigue venivano fatte separando rigorosamente il terreno dagli spazi liberi, dal tradizionale regno degli armenti.
Bènnere log., bènniri camp. ‘venire’; p.p. bénnidu, bénniu ‘venuto’. Base etimologica è l’akk. bā’um ‘andare, venire’. La forma sarda sembra la più vicina all’originale, mentre il lat. ueniō è un derivato. Questo è uno dei tanti verbi su cui gli indoeuropeisti si sono infervorati a “dimostrare” origini indimostrabili da un (inventato) indoeuropeo *guen (Benveniste, Origines 156).
Bodále log. ‘coso, cosa o persona indefinita’. Non è dall’it. cotale (come pensa Wagner) ma dall’akk. wuddi, uddi ‘certainly, probably’, poi aggettivalizzato in -le. Nel CSP 356 e 358: in gotale tenore. Ovvia la voluta corruzione dell’amanuense sulla falsariga dell’it. cotale.
Gustare, -ái log. e camp.; secondo Wagner, questa voce è identica all’it. gustare, di cui sarebbe un accatto. Ma Wagner ha preso un abbaglio, anzi ha volutamente forzato il suo lemma (illustrerò più oltre la strana tendenza del Wagner alle forzature). In realtà la voce sarda non è gustare ma bustare ‘desinare, mangiare’, anche ‘far colazione’; bustu ‘pranzo’. È l’equivalente di ismurzáre, immurzáre, smurzái. Wagner quindi erra a dare il significato di ‘gustare’ < lat. gustare ‘provare il sapore, assaggiare’. Infatti il termine bustare è autoctono, sardiano, con base nel sum. bur ‘tempo del pasto, ora del pasto’ > akk. būru(m) ‘fame’ + uštu, ištu ‘fuori da’ (stato costrutto būr-uštu > bū(r-u)štu nel nord Sardegna e b(ū)r-uštu nel sud), col significato di ‘fuori dalla fame’.
Isbattulare log. (Bonorva) ‘colpire violentemente’. Base etimologica l’akk. bâṭu ‘to show contempt, mostrare disprezzo, disdegno; oltraggiare’. Respingo la proposta del Wagner dell’origine dal lat. coactare ‘schiacciare’. Wagner anche in questo caso volle imporre la “legge fonetica” da lui inventata.
Patatas. Il toponimo Sas Patàtas nel monte Albo di Lula, territorio carsico, deriverebbe da un lat. *coactiare ‘schiacciare’ (secondo Giulio Paulis NLS 522), causa la forma “schiacciata” del sito rispetto al restante rilievo montano (ma è una falsità), e significherebbe ‘grande avvallamento’. Posta così, la questione appare già traballante, poiché il toponimo convive nello stesso sito con l’altro toponimo Janna e Nurái ‘il passo della voragine’ (perché presso l’angusto passo che introduce nel selvaggio Monte Albo c’è una grotta verticale molto profonda, a campana), ed il toponimo convive anche col contiguo Sos kilívros ‘i crivelli’ (termine che è tutto un programma, poiché quel suolo è fortemente carsicizzato e presenta vari buchi pericolosi). In realtà patàtas non attiene a *coactiare (verbo inventato tanto per giustificare un’assurda trasformazione da lat. c- a sd. p-) ma attiene all’akk. pattu, pātu, puttû ‘aperto’, termini che indicano i vari sprofondamenti del terreno (quelli che in sardo si chiamano normalmente putzos ‘pozzi’,da puttû ‘aperto’). Cfr. sum. pa ‘pouch, tasca’ + taḫ ‘to add, increase; addizionare, ingrandire’, il cui composto (pa-taḫ, raddoppiato per resa icastica: pa-taḫ-taḫ) potè significare in origine ‘pozzi profondi’; akk. patāḫu ‘bore through, perforato’.
Pazzare log. ‘mettere il caglio nel latte’; rifl. ‘coagularsi, accagliarsi’; anche di altre sostanze ‘aggrumarsi’ (su sàmbene); sost. pazzu ‘caglio’; anche ‘malattia infantile con vomiti’ (Casu). Ma quest’ultima voce, inserita arbitrariamente dal Wagner nel contesto del lemma, rientra in un campo semantico diverso, quindi per essa rinvio a pazzu. Quanto a pazzare, base etimologica è l’akk. pazārum ‘to hide o.s., conceal o.s., be hidden; nascondersi, celarsi, stare nascosto’. A quanto pare, alle origini l’uomo osservò anzitutto la capacità delle ferite di “metter crosta”, di celarsi. In un secondo tempo al verbo pazārum associò anche l’idea del coagulo del latte, il quale avviene appunto nascostamente. Wagner invece fa derivare pazzare da it. e lat. coagulare, riproponendo l’assurda “legge fonetica” che forza il lat. K, G a diventare sd. P, B. Qui debbo sottolineare un fatto incredibile, che Wagner inventò la sua “legge fonetica” per soddisfare una manciata di vocaboli (non più di 15 citati nel DES) per i quali egli non riusciva a far quadrare l’etimologia. Ammesso e non concesso che fosse mai esistita una tale legge fonetica per una irrisoria manciata di vocaboli, Wagner avrebbe dovuto rendersi conto che il lat. coagulāre è composto da un primitivo cum + agō ‘faccio convergere’. E allora avrebbe dovuto capire l’insormontabilità di ridurre il lat. cum al sd. pa-. Chi pretende di accreditare l’esistenza di questa assurda trasformazione mostra la risolutezza di chi si lancia senza paracadute sperando d’atterrare incolume.
Altri latinismi supposti da Wagner. La falsa “legge fonetica” appena discussa, inventata per soli 15-20 vocaboli al solo scopo di dare più lustro alla forzosa idea che la lingua sarda derivasse dal latino, è stata soltanto uno degli escamotage inventati dal Wagner per ancorare la propria teoria alla romantica “ossessione imperiale”. Per non tediare, scelgo soltanto due lemmi tra le migliaia disponibili. Ma si notino i molti altri “latinismi” già discussi o che discuterò nel corpo della presente premessa metodologica.
Murru2 log. e camp. ‘grigio’ (CSNT 282: I caballu murru). Per Wagner questo aggettivo è contrazione da lat. murīnus ‘color del topo’. Il termine è usato anche dagli antichi scrittori di veterinaria proprio ad indicare il manto del cavallo. Ma invero, Wagner non sa quale concetto avessero in mente gli antichi romani. Altro esempio sd.: braba murra ‘barba grigia’ ecc.
Per tutte le altre occorrenze citate dal Wagner in relazione a questo aggettivo (tipo ispiga múrina, etc.), rinvio alle voci múrina, múrinu, poiché le loro basi etimologiche sono assai diverse da quelle suggerite dal Wagner. Quanto a murru2, anche qui Wagner cade male, poiché pretende di accostare la barba di un vecchio nonché uno dei colori del nobilissimo cavallo al colore del ratto, un essere che l’uomo ha sempre tenuto in gran dispregio. Basterebbe ciò a mettere in allarme un ricercatore. Infatti la base etimologica di murru2 è il sum. muru ‘rainstorm, mist, drizzle; tempesta di pioggia, foschia, pioggerella’. Da qui quel meraviglioso colore picchiettato del cavallo.
Paríga è il termine col quale nel Campidano s’indica ‘un certo numero’, ‘una dozzina’; impropriamente pure il ‘paio’. Con incredibile insufficienza e nonchalance, Wagner scrive quattro-parole-quattro: «parίga camp. ’paio’, = *PARIC(Ŭ)LA». Nient’altro. Egli era uomo accorto, e sapeva che l’origine da lui proposta è inesistente: viene da lui supposta per riempire un vuoto cognitivo. E lascia il lettore impiccato a questo laconico ‘paio’, senza nemmeno un seguito esplicativo.
Peraltro non è che lo stesso Porru, dal quale Wagner attinse il vocabolo, abbia avuto incertezze a registrare la seguente frase contraddittoria: «Parìga s.f. pajo, paro, coppia. Ses parigas di ous, de pira ec. Su propriu de una duzzina, una serqua d’ova, di pere ecc.». Egli però trattò la materia con più sufficienza, lasciandoci una vaga traccia del concetto di dozzina. Questo è un progresso, che però non bastò a mettere sull’avviso Wagner. Inoltre il modello italiano ha il suo peso, e il DELI, nel registrare il lemma paio ‘coppia di cose, persone, animali’, attinge direttamente da it. paia, fondato sul lat. pāria, neutro plurale di pār ‘pari’.
Riconosco al Wagner la poca disponibilità di materiale alternativo, stante il fatto che si auto-condannò a frugare soltanto nella lingua latina. Ed avendo davanti agli occhi il modello pār, va da sé che lo vide come archetipo. Gli riconosco pure che in Sardegna sul tema ebbe pochi altri modelli, visto che in sardo per indicare il paio abbiamo soltanto dei lemmi italo-latineggianti concorrenti, quale l’italianismo coppia (con metatesi e rotacizzazione camp. croppa, dal lat. cŏpula), nonché páya (italianismo) e, appunto, parìga, che viene considerato una sopravvivenza medievale originata da un (inesistente) *paricŭla.
A nessuno è sembrato importante indagare perché il popolo sardo tende a misurare tutto in dozzine. Da quando sono nato non ho mai visto gente acquistare a decine ma soltanto a dozzine: una dozzina di paste, una dozzina di uova, una dozzina di piatti, e così via. E quando un campidanese va a far la spesa e vuole comprare una quantità di merce numerabile, ne chiede sempre una barίga, che non interpreta come paio ma proprio come ‘una dozzina’ (così è per le mele, le pere, le arance, e così via). Quando egli vuole andare oltre il numero uno o due, parla sempre di parίga. Il termine è usato estensivamente anche per la merce non numerabile, con procedimento generalizzante: così è per le ciliegie e tutta la merce minuta, ivi compresa, ovviamente, quella non edule. Cantu? Una parìga «Quanto? Un po’» (a indicare una quantità non misurabile ma già cospicua). Parìga è termine sardiano con base nel sum. bariga ‘unità di misura, di capacità’, ‘un contenitore per misurare’, da bar ‘forma esterna’ + iku ‘unità di misura’.
Italianismi. Una sotto-classe della “pregiudiziale latina” è la “pregiudiziale italiana”, cui Wagner ed i suoi epigoni si àncorano per giustificare l’origine di circa il 10% del vocabolario sardo. La riserva mentale dei ricercatori è che, intanto, anche gli italianismi sono di origine latina. In ogni modo Wagner, quando potè, volle distinguere e parlare propriamente di “italianismo”. E non lo sfiorò nemmeno l’idea che l’Italia romana era suddivisa in 32 popoli, con relative lingue, e che quelle lingue hanno prodotto i dialetti italici attuali. Talché io stesso, nel trattare le voci della Penisola, preferisco parlare spesso e volentieri d’italico anziché d’italiano, affinché si percepiscano le autonomie dell’antichità rispetto al latino.
Peraltro, il sud Italia formò per oltre 500 anni la Magna Grecia, e non è che dopo la conquista romana il greco delle coste sia decaduto nel giro di decenni. Ma sarebbe lungo rivangare questa problematica. A me compete in questa sede proporre alcuni esempi del tema prefissatomi.
Abbolicósu log. ‘diabolico’. Wagner ne propone l’origine dall’it. diabòlico, con perdita della prima sillaba. Ma in realtà la base etimologica è il composto akk. bu’’uru ‘catturato, prigioniero’ + leqû ‘prendere il potere’. Il composto bu’’uru-leqû significò in origine che è ‘succubo, preda di un potere (diabolico)’.
Accasare1 log. ‘maritare’; cfr. it. accasar(si). Wagner e chiunque altro pongono l’origine del termine sardo dall’it. casa ‘costruzione abitativa’ < lat. casa ‘capanna’. In realtà il termine accasáre è parimenti antico anche in Sardegna, ed ha base etimologica nell’accadico: v. kasû ‘legare, legare assieme’, ḫâsu ‘installare’, ḫuṣṣu (a kind of reed hut). Con ogni probabilità, la base più appropriata del lemma sardo relativo al matrimonio è l’akk. kasû ‘legare, legare assieme’.
Accássu log. ‘bisognoso’; accassu de sidis, de fámene ‘mezzo morto di sete, di fame’ (Spano). Wagner deriva il termine sardo dal sic. e it. casso ‘stanco, lasso’. In realtà il termine sardo è arcaico: vedi il verbo acansáre, accassáre, cansìre ‘star male, soffrire’; cansìdu p.p.; acassu, acansu, akensu ‘che sta male, che soffre’, ‘esausto, bisognoso’; camp. accasiòni ‘sofferenza, fastidio, malessere’; camp. acasionéri ‘chi produce un male, chi crea sofferenza’. Per traslato: cansàda ‘digressione, deviazione’. Base comune a tutti questi lemmi è l’ass.-bab. kanšu, kaššu, kansu ‘sottomesso, remissivo’ < kanāšu ‘sottomettere, assoggettare’.
Cascavallu camp. ‘caciocavallo’. Italianismo. DELI non sa trovare l’etimo, non riuscendo a individuare addentellati per il secondo membro -cavallo. La base etimologica può essere individuata soltanto dopo aver capito la tecnica di produzione del caciocavallo, il quale è un formaggio stagionato a pasta filante dell’Italia meridionale (specie della Campania), ottenuto da latte di vacca podolica. La forma è quella di una grossa pera (infatti in Sardegna è detto pireḍḍa ‘peretta’), il cui tozzo “picciolo” serve per legarlo ed appenderlo ad asciugare e stagionare. Talora il caciocavallo viene appeso entro una rete di rafia. Per il primo membro cacio- rinvio a casu; il secondo membro -cavallo ha base etimologica nell’akk. ḫabālum ‘to bind, harness; legare, imbrigliare’.
Incocciare, incocciái log. e camp. ‘incontrare, trovare, sorprendere’, come it. merid.: sic. ncucciari ‘ghermire, cogliere, soprendere’ (Traina); cal. ncucciari ‘accostare, avvicinare’; irp. nguttsà ‘indovinare’ e ‘colpire’ (Urciolo). Base etimologica è l’akk. ḫuḫārum ‘bird-snare, trappola per uccelli’. Il significato originario è chiaro, ed è chiara la sua evoluzione semantica nel bacino tirrenico.
Invece Wagner pretende che – siccome il vocabolo esiste anche nell’Italia meridionale – in Sardegna esso sia importato dal sud. Non lo sfiora nemmeno il sospetto che già dal Paleolitico sia esistita una Koiné tirrenica, alla quale la Sardegna partecipava da signora.
Ovviamente, il danno maggiore Wagner lo fa nel raffrontare fra loro sincronicamente queste voci, senza tentare la ricerca etimologica che ne avrebbe stabilito la loro origine prima, e se possibile la loro diacronicità.
Insólica in erba insólica (Cagliari); arbasólica (Cuglieri) ‘varietà di vite a frutto bianco’; corrisponde al nap. uva ‘nzoleca (Sarnelli); Isola del Giglio anzónaca; Elba: ansónico (Merlo); Pitigliano anzónica (Longo); cal. ansólia, insólia (DTC); sic. nzólia (Traina). A quanto pare, la voce sarda è d’accatto. Lascio al lettore l’impegno di controllare l’irresolutezza del Wagner (DES I 637) sull’etimo di queste voci italiche. Un indizio linguistico (il suffisso -ik-) fa pensare che tale vite sia entrata in Magna Grecia provenendo dalla Grecia. Lascio ai grecisti l’indagine, che sicuramente porta molto lontano, quasi certamente fuori dal loro mondo, esattamente al mondo semitico (vedi bab. īnu ‘vino’ + ṣulû ‘supplication, prayer; supplica, preghiera’). Secondo la mia interpretazione – la quale è in linea con tutti i nomi delle viti da me analizzati – insólica (īn-ṣul-ikos) in origine significò ‘vino da messa’, ‘vino per le suppliche nel Tempio’, e simili.
Pirone2 m. log. sett. ‘romano (contrappeso) della stadera’. Base etimologica è l’akk. pirru, perrum ‘payment collection, tax delivery; raccolta dei pagamenti, consegna delle tasse’. Nella prospettiva della nascita del linguaggio, questo vocabolo nitidamente sardiano acclara come si svolgeva il pagamento delle imposte allorché mancava ancora la moneta. Su una grande bilancia si poneva da una parte il peso accertato, e dall’altra il contribuente caricava grano od altro tributo, sino a che il peso si equivaleva.
Duole notare la superficialità con cui Wagner liquida la questione etimologica, scrivendo (DES II 276): « = ital. pirone (la limitazione al solo log. sett. e l’assenza del vocabolo negli altri dialetti esclude l’indigenato e più ancora l’etimo ‘pedone’ del Salvioni, RIL XLIX, 724, n.). Cfr. REW 6366». Si possono notare nella nota del Wagner due atteggiamenti culturali ancora oggi tipici dell’accademia: 1) quello di annotare comunque le soluzioni proposte dai suoi colleghi accademici, anche quando sono impresentabili e grondano mistificazione; 2) quello di sentenziare categoricamente la non-sardità dei vocaboli logudoresi allorché manchino delle controprove campidanesi.
Rata log. e camp. ‘rata, parte, quota in cui viene frazionato un pagamento’. Per Wagner è italianismo. DELI lo deriva dal lat. răta p. p. di rēri ‘pensare, opinare’ ma senza convinzione: infatti s’ignora persino l’etimo del verbo latino. Invero, base etimologica del tirrenico rata è il sum. raḫ ‘to break’ + taḫ ‘to add’. Il composto originario raḫ-taḫ significò ‘frazione (di un insieme) da addizionare’.
Reghentiare, arreghentiare log. ‘inasprire, inciprignire’ (di ferite, tumori); rifl. ‘inasprirsi, incocciarsi’; regentίa ‘collera, rabbia, ostinazione, cocciutaggine’. Base etimologica è il sum. raḫ ‘to beat, kill; picchiare, battere, uccidere’ + ti ‘arrow, freccia’. Il composto raḫ-ti- in origine indicò il ‘colpire di freccia’. Ovviamente è da espungere la proposta del Wagner di derivare questa voce da un it. recente (lat. recens, recentis) ‘avvenuto da poco tempo’ (sic).
Sinnu log. ‘senno, criterio’, parola usata anche nel Medioevo (CSP 348). Base etimologica il sum. šennu ‘priest, sacerdote’ (tutto un programma). Cfr. ant. fr. sen ‘intelligenza, ragione’ (DELI), evidente segno dell’arcaica Koiné Mediterranea. Wagner lo deriva dall’italiano, DELI dal francese, ma essi rimangono sempre nell’angusto cortile della filologia romanza.
Vária (Bitti), oggi válgia (s’álgia); sa várgia (Fonni); barza (s’arza) log.; bárgia, braxa camp.; viene definito dallo Spano ‘falangio, sorta di ragno velenoso, il solo che abbiamo nell’isola, dal Berni si chiama tarantola, ma meglio solìfuga’. Difatti non è la vera tarantola (Lycosa tarantula) e neanche il malmignatta (solifuga, che si chiama in Sardegna soloίga, suίga), ma una specie di Mutilla, un imenottero vespiforme “le cui femmine rassomigliano a formiche graziosamente screziate di giallo e di rosso” (Marcialis, Pregiudizi 59).
Base etimologica di vária è l’akk. bārû(m) ‘to catch, trap (with a net), wicked people; hunt, go hunting; catturare, intrappolare, gente cattiva; cacciare, andare a caccia’. Questa è l’esatta descrizione dei ragni in generale. Nel caso specifico, bária è aggettivale del verbo accadico qui indicato. Va da sé che le etimologie del Wagner sono fuori posto, poiché non si può sostenere che la denominazione provenga dal colore variegato (vária).
Caḍḍémis, caḍḍémini ‘persona miserabile, vestita di stracci o comunque male vestita, sporca’ (Puddu); kaḍḍémis cagl. plebeo ‘straccione, sporco, malvestito’ (Wagner); bestίu a caḍḍémis; Wagner lo presenta come equivalente del sic. gaddémi ‘chi somministra legna alla caldaia, abietto, dappoco’ allato a gaddìmi ‘idem’ e lo ritiene una probabile derivazione dall’ar. ḥadîm ‘servo’. L’ipotesi del Wagner va bene per la Sicilia. Per la Sardegna propendo a vederci l’influsso dell’akk. qaddu(m) ‘piegato’ da miseria, preoccupazioni, malattie + emû, ewûm ‘diventare’, ‘essere come’; questo verbo si usa spesso col suffisso modale -iš ‘come, like’. Il significato è ‘diventare come uno schiavo, un servo’. Alcuni sardi, influenzati in buona fede dal fatto che certe parole della Sardegna somigliano stranamente a lemmi inglesi con significato similare, giurerebbero che il termine sia stato creato da emigranti sardo-americani di un secolo fa, dalla locuzione God damned ‘che Dio sia maledetto’. Registro questa curiosità per far capire quanto forte sia la legge della paronomasia (della quale tratterò in seguito), la quale esercita la sua tirannia sia nel popolo sia tra gli intellettuali.
Caḍḍótzu camp., specialmente cagl. ‘sudicio’ (di persone). Il termine si ha pure ad Escalaplano, ossia sulle montagne degli antichi Galilla. Wagner propone una probabile etimologia da kaḍḍu ‘cotenna, pelle del maiale o del cinghiale’ < lat. callum. Ma è difficile accostarsi alla proposta wagneriana. Era nota nell’antichità l’abitudine all’igiene del maiale (a maggior ragione del cinghiale), che non è nè più sporco nè più pulito di altri animali, ed appare “sporco” solo allorché viene chiuso nell’abiezione del brago. Ma il brago, si sa, viene cercato naturalmente dal maiale (e pure da molti animali della savana) per crearsi addosso un impasto che, seccando, racchiude e uccide le zecche e tutti i parassiti della pelle. Nella stagione calda è usuale vedere branchi di maiali (quelli liberi in natura) immersi per lungo tempo nei fiumi d’acqua pura, col solo muso fuori (proprio come i bufali o gli ippopotami) allo scopo precipuo di annegare i parassiti. Il termine ‘sozzo, sudicio’ non poteva dunque richiamare il maiale, nonostante che gli Ebrei lo avessero considerato un essere immondo (ciò riguarda soltanto la loro religione, per la quale era immondo persino il cammello).
Suppongo che il termine caḍḍotzu col semantema attuale sia nato nell’alto medioevo ad opera dei preti cristiani, decisi a far tabula rasa di ogni forma di religione anteriore, della quale bersagliavano i termini sacri distorcendoli nella forma e molto più nel significato, che veniva capovolto, umiliato, lordato e quindi demonizzato. Nelle città sarde – giusta la (relativa) tolleranza degli imperatori – le religioni attestate erano le stesse professate a Roma: quella ufficiale dello Stato, ma pure quelle orientali (ebraica, egiziana, persiana, etc.). Era forte specialmente la religione ebraica, non solo per la forte presenza della diaspora ma anche perché gli Ebrei, dovunque stessero, erano gli unici a saper leggere e scrivere. Erano pertanto rispettati ed apprezzati.
L’unico termine antico accostabile a caḍḍotzu è il fen. qdš (qodeš) ‘santo, santuario’, ‘consacrare, consacrato’, riferito a tutto: sacerdoti, offerte, tempio e divinità. È principalmente accostabile l’ebr. qadòš ‘martire, santo’ (SLE 85). Ma può esserlo pure qaddiš, ch’era la preghiera ebraica ripetuta varie volte al giorno (SLE 73), o il kidduš, la benedizione a Dio espressa la mattina del sabato, recitata accanto a due candele, su una coppa di vino.
Somiglianza originaria tra sardo, catalano, spagnolo. Nonostante le obiezioni che fin qui ho mosso a M.L. Wagner, riconosco che per il passato egli fu il maestro indiscusso e insuperabile degli studi di linguistica sarda. Nato nel 1880 e morto nel 1962, compì gli studi al regio Humanistiches Gymnasium bavarese di Neuburg a. d. Donau e alle Università di Monaco, Würzburg, Parigi e Firenze. Dal 1905, su borsa di studio dell’Università di Monaco, cominciarono i numerosi soggiorni in Sardegna. Nel mentre dal 1907 fu nominato professore di lingue moderne alla Deutsche Realschule di Costantinopoli. Wagner conosceva, oltre al tedesco, il sardo, l’italiano, il francese e lo spagnolo, e seppe approfondire anche la conoscenza del rumeno. Essendo di casa in Turchia, è pensabile che sapesse gestire anche la lingua turca. Era indubbiamente poliglotta, e in quanto tale si potè concedere impegni di studio anche nell’ambito dei gerghi e delle lingue popolari, del giudeo-spagnolo, del portoghese, dello spagnolo, del catalano. Ovviamente alla base dei suoi studi doveva esserci la lingua latina e quella greca antica. Caballero andante [y ingenioso hidalgo] della filologia lo definì Karl Vossler, e ancora oggi ogni linguista s’inchina davanti alla vastità dei suoi excursus.
Nell’approfondire le lingue iberiche, Wagner si era reso conto dell’identità pressoché totale della lingua sarda col catalano e con lo spagnolo. Leggendo estesamente il suo capolavoro, il Dizionario Etimologico del Sardo, si evince che lo studioso tedesco agganciò quasi il 90% della lingua sarda a quelle iberiche. Ovviamente egli aveva approfondito anche gli studi sulla storia sarda, e dagli storici del suo tempo apprese che le vicende sarde avevano portato nei secoli anzitutto all’occupazione romana, poi all’occupazione pisana, genovese, catalana, dopo la quale la Spagna intera subentrò estesamente nell’isola. Infine, furono i Savoia a dominare la Sardegna.
Wagner tenne conto di questo fenomeno, ma con tutta evidenza lo interpretò mediante la cultura da lui assorbita nei luoghi di origine in gioventù, quando la pregiudiziale nazista pervadeva ogni poro del pensiero germanico. Di conseguenza egli ammantò i propri libri di una visione poco meditata, che proponeva una lingua sarda derivata quasi per intero dalle lingue iberiche. Wagner, per ragioni di stile scrittorio, non scrisse espressamente di derivazione né di origine delle decine di migliaia di lemmi da lui affrontati. Gli bastò esplicitare i due concetti di tanto in tanto, su poche centinaia di voci, conseguendo l’effetto che il lettore se ne convincesse per proprio conto. Fu un processo pressoché surrettizio, come tale poco adatto a risvegliare nel lettore il senso critico, inducendolo ad accettare le sentenze palesi o silenti del Wagner. Nelle altre migliaia di lemmi egli affianca semplicemente la voce iberica a quella sarda, suggerendo ex silentio la prima come origine della seconda.
Da me in quanto glottologo tali sentenze del Wagner sono state percepite da decenni come ingannevoli, ma è da quindici anni che ho rotto gli indugi col mio maestro Wagner, decidendo di contrapporre a mia volta una visione e una procedura metodologica diverse nello studio della lingua sarda. Il lettore sarà mio giudice. Sorge spontanea un’obiezione: se Wagner era convinto che il 90% della lingua sarda deriverebbe dalle parlate iberiche, come conseguenza si deve assumere che il popolo sardo, prima dell’invasione iberica del 1323, parlasse soltanto un 10% di vocaboli. Un glottologo sa che un popolo con tale penuria non può mai esprimere la propria cultura. Ci vuol poco a capire che la “pregiudiziale iberica” del Wagner è sorella della “pregiudiziale latina”: porta alle stesse conclusioni nichiliste, ossia ad ammettere che prima di Roma (in questo caso, prima di Barcellona) il popolo sardo si esprimesse mediante un plancher così misero, che può benissimo essere tralasciato, perché ininfluente nello studio del sardo attuale. Come corollario, va da sé che la lingua sarda attuale dovrebbe considerarsi accattata di recente, quasi al 100%, dai popoli viciniori. Come secondo corollario, si dovrebbe ammettere che la lingua sarda nella sua lunga storia sia stata di una gracilità così eclatante, da infrangersi e sparire ad ogni minimo urto colonizzatore. Si può notare che i filologi che sinora hanno condotto gli studi linguistici in Sardegna hanno tutti la stessa mentalità: credono che i Sardi abbiano una tale disaffezione per la propria lingua da barattarla con la prima lingua che s’affacci alle coste isolane.
Ciò equivale a dire che il popolo sardo, dopo aver vissuto con la propria lingua da 100.000 anni (o da almeno 40.000 anni) e fino al 238 a.e.v., di colpo vi rinunciò. Una volta latinizzati al 100%, i Sardi giunsero al 1323 della nostra Era, ed eccoli di nuovo abiurare alla propria parlata, calpestandola ed assumendo in breve tempo altre parole, altre visioni del mondo.
Invero, i fatti non sono mai andati per quel verso. I Sardi hanno sempre mantenuto la lingua delle origini, salvo le poche contaminazioni che in ogni paragrafo vado dimostrando. Quindi è ovvio che la visione del Wagner va rivisitata con occhio disincantato. La mia visione è semplice: se i Sardi condividono con gl’Iberici il 90% del proprio vocabolario, vuol dire che Sardi ed Iberici lo condividono già da 100.000 anni, o giù di lì. Insomma, rammentando la “presa a tenaglia” che l’Homo, disceso fino al Delta, operò lungo le coste mediterranee, va da sé ch’Egli prima sbarcò a Gibilterra su otri gonfi di paglia, poi dilagò sino alla Linguadoca, alla Liguria, all’Etruria, e di là per la Corsica arrivò in Sardegna. Per questa ragione gl’Iberici sono stati i primi, nel Paleolitico, a parlare il linguaggio nilotico, poi sbarcato in Sardegna; ma tutto ciò avvenne sempre in epoca arcaica, non nel 1323.
Ecco di seguito qualche vocabolo indissolubilmente e pariteticamente iberico-sardo (o sardo-iberico).
Altanèra camp. ‘aquila grande’ (Spano). Wagner deriva il lemma da sp. altanero ‘aplícase a les aves de rapiña de alto vuelo’. In realtà i lemmi sardo e spagnolo hanno base etimologica nell’akk. alītu, elītu ‘altezza, parte alta’ + erûm ‘eagle’, e significò in origine ‘aquila dei luoghi eccelsi’.
Amistáde, amistádi log. e camp. ‘amicizia’; uguale a sp. amistad. L’uno e l’altro vocabolo hanno basi etimologiche comuni nell’akk. a, an, ana ‘per’ (finale) + misu, mēsu ‘washing, purification’ + ṭabtu ‘pace’. Il composto a-mis-ṭabtu significò in origine ‘purificazione della pace’. Questa parola è arcaica. Non può essere vero che derivi dalla Spagna. L’una e l’altra parola sono mediterranee ma autonome, in quanto facenti parte di unica Koiné. L’arcaicità di questa parola si nota dalla combinazione delle tre componenti e indica il momento in cui le famiglie nemiche facevano solennemente la pace, purificandosi con l’acqua (rito uguale a quello dell’ingresso nel Tempio) e tenendosi pubblicamente e reciprocamente la mano.
Arraccáda nuor. e camp., meno frequente nel log.; spesso arreccadas (Cagliari, Villacidro, Iglesias, Sarrok) ‘orecchini pesanti’ = cat. arracada, arrecada; sp. arracada; sass. raccára ‘idem’ (Muzzo): un pággiu di raccári ‘un paio di orecchini pesanti’ (Calvia). Base etimologica è l’akk. raqādum ‘to dance, skip; danzare, saltellare’ (infatti gli orecchini sono l’unico ornamento muliebre che ballonzola liberamente).
Carrogna (carroña) log. e camp. ‘donna di facili costumi’; cfr. cat. carronya, it. carogna (ambedue con identici significati spregiativi, relativi a persona infame raffigurata come carcassa puzzolente). Wagner propende a vedere l’origine della voce sarda dal catalano (e ciò soltanto perché essa contiene …due -rr- come in Sardegna!). L’atto del Wagner, oltre ad essere superficiale per il fatto che confronta lemmi coevi la cui storia non viene approfondita, non si pone nemmeno il problema delle cause che portarono in Italia ad una -r-, e in Catalogna a due -rr-. A lui basta l’evidenza della doppia -rr- per decretare che la Sardegna è debitrice di un ennesimo vocabolo dalla Catalogna. Questo metodo… “audio-visivo” è ascientifico e antistorico, perché, non tenendo conto della pronuncia italiana, si priva dell’opportunità di scendere al fondo dei millenni per individuare il prototipo di tutte queste voci mediterranee.
Soltanto andando alle origini arcaiche siamo in grado di capire il fenomeno, il quale va scomposto in due rami d’indagine per essere meglio inquadrato. Il primo ramo conduce forzatamente alla situazione storica del Mediterraneo nei millenni precristiani, allorché le continue guerre che recavano ad alte perdite tra i maschi, nonché la disuguale organizzazione del lavoro e la disuguale struttura ereditaria, portava a un quadro socio-economico nel quale la vedova o l’orfana – nonostante le ipocrite leggi morali e religiose che suggerivano l’elemosina e la protezione delle vedove e dei bimbi – riuscivano a sopravvivere soltanto prostituendosi. Il secondo ramo d’indagine è quello meramente linguistico, in base al quale scopriamo che la lingua accadica offre la voce karru, kāru(m) ‘quay, port, (river) quay; molo, porto, porto fluviale’. Unire questi due risultati è facile, considerando che le prostitute s’ammassavano principalmente lungo i porti dei grandi fiumi o sui moli dei porti marini. Ragioni ovvie: era lì che convergevano i marinai ed i commercianti di passaggio, era lì che alle donne era consentito di esercitare la prostituzione sacra senza pagare nemmeno il fio della condanna morale.
Quindi carrogna non è un inasprimento morale e linguistico (le due -rr-!) mirante ad equiparare la prostituta alla carcassa puzzolente d’una bestia (ciò sarebbe stato il colmo della contraddizione in bocca a un maschio che prima del matrimonio era invitato dal padre a “farsi esperto”), ma è semplicemente un aggettivo professionale in -nia indicante ‘quella dei porti, quella dei moli’. Si può constatare che in Sardegna e in Catalogna prevalse l’akk. karru, mentre in Italia prevalse l’akk. kāru, da cui le due voci carrogna e carogna. Invece l’it. carogna intesa come bestia in decomposizione ha altro etimo, infatti è lemma precipuamente italico (è aggettivale spregiativo da lat. carō, carnis ‘carne’), mentre in Sardegna s’usa precipuamente mortorzu o ispéigu (vedi).
Ditta2 camp. ‘prétziu crésciu in is compras a s’incantu’: crèsciri ditta ‘aumentare l’offerta o il prezzo’; béndiri a ditta ‘vendere per la maggiore offerta’; cfr. cat. dita ‘lo preu que’l comprador posa a lo qu’es ven y arrenda: postura’. Base etimologica è l’akk. diktum ‘fighting, combattimento’ (tutto un programma).
Inconaresì log. ‘essere di malumore, stizzirsi, affliggersi’; cfr. sp. enconarse ‘irritarse’; (Spano) inconadu ‘adirato, disgustato, sorpreso’. Base etimologica è l’akk. inḫum ‘hardship, trouble; sofferenze, guai’.
Puḍḍu (Missa de Puḍḍu, de Buḍḍu, de is Puḍḍas) in tutta la Sardegna è la ‘Messa di Natale’, celebrata la sera del 24 dicembre in ora tale che il momento della nascita di Gesù corrisponda con la mezzanotte.
Wagner è convinto che tale Messa abbia a che fare con i polli, e cita a rinforzo la corrispettiva misa del gallo spagnola. Ma si sa che i polli (galli, galline) vanno a dormire al calar del sole, e si svegliano all’alba. Orari che non corrispondono a quello della Messa celebrata dai Cattolici. In questo contesto, sembra chiaro che gli Spagnoli si ritrovino il modo di dire moderno come traduzione paretimologica (e omologazione al semantema del lat. pullus) di un termine mediterraneo non più compreso. Così è per il sardo puḍḍu.
L’enigma del sardo puḍḍu inteso come ‘pollo’, e parimenti dello sp. gallo inteso come ‘pollo’, è svelato dall’etimologia, che ha base nell’akk. pūdu, būdu (un genere di festa). Il fatto che il sardo (e sardiano, oltreché mediterraneo) puḍḍu, buḍḍu abbia in origine significato, per antonomasia, una festa, la dice lunga sull’importanza di tale festa, la quale, cadendo al solstizio d’inverno e quindi al Capodanno solstiziale, doveva essere la più importante dell’anno. Infatti tale festa dava avvio ai riti della morte e resurrezione del Dio della Natura, rito che poi dalla nuova religione fu incanalato nel Carnevale. La tradizione cristiana del Natale, sovrapponendosi alla tradizione pagana, non riuscì ad estinguere il termine mediterraneo, che ancora sopravvive in Sardegna.
Tamagnu (Nuoro, Osidda, Goceano) ‘statura, grandezza naturale’ = sp. tamaño. Nel log. sett. occorre come f. temagna ‘qualità, proporzione, dimensione’: Sun totos duos dessa matessi temagna ‘sono della stessa misura’; ladros dessa matessi temagna ‘della stessa specie’ (Casu). Base etimologica il sum. tam ‘to trust, believe; dar fiducia, credito’ + aĝ ‘to measure’. Il composto tam-aĝ (pronuncia: tamagn) significa da sempre ‘misura fiduciaria, standard, ufficiale’. Non varebbe la pena osservare che Wagner opera una doppia operazione subliminale: 1. la prima è di accreditare ex silentio l’origine spagnola della parola sarda anziché assentire sull’origine mediterranea; 2. la seconda è di non proporre l’etimologia, accreditando tale obbligo come superfluo.
Valentía log. e camp. ‘prodezza’. Wagner ha registrato questo vocabolo, prendendolo da due scrittori sardi, ma lo ha corrotto ad libitum soltanto per poterlo accreditare come derivazione da sp. valentía ‘echo o azaña heróica’. In realtà, la voce sarda autentica è balentía, per il cui etimo vai a balente.
Zira log. sett. ‘striscia’ (di tela, di carta, di terreno): Casu = sp. jira ‘tira de tela o jirón’. Base etimologica il sum. zir ‘to break, tear out; rompere, strappare’: esempio tipico della stretta parentela sardo-iberica fin dal Paleolitico.
La pregiudiziale iberica. Nel paragrafo precedente abbiamo riconosciuto che Sardegna ed Iberia condividono fin dal Paleolitico parecchie migliaia di vocaboli, ancora vivi nelle rispettive parlate. Si spiegano anche per questa via i rapporti sempre esistiti tra il popolo catalano e quello sardo, come c’insegna la storia dei giudici d’Arborea e la stessa vita di Eleonora d’Arborea. Ma la visione dei filologi romanzi è diversa: essi pretendono che le voci iberiche in Sardegna siano state importate, cancellando le precedenti voci sarde (…ammesso che ne esistessero…). Questa visione è palesemente miope, ascientifica, indimostrabile. Lo scopriremo discutendo qualche lemma.
Cannutígliu log., canotίgliu camp. è la ‘canutiglia, filo d’argento o d’oro per ricamo’. Wagner sostiene che il termine deriva da sp. cannutillo, cañutillo ‘hilo de oro o plata rizado para bordar’. In realtà, base etimologica è l’akk. ḫanû (proveniente da Hana, città della Mezzaluna Fertile celebre per le stoffe di pregio) + tillu ‘bardatura, bordatura, segno esteriore, applicazione a stoffe cerimoniali’. Quindi ḫanû-tillu in origine indicò la ‘bordatura proveniente da Hana’. Se dovessimo immaginare che le pregiate stoffe di Hana, celeberrime in tutto il Mediterraneo, arrivassero in Iberia by-passando la Sardegna, dovremmo accettare che la Sardegna fu tagliata fuori da ogni commercio, in andata e in ritorno. E ciò non è vero.
Carignátula (cariñátula) ‘tignola, tarma’ (Spano); anche caragnada; voce gallurese; cfr. còrso caragnattu, caragnáttulu ‘specie di ragno’, caragnattula ‘scolopendra’. Per Wagner l’origine è iberica. Invero, la base etimologica è l’akk. kâru ‘to rub’ ‘sfregare’ + naʼdu ‘attento, riverente’: il composto si riferisce all’attento “sfregare”, ‘rosicchiare’ del tarlo.
Immurzare log., ismurzáre centr., immurgiáre centr., smurzái camp. ‘far colazione’, ‘far siesta per mangiare’; immurzu ‘merenda’, sass. immùzzu. Secondo Wagner, che s’accoda al Corominas, dovrebbe essere una forma iberica recente, del XIX secolo, vedi sp. almorzar, cat. esmorzar. Wagner avrebbe dovuto farci capire perché gli Spagnoli, che in Sardegna cessarono la propria dominazione tre secoli fa, abbiano inventato un termine così tardo, lasciandolo poi in eredità ai Sardi dopo aver cessato il dominio, che peraltro negli ultimi secoli fu oltremodo indiretto, poiché i possidenti e feudatari spagnoli amministravano con missive dalla Spagna (o comunque dalle città sarde, non dalle campagne) attraverso i propri fattori. Ancora più arduo è pensare che il termine sia stato lasciato in Sardegna dai Catalani, che governarono l’isola soltanto nel 1300-1400.
È strano che Wagner non si sia accorto che il termine è pansardo, ed è molto utilizzato in ogni paese della Sardegna (non nelle città). Viene usato non tanto per indicare la ‘colazione’ (concetto ignoto ai sardi), ma per indicare una “rottura” dell’attività giornaliera al fine di ricaricarsi d’energia. Semanticamente equivale all’ingl. breakfast ‘rottura del digiuno’, ed indica in particolare il pasto della siesta meridiana. Debbo quindi ammettere che il termine sia molto antico. Infatti è sardiano, con base nell’akk. emṣum ‘affamato’ > *em(u)ṣum (anaptissi eufonica) > immùzzu (forma sassarese). Da qui le numerose varianti di immuzzu, comprese quelle con la classica epentesi di -r- dovuta a una legge fonetica sarda, e comprese le semplificazioni tipo murzu.
Disvelare log. ‘vigilare’; cfr. sp.-cat. desvelar; sost. disvélu, desvélu log. ‘sveglia’ = sp. desvelo. Wagner presenta la dipendenza della voce sarda da quella iberica, ma la verità è diversa, e lo dimostra ad esempio il camp. billái ‘vegliare, custodire, far la guardia’: billai su mortu; billai bona parte de sa notti studiendu (Porru). Bil-lai, privo del prefisso dis-, mostra chiaramente il radicale del verbo dis-vel-are ed acclara la sua origine dall’akk. bêlu ‘detenere (qualcuno), dominare, governare; to rule, take possession of’. In questo caso si evidenzia l’esatta funzione del pref. dis-, che non è privativo ma confermativo. Quindi disvelare significò anzitutto ‘vegliare, dominare, governare con determinazione’.
Irrobbare log., sdorrobái camp. ‘derubare’. Da rifiutare l’origine del verbo da sp. robar ‘idem’, proposta dal Wagner il quale propende per quell’origine anche quando l’evidenza è contraria. Tale voce è denominale da sd. robba ‘gregge, peculio, ‘bestiame’, ‘tutto ciò che uno possiede’. Wagner sostiene che robba derivi dall’it. roba (notisi la contraddizione, visto che prima indica l’origine iberica di irrobbare ‘portar via la robba’). A sua volta DELI registra roba come ‘ciò che di materiale si possiede o che serve in genere alle necessità del vivere’, derivandolo dal francone rauba ‘armatura’, ‘veste’: ma anche qui si cade in errore. Si vede che il termine si è espanso in Europa, ma nessun ha messo in evidenza la base etimologica, che è l’akk. rubbû ‘portato a piena crescita’, ‘incrementare, migliorare’, ‘avere interessi su’. Cfr. ingl. robbery ‘beni acquisiti con la grassazione’, to rob ‘derubare’, robber ‘ladro’; it. rubare.
Madéra-Linna. In camp. sa madèra o marèa (term. de maistu de barcas) funti ‘pezzus de linnámini de barca fattus a guidu po sustegnu de is taulus’ (Porru), = sp. madera ‘legno’. Questo è uno fra mille esempi che Wagner propone, relativo a voci che invece agonizzano o sono morte in Sardegna dopo l’epoca del colonialismo. Il termine largamente più usato in Sardegna non è certo madéra ma linna; ma anche linna per Wagner è coloniale, dal latino, mentre ha la base akk. liginnu (un tipo di tavoletta).
Magalléri camp.; mragalléri (Muravera) ‘giovane dell’anguilla latirostro e del grongo’ (Marcialis). Possibile base etimologica è l’akk. magallum (a big boat, una grossa barca). Se l’intuizione è giusta, qui assistiamo ad un processo in cui dalla barca da pesca si addivenne a nominare un tipo di pesce. Wagner dichiara la sua impressione che la voce sia catalana, “ma che non si trova nei dizionari”. A tanto giunge la pregiudiziale iberica in quello studioso.
Pansíri, pantzíri camp. ‘appassire’; mela pantzída ‘mela aggrinzita’ = cat. pansir-se ‘dessecar per l’acció del sol, per la calor excessiva’. Indubbiamente la voce sarda ha subìto l’influsso fonetico catalano, ma la voce è anche italiana: appassìre ‘idem’, dall’antico participiale passo ‘appassito’ (di erbe, frutta, per mancanza di umore). Base etimologica è l’akk. pa’ṣum, pāṣu ‘disbanded, off-duty; fuori servizio’ (truppa e altro), ‘crushed, broken up; schiacciato, rotto’. Questa è uno dei tanti lemmi da me elaborati nel Dizionario Etimologico senza citare il testo del Wagner (per non appesantire la narrazione), il quale traccia la vita di questa voce traendo gli esempi catalani (parecchi esempi) e quindi inducendo subliminalmente il lettore a credere alle origini catalane o spagnole.
Patranga (Bonorva) ‘finteria’, ‘fatto, cosa inventata’ = sp. patraña ‘mentira o noticia fabulosa’. Possibile base etimologica l’akk. patḫu ‘holed, bucato’ of discarded shoes, di scarpe abbandonate. Ma è più congruo l’akk. paṭārum ‘to loosen, release; allentare, rilassare’, paṭru ‘released’ + anḫu ‘tired, dilapidated; sfinito, dilapidato’ (in composto paṭr-anḫu). Wagner, disdegnando l’analisi etimologica, s’assicura in primis di ricondurre tutto all’iberico, lasciando però la sua proposta senza spiegazioni.
Pedríscia log. sett. ‘soglia, limitare’; pedríscia dessu balcone ‘davanzale della finestra’ (Casu); pedrissa, predissa log.; pedritza (Sennori); pidrissa sass. ‘sedile di pietra addossato al muro, da cui si monta a cavallo’. Per l’etimo vai a préḍḍa, pedra.
Wagner, oltre a considerare la base pedr- di origine greco-latina anziché, più correttamente, di origine mediterraneo-semitica, considera anche il suff. -íscia come non-sardo. E insiste: «probm. dal cat. pedrissa ‘massa de pedra’; pedrís ‘lloc abundant de pedres’; ‘seti de pedra’, ‘banc de pedra al peu de la porta, al pati, etc. per a seure’». Se escludiamo la foglia di fico espressa con “probm.”, da lui (e da altri imitatori) largamente usata per non apparire partigiano, egli non riesce a nascondere il suo filo-catalanismo, e non sa dove altro parare con la sua erudizione “di galleggiamento”. Invero, -íssa, -íscia è formazione tematica molto usata in Sardegna ad indicare un’attività o professione al femminile: crabarìssa ‘caprara’, abbatissa ‘abbatessa’, priorissa ‘prioressa’ e così via. La sua origine sta nell’ass. issu ‘woman, wife’, ebr. iššāʼ ‘donna’ ( אִׅשָּׁה ), bab. iššī ‘ella, she’. In Sardegna la pietra lineare della soglia e del davanzale, nonché il sedile spartano posto a lato della soglia, ricevettero suffisso femminile per il rispetto dovuto alla donna, Poiché la soglia, il davanzale, il sedile laterale alla soglia delle case antiche erano funzionali esclusivamente alle donne, anche perché erano anzitutto esse ad aver bisogno della predella per montare a cavallo. Stessero le case in mezzo alla foresta (come in Gallura) o nella viuzza paesana, questi tre “posatoi” erano destinati alle donne: per parlare a lungo sulla soglia con la vicina, per stare alla finestra in attesa dell’anima-gemella, per sedersi accanto all’uscio a filare, a cardare, fare cestini, salare i pomodori, e tanto altro.
Pendòni m. camp. ‘persona spregevole’; cfr. sp. spendón ‘persona despreciable’. Per l’etimo non si può recepire “pèndere” (come invece pretende Wagner), perché non si riesce a spiegare che cosa c’entri la semantica del “pendere” con la semantica della “spregevolezza”. Wagner, al solito, si soddisfa nell’abbinare due vocaboli foneticamente simili, senza indagarne la comune semantica. Egli fa ciò sempre e comunque, ma si sente particolarmente soddisfatto quando con l’abbinamento di due voci egli crede di “dimostrare” l’origine della lingua sarda da quella iberica. È invece congruo indicare la base etimologica di pendòni nell’akk. pēndu, pēmtum ‘charcoal, carbone’ (da cui anche pendû ‘mole, birthmark on face; neo, macchia scura sul volto’). In tal caso si assume pendòni come aggettivale in -òni, e si può agevolmente identificare questo pendòni come un antico ‘carbonaio’, il quale era sempre annerito per causa di lavoro. Di qui la metafora riferita a un ‘uomo spregevole’.
Poále, puále (Bitti, Posada, Dorgali, Orosei, Macomer, S. Lussurgiu); upuále log. ‘secchio di latta o di zinco per mungere’ = cat. poal ‘galleda’. Wagner rifiuta la proposta del Gröber che upuále fosse derivazione (aggettivale) da sd. úpu < cúppu. A maggior ragione rifiuta l’etimo simile proposto da REW 2409: lat. cuppa ‘coppa’. Fa tutto ciò per inchiodarsi all’origine catalana, quasi a testimoniare estremisticamente che in Catalogna fosse nata la lingua poi trasmessa alla Sardegna. E non s’accorge che la stessa voce catalana partecipa della Koiné Mediterranea < akk. kūbu ‘a drinking vessel’, che diede l’aggettivale *kūbu-ale > (ku)buale > upuale.
Recádu log. e camp. ‘notizia, ambasciata, saluto, ossequio’ = sp. recado. Base etimologica è l’akk. rēqu ‘far, distant; lontano, distante’ + âdu to take notice of’. Il composto rēq-âdu in origine significò ‘ricevere notizie da lontano’. Etimologia lineare per la quale non si può insistere sullo spagnolismo a senso unico proposto dal Wagner, quando è evidente l’origine comune.
Recuíre log. ‘raccogliere’. Cfr. sp. recudir ‘volver una cosa a su sitio’. La voce sarda pertinente al ‘raccogliere’ è gollίre, collίre, goḍḍίre, ingolli. Invece il riferimento spagnolo citato dal Wagner si attaglia soltanto al sd. recuίre ‘ritornare’. Qua, come si vede, Wagner ha raggiunto l’acme dell’assurdo, prendendo una voce spagnola, ritagliandole sopra una voce sarda inesistente, e dando a questa, forzatamente, il significato spagnolo.
Sabanitta (Macomer); banitta log. e camp. (Cuglieri, Busachi, S. Lussurgiu, Milis, Perdas, Escalaplano); sa baίnta (Usellus); ballitta (Fonni) ‘materasso’. Nel CSMB 32 banita è più che altro una ‘coltre’. In origine fu banitta, essendo sa- un articolo concresciuto. A sua volta banitta ha base etimologica nell’akk. banû ‘to become good, look after s.o. kindly; divenire buono, prendersi cura delicatamente di qualcuno’. Va da sé che il concetto originario fu quello del CSMB, e la voce è autenticamente sardiana. Rinvio al DES II 373 per capire l’arte sopraffina del Wagner nel menare il can per l’aia e discutere del sesso degli angeli. Inoltre il suo tentativo di accreditare queste due voci al mondo iberico è ad un tempo patetico e losco: egli infatti opera con argomenti insieme scoperti e subliminali per fissare l’origine del vocabolo nell’Iberia, nonostante ch’esso sia ufficialmente datato al 1242.
Saètta log. e camp. ‘freccia’; anche ‘fulmine’ (log. sett.). Cfr. it. saetta < lat. sagitta ‘freccia’. Wagner pretende senza ragione che la voce sarda sia da sp. saeta, quando è evidente che la voce nacque in ambito tirrenico.
Sumbréri log., sass., camp. ‘cappello’; gall. simbréri (Azara) = sp. sombrero ‘che fa ombra’. Ovviamente Wagner indica la parola sarda come accatto da quella spagnola. Ma ciò contrasta con l’arcaicità del lemma, che fu mediterraneo da parecchi millenni, poiché la base etimologica è il sum. šun ‘sole’ + bur ‘garment, clothing’. Quindi in origine šun-bur (di cui sumbréri e aggettivale di funzione in -éri) significò ‘indumento (copricapo) per il sole’.
Il Corominas volle sancire d’autorità che lo sp. sombra è «alteraciόn del lat. ŭmbra, id., conservado en las lenguas hermanas, y en el deriv. umbrίa, 1739; umbrίo, 1513. La s-, agregada sόlo en portugués y castellano, es probable que se deba al influjo de sol y sus derivados, por ser sol y sombra, solano y sombrίo, solear y sombrear, conceptos correlativos, opuestos y acoplados costantemente. La variante solombra, corriente desde antiguo, h. 1250, en los dialectos leoneses, judeoespañoles, portugueses y occitanos, comprueba la certeza de esta explicatiόn». Nel ragionare del Corominas osserviamo il vertice cui può giungere la perspicacia dei filologi romanzi, la quale, impiccata alla credenza che tutto abbia origine nel latino, si appaga nell’osservare i vari concetti correlati, senza però un sia pur minimo colpo d’ala che gli faccia cogliere le radici profonde dei processi che portarono al misterioso s-, da loro percepito puerilmente quale parente oramai consumato del… s-ole.
Nel capoverso iniziale ho indicato quali sono le vere radici dello sp. sombra ‘ombra’ (< sum. šunbur); mentre il lat. ŭmbra, sd. umbra ‘ombra’ ha diversa etimologia. Semerano (OCE II 599) propone ŭmbra dal sum. umbara ‘riparo, difesa’. Il Pennsylvania Sumerian Dictionary dà però umbara ‘aid, help; aiuto’, per quanto il campo semantico sia lo stesso. In ogni modo, è molto più congrua la base akk. ūmu ‘daytime’ + burûm ‘riparo, copertura, tetto’, dove il composto ūm-burûm in origine significò il ‘riparo dalla luce’.
Traggèra, traggèa, treggèa camp. ‘anici in camicia’ ossia minuscole palline zuccherate che imperlinano la superficie dei dolci. Cfr. it. antiq. treggea ‘idem’, ‘confettura’. La sopravvivenza di questa parola tirrenica è oltremodo indicativa, poiché ha la stessa formazione che ritroviamo in trággiu (vedi sotto): insomma, la traggèra fin dalle sue origini fu una leziosità, un impreziosimento visivo, e non poté mancare di essere abbinata all’idea della cortigianeria, del lusso di corte.
Trággiu (Bosa) ‘coro’. Soltanto a Bosa è così definito «il locale assetto di quattro voci maschili, dislocate secondo nomenclature analoghe a quelle delle altre tradizioni polivocali sarde: bassu, contra, tenore, contraltu»3. Su trággiu è insomma un quartetto, nel quale un tenore intona e canta con un certo ritmo ed una certa melodia, gli altri tre cantano le riprese e fanno l’accompagnamento.
Per Wagner trággiu, trazzu è la ‘foggia, moda di vestire’, secondo lui dal cat. trajo, sp. traje ‘vestito’; denominale attraggiare; log. aer bellu trággiu ‘attillarsi, avere buone maniere’. Quindi trággiu è il modo di ‘presentarsi’ cantando con buone ‘maniere’.
Trággiu-trajo-traje hanno un loro significato profondo, con base etimologica nell’akk. tīru(m) ‘un cortigiano’ + awûm ‘parlare’, ‘riflettere’ su qualcosa, ‘(parole) che sono in uso, che sono in alta considerazione, che sono studiate (per la loro preziosità)’. Abbiamo quindi uno stato-costrutto che produce il composto sardiano *t(i)r-awum > t(i)rággiu, significante ‘cortigiano che recita parole preziose’. In questo caso il riferimento è al tenore del quartetto di Bosa, ma s’estende agli altri significati di trággiu in quanto ‘stile personale dei poeti-cantori’ nelle sfide amebee. Questa etimologia crea un importantissimo squarcio di vita sociale e civile di 4-5000 anni addietro. Sappiamo quanto fosse ricca la letteratura semitica del secondo Millennio prima dell’Era volgare. Quella è la stessa letteratura che ha generato i poemi di Ugarit, i Salmi della Bibbia ed anche l’ineffabile poesia dei Vangeli. Sembra chiaro che a quei tempi un cantante capace di recitare e ritmare in melodia preziose parole poetiche veniva elevato ipso facto al rango di cortigiano (vedi l’esempio di Torquato Tasso, di Baldassar Castiglione, di Ludovico Ariosto, di Ovidio, di Virgilio e di tanti altri poeti del passato, elevati al rango di cortigiani per il talento poetico). È sbalorditivo che dopo 4000 anni il significato di certi termini non sia nient’affatto corrotto. Il log. aer bellu trággiu ‘attillarsi, avere buone maniere’ richiama proprio la figura del cortigiano, che delle buone maniere fece uno stile di vita.
Trettu log. e camp. ‘tratto, spazio, intervallo’; in cuḍḍu trettu (Laconi) ‘in quel luogo’; a trettu ‘a portata, vicino’; (Nuoro, Dorgali) ‘falciata, andana’. Cfr. cat. tret ‘distancia de lloc o de temps’. Manco a dirlo, Wagner lo accredita subliminalmente come vocabolo catalano («Il Salvioni… lo riconobbe come vocabolo catalano, ma opina che si è incontrato con l’ital. tratto, ciò che non è necessario»); e ciò gli basta non solo per omettere l’indagine etimologica, ma per additare l’opzione scartata (l’it. tratto) come ultimo (indiscutibile) approdo d’improbe fatiche culturali. Base etimologica di trettu è invero l’akk. ṭēru ‘terra, territorio’ + ettum, ittum ‘sign, signpost, road marker; indicazione, segnavia, miliario’. Il composto ṭēr-ettum significò in origine ‘tratto di territorio misurato’.
Turráu camp. ‘essere malato’; turráu in conca ‘malato di mente’. Base nel sum. tur ‘ essere malato’, ‘malattia’.
Vissentu Porru, che pubblicò il Dizionariu Sardu Italianu nel 1832, lo considerò tout court un termine catalano, un participio significante anzitutto ‘riarso, seccato, fatto adusto’; caffè turrau ‘caffè abbrostito, tostato’; méndula turrada ‘mandorle tostate’; pani turráu ‘pane arrostito, abbronzato’. Anche l’infinito turrái ebbe ovviamente la stessa origine catalana, lingua alla quale quasi tutto lo scibile sardo doveva origine e dignità, secondo loro. Erano tempi, quelli, in cui già si capiva, illuministicamente, che la lingua sarda doveva essere salvata in un Dizionario, epperò la convinzione “derivazionale”, “coloniale”, tra gli studiosi era monolitica: la matrice della lingua sarda, oltreché nel latino e nell’italiano, per gli studiosi stava esclusivamente nel catalano e nello spagnolo, ossia tra le lingue degli Stati che avevano colonizzato l’isola: la lingua sarda era insomma un’accozzaglia di vocaboli che forse, senza quegli apporti, non sarebbe esistita. Così la pensò pure Wagner, che precisò l’origine del termine sardo nel cat.-sp. turrar, torrar ‘torrefare, abbrustolire’. Anche su turróni ‘il torrone’ ebbe, beninteso, la stessa origine, e DELI viene pomposamente a ribadirlo, da turrar ‘torrefare’ (nonostante che la confezione del torrone stia agli antipodi della torrefazione). La pigrizia mentale fa tutt’uno con l’ignoranza, sua fedele ancella.
In realtà turráu nel senso di ‘malato’, turráu nel senso di ‘torrefatto’, e turròni ‘dolce di miele e mandorle’ hanno tre diverse origini. La prima è stata già vista. Il concetto della torrefazione, dell’abbrustolire, del riarso, bruciato, caldissimo, ha base nel sum. tur ‘ridursi, diventar piccolo’, akk. tūru(m) ‘ritirata, tornare indietro’, poiché l’effetto della temperatura caldissima è di seccare senza incendiare.
Circa il torrone, la semantica di questo friabile, croccante e squisito dolce di miele, mandorle (o noci) e albumi d’uovo va riferita esclusivamente al fatto che per la sua confezione occorre (occorreva) rimestare per almeno 4 ore il prodotto, riportandolo a una pasta dura e filante. Dall’interminabile rimescolare col bastone viene la sua semantica, dall’akk. turru ‘turned, rigirato’, tūru(m) ‘il rigirare’ + sum. unu ‘cibo, pasto’: il composto tūr-runu significò ‘cibo rigirato’.
Unità dei dialetti sardi col dialetto sassarese. La lingua sarda è complessa. Ma più complessa è la fatica di far ragionare su di essa gli specialisti. Ognuno ama rinserrarsi nel proprio particulare, vagheggia sui fumi di teorie mai discusse, accetta fideisticamente le datate “sentenze” dei dotti, e non s’accorge che la lingua sarda è veramente singolare. Purtroppo, è il percepire certi vocaboli come assolutamente peculiari alla propria zona di nascita a rendere partigiano il ricercatore sardo (ahimé, non soltanto lui!). Sì. Perché non è facile padroneggiare 100.000 vocaboli, e non è facile ammettere che tale massa va alleggerita scompartendola tra le varie subregioni. Il che non significa che ogni sub-regione debba curarsi soltanto dei propri vocaboli. Spessissimo molti vocaboli sardi sono identici tra le singole subregioni, ma si distinguono uno ad uno per peculiarità fonetiche. Va da sé che l’esorbitante numero di 100.000 si riduce d’un colpo se unifichiamo a grappolo tutte le voci sotto dei “capifila”, sotto lemmi capaci di raccostare e spiegare le diversità (come spesso faccio io in questo Dizionario, e come seppe fare magistralmente Wagner il quale, nonostante i tanti errori nel tentare di accorparli, riuscì a ricondurre i suoi 20.000 vocaboli entro 7000 lemmi).
La Sardegna ha un retaggio vetusto, parla la sua lingua da decine di millenni, e le sue radici lessicali s’intersecano tra zona e zona pervadendo tutte le aree linguistiche. Chi ignora l’esistenza di una vera e propria rete ignora la complessa unità della lingua sarda. Il concetto della rete è adeguato. E se la rete viene lacerata in un solo punto, ciò basta a far scappare i tonni. La rete è unica, la lingua è unica. Per capire la lingua occorre tenere integra la rete. Altrimenti sfugge un’intera fenomenologia.
La leggerezza culturale (direi la fanciullezza del neofita) che ha portato molti dotti a lacerare questa rete ha creato grossi danni, ivi compreso il danno sul dialetto sassarese. Da almeno 100 anni c’è la “conventiō ad excludendum” del dialetto sassarese, semplicemente perché nessuno degli esperti lo ha voluto studiare contestualmente a tutti gli altri dialetti sardi. Questa cappa di piombo pesa, beninteso, principalmente a causa della sorda opposizione del Wagner, il quale non ammise mai il dialetto sassarese nel novero delle parlate sarde. Ecco l’aristotelismo; ecco l’Ipse dixit! Ma pesò anche la ricerca di Antonio Sanna ai tempi del Wagner, intitolata “Il dialetto di Sassari”. Un ricerca che rinfrancò Wagner e lo stesso Sanna (ch’era nativo dell’Île de France logudorese: Bonorva).
Perché non dirlo?: quelli erano tempi da “Premio città di Ozieri”, i tempi della rivista “S’ischìglia” di Angelo Dettori, tempi in cui la cattedra di linguistica sarda era affidata a un logudorese, allorché le gare poetiche s’esprimevano spesso in logudorese e gli stessi premi di Ozieri toccavano a scrittori logudoresi. Non erano pochi i dotti che giuravano sulla sardità genuina del dialetto logudorese, mentre al campidanese toccava l’onta d’essersi macchiato con le lingue d’Oltre-Tirreno.
Ecco la pretesa purezza, l’ideologia che ha accecato coorti di studiosi, inducendoli a creare scale di valori, ad inventare lo spettro cromatico ai cui limiti la luce svanisce in frequenze non percepibili. Laddove pare che un dialetto sardo si squagli in altri universi linguistici, ecco gli studiosi a dichiararne la liminarità e per ciò stesso l’esclusione dai canoni portanti della sardità originaria. Nemmeno l’insularità della Sardegna è mai riuscita a fare accettare l’insularità della sua lingua, ed ancora oggi dei baldi scouts vanno alla scoperta dell’Arca, di un dialetto più originario del dialetto contiguo, che mai troveranno, almeno sinché i loro canoni ideologici inseguiranno un’idea sortita cervelloticamente, anziché parametrare materialmente una realtà che da decenni aspetta d’essere conosciuta.
In questa mia premessa metodologica ho abbondantemente mostrato (e dimostrerò ulteriormente) gli errori di metodo in cui tali studiosi sono incappati. Ammesso e non concesso che sia possibile parlare di una schiettezza sarda nel senso di una originalità genuina riferita a una precisa zona linguistica, andrebbe poi spiegato di che si tratti, e perché mai si voglia individuare quella zona. Sinora nessuno lo ha fatto, o per meglio dire: ci hanno tentato, senza riuscire. Ma è singolare che, sotto-traccia, il tarlo della schiettezza sarda, della individualità sarda, abbia lavorato e stia ancora lavorando, divorando i migliori cervelli delle nostre Università.
Sulla lingua sarda ognuno è andato liberamente per suo conto, come un “ragazzo sul delfino”, affrancato e sognante in una galoppante e selvaggia indisciplina che nemmeno Wagner ha saputo raffrenare, nonostante il suo ideologico scalimetro che dà la pagella del superiore e dell’inferiore, nonostante che Wagner abbia prodotto una Fonetica Storica del Sardo giudicata la “pietra di paragone” per qualsiasi studio linguistico.
Lo studio di Antonio Sanna non fu di per sé la “pietra dello scandalo”. Tale studio andava fatto, e ringrazio il Sanna per i suoi meriti. Ma al solito i danni sono creati dagli epigoni. Si accampa lo studio del Sanna come un Moloch abbagliante e totalitario, e lo si accetta come un “nec-plus-ultra”, Colonne d’Ercole invalicabili, termine degli spazi consentiti allo studio del dialetto sassarese. È nella contemplazione di quel Moloch che accettiamo (quasi come una tesi che ci affranca da ogni responsabilità) l’incatenazione del dialetto sassarese a quello gallurese → alla lingua còrsa → alla lingua italiana (al toscano, al genovese), creando la centrifuga che proietta Sassari oltre la stratosfera e lo fa atterrare in suolo lunare.
Ma Antonio Sanna voleva fare soltanto uno studio storico, dimostrando il peso dei còrso-galluresi nel ripopolare Sassari a seguito delle due Grandi Pesti. Siamo noi ad aver visto in lui le “Colonne d’Ercole” ed esserci sinora privati della possibilità di tesaurizzare positivamente lo sforzo del Sanna, nel più vasto ambito di una ricerca, sempre possibile, che conduca a capire esattamente il ruolo del dialetto sassarese nella storia linguistica della Sardegna.
È stato proprio lo studio analitico del D.E.S., da me condotto sino all’ultimo lemma, ad aver accertato che il dialetto sassarese condivide con i restanti dialetti sardi quasi il 90% dei vocaboli (salvo una parte della sua fonetica, la quale è condivisa però dall’Alto Logudoro, della cui arcaica sardità ho abbondantemente discusso nella mia Grammatica Storica, al cap. 3.1.10).
In questa Premessa manca lo spazio adeguato a discutere esaustivamente sulla sardità del dialetto di Sassari. Più spazio gli è riservato nel mio Dizionario Etimologico del Dialetto Sassarese, in via di completamento. Qui mi basta anticipare che il dialetto di Sassari condivide con Cagliari più vocaboli (e persino più fonetica) che con la restante Sardegna. Questa sentenza non va vista come némesis da me scatenata contro i detrattori dell’unità linguistica isolana; è però un aspetto che da solo è in grado di fare esplodere tutte le pregresse certezze. E qui chiudo, proponendo soltanto qualche lemma che dimostra l’unità dei Sardi.
Abbastu camp. ‘sufficienza’; di abbastu ‘a sufficienza’; sass. abbáłtu ‘idem’. Vedi sp. abasto, cat. abast; it. abbastanza, bastare ‘essere sufficiente’, che DELI ritiene di etimologia sconosciuta. Invero la base è l’akk. bâštu ‘dignità, sorgente d’orgoglio’; bašû ‘to become ripe, diventare maturo; be available, in safekeeping, essere disponibile; materializzare un profitto’.
Abbauca’, abbacca’ sass. ‘stordire, sbalordire, intontire’: è tuttu abbaucaḍḍu da li midizini ‘è intontito dalle medicine’. Per i tanti lemmi che ne sono coinvolti, rinvio la discussione al quart’ultimo paragrafo (“La dittatura dell’incompetenza”).
Abbundare, -ái log. e camp. ‘abbondare’; anche log. bundare: bundat sa vida in noa giuventura; sass. abbunda’. Wagner considera abbundáre e abbundíri (vedi) come italianismo o spagnolismo, evidentemente collegati al lat. abundantia ‘straripamento, flusso eccessivo’, abundo ‘straripare, traboccare, sovrabbondare’. Vi sono due opzioni: la prima delle quali porta al lat. ab-unda, richiamante il concetto dell’onda che straripa (ab- + unda); la seconda opzione è il sum. bun ‘spingere’ + du ‘to heap up, pile up, accumulare’, onde bun-du col significato sintetico di ‘ammassare’: ciò andrebbe bene al sardo bundáre.
Abbundíri camp. ‘cibo che aumenta di volume in cottura’; log. bundìre. Per l’etimo vai ad abbundáre.
Accabussái, cabussái camp. ‘tuffare, tuffarsi’; cfr. cat. accabussar ‘id.’. Il significato iniziale fu ‘entrare di testa come punta di freccia’, da sd. cabu ‘testa’, sass. ‘idem’. (v. lat. caput ‘id.’). L’origine dei lemmi sardo e latino è l’akk. kāpu, kappu, kāpum ‘roccia, riva, cliff, embankment (of river, of mountain)’. Il secondo membro del lemma cab-utza’ ha base nell’akk. ūṣum, uṣsu ‘punta di freccia’.
Accattái(sì) camp. ‘accorgersi’. Cfr. sass. agattassi ‘idem’. Base etimologica è l’akk. qatû ‘be completed, be achieved, essere completato, essere acquisito’. Vedi log. agattáre, sass. agatta’ ‘trovare’.
Acciappinái camp., ciappináre log. Per l’etimo vai a sass. ciappínu.
Ciappínu sass. ‘incompetente, schiappa, poco capace’; sass. acciaputza’, log. acciaputzáre, inciaputzáre, camp. acciaputzái ‘acciarpare, abborracciare’. Base etimologica di questi lemmi mediterranei è l’akk. ḫapû, ḫepû ‘to break’ (vessel etc.), ‘to ruin destroy’ (city, land, people), ‘to crack, crush, injure’ (part of body).
Accióu camp. ‘chiodo’, sass. ciódu.
Aggaffare log.; aggatta’ sass.; -ái camp. ‘afferrare, acchiappare’; cfr. cat. agafar ‘coger, asir, apañar’, anche accaffiáre log., accaffái, aganfái camp. Base etimologica è l’akk. kappum ‘mano’.
Aláscia camp. ‘mobile’. Wagner lo deriva dallo sp. ant. alhaja ‘mueble, utensilio’. In log. aláscios ‘attrezzi, suppellettili, strumenti di lavoro’. Ma occorre confrontare questi lemmi col log. e camp. calásciu ‘cassetto’ (di un canterano, di un contenitore di biancheria), che è il prototipo, almeno per la Sardegna. A quanto pare, siamo dinanzi a varie forme lessicali con vari esiti fonetici e varie semantiche; ciò reca ragioni valide per vedere i vari lemmi come crescite autonome, ognuna nel proprio territorio, nell’ambito della lingua sarda. In ogni modo la base etimologica di log. calásciu, sass. carásciu è il sum. ḫal ‘basket, pot’, kallu ‘bowl’ + aš ‘bread’; quindi il composto ḫal-aš in origine significò ‘cesta del pane’.
Alloriái camp. ‘turbare l’altrui mente con grida o atti che intronano il cervello in modo che si perde il sentimento e il discorso’. Per Wagner è una formazione espressiva (sic), al pari di log. alloroscáre ‘abbaiare rabbiosamente; gridare con ira’ (vedi).
Ma il termine non è espressivo, è invece la base genetica del log. allorigáre, in formazioni del tipo mi fazzi vinì la lòriga sass. ‘mi sta logorando i nervi’, arrigga’ a la lòriga ‘ridurre all’estremo della sopportazione’.
Lòriga nel senso di ‘estremo della sopportazione’ ha base etimologica diversa dall’altra lòriga (anello); i due lemmi si sono assimilati per paronomasia soltanto nel medioevo. Per capire lòriga ‘estremo della sopportazione’ occorre porre mente allo stato fisico prodotto negli astanti da una persona assillante, o lamentosa, o pedantissima, che siamo costretti a sopportare a lungo. Il nostro eccesso di tolleranza nei suoi confronti viene – per ragioni di educazione – somatizzato, ma opera lo svuotamento delle energie positive; ci si sente infine compressi, o emunti, privi di forze, incapaci di sentire le vibrazioni positive della nostra anima, la quale a questo punto è spenta, violata. Questo è il momento della fuga, o della rimozione della persona che produce tanta negatività; ma può essere il momento di un’esplosione di rabbia e di urla (o di violenza) contro il pedante. Mi fazzi vinì la lòriga ‘mi porta all’estremo della sopportazione’ sembra avere base etimologica nel sum. lu ‘to stir up, risvegliare, fomentare, provocare’ + ri ‘to cry, cry out, wail, complain; urlare, gemere, lamentarsi’. Il composto lu-ri (di cui il log. lóriga è aggettivo in -ca) in origine significò ‘provocare gemiti, urla’.
Ammaccionaisì camp. ‘rannicchiarsi, ripiegarsi su se stesso, seduto o coricato’. Secondo Spano anche ammasonaisì. Wagner non riesce a quagliare l’etimo. Questo è un verbo legato all’estasi, alle sensazioni estreme in fase oracolare’, da akk. maḫum ‘to rave, delirare; dipartirsi (da se stesso)’; maḫḫû ‘esaltato’, da cui sd. maccu ‘matto, scemo, pazzo’.
Aúndi camp. merid. ‘dove’. Il prototipo è il sass. undì (vedi). Wagner osserva: «nel gall. e nel sass. abbiamo úndi (sic, al posto di undì) ‘dove’; ma questo úndi non può essere identico al camp. aúndi, già per la discontinuità geografica (sic!). Esso invece si continua nel còrso, specm. còrso mer., onde (cfr. soprattutto Lichtenhahn, l.c., p. 79, seg.). A torto, sedotta dalla fallace omonimia delle forme gall. e camp. mer., l’Autrice le considera come geneticamente identiche». Il lettore scoprirà in questo pezzo del Wagner un autentico pasticcio, dove emergono due situazioni false. La prima (undì ≠ úndi) è stata qui svelata. La seconda falsità è da lui stesso evidenziata nel considerare il dialetto sassarese una bastardaggine italianeggiante, anziché uno dei tanti dialetti sardi, il cui fondo arcaico ancora oggi mostra migliaia di identità con la parlata cagliaritana.
Guruséle nome della celebre fonte di Sassari, oggi detta Rosello o Ruseḍḍu. Un tempo stava fuori delle mura cittadine, alla base della parete calcarea alta 25 metri. Guru- ha i confronti etimologici con l’ebr. יְרוּ* (*iěru) ‘insediamento’ < sum. iri ‘città’. -Sèle = Šalimu (dio semitico della salute) < akk. šâlu ‘rallegrarsi, godere di qualcosa’, ‘star bene’, salāmu ‘essere in pace’ (ebr. šālom ‘pace, salve!, arabo salām ‘pace’). Cfr. Bruncu Salámu (un monte di Dolianova, dove sgorgano acque ritenute curative); e vedi il monte Guruséle, il più alto dei Supramonte di Baunei, dove si diparte il primo ruscelletto che va a formare il fiume sacro chiamato Ilune. Cfr. comunque l’akk. šalû ‘sommerso’ (> “battesimi”), salā’u ‘spruzzare’ acqua’ (nei rituali di purificazione).
Guru-séle > Ru-séllu = Jerušalaim significò ‘città di Šalam’. La Sardegna è intrisa di nomi che ritroviamo anche nella civiltà ebraica.
Ille, illu, illa ecc. esisteva come pronome indipendente dopo preposizione in sardo antico (CSP 203: Et ego tenninde corona cun ille; 227: Et ego kertainde cun ille; 45: et kertai cun illu; 33: ca non bi abean bias in illos; CSNT 133: sos ci certaban cun illu. Le forme atone sono (i)lu, (i)la ecc. e per il dativo (i)li, (i)lis (CSP 29: et issos derunilos appare, e ccoiuuainusilos; 3: Judicarunili ad issos a destimonius; 31: naraitili iudike; CSNT 49, 50: aprezarunmilas; 74: indulserunmilu; 171: issos kertarunlis, ecc.). Frequentemente occorrono forme in funzione enclitica (CSP 98: et giraitsemi supra’lla; 33: sinde kertat alikis pro ‘llos; CSNT 145: certabat pro’lla; CSMB 149: kertait cu ‘llu; 168: et ego binki de’ llu, ecc.). Nel camp. ant. abbiamo le stesse forme (CV XI, 2: illi illas firmu ego; III, 1; IV, 1 ecc.: ki mi ‘llu castigit; VI, 4: ca ‘lla dau, ecc.); in sede postverbale pare si preferisca ell- (VIII, 4; XVI, 4: dedi ellu; XIX, 3: dau ella, ecc.).
Nel sardo moderno queste forme toniche si usano molto poco cedendo il posto a isse, issu; come forme atone abbiamo in camp. ḍḍu, ḍḍa, ḍḍus, ḍḍas, ḍḍi, ḍḍis; in log. lu, la, los, las, li, lis (queste ultime anche nei condaghes).
Tra le forme logudoresi qua citate, va notato che lu log. e sass. è anche art. det. = ‘il’. Attualmente, il sum. lu in quanto articolo determinativo mediterraneo, sopravvive proprio nel dialetto sassarese-gallurese: es. lu cani, lu pani, la prància ‘il cane, il pane, il ferro da stiro’. Sopravvive anche nell’Italia del sud: es. lu pisci-spada ‘il pesce-spada’. Altri esempi sardi del sum. lu si trovano attualmente nei suffissi cristallizzati dei cognomi sardi in -lu, nei quali confluisce pure il pronome dimostrativo sum. ul. Cfr. il cgn Buttόlu composto dal sum. bu ‘perfetto’ + tu ‘formula magica’ + lu ‘persona’, ‘colui che, colei che’: bu-tu-lu, col significato originario di ‘chi è addetto alle formule magiche’. Da tutto quanto si è detto, si capisce che le forme sd. ille, illu, illa hanno subìto l’influsso del lat. ille, illa, che si è sovrapposto alle forme sumeriche in lu originariamente usate in tutta la Sardegna.
Spaperrottái, spapparottái camp. ‘fueḍḍai meda e sentza neçessidadi’ (Porru), ‘ciarlare, cianciare’. Casu registra ispabarrottare ‘gridare, vociare’. E già l’apporto del Casu dimostra l’unità lessicale tra Cagliari e Alto Logudoro. Wagner le considera voci onomatopeiche, non aiutando così a legare i fili. In realtà, la base etimologica di spapperrottái è la stessa che vale per i ‘rondoni’ (chiamati a Sassari babbarrotti), dal sum. par ‘canale’ (raddoppiato in senso superlativo) + ud ‘bird’: quindi pa-par-rud significò, già 40.000 anni fa, ‘uccello dei canali’ (infatti questo animale si nutre esclusivamente d’insetti, di zanzare, e per questo frequenta i siti umidi dove gl’insetti abbondano). Questo traslato riferito a chi ciarla continuamente è dovuto al fatto che le rondini, i rondoni, quando cacciano a stormo strillano senza sosta, volando a bocca aperta e creando un chiasso festoso. Con ciò ho dimostrato un triangolo lessicale inossidabile tra Cagliari, Sassari, Alto Logudoro.
Tukké sass. ‘sorta di benda che fascia o abbellisce il capo delle donne’. Base etimologica è il sum. tuku ‘acquisto, tessuto, stoffa’. Si capisce che il tukké un tempo fu un oggetto di cosmesi, per i momenti della festa. Vedi anche sum. tuku ‘to acquire, acquistare’ (nei tempi arcaici le cose acquistate costituivano dei veri e propri beni di un qualche pregio); anche tuku ‘to beat, strike of cloth, to weave’ (e qui siamo nel campo semantico della fabbricazione delle stoffe).
Wagner preferisce registrare in altro modo: a dukè ‘a punta, dicesi del modo come le donne si abbigliano il velo in testa’ (Spano). Egli non scrive altro, suggerendo ex silentio che dukè sia un modo, non una cosa, e lasciando subliminalmente intendere che la forma sassarese sia un accatto francesizzante, ignorando del tutto la sua origine arcaica, sardiana.
Forte parentela tra logudorese e campidanese. Oltre ai brevi accenni del paragrafo testè concluso, sono i pochi esempi seguenti a mostrare, a maggior ragione, la strettissima affinità del dialetto logudorese col dialetto campidanese, la quale si esprime in decine di migliaia di voci.
Abbojare, abbojare (Mores) ‘incontrare’. Lungi dall’etimo di attoppare (vedi), questa voce ha base etimologica nel sum. bu’i ‘to face, incontrarsi, mettersi a confronto’.
Abbóju log. e camp. ‘appuntamento’. Per l’etimo vai ad abbojare.
Abborréssere log., abborréssiri camp. ‘aborrire, avere in odio’; sass. abburrissi’ ‘svergognarsi, coprirsi di vergogna, screditarsi’. Per l’etimo vai ad abburrésciu.
Abburrésciu camp. ‘ubriaco fradicio’; burràcciu ‘ubriacone’, burraccera ‘ubriachezza’. Wagner lo fa derivare dallo sp. borracho ‘ubriaco’. Invero i lemmi sardo e spagnolo sono forme metatetiche dall’akk. buḫḫuru ‘cuocere, riscaldare’, ‘tener caldo’; buḫru ‘stato di cottura’. Non a caso in Sardegna cottura equivale semanticamente a sbornia. A dire il vero, le semantiche convergono dall’origine, poiché anche il log. cóttu ‘ubriaco’ ha origini accadiche, da akk. quttû ‘completato’ (ossia riempito, messo KO dal vino). Sembra di capire che mentre la forma abburrésciu ha attecchito soltanto nel sud dell’isola, cóttu ha attecchito nel nord. Abburrésciu s’incrocia, pure semanticamente, col log. sett. abburrare, abburrigare(si) ‘immergersi nel fango o nell’acqua’, ‘infangarsi’, che Wagner ritiene dallo sp. barro ‘fango’: ed è possibile. Ma intanto c’è il confronto con l’akk. barruru ‘con occhi luccicanti’ con riferimento anche alla persona ubriaca. In ogni modo la vera base etimologica è l’akk. burrû ‘prostituto, prostituto sacro’ (tutto un programma).
Alleputzíu, alleputzáu camp. ‘ben vestito’, ma anche ‘ringalluzzito’, ‘allegro’; forse i tre campi semantici in origine furono idealmente più contigui, poiché nei tempi arcaici il ben vestire era tipico delle grandi feste, quindi dell’allegria. La base semantica si riferisce al composto akk. allu ‘puro, chiaro’ + pūṣu ‘bianchezza, candore’: stato costrutto alli-pūṣu, col significato di ‘candore immacolato’. Da respingere la proposta del Wagner di ricondurre queste voci a lèppore ‘lepre’.
Questo part. pass. ha il referente in alleputzare log., alleputzái camp. ‘attillarsi, vestirsi elegantemente, vestirsi con cura, abbigliarsi’.
Attobiái camp. ‘incontrare’. La base etimologica è diversa da quella di attoppare (vedi): attobiái contiene una labializzazione intervenuta per legge fonetica campidanese sul sum. tul ‘well, pozzo’. Nelle età primitive il pozzo era l’unico punto d’incontro certo e diuturno della comunità. Cfr. log. attόliu ‘convegno, appuntamento’; attoliare ‘chiamare, unirsi’ (Fonni): Spano.
La lingua arcaica fu compresa spesso sino al Rinascimento. Può sembrare una boutade, ma sono astretto ad ammettere che la lingua arcaica in Sardegna fu compresa sino a tempi recenti. Con essa, cinque secoli fa, si confezionarono ancora parole nella consapevolezza che si stavano utilizzando radicali primitivi, ancora compresi nella loro essenza e come tali ritenuti portatori di significato, capaci di entrare a buon diritto nella costruzione delle frasi. Anche qui gli esempi possono abbondare, ma limito l’intervento a pochi lemmi.
Allóḍḍu2 nome tabuistico della ‘volpe’. Base etimologica può essere il sum. ala ‘demon’, o alad ‘spirito’ + ud ‘storm demon’; in ogni modo, quel modo d’intendere la volpe transitò anche nell’akk. allû ‘that (one)’ + ūdu ‘distress, affliction’: all-ūdu significò ‘quello dei malanni’, quello che porta malattie, sventure’, etc. Chiaramente, il nome fu satanizzato in epoca bizantina, e questa è una delle tante prove che almeno nell’alto Medioevo in Sardegna si parlava ancora semitico, con una vasta base di vocaboli sumerici.
Cozzorottu (Orgòsolo) ‘tutolo, pannocchia del granturco’. La base etimologica è nel bab. kuṣṣuru(m) ‘zeppo di nodi’.
Mammòne (gatto). Come si è visto ai lemmi gattu e catzu, la figura del gatto subì un radicale capovolgimento tra l’epoca antica ed il Medioevo cristiano. Il gatto per gli Egizi era un dio (in virtù del fatto che liberava i granai dai topi e le piantagioni dai ratti). Nel Medioevo divenne, per influsso dei preti cristiani, una creatura posseduta da Satana. Sacchi pieni di gatti vivi venivano buttati nel fuoco per festeggiare il solstizio d’estate, pratica che continuò in Francia sino al secolo dei Lumi. Il Gatto Mammone, clericale invenzione del Medievo, è un gatto dalle fattezze infernali, terrificanti. Non poteva essere altrimenti, considerata l’esigenza di capovolgere la splendida visione che del gatto avevano gli antichi. La base etimologica è il sum. ma ‘to burn’ + munu ‘scorching, rovente’: mam-munu ‘che brucia al calor bianco’ (un essere demoniaco, insomma). Si noti che questo è uno dei tanti lemmi creati esplicitamente in epoca medievale, in epoca bizantina, ed è testimone del fatto che ancora nei primi secoli cristiani in Sardegna si parlava semitico.
Mangrofa è il cognome di Maria Mangròfa, moglie di Antòni Cracassòni, il favoloso costruttore dei nurághes nominato in tante storielle facete del Nuorese. Mentre lui era un gigante buono, Mangròfa non era gigantessa ma orca, e si cibava di carne umana (Francesco Enna, SS, 98). La sua fine violenta ha varie tradizioni, compresa quella che fu bruciata dai genitori dei ragazzi che divorava. Scrive Dolores Turchi4 che la sua dimora fosse una grotta presso la chiesa di santa Lucia a Oroséi, ma la sua personalità è raccontata in modo diverso secondo i paesi o l’informatore: quindi può essere pure sacerdotessa-maga.
L’etimologia, sempre che il nome attuale non si discosti in modo significativo da quello antico (a noi ignoto), porta alla agglutinazione sum. ma-ḫurum-bu, col tempo aggiustato in maḫ(u)rumbu e metatesizzato in manḫrubu > mangrofa: da ma ‘bruciare, arrostire’ + ḫurum ‘bimbo’ + bu ‘cavità’ = ‘(colei che) ‘arrostisce i bimbi nella grotta’. Si noti che questo è uno dei tanti lemmi creati esplicitamente in epoca medievale, in epoca bizantina, ed è testimone del fatto che ancora nei primi secoli cristiani in Sardegna si parlava semitico.
Mardi. Nel meridione s’intende con mardi la femmina del porco, il cui etimo è universalmente proposto dal lat. mater. Ma è molto strano che un animale così vilipeso in tutta la storia della letteratura abbia tale etimo. Quando non si è trovato di peggio, al momento della gravidanza il suo ventre è stato adattato pure al concetto dell’esecrando cavallo che sconfisse la civiltà dei Troiani: e la scrofa diviene troia, appunto. In realtà mardi, col significato attuale, è nato in epoca bizantina, quando il clero cristiano si dedicava con pertinacia ad estirpare l’antica religione. E così l’akk. wardu (leggi mardu) ‘ministro addetto al culto della divinità’ è diventato nientemeno che una ‘troia’.
Mincidissu camp. ‘demonio’. Questo lemma ha parecchie variabili: log. mintsídiu ‘provocazione, alterco, macchinazione’, mintsidiáre ‘provocare, attaccar brighe, seminar zizzanie’; camp. mincídiu ‘bugia’, mincidiόsu ‘bugiardo’, smincìri ‘sbugiardare’.
Secondo Wagner queste forme hanno base nel’it. omicidio, passato attraverso forme di antico sassarese (Stat.Sass. III, 33 (92 r): tu de menthis). Ma la proposta del Wagner non ha nessun puntello, essendoci una fortissima differenza semantica tra la supposta base ed i supposti derivati. Le forme qui trattate hanno invece la base in una incredibile metamorfosi semantica voluta dai preti bizantini nel primo Medioevo, allorché la polemica antiebraica, per iniziativa dei Padri della Chiesa e dei primi concilii, era divenuta parossistica. La forma di partenza è proprio il sardo minca, mìncia ‘membro virile’ (vedi), che si compose con la forma akk. deššû ‘eccessivamente opulento, dotato’, dīšu ‘sviluppo (del virgulto, della verga)’, dešû(m) ‘essere copiosamente dotato’, dēšû(m) ‘abbondante, fiorente’.
Ai preti cristiani della Sardegna non bastò quindi dissacrare la Minchà (lett. ‘offerta’: la preghiera ebraica del pomeriggio, che s’apre col Salmo 84 e prosegue con un lungo passo tratto dai Numeri 28, 1-8 che parla dei sacrifici quotidiani), facendone addirittura un cazzo; non bastò: si volle identificare la Minchà pure col Diavolo, e con blasfema doppiezza (riferita a un tempo al cazzo ed al Diavolo) si volle presentare la minchà come l’Essere infernale “molto grosso”, “fiorente”, “eretto” (dešû, dīšu) proprio come un cazzo.
Monteleone Rocca Dòria. È l’altura che un tempo fu la più munita della Sardegna. Lassù la Potenza divina discendeva al naturale, senza l’ausilio del genius loci. Lassù c’era la sede naturale del Dio-Toro, del Dio-Fecondatore, ossia ci risiedeva la Potenza che generava il Mondo. Quella rocca ebbe poi il nome dai Dòria che se n’erano impadroniti. Ma in origine fu Monte Leone (e conservava pure l’alternante epiteto di Perda e Tòri, preferita dal Fara). La confusione è evidente.
Cominciamo da Tori, ancora conservato in numerosi cognomi, quale Turi, Toro, Tore, Torre, Dettori. Il Taurum ‘Toro’ per i primitivi Romani era l’emblema dei ‘giuramenti d’amore’. Ma noi sappiamo che il nostro Tori deriva dal sum. tūr, akk. tūru ‘rifugio, protezione’. Quindi Perda e Tori = ‘Rupe della Protezione (divina)’. Quanto a Monte Leone, abbiamo la base akk. līʼum ‘toro’. E così torniamo al Toro, ch’era l’effige vivente del Dio della Natura, il Fecondatore sacro. Tra Leone e Toro, una delle due parole è paradossale. È chiaro che quel “leone” in Sardegna non ha nulla a che fare: i Sardi nei tempi primitivi non conoscevano i leoni. Monte Leone si riferiva certamente a un Toro, al Toro Protettivo (che veniva nominato līʼum in accadico e tūr in sumerico). Da qui il doppio nome Monte Leòne nonché Perda de Tori.
Moriscu (figu moriscu) ‘ficodindia’. In Sardegna c’è un concorrere di linguisti, a loro volta influenzati dai botanici, che sostengono l’origine del termine dalla Spagna, dove l’Opuntia ficus-indica è chiamata higuera de moro (cat. figuera de moro): Wagner DES 128.
Si sostiene che gli Spagnoli chiamarono in tal modo il fico d’India “perché importato dagli Arabi”. Ma tale diceria osta clamorosamente col fatto che gli Spagnoli sono gli scopritori dell’America, gli stessi importatori dell’Opuntia ficus-indica, ch’era espansa in tutta l’America centrale con focus negli altipiani messicani. Come mai avrebbero dovuto chiamarla “fico degli Arabi”, “fico dei Mori”?
Quello della higuera de moro è il più grossolano equivoco della storia della linguistica. Certamente è da pensare che questo fu uno dei primi frutti gustati dagli equipaggi, visto che la scoperta dell’America avvenne il 12 ottobre, quando ai Tropici il fico d’India contiene il massimo della polposità e, specialmente nei luoghi d’origine, si presenta nel massimo vigore.
Va fatta attenzione alla differenza tra higuera de moro / figuera de moro e il sardo figu morìsca. Per quale ragione i Sardi, che a quei tempi erano una colonia catalano-aragonese, avrebbero dovuto tradurre diversamente dai loro dominatori, inserendo quello strano suffisso -ìsca, e per giunta credendo che il prodotto provenisse… dagli Arabi?
Ecco come la paronomasia (o l’equivoco che dir si voglia) ha agito indisturbata sino ad oggi.
È a questo punto che occorre mettere in ballo gli equipaggi di Colombo, gente avvezza all’uso della propria lingua mediterranea. Essi sono la chiave di volta che fa capire l’equivoco. Ma da soli non basterebbero, se non entrassimo nell’ordine d’idee che gli stessi Sardi, e gli Spagnoli, specialmente i Catalani, avevano lingue col sottofondo semitico. In realtà moriscu è aggettivo sardo, che non significa ‘moresco’ ma ha base nell’akk. mūru(m) ‘giovane animale; giovane toro’ + išku ‘testicolo’, col significato di ‘testicolo di torello’. Fu la forma del frutto a colpire i Sardi. A sua volta, higuera de moro significò, per gli Aragonesi, ‘fico del torello’ (sempre riferito ai testicoli).
Perdigònes, -is log. e camp. m. pl. ‘pallini da caccia’ = sp. perdigones ‘granos de plomo para la escopeta’. Ovviamente il prototipo è sd. perda ‘pietra’ (< akk. paṭāru ‘tagliare, fare a pezzi’, ebr. pāṭar ‘to split’, akk. piṭru ‘pezzo’) + akk. gunnu ‘mass, bulk; massa, volume’. Quindi perdi-gònes è uno stato costrutto, col classico -ī- intermedio, e significò in origine ‘massa di pietruzze’. Chiaramente, la voce composta è riferita ai primi archibugi di fine ‘400, allorché s’inserivano delle pietruzze (graniglia marina o fluviale), mancando spesso la disponibilità dei pallini di piombo. Ciò che stupisce in questa etimologia è che persino agli albori del Rinascimento il popolo riusciva a formare in lingua accadica parole nominanti tecnologia avanzata.
Sirimágus. Il Monte Sirimágus fu ritenuto l’abitazione del Diavolo. Vietato portarci le greggi, andare a far legna, avviare coltivazioni. Sta al centro di un triangolo tabuico nell’area collinare tra Carbònia, Tratalìas e Perdáxius. Soltanto le pendici del Monte fanno eccezione, grazie alle sorgenti. L’area è meglio nota come Sa skìna de s’Ifférru ‘la schiena dell’Inferno’. Si dice però (ecco il fatto illuminante) che fino a circa 400 anni fa il Monte fosse meta di pellegrinaggi cristiani: ai canonici che ci avevano eretto una chiesa si portavano cibi e doni. Qualcosa andò storto, e la zona divenne off-limits. Sino a poco tempo fa, le vecchie dicevano che chi si avventurava rischiava di venire schiacciato da massi rotolanti.
La memoria della gestione pretesca delle processioni riguarda, a quanto pare, la volontà della Chiesa cattolica di controllare certe processioni paganeggianti. Che poi tale controllo sia cessato con l’avanzare dell’Inquisizione e della Controriforma, fu soltanto perché si preferì rendere maledetto il sito. Queste notizie, estrapolate da pag. 39 de L’Unione Sarda del 16 luglio 2006 (articolo di Andrea Scano), aprono uno squarcio sui processi di dominio della Chiesa, operati sino ad epoche recenti, considerate le varie tendenze paganeggianti ancora presenti nelle tradizioni popolari.
Il mistero di quelle processioni pagane e della loro logica intrinseca può essere chiarito soltanto con l’indagine etimologica, mediante la quale si capisce che Sirimágus è un composto sardiano con base nell’akk. ṣīru(m) ‘esaltato, supremo, splendido’ di un dìo + maḫû(m) ‘delirare, diventare frenetici’. Si capisce allora che il Dìo venerato sul Monte era il dio della Natura, destinatario delle processioni bacchiche e orgiastiche mirate alla rigenerazione.
Sixiliánu camp.; gigiliánu (Perdas); xixiniáu (Mogoro); sitziliánu (Villacidro) ‘granturco’. Qualcuno lo riferisce al ‘(grano) di Sicilia’. Ma viene ostico tentare di giustificare tali passaggi commerciali per un grano proveniente dalle Indie. Siamo dinanzi a una paronomasia.
Anche qui, come per cíxiri ‘cece’ (vedi), il primo concetto fu quello di ‘grano tondeggiante’ (rispetto alla forma del grano mediterraneo). Ma pare che abbia influito anche il sum. ḫili ‘luxuriant, lussureggiante’, opportunamente raddoppiato (ḫil-hili-ánu) per riferirsi alla grande produttività di una pannocchia rispetto alla spiga del grano.
Il nome di questo moderno tipo di grano è una delle tante prove del fatto che ancora nell’arco del XVII secolo il popolo sardo utilizzava con naturalezza le radici della propria Urspache, che ancora comprendeva appieno quale eredità di un arcaico passato in cui la parola era analizzata a tutto tondo, nella sua forma e nel suo significato. Vedi anche l’altra forma trigu muriscu.
Wagner evita di produrre etimologie. Con riguardo al paragrafo precedente, sento che qualche linguista insorgerà invocando prudenza e ponderatezza. Queste virtù sarebbero i metri di un meritorio atteggiamento obiettivo, se fossero espresse da uno che le esercita nell’affrontare i problemi più scottanti. Ma, diciamolo serenamente, sono virtù spesso conclamate, che suonano sarcastiche quando s’invocano da chi sinora ha fatto esercizio d’immobilità senza dare alla linguistica sarda contributi solidi.
Non disconosco a certi filologi romanzi il prezioso impegno da loro profuso nella studio della lingua sarda, ed è proprio perché sono pronto a riconoscere apertamente i loro meriti che chiedo il corrispettivo del perdono quando la mia franchezza rischia di ferirli. Mi manca l’intenzione. Ferire non è mai stata la mia vocazione, anzi preferirei che le mie constatazioni fossero sempre accettate per amichevoli e concilianti, quando non soffuse d’entusiasmo. Infatti a me interessa unire, non profligare. Ma quà entra in campo la serietà scientifica, una severa maestra di disciplina che non posso celare dietro il velo della timidezza o dell’ipocrisia, a meno che non voglia dichiarare falsa la mia metodologia.
Occorre rivelare un fatto sconcertante, che è persino difficile da fare accettare, ed è che Wagner ha sempre evitato d’impegnarsi nelle etimologie. Parimenti accade a molti linguisti che avrebbero dovuto esserne gli eredi. Detta così, anche quest’affermazione sembra una clamorosa boutade espressa per suscitare nuovo sconcerto e discordie. Ma io, essendo uno studioso della lingua sarda, mi sento fortemente coinvolto nella ricerca della verità, e pertanto sono obbligato a proporre un metodo che rimetta saldamente in piedi ogni tipo di studio sulla lingua. Il DES, capolavoro riconosciuto del genio wagneriano, non individua nemmeno una etimologia. Ho cominciato a spiegarlo nei paragrafi precedenti, sto per spiegarlo in questo paragrafo, proseguirò in quelli seguenti. Se il lettore leggerà coscenziosamente, capirà la verità della mia proposizione. Vediamo all’uopo (tra le migliaia) qualche lemma trattato dal Wagner.
Gammurra camp. antiq. ‘specie di panno: gamurra’ (Porru) = it. antiq. gam(m)urra ‘veste antica di donna, gonnella’. Base etimologica è l’akk. ḫammû (a garment, un vestito) + ūru ‘city’ < sum. Il composto ḫamm-ūru significò ‘vestito da città’ (ossia vestito di buona fattura). Wagner (cfr. voce nel DES) non ha prodotto alcun etimo.
Gana log. e camp. ‘voglia, desiderio, appetito’ = sp. gana; mala gana ‘svogliatezza’. Base etimologica è il sum. gana ‘shackles, ceppi, impedimenti’. Evidentemente il concetto di ‘voglia’ si è evoluto da un significato arcaico che privilegiava l’atto del trattenere, inceppare. Questo vocabolo è un chiaro testimonio di come le idee abbiano acquisito il senso astratto partendo da un fatto concreto. Wagner propone surrettiziamente l’origine spagnola del vocabolo sardo ma non produce alcun etimo, dispensandoci dall’esigenza d’indagare almeno il vocabolo spagnolo. Invero, gana è voce mediterranea.
Grori, groli (Bitti) ‘avannotto di trota’. Base etimologica è il sum. giru ‘fish, pesce’ (da cui it. gir-ino ‘piccolo pesce’) + uri ‘fish, pesce’. Il composto pleonastico (duplicazione semantica) gir-uri in origine ebbe significato moltiplicativo, e nel contempo diminutivo. Wagner considera il vocabolo “probm. preromano”: un’ipotesi gettata così, con nonchalance, tanto per chiudere il discorso senza indagine.
A sa muda log. ‘zitto, in silenzio’; sd. mudu ‘muto’; cfr. lat. mūtus ‘che non ha le capacità fisiche di parlare’. La voce latina fu usata dapprima per gli animali (mutae pecudes), interpretate dal DELI nel senso che «non sanno fare altro che mu». Interpretazione assurda, ovviamente, poiché il mu è solamente tipico del bove. A nessuno venne in mente che anche i saggi preferiscono star zitti. Infatti il sd. istare assa muda significò sin dalle origini ‘stare come il saggio’, da akk. mūdu ‘saggio, sapiente, esperto’.
Pèsame, -i log. e camp.; pèsamu log. ‘condoglianza’; donai su pèsame camp. ‘condolersi’ = sp. pésame, dar el pésame. Cfr. sic. pèsami, pèsamu ‘idem’ (Traina); nap. ant. pésame ‘idem’. Base etimologica è il sum. peš ‘to disappear, scomparire’ + ama’era ‘mourner, parente del defunto’ (composto da ama ‘mother’ + er ‘mourning, essere in lutto’). Wagner tace, soddisfatto nella convinzione che il vocabolo sardo derivi dalla Spagna. Ma il vocabolo è mediterraneo.
Tricca (Nuoro, Fonni); triga (Norbello, Aritzo); trija log. ‘pergola e uva galletta’ (Stat. Sass. I, 128 (42v): pastinare tricla et simiçante uva); trigarzu, trijarzu ‘pergolato’. Base etimologica è l’akk. tīru (a covering) + suffisso mediterraneo -ca. Wagner sull’etimo tace.
Gli equivoci e le paronomasie. O tace, o cade nell’equivoco. Ed anche quando s’accorge dell’equivoco, Wagner purtroppo non lo risolve scientificamente (rinvio, come esempio, alla voce kenábura, già trattata).
Le lingue sono zeppe di equivoci, e la Sardegna non è immune. Essi sortiscono spesso nell’intimo di una singola lingua (o dialetto), ed ovviamente tendono a moltiplicarsi nel confronto tra lingue o dialetti. Così avviene in Sardegna, dove il sintagma camp. Toccamì ainnantis ‘cammina davanti a me’, in log. può essere inteso come ‘tòccami davanti, nelle parti anteriori del corpo’.
In Italia ha preso vigore da molto tempo il sintagma “fare repulisti” nel senso di ‘fare pulizia’ (reale o morale). Evidentemente l’espressione fu inventata da qualche giullare o studente medievale ed il volgo, ignorando il latino, non poteva sapere che quel buontempone aveva stravolto semanticamente il perfetto lat. repulisti ‘respingesti’ (vedi il salmo 44 (43),10: Nunc autem reppulisti et confudisti nos ‘ma ora ci hai respinti e coperti di vergogna’).
Wagner nelle sue opere non trascurò di annotare qualche equivoco, ad esempio citò l’uso del vocabolo centro-merid. suppa ‘niente’: Kirco e non b’agatto suppa; Non ni budìa fai suppa. Egli, più divertito che scientificamente coinvolto, nel DES riproduce la seguente situazione: «rientra nell’inventario dell’italiano maccheronico la frase, riferita al figlio: Non ne posso fare zuppa: è morto bicchierino = ‘non posso cavarne nulla: è molto birichino’». Wagner non s’accorse che quella frase maccheronica sguazzava nella paronomasia. Egli dichiarò ignoto l’etimo del sd. suppa, mentr’esso ha base nell’ass. ṣuppu ‘decorato, rivestito, ricoperto, placcato’, šūpû ‘rendere splendente, visibile’, col significato riferito semanticamente al risultato dell’abbellimento di un corpo bruto, una trasformazione da oreficeria, una decorazione che migliora fortemente lo stato grezzo.
La paronomasia è una legge linguistica, come tale subita passivamente dal parlante; salvo nei casi di umorismo, dove un comico produce la risata attivando l’opposizione dei significati tramite lo slittamento, il doppio senso, la polisemia, l’equivoco tra due identiche formule fonetiche (v. cap. 1.3 della mia Grammatica Storica).
La paronomasia (quindi la conseguente paretimologia) scaturisce ad esempio dal log. janna a bòi ‘porta con i battenti accostati per bloccare e filtrare la luce’, intesa dal Wagner come ‘porta a bue’, mentre la base etimologica è l’akk. apu ‘foro, apertura’; abû, apû ‘velato’ < abû, apû ‘diventare velato, nuvoloso’.
Altro esempio di paronomasia è il camp. arròsa ‘morbillo’, che i ricercatori derivano dal nome di fiore rosa, mentre la base è l’akk. rūšum ‘rossore’.
Altro esempio sono le locuzioni andare esse per essi ‘andare girovagando senza meta’; a pili esse ‘coi capelli scomposti’; craba corressa ‘capra con le corna reciprocamente sghembe’; asse’ tuttu a esse ‘essere smidollato, sbilanciato, sciancato’ (Sassari); barrócciu a esse ‘carro sgangherato’ (Sassari); occi a esse ‘con gli occhi storti’ (Sassari). Wagner, incappando nella paronomasia, ritiene che essi, esse sia un termine video-fono-semantico, dalla lettera S. Invece la base è l’akk. ešeum, ešû(m), ašu, išû ‘confuso, aggrovigliato, arruffato’ di filo, capelli, barba, mente, occhi.
Nella paronomasia s’incappa spesso indagando i toponimi, è ovvio. Ad esempio Pedru surdu, interpretato come ‘Pietro il sordo’, è il nome di un’alta sella rocciosa e selvaggia, improduttiva, vicina alla vetta del Gennargentu, sepolta per quattro mesi dalla neve, dove i pastori s’astennero dal salire, lasciandola alla vocazione selvaggia, a dimora dei mufloni e delle aquile, che sono i veri signori della montagna. Il nome ha base nell’akk. pitru(m) ‘territorio selvaggio’ + surdû ‘falco’ = ‘selvaggio sito di falchi’.
Purtroppo debbo constatare che ai filologi non è bastato impaniarsi nella paronomasia; alcuni sono andati oltre, giungendo a distruggere qualche parola sarda. Lo scempio è stato persino facile, quando il filologo era un ignaro straniero; ma l’effetto non è stato diverso quando alla distruzione hanno contribuito dei filologi sardi. La filologia esercitata sulla lingua parlata non s’addice a dei lavoratori-a-tavolino, a gente che non ha mai vissuto col popolo, nei villaggi, e non ha mai ascoltato l’intenso palpito del linguaggio. Lo scempio è avvenuto come in una commedia degli equivoci, illuminata da un “ipse dixit”, da un moloch di provenienza oltremarina, dinanzi al quale non solo il popolo ma persino i “dotti” paesani, i “dotti” cittadini, per quanto indigeni, hanno flesso la schiena in nome dell’autorità. E così nei dizionari sardi non si trova tadannu! ma ita-dannu!, interpretato ‘quale danno!’. Io, che sono glottologo, che vivo nel popolo e col popolo campidanese da 54 anni, non ho mai sentito ita-dannu ma soltanto tadannu! Quei linguisti, quei dotti, non avrebbero mai osato violentare la lingua sarda, se avessero saputo che l’invocazione di paura Tadannu! non è altro che l’invocazione akk. dandannu ‘Dio Onnipotente!’.
Nello scempio delle parole sarde ritrovo anche l’eponimo Sardus Pater. In questo caso la responsabilità maggiore va agli archeologi. Per la verità Giovanni Ugas (Shardana e Sardegna) ha cominciato a raddrizzare la questione, parlando autorevolmente di un dio eponimo. Però dico che non gli sarebbe stato eccessivo andare oltre invocando una sensata etimologia a supporto di questa intuizione. La dedica Sardus Pater Babay fu gestita dai Romani senza sapere ch’era sumerica. L’architetto di Antas non riusciva a comprendere il significato sardiano, che oggi può tornare finalmente in auge partendo dal sardiano Babay, che ancora nel sd. attuale si pronuncia babbáy, babbu ‘babbo, padre, Padreterno’, con tutte le conseguenze del caso. Va osservato che Babay o Baba fu una grande divinità femminile sumerica, da babaya ‘old man’ (il vocabolo era originariamente maschile, e tale rimase in Sardegna; soltanto dopo, e soltanto in Mesopotamia, esso fu proposto al femminile per la trasposizione al femminile del culto di Baba). E così in suolo sardo ancora una volta sveliamo le radici arcaiche della lingua sumerica. In Sardegna in origine questi vocaboli dovevano essere composti nella sequenza Šar Dū Padr Babay, col significato di ‘Terribile Signore Creatore dell’Universo’ (Šar ‘totalità, mondo’ + dū ‘Creatore’ + Padr ‘distruttore’ + Babay ‘Signore, Kýrios’).
Lo stesso epiteto, evidentemente corrotto dall’intervento del clero bizantino, ritroviamo nel Monte Santu Padre, una montagna visibile da mezza isola, il cui nome desta immediato sospetto perché in Sardegna dovrebbe dirsi Monte Babbu Santu (padre non esiste). L’epiteto è una paronomasia: in origine doveva essere Monte Sardu Padr. La dedica corrotta del tempio di Antas, il nome corrotto di questa montagna, sono prove concorrenti a dimostrare che Sardu è l’arcaico Dio eponimo dei Sardi. Insomma, questa figura sacra era lo Jupiter sardo.
Ma torniamo a suppa, che fece ridere Wagner. Non so s’egli abbia riso anche nel voler tradurre pilu e titta ‘mastite’ come ‘pelo nella mammella’. Non c’è nessuno che abbia inteso diversamente questo malanno, nemmeno il medico che affrontò scientificamente questo sintagma, S.A. Zonchello (v. Bibliografia). Nessuno potè accorgersi che la base stava nell’akk. pīlu, pēlu ‘calcare, pietra calcarea, blocco di calcare’ + ‘nutrimento, cibo’ (tîtum): pertanto pilu e titta, da almeno 5000 anni, significa ‘pietra della mammella’.
Adesso ci tocca sostare su log. pazza, ‘idea presumida ki unu tenet de iss’etotu, comente canḍo si daet bàntidos kentza méritu’ (Puddu); palla camp.; páglia sass. Questo vocabolo è stato compreso da Wagner come ‘bugia’, ma non è così. Esso si applica ai presuntuosi che si esibiscono, si sovraespongono, fanno spacconate, millantano: pazzósu, pallósu, paggiósu, palléri. Sarebbe una contraddictio in terminis assumere a base di questa voce proprio la paglia, una sostanza umilissima. Va da sé che ci troviamo dinanzi a una paronomasia, e di palla, pazza si sono ignorate le origini. Base etimologica è il sum. pala ‘a royal garment, un vestito da re’. La plurimillenaria parola rimane quindi viva per indicare chi vuole assumere vesti regali anche quando è un pollo da batteria. In collegamento c’è il log. ispazzare ‘millantarsi’; cfr. nap. paliúsǝ ‘vanitoso’; pagghiuse ‘fanfarone, millantatore’. È fuorviante che Wagner inglobi in questo lemma l’it. battere la paglia ‘vagare col discorso’, ted. leeres Stroh dreschen ‘batter la paglia senza ricavo, fare discorsi a vanvera’. Infatti il sintagma del Wagner è autodimostrativo: nel senso che non si ricava nulla dal battere la paglia, come non si ricava nulla dal battere l’acqua: sono follie di gente che ignora il valore del tempo e fa perdere tempo agli altri. Dobbiamo ammettere che i campi semantici del vanitoso e di colui che fa discorsi a vanvera sono radicalmente diversi.
Penultima voce da me proposta è pittiracca log. sett. ‘viottolo incastrato, incassato, ossia scavato nella roccia o nelle alluvioni’. Secondo Wagner, la voce «si spiegherebbe bene come pettúri + acca ‘petto di vacca’ (indicando un viottolo talmente stretto che ci passa solo il petto di una vacca)». Ma questa è una puerile contraddizione, non tiene conto che lo scavo delle strade (tali erano i viottoli nell’antichità) richiedeva grande impiego di braccia e perenne manutenzione; quindi nessuno si sarebbe sognato di realizzare vie così anguste e inutili. I viottoli furono sempre realizzati a misura del carro tirato da 2 buoi, larghi almeno 3-4 metri. Invero, la base etimologica è l’akk. petû(m) ‘aprire + raqqum ‘thin, fine; sottile’. Il composto significò ‘scavo angusto’, ma ciò non giustifica l’interpretazione del Wagner in relazione ai viottoli (evidentemente la definizione nacque per altri scopi). Tantomeno aiuta quando l’insigne studioso intende rafforzare la sua interpretazione con la locuzione sa janna est a unu bòe ‘la porta ha i battenti socchiusi’ (dov’egli intende bòe come bue, annotando che janna a bòi «si dice di una porta socchiusa, che lascia passare un solo bue» (sic!). Egli non si è reso conto che un solo bue nelle porte contadine non riusciva nemmeno a infilarsi, o le infilava danneggiandole, anche se spalancate. La base del sintagma a bòi è stata già spiegata.
Valverde. Ecco una delle più assurde paronomasie della Sardegna, talmente espansa e corruttiva, da avere infestato pressoché l’isola intera. È doloroso che nessun filologo se ne sia accorto. Cominciamo dalla dorgalese (Nostra Sennora de) Balu Irde o Palu Irde. Quel Valverde, tipico delle più antiche chiese campestri dove si adora una Madonna cristiana sconosciuta fuori dell’isola, non è altro che la paronomasia di Ba‛al Irdu (akk. Bēlu Irdu, Bēlu Išdu), epiteto sacro col significato di ‘Signore Base-del-Cielo’, ‘Ba‛al Base-del-Cielo’. Ba‛al è attestato in Sardegna e in tutto il Vicino Oriente: in arabo, ugaritico, fenicio, punico, aramaico, nabateo, palmireno, amorrita, babilonese, accadico. In ug. fa bʽl ‘signore, proprietario’, amorr. baʽlum, bab. ba’lu ‘grande, maggiore’, akk. bēlu ‘signore, proprietario’, e così via.
Questo dio, particolarmente onorato in Cartagine dal V sec. a.e.v. assieme alla compagna Tanit, fu onorato in Sardegna allo stesso modo. Onde il suo nome è sotteso a tutti i toponimi o nomi sacri echeggiati in Sardegna col nome Palu o simili. Furono talmente importanti le onoranze a Ba‛al, che la Sardegna ha lasciato in suo onore persino dei cognomi: anzitutto Palùma, Palùmu, Palomba (quest’ultimo storpiato e indirizzato alla semantica di ‘colomba’). La loro base etimologica è l’akk. palûm ‘bastone, phallos, palo sacro’ (riferito a Ba‛al “Fecondatore”) + ūmu ‘giorno’, significando ‘Giorno del Palo’, ‘Festa del Palo’. Ricordo ad es. Su Palu di Santu Lussùrzu, celebrato al colmo del Carnevale. Vedi anche i cognomi Pala, Palitta, Paliotta (gli ultimi due significano ‘Seguace di Ba‛al’), Palimoḍḍe (epiteto = ‘Saggezza di Ba‛al’). Vedi inoltre i vari toponimi rimasti in Sardegna: Balláo, Paláu, Baláy, Punta Palái, etc.
Onomatopee. Spero si sia capito che in questo lavoro non ho avuto mai intenzione di sminuire il prestigio universale che Wagner si è meritato nell’indagare con dedizione ineguagliata la lingua sarda. Prima di lui nessuno lo aveva fatto, mentre agli studiosi posteriori non venne alcun uzzolo di cimentarsi perché ai loro occhi il monumento eretto da Wagner era compiuto e perfetto, e sembrò sciocco smantellarlo per ricostruirlo su altre basi. Anche da me la statua del Wagner fu sempre considerata come perfetta. Ciò per 31 anni dopo la mia laurea in glottologia. Mi si perdonerà se da soli 15 anni sto tentando di delineare una nuova via d’interpretazione della linguistica sarda. Dal mio punto di vista, lungi dal voler dissacrare il pater noster, ogni mia osservazione rivolta al pater non è altro che un fraterno memento rivolto ad filios. Sono i ricercatori posteriori, quelli già morti e quelli viventi, a non aver capito che i tempi stavano maturando verso orizzonti più scientifici. Quanto ai ricercatori ancora viventi, vorrei comunicargli che il più grande omaggio che possiamo fare al grande Wagner è di rimetterci a studiarlo con la prospettiva di rinnovare almeno l’intonaco della sua grandiosa piramide.
Se è vero – come sto dimostrando per tutta questa premessa metodologica – che a Wagner difettava il metodo e, come corollario, ch’egli non trovò mai il modo di approfondire le etimologie, allora corre l’obbligo di perseverare nella dimostrazione affinché i posteri capiscano. In questo paragrafo mi soffermo sull’onomatopea, da Wagner pretesa per almeno il 20% dei suoi lemmi. Con tutta evidenza, egli propose un numero altissimo di onomatopee tanto per chiudere la discussione, trovandosi nell’impossibilità di proporre l’alternativa di un etimo credibile. Vediamo gli esempi.
Per Wagner è onomatopea il log. e camp. racca ‘rantolo del moribondo’, mentre la base etimologica è il sum. raḫ ‘disease’, ‘to beat, kill; battere, uccidere’. Altra pretesa onomatopea è tzoccare ‘battere’; tzoccu ‘scoppio’. Noto intanto l’affinità fono-semantica con l’it. ‘toccare (delle campane etc.)’. Su tzoccu o toccu (cfr. it. tocco) indica una gamma di suoni od azioni: il tocco della campana, il tocco o tatto. Base etimologica il sum. tuku ‘to beat, battere, dare un colpo’.
Affine a tzoccare è tzaccare, tzaccái log. e camp. ‘fendere, spaccare, scoppiare, crepitare, crepare’ e per estensione ‘screpolare’ e simili; tzaccadùra ‘fessura, scoppio, crepitio’ ma anche ‘ragade della cute o dei capezzoli’. Wagner, seguito dai ricercatori seriori (Zonchello e altri) ritiene che la voce sia rigorosamente onomatopeica. Invece ha base nell’ass.-bab. ṭaḫadu(m) ‘fiorire, sbocciare, divenir lussureggiante’, anche ‘scoppio, esplosione, rottura’; ‘spaccare, cedere’ (riferito specialmente al foruncolo)’.
La quintessenza della (falsa) onomatopea, contaminata dalla pregiudiziale latina, si percepisce nel sd. páperos (donnos páperos). Nel medioevo sono i ‘vassalli’ del giudice o i ‘membri della famiglia reale’ (e genericamente il ‘patrimonio della corona’). Una sola volta nei codici si legge pauperos, ed ecco affiorare la precoce confusione che già ne stava tarlando la semantica. Tale confusione entrò anche in un documento cagliaritano del 1119 (CDS I, p. 198b), che in latino scrive: servos de pauperum. Questa parola s’incontra solo in documenti del sec. XI o dei primi del XII (Bonazzi, ed. CSP, p. 156). I donnos paperos ricordati dal CSP 34 sono precisamente i monaci di S. Pietro (pag. 58 dell’estratto). Ma ecco il tarlo del diavolo!: Wagner non capì che in tutta questa situazione si era insinuata la confusione, ed imprudentemente scrisse una ovvietà, ossia che la voce pauperes indica in numerosi documenti i poveri ed i degenti (CDS, p. 226b, anno 1164): ad sustentationem pauperum; ibd p. 244a (sec. XII): sa eclethia paupera; p. 251a, 252b (anno 1182): ab alimentis istorum pauperum (Solmi, Cost., p. 47, n. 4).
Però Wagner percepiva che qualcosa non combaciava, quindi il termine páperu applicato ai ricchi del Giudicato continuò a sembrargli strano. A noi sembra persino più strano che un linguista della sua levatura si lasciasse intrappolare da una banalissima somiglianza di vocaboli: le somiglianze fonetiche sono normali in qualsiasi vocabolario. Egli non si scosse nemmeno al sapere dai giuristi delle materie medievali che a quei tempi tre classi sociali si contrapponevano ai ricchi (ai majorales): i servos, i liberos, i pauperos (ma non i paperos!). Egli si chiedeva disperato «In séguito a quali circostanze i liberos si identificarono con i pauperos?». Lo stesso equivoco-confusione persiste ancora oggi tra gli aggettivali pauperile e paberile (quest’ultimo interpretato oramai (e ci mancava!… dopo il tarlo del diavolo!) come “terreno proprio dei pauperes, da loro posseduto a titolo collettivo”: «Erano precisamente i terreni che si chiamavano anche terras de páperos» (Wagner). Assurdo. Queste confusioni inqualificabili gravano sugli studiosi contemporanei come un macigno, e nessuno si scuote nel constatare che in sardo moderno l’aggettivale paborile, paberile significa semplicemente ‘pascolo, maggese’, e che soltanto qualcuno (es. Guarnerio, Solmi) lo identifica col lat. pabŭlum (sbagliando però anch’essi).
Invero, su paberìle era la terra coltivabile di un villaggio: era il vidatzone messo a riposo annuale o biennale (maggese), e diventata prato domestico (che è diverso dal pardo naturale) a disposizione, in comunione gratuita, degli abitanti ad uso pascolivo. Si trattava di campi non riseminati, dove si poteva pasturare il bestiame controllato da speciali incaricati (i maiores de pradu o pradàrgios). Questi diritti reali pubblici assunti per consuetudine si chiamarono, in epoca iberica del Regno di Sardegna, ademprìvi, e furono aboliti in epoca sabauda con la legge sulle chiudende.
Quando si dice incantesimo… Tornando al pl. páperos, Wagner s’impuntò a tal punto sulla identità di sd. páperu con lat. pauper ‘povero’, che chiuse tre lunghissime pagine di disamina del problema con una dichiarazione ultra-salomonica, giungendo a squartare con una sciabolata il bimbo che Salomone aveva solo minacciato: «Come già fu detto, l’accezione giuridica di páperu si è perduta, ma nel senso ordinario di ‘povero’ la voce vive tuttora nel camp. rustico come pábaru, páburu. È diventata ormai rara, ma l’abbiamo notata a Cabras; e cinquant’anni fa, l’abbiamo sentita giornalmente da un povero cieco, nativo del Campidano di Oristano, il quale, sulle Scalette di Santa Chiara a Cagliari, mi soleva chiedere l’elemosina con la sua cantilena monotona, ma molto chiara: Po s’amòri de Déusu, sa garidari po unu báburu tsurpu». Questo è il livello infimo al quale non avremmo mai voluto che Wagner scendesse.
Al fine di rompere l’incantesimo di tale immarcescibile equivoco-confusione, dichiaro che l’aggettivale paberìle, poborìle, paborìle ha base etimologica nel sum. pa ‘fronda’ + be ‘tagliare’ + ri ‘camminare lungo (pascolare)’ + li ‘fronda, germoglio’: pa-be-ri-li. Il significato originario fu ‘pascolo per brucare i germogli’. Tutto qui. Gli armenti del villaggio avevano un anno di tempo per brucare i germogli di quei terreni, sortiti dai semi delle coltivazioni dell’anno precedente (grano, ortaggi). Quello del paberìli era dunque un pascolo speciale, molto diverso da quello del saltu, sartu (vedi), quest’ultimo composto di flora selvatica meno appetita dalle pecore: infatti a su sartu si mandavano soltanto capre, maiali, bovini, che si consolavano con le frasche della macchia e con le fronde degli alberi.
Quanto all’etimologia di (donnos) páperos, essa si basa sul sum. pap ‘primo e più importante’, ‘preminente’ + era ‘leader (dell’assemblea)’: pap-era. Il significato è ovvio: gli antichi “nobili” erano chiamati páperos né più né meno come i pennuti che avanzano sicuri, dondolanti, pettoruti e schiamazzanti. Anche Wagner l’avrebbe capito, se non si fosse incagliato sulla pregiudiziale latina. Mentre DELI e la stessa Treccani considerano papero, papera di origini onomatopeiche (sic!).
Voci imitative, formazioni scherzose. Indubbiamente, Wagner appare poco credibile nell’aver disseminato il suo DES d’inesistenti “onomatopee”, anche quando, cambiando il vocabolo, decise di nominare le presunte onomatopee come “voci imitative”, oppure come “formazioni scherzose”, o “formazioni infantili”. Si segua il grande groviglio di lemmi accorpati dal Wagner sotto il seguente vocabolo.
Accuccaresì log. accuccaisì camp., accuccassi sass. ‘accoccolarsi, accovacciarsi’; ‘appiattarsi, nascondersi’. Secondo Wagner queste sono voci fonosimboliche, e porta l’esempio dell’it. accoccolare, sic. ncuculari, sp. acucularse, astur. encucase. Wagner reca molti altri esempi, tentando una catalogazione che però diviene un guazzabuglio, dov’egli propende per considerare tutta la folla di questi lemmi sardo-italo-iberici come onomatopee (DES 49-50). Mi rincresce constatare che Wagner, qua e là, dà poca importanza alla legge della polisemia. Ora ne avremo un saggio.
Considerando il significato di accuccaresì come ‘appiattarsi, nascondersi’, la base etimologica è il sum. kukku ‘buio, tenebre’, ciò che consente l’azione della civetta (Athena noctua), in sd. detta cuccu, che s’aquatta nel buio e poi aggredisce repentinamente; vedi akk. ḫua ‘civetta’, da cui sd. a cùa ‘al modo della civetta, nascostamente’.
Considerando invece il significato di accuccaresì come ‘accoccolarsi, accovacciarsi’ (detto anche dei cani che si rannicchiano ai piedi del padrone o che si sottomettono al cane più forte), entra in campo l’akk. akû ‘weak, powerless, humble; debole, senza potere, umile’, ripetuta per potenziarla (akû-aku-), e si riferisce ai gesti rituali che gli antichi accattoni, o prigionieri, o bisognosi, facevano in atto di sottomissione chiedendo protezione.
Questo discorso relativo all’it. accoccolarsi è talmente serio e imponente, che corre l’obbligo di soffermarsi a dipanare il grande groviglio culturale creato dal suo uso. Infatti ci sono varie parole con fonetica simile che han fatto delirare (letteralmente: uscir dal solco) il fior fiore degli etimologisti.
E allora comincio dall’it. còccola, il ‘frutto del ginepro’. DELI ne registra la prima apparizione nel sec. XIV: la voce avrebbe l’etimo nel lat. cŏccu(m) ‘nocciolo dei frutti’. Ma ciò è assurdo, ed è in compagnia con altri etimi assurdi apparecchiati per gli altri lemmi affini, quali coccolàre, cocco (uovo di gallina), còccolo (bambino paffuto, bambino prediletto), il cognome sardo Coccolòne, e così via. In questo guazzabuglio occorre mettere ordine, poiché ogni termine ha una precisa e distinta etimologia, radicalmente diversa da quelle proposte.
Iniziando da còccola, il lemma non ha affatto l’etimo su citato, anche perché la còccola non è un nòcciolo, ossia non ha un guscio duro come quello della noce, ma è uno dei tanti frutti morbidi. Questo frutto viene usato moltissimo dagli uccellatori in Sardegna (si può immaginare che nei tempi andati fosse d’uso comune nel Mediterraneo) per attirare e catturare al laccio gli uccelli da passo. Còccola ha base etimologica nel sum. ḫu ‘bird’ + kul ‘meal’, col significato di ‘cibo degli uccelli’.
Analizziamo adesso l’it. coccolare ‘vezzeggiare’, ritenuto dal DELI voce infantile da confrontare con cocco ‘uovo di gallina’, considerato onomatopea da confrontare con coccodè (sic!). A fronte dell’inadeguatezza delle etimologie proposte, preciso che coccolare si basa sull’akk. kukku(m) ‘(un genere di) dolce’ + ul ‘frutto’, col significato di ‘frutto-dolce’, ovvero ul ‘qualsiasi cosa’, col significato di ‘qualcosa di dolce’; ma può andar bene anche ul ‘gonfiarsi, ingrossarsi’ (riferito in questo caso ai bimbi paffuti), col significato originario di còccolo come ‘dolce polposo’.
Cocco in quanto ‘uovo di gallina’ è considerato onomatopea, imitazione del coccodè emesso dalla gallina quando sta per espellere l’uovo (sic). Ma un suono con la sequela di fonemi c-o, c-o, d-e non viene mai emesso dalla gallina, e nemmeno viene emesso il più semplice c-o, c-o, trattandosi invece di un rumore indistinto emesso dalla strozza a causa dei dolori dello sfintere. L’uovo fu chiamato cocco dall’akk. kukku(m) ‘dolce’, poiché di esso la gente è sempre stata ghiotta; e coccodè (che indica propriamente la ‘gallina’, anziché il suo verso) non è termine onomatopeico, non corrisponde ad alcun rumore, ma è l’esito dell’akk. kukku + sum. de ‘versare, emettere’, come dire, ‘emettitrice di dolci’. Ma tanto per attenerci unicamente alla lingua sumerica, possiamo proporre per la ‘gallina’ anche la seguente etimologia: kuĝ ‘scala a pioli’ + deg ‘radunarsi su’ (kuĝ-deg > kug[u]-deg > kugudè), col significato di ‘(colei che) si raduna sulla scala a pioli’: è infatti nota la tendenza della gallina a dormire di preferenza sulle scale a pioli, in difetto a dormire sugli alberi, che raggiunge svolazzando goffamente: tutto ciò per sfuggire alle volpi.
Quanto al cognome sardo Coccolòne, Coccollòne, preciso intanto che non è italiano, come vorrebbe Pittau DCS 223, poiché non è recepito dal De Felice; circa l’etimologia, essa non si basa sul fatto che il coccolone “ama farsi coccolare” (Pittau), ma si basa integralmente sull’accadico, essendo un raddoppiamento fonetico di ḫullu(m) ‘collana (in quanto ornamento)’, quindi ḫu-ḫullu + suffisso sardiano -ne (ḫu-ḫullu-ne), col significato di ‘(colui, colei che) si impreziosisce con le collane’: riferito a chi si agghinda per le feste, o riferito alle prostitute sacre ed ai prostituti sacri.
Di seguito propongo altre etimologie relative a voci che escono dal groviglio appena discusso.
Pimpirínu nelle frasi a pimpirínu (Fonni); assu pimpiríu (Milis); appimpirinare, -ádu log. sett. (Casu); a pirpirínu o a pirpirináos (Nuoro); apirpirináu (Dorgali): apprippieḍḍádu (Desulo); istare appispirináu (Orani); istare assa pispirináta (Siniscola); a pispirinádu (Macomer); a culispíspiri (Bitti); a culispíspidi (Nule); appippirináu (Norbello); a pippiniáu (Mogoro); a bibbirínos, a bibbirináu (Baunei, Busachi, Tonara, Belvì, Laconi); abribiḍḍáu (Tortolì); istáe a sa rbibiḍḍincáda (Villagrande); a culimpípiri log. gen.; a curimpíparu sass. ‘accoccolarsi, accolato alla beduina’. Per Wagner queste sono formazioni infantili e scherzose. Ma egli non può sentirsi autorizzato a classificare a modo proprio tutto ciò che non comprende! Invero, la base etimologica è il bab. parû ‘to excrete, defecare, cagare’. Da cui si evince che in Sardegna il prototipo fu la forma sassarese, ovviamente reduplicata per esigenze icastiche con le formalità dello stato costrutto (dove la -a- intermedia diviene -ī-), onde culu in pī-paru ‘culo nella posa di defecare’.
Altro esempio: straùllu ‘grido, urlo emesso per spaventare, chiasso sconvolgente’, deverbale di straullái ‘strillare, urlare, far chiasso’, che deriverebbe dal corrispondente it. strillare. Gli etimologisti non hanno ancora trovato accordo sull’etimo dell’it. strillare, e comunque è azzardato accostargli il sd. straùllu. Per Wagner quella sarda è “voce imitativa”, ma non spiega che cosa ci sia di “imitativo” tra il vocabolo e la voce scomposta di chi urla (la quale, fonicamente, è nient’altro che un iii!!!, aaa!!!). Invero, la base etimologica di straùllu è il sum. tar ‘to cut down, abbattere, tagliare’ + uli ‘lamentation’. Il composto tar-uli, reso icastico dall’accrescitivo s- e sottoposto a metatesi (s-tra-uli), in origine indicò un lamento straziante (lacerante, dirompente)’.
Zariθθu, giaríθθu «si chiama nella Barbagia una specie di ritornello bizzarro che accompagna la chiusura di certe canzoni e che difatti rassomiglia al nitrito del cavallo» (così Wagner). Ma si osservi il collaterale verbo zarridare (Nuoro, Orgosolo, Mamoiada, Orani); giarraspidare (Oliena); garrizzare (Gavoi) ‘nitrire’. Base etimologica è il sum. zara ‘concern, preoccupazione’. Ma può essere anche il sum. zaraḫ ‘wailing, lamentation’. A proposito del ‘ritornello’ su citato, G.M. Cabras (Vocaboláriu baroniésu p. 400) scrive a un dipresso le stesse cose del Wagner, attingendo da lui a piene mani acriticamente. È invece sensato credere al linguista baroniese Andrea Deplano – il cui metodo non ha mende – quando afferma che a lui in Baronia non sono noti i vocaboli zarridare e zariθθu; e tantomeno gli sarebbero noti coi significati addotti dal Wagner.
Omofonie. Le false “onomatopee”, le false “voci imitative”, i falsi “fonosimbolismi”, riguardano complessivamente il 30% dei lemmi studiati dal Wagner. Sono una percentuale eclatante a dimostrazione della sua assenza di metodo. Un altro 30% riguarda più propriamente le omofonie (e siamo così al 60% dei lemmi: una enormità). Pretendere di risolvere le questioni etimologiche soltanto in forza dell’omofonia tra due elementi, senza alcun rispetto per gli aspetti storico-semantici, pone l’etimologista al difuori del metodo scientifico. Non si riuscirà mai a risolvere le etimologie, senza un approccio che proietti la parola sullo sfondo socio-culturale dei tempi primitivi. Purtroppo è solita del Wagner la pratica di accorpare le parole aventi fonetiche identiche o simili entro un solo campo semantico, senza tener conto della legge della polisemia e quindi senza prendersi la briga d’isolare ogni vocabolo per tentare di rinverdirne l’originaria indipendenza fono-semantica. In tal modo sfugge al Wagner la possibilità di far pulizia entro i propri sistemi logici, e gli sfugge anche l’esigenza prìncipe di non confondere e fuorviare il lettore. Nel paragrafo precedente abbiamo testè discusso di accuccaresì, sotto la cui voce Wagner ha preteso di accorpare, per semplice omofonia, concetti enormemente diversi. Passo ad altri esempi, che ho contenuto nel numero, nonostante ce ne siano migliaia.
Allughinzare log. ‘sporcare, annerire’; alluxingiái ‘sgualcire, sporcare i vestiti’; lughinzósu log., luxingiósu camp. ‘sporco, lurido, sudicio’. Wagner pretende come base lukinzu, lughinzu, luxίngiu ‘lucignolo’ (omofonia), ed è assurdo, poiché la base delle sue tre voci è lughe, lùere (vedi). Egli non è in grado di osservare che la vera base etimologica di allughinzare è il sum. luḫum ‘charcoal, carbone’.
Astra ‘ghiaccio’. Il gelo, il ghiaccio è un elemento che i pastori sardi hanno sempre temuto. Le transumanze esistettero fin da Età paleolitica proprio per evitare le morie del bestiame. I Sardi inventarono ben otto parole per indicare il gelo, il ghiaccio (altre cinque seguono qui appresso). Ma astra in origine indicava l’idea del tremare. Infatti la base etimologica è il sum. ašru ‘che fa rabbrividire dal freddo’, una metonimia per ‘frost, gelo’. Va da sé che gli altri vocaboli sardi àstragu, àstrau, astròre, astraòre, indicanti il ‘ghiaccio’, sono aggettivali di astra. Che poi i filologi romanzi propongano l’origine del sardo astra dal lat. astra ‘stelle’ (che invece hanno etimo nettamente distinto, come vedremo), la dice lunga su chi si fida soltanto dell’omofonia.
Attoccare log. ‘abbaiare, latrare; urlare come i cani’; attoccu, attόkkida ‘abbaio, canizza’; dare s’attoccu ‘emettere un grido a intervalli’. Base etimologica è l’akk. tukkum ‘alarm, warning’. Va da sé che va respinto l’assurdo invito del Wagner di vedere in questo verbo una variante fono-semantica di toccare ‘toccare’ in tutte le accezioni italiane.
Tzóu log.; accióu camp., ciódu sass. e gall. ‘chiodo per ferrare i cavalli’, ‘chiodo per le ruote piene’, ‘chiodo per le scarpe’. A Nuoro si dice cravu < lat. clāvus ‘chiodo’. Wagner crede tzóu accatto italianistico da chiodo, ma sbaglia, poiché ambedue sono voci tirreniche aventi base nel sum. zu ‘tooth, dente’. Si può notare che la voce logudorese è assai più vicina al sumerico che non la voce italica, quindi sembra il prototipo delle voci che poi si sparsero nel Tirreno.
Dissíbulu (Osilo) ‘diavoletto, ragazzo irrequieto, discolo’. Base etimologica è l’akk. dešû ‘to sprout, flourish, let prosper, be copiously supplied; germogliare, essere fiorente, far prosperare, essere copiosamente dotato’ + būlum ‘animals, livestock; bestiame di proprietà’. Dal composto si nota che le qualità positive elencate riguardavano il bestiame di proprietà, e costituivano l’orgoglio del proprietario. Va da sé che l’uso sopravvissuto ad Osilo riguardò nel passato i bambini assai vivaci (quanto a intelligenza, agilità, forza) e poi dilatò verso ulteriori specificazioni. Quindi è da rifiutare la pretesa del Wagner di ricondurre la voce osilese a discípulu ‘discepolo’ (di Cristo).
Fraitzínu (tussi) o tussi molentìna ‘tosse asinina’. Puddu ricorda che per fraίtzu e l’agg. fraitzίnu si è conservato il significato di ‘furbesco, astuto’. Wagner traduce la voce come ‘traditore, imbroglione, fuoriuscito, bandito, ladro’, e ritiene che il campo semantico sia prodotto, nientemeno, dall’it. fra’ ‘frate’, col significato quindi di ‘frataccio’. Ma questa interpretazione è miope. In realtà la base etimologica è l’akk. parriṣu ‘criminale’, da cui metatesi prai-, frai-. Vedi in ogni modo il lemma faurratzίnu, per capire la deriva paronomastica cui può portare un termine oramai incompreso.
Frazare log., frazza’ sass., fragia’ gall. ‘corrodere, consumare’; mancarri ki sia frazzàda ‘anche se è consumata’; male cuádu, frazu de pubiḍḍa ‘male nascosto, rodimento di moglie’; cfr. genov. frażżâ ‘consumare, sciupare’; romanesco frajasse ‘guastarsi, andare a male’; irpino e calabr. fraiá ‘abortire’; tosc. dial. frazzo ‘avanzo, frammento’. L’analisi etimologica del Wagner è un classico esempio della metodologia corrotta dalla pregiudiziale latina. Egli infatti produce anzitutto l’ipotesi del Romanisches Etymologisches Worterbuch, ossia che il termine derivi da un lat. fractiō, fragium, da un inesistente *fragulare (dove si cita un camp. *fragiare che parimenti non esiste: parole del Wagner); poi lo stesso Wagner riprende le distanze dal *fragulare del REW. Altra tesi da lui esposta è che il nostro termine derivi in ultima analisi da lat. (nau)fragium. Quanto al fragiu degli Statuti Sassaresi, e quanto alle forme odierne, esse sono tutte relegate in Logudoro, e, mancando nel resto dell’isola, per Wagner «sono sicuro indizio della provenienza forestiera» (sic). Il lettore, da quanto precede, ha agio di notare che Wagner non prende esattamente posizione, ma lascia intuire ex silentio d’essere d’accordo col lat. fragium attraverso forme quali (nau)fragium. Al che noi osserviamo anzitutto la tesi miope e colonialista secondo cui un lemma presente esclusivamente nel Logudoro «sia sicuro indizio della provenienza forestiera». Osserviamo poi l’arroganza del credere all’esclusiva origine latino-romanza. Osserviamo infine che è metodologicamente anormale avvicinare due campi semantici descriventi, rispettivamente, il logoramento (putacaso, di una stoffa) ed il naufragio!, il quale, si sa, ha il corrispettivo nel lat. frangere ‘rompere’.
Ciò accade perché non sono stati scrutati i dizionari semitici, dove per frazzare troviamo l’akk. parāṣu(m) ‘sbrecciare’ una parete’; parā’u(m) ‘affettare, tagliare di netto’; onde da p(a)rāṣu > frazzáre.
Gutta2 margh. ‘sincope, paralisi’. Per l’etimo ci possiamo riferire alla base bab. akûtu ‘invalidità’, da akû ‘debole, senza forze’, specialmente ‘zoppo, sciancato’; anche uqqu ‘paralisi’ (voce apofonetica in u-). Ma vedi l’ampia discussione a proposito di agottiadùra ‘vitiligine’. Spiace osservare che i linguisti precedenti hanno interpretato anzitutto per assonanze, traducendo gutta come ‘gotta’ (Spano, Wagner): mentre quest’ultima è malattia diversa. Spiace anche osservare che spessissimo Wagner accorpa le voci similari o identiche sotto un unico lemma, creando notevole confusione. Tale destino ha avuto anche gutta2, che è stata abbinata a gutta1 ‘goccia’ nonostante l’evidente discrasia semantica.
Igumarras (Laconi), irgumarras (Desulo); vigumarras (Mogoro, Escalaplano) ‘lampi secchi, il lampeggiare parossistico e senza pioggia durante certe perturbazioni sciroccali di settembre’. Questo termine meteorico, il cui prototipo pare irgumarras, ha base nell’akk. irḫu ‘aggressiveness, insolence’ + marrum ‘bitter’ (of wind). Il composto irḫu-marrum in origine indicò la ‘paurosa aggressività’ (del temporale). Immagino che la sequenza ininterrotta di migliaia di saette aria-aria fosse vista come dimostrazione della rabbia del Creatore. Wagner inserisce queste voci tra quelle legate a vicru marinu (v. vicru ‘vitello’) ossia alla ‘foca monaca’, tentando di accreditare fantastiche sarabande di foche eccitate dai temporali di fine estate. Ma vicru ha tutt’altro etimo rispetto a quello ora esposto.
Imbòrvita (Bitti), imbòrvida (Nuoro) «si chiama il pane che si manda ai vicini e ai poveri il settimo o il nono giorno dopo la morte di un familiare». Secondo Wagner è così detto perché “coperto da un panno”, quindi da imbόrvere ‘involgere’. Wagner, a mio parere, sbaglia su tutti i fronti. Occorre tener presente che in Sardegna l’assistenza alla famiglia del morto è un obbligo morale. Per s’imbòrvita non è la famiglia del morto che invia ma anzi è quella che riceve dai vicini i beni eduli. Anche se è vero che in Campidano la famiglia del morto dopo 30 giorni dona un pane a coloro che hanno assistito alla messa di suffragio. Ma è s’imbòrvita come parola a destare forti sospetti sull’operato del Wagner, poiché non ha attinenza né con l’involgere né col celare il dono. La base etimologica è il solito in- mediterraneo (complemento di moto a luogo, oppure dativo) + akk. bu’’ûm ‘to look for, cercare qualcuno; look after, prendersi cura di’ + wêdum ‘sole, solitary, alone; solo, solitario’. Il composto in-bu’’ûm-wêdum in origine significò ‘prendersi cura delle persone sole’.
Incappare it. ‘essere irretito, preso da una situazione impediente, spesso malevola’. Cfr. log. incappare, camp. -ái ‘capitare’: tristu a kin’incappat ‘sfortunato colui al quale succede’. Base etimologica è l’akk. kappum ‘palmo della mano’. In questo caso il concetto basilare è quello d’essere afferrato da una mano rapace. Sbagliato l’etimo del DELI da cappa ‘mantella’. Wagner (DES I 622), senza immischiarsi in questioni di etimologia, sostiene che la voce sarda è un accatto dall’it. incappare.
S’incappat. Dopo l’azzardo di incappare, Wagner rafforza la sua idea accreditando la stessa origine all’avverbio di dubbio: s’incappat. Quindi traduce Ómine pipadore s’incappa non ‘nde leo ‘uomo fumatore, se capita, non lo sposo’. Invece sincappat è voce log. ‘forse, probabilmente, mi pare che, secondo me’; sincappat appo intzertáu ‘mi pare d’avere indovinato’; sincappat mi lu faghes iskìre ‘spero me lo farai sapere’; sincappat l’as cumpresa ‘mi pare che l’abbia capita’; sincappat lu fricas tùe! ‘stai fresco che lo freghi tu!’. Questa è un’antichissima invocazione del genere di quella araba (inshallàh ‘che Dio voglia’),ed ha base etimologica nell’akk. Sîn ‘la Dea Luna, la Dea Madre Onnipotente’ + kapātu ‘mettere insieme, riunire’ (dei segni portentosi, segni d’auspicio). Quindi sincappat significò in origine ‘che Sîn mostri dei segni positivi’.
Inférias log. ‘pastoie’. Cfr. tosc. ferie ‘idem’; cal. férgia ‘pastoia di ferro da cavallo’, abruzz. ferge. Wagner ne propone la parentela col ferro, evidentemente attratto dalla “pastoia di ferro” qui citata, alla quale non credo in linea di principio. Infatti una cosa è la ‘pastoia di ferro per uomini (manette)’, applicata ad esseri intelligenti per ammonirli a star calmi e non farsi male inutilmente, altra cosa è ‘impastoiare col ferro un animale’ che, non essendo intelligente, auto-distrugge le proprie gambe, condannandosi alla morte e producendo un danno economico al padrone. Questo lemma è uno dei tantissimi che denuncia la scarsa acribia del Wagner, il quale risolve le sue etimologie soltanto in funzione delle assonanze (inférias/ferro), senza considerare la semantica. Invero, la base etimologica più congrua per inférias è il sum. birig ‘to sneer at, farsi beffe di qualcuno; contract oneself, contrarsi, rattrappirsi; roll up, arrotolare, rimboccare’, da cui si può evincere un campo semantico dove domina l’atto d’imperio o di violenza ed il concetto di mettere attorno (appunto: i lacci ai piedi).
Ingenium in CSMB 93: Ismendarunt su condage suo in corona de logu, ki aviat factu ad ingenium (ch’egli aveva falsificato) et segarunt illum. La traduzione è del Wagner. Egli riconduce il sd. ingenium ad irghenzu nuor., abbenzu, aenzu, enzu ‘difetto fisico o morale; debolezza, macchia’; e deriva irghenzu e tutte le voci ad esso legate dal lat. ingĕnium ‘natura, qualità, indole, inclinazione’. Non si rende conto che la vera base etimologica di irghenzu è l’akk. irḫu ‘aggressiveness, insolence; aggressività, insolenza’. L’interpretazione del Wagner è ascientifica, e in quanto tale incappa in tre errori: il primo quando rifiuta l’approccio semitico; il secondo quando prende come base una voce latina senza alcun criterio, poiché tra irghenzu e ingenium c’è troppa differenza fonetica ed anche semantica; il terzo quando pretende che si accetti il lat. ingenium come “falsificazione” anziché come ‘natura, qualità, indole, inclinazione’. Detto con rispetto, questo è un imbroglio oratorio che induce subliminalmente il lettore ad accettare la proposta come vera, omologando ingenium ad irghenzu e ponendo l’origine di quest’ultimo in ingenium medesimo! L’imbroglio va svelato: la proposizione subordinata ki aviat factu ad ingenium è da tradurre ‘che aveva fatto (scritto) secondo le proprie intenzioni (e non secondo verità)’.
Istuvada log. ‘colpo di coltello al fianco; percossa’ (Casu). Contrariamente a quanto propone Wagner, questa voce autenticamente sardiana non ha alcuna relazione con tuvu (agg. ‘cavo, profondo’ detto d’alberi, per estensione ‘spelonche’, base etim. bab. ṭubû ‘un genere di canna’). Base etimologica di istuvada è il sum. tub ‘to strike down, colpire’.
Là locuzione esortativa camp., usata in frasi quale Là ki ti partu de conca! ‘Sta attento che ti parto di testa, che ti dò una testata!’; Là ki ses fendi su scimpru! ‘Attento a te che stai facendo lo scemo!’. La base etimologica è l’ug. l-, /la/ ‘o’ (interiezione). Il camp. là funziona esattamente come nell’ugaritico, prefisso alla parola o al verbo seguente come interiezione vocativa. Ma vedi anche l’akk. di Emar la = ingl. to, it. a, lat. tibi. Come base etimologica primaria abbiamo il sum. la ‘mostrare, esporre’, col significato quindi di ‘guarda!, attento!’; si noti l’interiettivo sum. a-la-la, che riappare nella interiezione camp. là là là, per richiamare l’attenzione di qualcuno su qualcosa: ‘guarda, guarda, guarda!’. In Campidano s’usa la particella là anche col significato similare di ‘tieni, afferra!’ (uso pure italico). Ma altrettanto spesso la particella campidanese è strettamente agglutinata nella più complessa forma infinitiva labái.
Non è lecito considerare il camp. labái ‘osservare’ come avente base nel sum. la ‘mostrare, esporre’ + ba ‘colà, là’ (prefisso dativo-locativo): la-ba, con significato di ‘guarda là’. Oggi i linguisti percepiscono là – in quanto particella isolata – come forma imperativa dell’infinito camp. labái ‘guardare, mirare, osservare’. Ma si noti che la voce labai, essendosi oramai consolidata come supposta da un sd. *labai, *labare, riceve anche le forme congiuntive di rispetto lebi, lébidi ‘guardi’. In realtà la forma labái ‘guardare’ è già di per sé corrotta, ed ha base nel camp. la + bá(d)-. Non a caso c’è il corrispettivo log. ab-baid-áre (con a- dat. prefissato): cfr. badiáre (Olzai, Ovodda, Gavoi) ‘guardare’; it. bad-àre ‘osservare, mirare a’.
Il camp. la-bái è quasi sempre impiegato all’imperativo, dove abbiamo il semplice là! ‘guarda, osserva!’, ma pure il composto labbáḍḍu!, labbaḍḍu innòi! ‘mìralo, védilo qua!’ (da là baḍḍu…). La base etimologica di bad- è il sum. bad ‘fortezza’ ossia ‘luogo alto d’osservazione’. Ultima osservazione: Wagner (DES II 1) cita questo lemma sotto la voce italianistica labare ‘lavare’, principalmente ‘cercare i pidocchi in testa’ (e le pulci sul corpo), pretendendo l’origine etimologica di là, labái dal lat. lavāre. Un modo di ragionare che esula da ogni approccio scientifico.
Maiòre log. ant. ‘titolo comune significante la preminenza assunta da un uomo sui suoi dipendenti’; pl. anche maiorales. La base etimologica è la stessa di magistru, maistru, mástriu, mastru log. ant. ‘maestro’ (vedi). Questa voce è passata attraverso il lat. magister (da magis, majus), ma ha base etimologica nel sum. maḫ (cfr. it. maiùscolo ‘di proporzioni maggiori’) ‘grande, potente’; il suff. -yo-, -yu- ha basi semitiche: ug.-ebr. jṣ’, aram. j‛a, akk. aṣû ‘salire; to rise, to grow’. È inammissibile che Wagner abbia preteso di porre come base di maiòre il camp. mòri ‘viottolo di campagna’. Infatti tra l’aggettivo connotante il maggiore ed il nome riferito al sentiero passa un abisso semantico. Wagner non potè capire che mòri ‘sentiero’ ha base etimologica nel sum. mu ‘good’ + rub ‘to go, andare’: mu-rub indicò in origine il ‘buon andare’ ossia la possibilità di muoversi senza attraversare né selva né sterpaglie.
Mudróxu (Sarrabus) ‘orifizio dell’alveare, unico ingresso delle api’. Base etimologica è il sum. mud ‘cavità’ + uru ‘dwelling’. Il composto mud-uru in origine indicò il ‘buco dell’abitazione’. Da scartare l’assurda proposta del Wagner che indica l’origine nell’it. mordere.
Muldidòri (Teulada) ‘ragno’. Base etimologica il sum. mul ‘insect’ + de ‘to winnow, vagliare, discernere’ + dur ‘to dwell, abitare’. Il composto mul-de-dur in origine significò ‘insetto che abita dentro il vaglio’ (per la forma della ragnatela). Da respingere l’interpretazione del Wagner, che lo considera ‘il morditore’, da it. mordere.
Oru log. in leare όru ‘aver sentore’ (Spano). Base etimologica il sum. ur ‘to smell, sentire odore, annusare’. Purtroppo Sanna e Wagner lo derivano dal log. orettare ‘guardare dalla soglia della porta’.
Pibaratzu agg., detto di un cavallo screziato o di pecora bianca a macchie rosse (Sarrabus). La voce non deriva dall’it. vipera (serpente velenoso viviparo), come suggerisce assurdamente Wagner, ma dal sd. píbere, píbiri ‘pepe’. Quindi significa peperato.
Pistoccu log. e camp. ‘pane biscottato e scisso in due sfoglie’. Wagner lo considera metatesi dell’it. biscotto ‘pane cotto due volte’, ‘pasta dolce cotta lungamente al forno’ (< lat. biscŏctum ‘cotto due volte’). Questa interpretazione ha lasciato il segno tra i “dotti” e nel volgo. Invero, la voce sarda è totalmente autonoma, avente base etimologica nel sum. piš ‘bank, shore, rim, quay, bancata, riva, costa’ + tuk ‘to break off, cut, scratch, staccare, tagliare, incidere’. Il composto piš-tuk in origine indicò un ‘(pane) piatto e secco che si scinde in due’.
Pasticci e funambolismi. Come abbiamo constatato, purtroppo, sono migliaia i pasticci ed i funambolismi esibiti dal Wagner in fangose, assurde, lunghissime discussioni entro le quali egli macina voci latine o “neolatine”, condite dalle leggi fonetiche della Scuola Indogermanica (da me rifiutate: vedi Grammatica Storica), le quali creano una cortina fumogena adeguata a sfinire il lettore ed indurlo ad accettare fideisticamente ogni proposta. Comincio la breve sequenza con un esempio sardo-italico.
Aquà = it. ‘qua’ = sd. innòi, innòghe. Questo è termine del gergo ramaio di Isili. Il lemma è una spia del fatto che i ramai di Isili in origine ebbero rapporti stretti con i ramai d’Italia. Infatti quest’avverbio in Sardegna non viene usato, ed è evidente che il lemma acuà (o aquà) è lo stesso lemma italico qua, da cui però il gergo ramaio si distingue in virtù del ridondante prefisso locativo a-.
Stando al DELI, l’italico qua ‘in questo luogo, in questo posto’ dovrebbe avere la base etimologica nel lat. (ěc)cu(m) hāc ‘ecco pur di qua’. Ma non occorre grande acribia per notare l’ybris …creativa del DELI: quel Dizionario infatti ci fa assistere dapprima alla distruzione di una parola intera (ěccum), poi alla religiosa delicatezza con cui se ne preleva un pezzetto (-cu-), infine all’azzardo da Frankenstein che appiccica -cu- al lat. hāc e crea il minotaurico -cu-hāc, senza più curarsi della fine che possano aver fatto tutti gli altri membri, compresa la velare finale (-c) che, non si sa mai, poteva anche essere un pezzo importante.
A me, incapace dei vertiginosi e avveniristici esperimenti del dottor Frankenstein, resta un’unica, arcaica, risorsa: attingere al dizionario sumerico, dove trovo ku ‘to place, collocare, mettere, porre’ + -a (suffisso locativo con valore ‘in’): ku-a significò ‘in questo luogo, in questo posto’, proprio come in italiano.
Berríle, verrίle, errίle log. ‘vernino’: anzone verrile. Per l’etimo vai a iverru ‘inverno’. In ogni modo, per questa voce occorre molta cautela. Infatti il giusto prototipo di essa è barrίri agg. sass. ‘agnello grande’, propriamente del mese di aprile. L’interpretazione, qui postata dopo essere stata semplificata (dove si mescolano i concetti dell’inverno, dell’agnello grande, del mese di aprile), è del Wagner, non mia: io non la condivido affatto. Persino Bazzoni si périta di accreditare l’incredibile certezza del Wagner. Invero, base etimologica di barrίri (a quanto pare anche di berrίle) è l’akk. barûm ‘to be on the market, available; essere disponibile per il mercato’ ossia essere grande abbastanza per valere come carne da vendere.
Cadattu ‘cardo stellato’ (Centaurea solstitialis L., Centaurea calcitrapa L.). Inserisco, tra quelle trattate dal Wagner, una voce trattata espressamente dal Paulis NPPS 78-80 in relazione alla calcitrapa. Nel ricordare che Wagner ne ignora l’etimo, Paulis propone tale fitonimo come contrazione di kardu ed al contempo continuazione di un inesistente lat. *atractulus, forma basata su atractylis (che però secondo Plinio è il Cartamo lanato) quale imprestito d’epoca bizantina (sic!), il quale in Sardegna avrebbe prodotto – secondo lui – una serie contorta e defatigante di assimilazioni, dissimilazioni, semplificazioni, complicazioni, rinvii, obliterazioni, contrazioni, anaptissi, epentesi, dilegui, aferesi, metatesi, analogie produttive… e quant’altro si voglia pescare da un trattato di tecnica fonetico-stilistica. Alla fine Paulis, irrimediabilmente perduto nel labirinto da lui stesso creato, non produce alcun etimo, lasciando il lettore stanco e frustrato dopo aver letto tre pagine col desiderio di scorgere una soluzione. I miei lettori sono vivamente pregati di ripercorrere quelle pagine.
In realtà cadattu è un composto sardiano con base nell’akk. kādu(m) ‘sentinella’ + atû(m) ‘portinaio’. Per capire questo sintetico appellativo significante ‘guardiano degli usci’, basta leggere tutti gli altri consimili significati dati dai Sardiani alla calcatreppola, pianta d’elezione con cui si fanno delle effimere “porte”, “cancelli” per impedire alle bestie di rapina di entrare negli ovili.
Féstina centr., gall. designava originariamente le scale a intagli, oggi inesistenti. Oggi il vocabolo si usa per la ‘scala a pioli’ (Nule, Dorgali), in Gallura anche per il ‘tronco d’albero coi rami sporgenti e sfrondati al quale s’appendono utensili o bestie scannate’, altrove chiamato anta. Base etimologica è il sum. peš ‘to slice, affettare, to cut into, tagliare in…’ + ti ‘rib, stecca’ + nug ‘plant’. Il composto peš-ti-nug in origine indicò una ‘pianta resecata a stecche’. Esemplare l’affanno indagatore del Wagner (DES I 514), che abbina la nostra voce a questa e a quella, arrecando soltanto danni; es.: l’abbina al lat. infestus ‘ostile, aggressivo, nemico’; allo sp. enhiesto ‘alto, levantado’; al lamant. injiestro ‘ognuno dei quattro pali ai capi del carro’. Egli vi assomma anche il berbero tafesna ‘scala’ (voce del tutto diversa), ch’egli ostinatamente pretende ravvicinare al nostro féstina.
Fúndere log., fúndiri camp. ‘fondere, liquefare’. Cfr. lat. fundere ‘sciogliere, spargere, disperdere, volgere in fuga, sconfiggere’; infundibulum ‘imbuto’; fūtis ‘vaso per mescere’; fūtilis ‘che si versa o si disperde’ < base apofonica corrispondente ad akk. pādum ‘to set free, liberare’. Vedi DES I 556 per capire la disastrosa e confusissima operazione con la quale Wagner riesce ad unificare l’etimo di due lemmi assai diversi, fúndere e infúndere.
Ineḍḍa centr. ‘lì, in quel preciso punto’, ‘là, colà, lontano’; anche inḍeḍḍa: mirare sa luna de ineḍḍa ‘guardare la luna da un punto preciso’; in cuḍḍa biḍḍa ineḍḍa ‘proprio in quel villaggio’; ineḍḍa andet sa fama ‘la fama si levi alta’ (cfr. sum. ed ‘to go up, salire in alto; to come forth, uscire’). Wagner sbaglia a dare a ineḍḍa il significato di ‘lontano’, tout court. Parimenti sono insufficienti le traduzioni date dal Puddu 865: ad es. prist-inneḍḍa ‘prestu a un’ala’ (peráula po kizire su cane) ha un significato assai distante da quello dato dal Wagner, e Puddu questo non l’ha chiarito.
A mio avviso, la base etimologica di alcune di queste locuzioni sta nel sum. ed (vedi l’esempio citato), per altre nell’akk. eddu(m) ‘punto, appuntito’ < edēdu ‘essere appuntito’. Per non impegnare spazio, non riporto la fangosa, lunga discussione del Wagner (DES I 629), che ruota sulla manipolazione di alcune voci latine, condite dalle leggi fonetiche inventate dalla Scuola Indogermanica, le quali, partendo da basi irrimediabilmente sbagliate e compromesse, creano soltanto pasticcio.
Osca log. ant. ‘poi, dopo’. Frequentissimo nei condaghes, in séguito cede il posto a posca (vedi) ‘poi, appresso, dipoi’ (avverbio), che però spunta ogni tanto anche nei documenti antichi. Nella CdL posca è l’unica forma. Facile arguire che osca è la forma arcaica della parlata sardiana. Infatti, base etimologica è il sum. us ‘to follow’ + ca log. e camp. ‘che’ come introduzione delle proposizioni dirette (accusative) e in applicazioni varie, da sum. ka ‘to talk, parlare’. In pratica us-ka anticamente ebbe il significato di ‘poi che’. Wagner, convinto della priorità temporale di posca, ha scritto tre pagine nel disperato tentativo di scoprire un arcano per lui inscrutabile.
Regra (Nuoro, Dorgali, Orune, Nule); rega (Bono); règia (Oschiri, Buddusò, Mores); sa regge (Sennori); règgia (Berchidda); rèja, melarrèja (Luras, Ozieri); melarèggia (Pattada); arrèga camp. ‘favo di miele’. Regra e simili sono retroformazioni dal prototipo melarrèja. Per l’etimo vai a méli, mela + akk. rēyûm, re’ûm ‘shepherd, pecoraio, pastore’. Nell’alta antichità melarrèya significò ‘miele dei pastori’.
Impossibilitato a riscrivere e riproporre l’intera pagina da cui ho preso le mosse, rinvio a DES II 346 affinché i futuri linguisti percepiscano il guazzabuglio prodotto dal Wagner il quale, paralizzato nella ricerca di un etimo qualsivoglia (salvo poi parare a un lat. reg(ŭ)la ‘regola’: sic!), s’impelaga in una cabalistica manipolazione delle leggi fonetiche da lui stesso inventate, confrontandole con quelle altrettanto inventate della linguistica indoeuropea. Inoltre introduce anche rèya ‘traversa del cancello’, oltre a voci similari basso-italiche aventi tutt’altri significati, quasi che tali voci abbiano a che fare con la nostra. Il risultato è, purtroppo, una pagina allucinata.
Resare log. (rasare: Nuoro, Mores); arresái, arrasái, arrosái camp. ‘recitare il rosario’; ‘fare orazione’, ‘dire il breviario’; fagher (fai) su résu, s’arrésu ‘la preghiera quotidiana del prete’. Cfr. sp. rezar ‘recitare orazioni’, rezo ‘preghiera’; arreséndu (Mogoro, Terralba), arreséndi (Cagliari), arroséndi (Villacidro) ‘Credo’ (la preghiera-cardine del cristianesimo). Quanto precede è scritto dal Wagner, e si può notare ch’egli ha fatto un po’ di confusione, mettendo assieme il Rosario, il Credo, ed una poco chiara ‘preghiera quotidiana del prete’. Wagner è partito da sp. rezo ‘preghiera’, credendolo l’origine delle altre parole spagnole nonché di quelle sarde. Ma, a parte che non dà l’etimo di rezo, rezar, egli ha fatto dei grossi errori. Base etimologica di rezo è, invero, l’akk. rēṣum ‘helper (god, goddess), che soccorre’; ‘to help, soccorrere’: Sîn-rēṣam ‘Help me, Sîn!; Dea Luna, soccorrimi!’ (usato come invocazione nella preghiera, ed anche come nome muliebre). Quindi è inadeguato quanto propone Wagner, che il verbo sia riferito al rosario, alla ‘preghiera quotidiana del prete’ e pure al Credo. Possiamo invece notare che oramai a livello popolare ed a livello colto la confusione ha prevalso, mentre al fondo rimane l’akk. rēṣum che tramanda intatta sino ad oggi una parola che denuncia una incredibile sopravvivenza della religione pre-cristiana.
Scrikkillònis m. pl. camp. (Escalaplano); scrikkillôis (Mogoro); cicillònes (Villagrande); sciscillònis (Cagliari); pripixònes (Laconi); spripillôis (Usellus) ‘racimoli’. Base etimologica di scrikkillònis ed affini è il sum. kirkir ‘bird’ + lum ‘drinking vessel’, anche ‘fruit’. La Sardegna nel periodo della vendemmia sta ancora nel pieno della siccità estiva, e gli uccelli sono in grande sofferenza per assenza d’acqua. Pertanto il composto kirkir-lum in origine dovette significare, più che ‘frutta degli uccelli’, ‘acqua degli uccelli’. [Questo è l’esempio di come devono essere trattate le etimologie, con un occhio agli antichi vocabolari e l’altro all’ambiente del luogo. Invece Wagner DES II 394 satura le proprie ipotesi con parole inventate (con l’asterisco) e con depistaggi epistemologici operati mediante la presentazione d’una serie di vocaboli travianti, quale sd. kiskizza ‘vagliatura del grano’, sp. cencerrón ‘racimolo d’uva’, sd. pipiòne ‘acino d’uva’].
Séru log. ‘sentore’: leare su séru ‘aver sentore’ (detto specialmente dei cani da caccia); cane de séru ‘cane dal naso fine’; fig. ‘persona molto accorta’ (Casu), ‘giudizio, riflessione’ (Soro); leare séru ‘subodorare’ (Spano); ista in séru! ‘mantieni il senno!’; serare ‘sentir la preda’ (detto dei cani); riflessivo ‘ravvedersi, rinsavire’; anche seriare: l’apo seriadu in cussu logu ‘l’ho visto in quel luogo’.
Leggendo in DES II 411 si apprendono le angosce dei linguisti nell’indagare questa voce. Antonio Sanna, non sapendo che fare, tentò di sentenziare che Spano, Soro e Casu avevano registrato parole inesistenti (sic); ciononostante s’arrovellò paradossalmente nel sostituirvi verbi e significati d’altri campi semantici, tipo it. segregare (operazione illecita e assurda, la sua, seguita dal Guarnerio che tentò d’intruppare quelle voci nell’it. sceverare ‘discernere con la vista’). Il Meyer-Lűbcke rigettò il tentativo del Guarnerio ma se ne lavò le mani. Il Salvioni dubitò del Guarnerio e propose in cambio l’origine dal lat. verus ‘vero’ (sic). Wagner rigettò salomonicamente tutti quei rovelli, per andare at random e pescare infine la parola sostitutiva dal sintagma leare oru (dallo Spano), che considerò sinonimo di leare séru. Invero, Wagner nel suo cieco brancolare cadde bene, in quanto leare όru ‘aver sentore’ ha base etimologica nel sum. ur ‘to smell, sentire odore, annusare’. Ma rimane il clamoroso smacco di quattro luminari della filologia romanza, che preferirono by-passare il problema di séru, dispensandosi dall’indagare la sua base etimologica, che poggia nel sum. sir ‘to be pointed, essere acuto’.
Súmere, sumίre log.; sumίri camp. ‘trasudare’ (detto delle botti e altri recipienti). Base etimologica il sum. sumun ‘soaking vessel, vaso bagnato, inzuppato’. Rinvio a DES II 444 affinché si capiscano gli assurdi funambolismi del Wagner e dei suoi colleghi nel tentare di accreditare un qualsivoglia etimo.
Supuzzare nuor.; suguzzare log.; sumbuzzare (Ghilarza); sumbullái, sciumbullái camp. Wagner dà a supuzzare, ed a quelle presentate come varianti, quattro significati collegati (vedi di seguito). Ma è tale il caos da lui creato nell’esporre la questione (v. DES II 446), che porvi rimedio è arduo. Il lettore, dopo aver letto pazientemente nel DES l’esposizione del Wagner, adesso dovrà seguire con la stessa pazienza i miei tentativi di sbroglio.
1) ‘sconvolgere, scompigliare’: tengu su stόgumu sciumbulláu, camp., anche sciamballáu ‘scompigliato, sciamannato ossia sciatto o maldestro’; cfr. lucch. sciambugliare ‘muovere lo stomaco, suscitare nausea’ (Nieri); anche ‘rimescolare, intorbidare l’acqua’. Quanto precede è esposto dal Wagner, senza che fornisca esempi fraseologici di supuzzare, che invece ritroveremo ai punti 2 e 3. La forma sciumbullái sembra parente di it. subbuglio ‘confusione tumultuosa, scompiglio’ (che DELI suppone dal tardo lat. subbullire ‘bollire un poco’ [assurdo!] mentre deriva dall’akk. šūbu ‘rush, affollamento, ressa; to flatten, abbattere, spianare’).
2) ‘portare di notte le pecore al pascolo’ (come si fa nella stagione calda). Il rumore e lo scompiglio che ne nasce si chiama supúzzu, suguzzu, sciumbullu (cfr. it. subbuglio), ciò che spiega l’applicazione del verbo al trasporto notturno delle pecore. Il sostantivo e il verbo si usano anche per un qualsiasi rumore: inténdu sciumbúgliu ‘sento rumore’; (Mogoro) s’áqua sciumbúllada mei sa brocca ‘l’acqua diguazza nella brocca’. Tutta questa esposizione è fatta dal Wagner, ed è caotica, anzitutto nell’abbinare allo scompiglio il pascolare delle pecore (che è quieto e mansueto, anche di notte: esperienza mia personale); poi nel forzare subliminalmente il lettore a considerare l’origine di sciumbullu (subbuglio) da tale idilliaca quiete. Nel tentativo di mettere ordine, dico che suguzzu deriva dal sum. suḫ ‘to confuse, confusion’ (supuzzu è l’effetto di Lautverschiebung: v. la mia Grammatica); per sciumbullu ho dato l’etimo al punto 1.
3) log. suguzzare(sì) significa anche ‘svegliarsi presto’ (Mores, Bonorva), e così anche camp. sciumbullái: sciumbulla! ‘svegliati!’ (Domus de Maria). Questo significato deriva dall’anteriore: i pastori che portano le pecore al pascolo di notte, si devono lavare presto. Perciò si chiama nel Logudoro Suguzzadora la ‘costellazione d’Orione’ (Spano, il quale osserva: “con esso i pastori chiamano la prima stella di Orione, quando di mattina spunta nell’estate e muovono dalla mandra le pecore per pascere un’altra volta”). Il Canonico dà come etimo del nome il lat. sequor, ma ciò è impossibile.
Quanto precede è esposto interamente dal Wagner, e si noterà un incredibile pasticcio dove si mescolano i concetti dello “svegliarsi presto” (all’alba, di notte?); del “pascolo notturno”; del “pastore che si lava presto” (all’alba o di notte?, ma a che serve introdurre l’idea balzana del lavarsi?); della costellazione di Orione (la quale, osservo io, non sorge durante il pascolo estivo-notturno ma d’inverno, e sorge dopo il tramonto, non di mattina); del “muovere il gregge di mattina” (mentre Wagner era partito dicendo che il gregge viene mosso in piena notte). Wagner, insomma, concatena cinque concetti che fanno a pugni, ed il lettore rischia d’impazzire davanti a un’esposizione folle.
4) per il log. sett. il Casu dà sumuḍḍίre, simuḍḍίre con tutte le accezioni essenziali di supuzzare: ‘muoversi, menar le pecore al pascolo’, inoltre ‘nascere, spuntare (di erbe)’ (tutto ciò è registrato dal Wagner). Invero, la base etimologica è il sum. sub ‘to go’ + ud ‘goat’, udu’l ‘sheep, fat sheep’, udul ‘herdsman’. Da queste radici potè nascere il significato del ‘condurre le pecore, o le capre’ (sub-ud o sub-udu’l), relativo al sd. supuzzare, e pure relativo a sumuḍḍίre o simuḍḍίre interpretati come nasalizzazione di sub-ud.
5) Quanto alla costellazione di Orione, Wagner non ha spiegato perché essa sia chiamata Suguzzadora, da lui intesa come ‘colei che risveglia presto (la gente)’. Invero, il tentativo di trovare l’etimo passa per il sum. šugi ‘senior, elder, old person’ + za ‘man’ + duri ‘male, virile’. Il composto šugiz-za-duri significò in origine ‘uomo anziano dall’aspetto virile’ (ed abbiamo l’idea della costellazione di Orione).
Tiváni ‘corvo’ a Baunei, Villagrande, Arzana, Gairo, accanto a crobu: esattamente crobu-tivani, specialmente nella locuzione ancu ti nḍi lè tivani! ‘che tivani ti porti via!’. Quanto precede è riportato da Wagner DES II 492, dove l’Autore insiste ad affermare che tiváni è l’arcaico nome ogliastrino del corvo. A parte che, come suo solito, non opera l’indagine etimologica, egli nemmeno si pone l’obbligatoria domanda: Per qual ragione un minuscolo corvo sarebbe in grado di rapire un uomo? Invero, la base etimologica di crobu-tivani è l’akk. kurūbu (a bird) + tībum ‘attacco, insurrezione’; quindi kurūbu-tībānu (-ānu è suff. aggettivale) indicò in origine un ‘uccello d’attacco, di rapina’ (evidentemente si riferì all’Aquila reale, la quale ha la forza di sollevare persino una capra adulta; oppure si riferisce a s’ingurtosu). Tivani s’impiega anche nel senso di ‘ingordo’: quindi a maggior ragione restiamo nel campo semantico di s’ingurtόsu (‘gipeto o avvoltoio degli agnelli’). Rafforza questa impostazione il fatto che esistette anche il cognome medievale Tiuani (CV XIC) e Tifani (CSMS), il quale indica chiaramente un arcaico nome maschile correlato proprio all’avvoltoio (nome di guerriero). L’impenitente protervia ideologica del Wagner lo induce a scartare persino il bèrbero siwân, che in tutte le varietà di quella lingua designa vari uccelli di rapina, per lo più il gheppio o l’avvoltoio. Ma Wagner preferisce la forma marocchina tsiouânt, perché essa indica il corvo e ciò conferma la sua convinzione ideologica!
Tutare centr; tudare, tudái log. e camp. ‘coprire il fuoco con terra o cenere’, ‘sotterrare, seppellire’. Base etimologica è il sum. tun ‘to cover’ + tab ‘to burn, fire; bruciare, infiammare’. Il composto tun-tab in origine significò ‘coprire la fiamma, il fuoco’. Rinvio a DES II 537 per apprendere le assurde evoluzioni nel tentativo di giustificare un (inesistente) lat. *tutare e persino un’origine dal fr. tuer ‘uccidere’.
Visèra, bisèra, isèra log. ‘figura, apparenza’. Rinvio a DES II 580 per osservare il guazzabuglio creato da Wagner, il quale ha abbinato arbitrariamente a questa voce anche iseriare ‘nauseare, schifare’, nonché isèria, bisèra ‘beffa, trastullo’, sostenendo che «da ‘maschera, viso contraffatto’ si spiega l’idea di ‘contorcere la faccia per effetto dello schifo o della beffa’» (sic). Invero, le basi etimologiche sono tre, molto distinte.
Tzira camp. ‘sa natura de is vitellus, mascus e angionis’; ‘verga, natura, nervo’ (Porru); sa sίra (Iglesias) ‘pene’; sirìle, serìle log. ‘membro genitale del toro, del verre, dell’uomo’. Base etimologica nel sum. šir ‘testicolo’, di cui sirìle è aggettivo. Vedi anche tzirogna. Rinvio a DES II 595 affinché si apprenda direttamente l’assurdo discorso del Wagner, il quale coinvolge il Guarnerio, il Rolla, l’Alessio in fuorvianti ipotesi sull’origine di queste voci.
Voci spurie (per Wagner) o voci da lui stesso inventate. Dopo la segnalazione dell’enorme congerie di errori di traduzione fatti dal Wagner, non può mancare la segnalazione di un altro fenomeno osservabile nel DES, cioè le cosiddette “voci spurie” (interpretate così dal Wagner ma che spurie non sono). Ci affianco anche le voci che lo stesso Wagner inventò ma che non trovano riscontro nel vocabolario sardo.
Carrubba camp. ‘carru sentza rodas po trasportai perdas etc, ki is bois trascinant po terra’ (Porru). Era, insomma, un ‘slitta’ (per la quale cfr. tracca). Base etimologica è il sum. ḫara ‘wagon, carro’, akk. ḫarû ‘contenitore supportato da un carro’ + ubûm ‘misura di capacità’. Quindi è da tenere in non cale la meraviglia del Wagner per questa parola, ch’egli ritiene sbagliata, una voluta deformazione popolare al posto di carrùca (vedi).
Cardanéra nuor. e camp., cordonèra (Busachi) ‘cardellino’ (Carduelis carduelis). Base etimologica è l’akk. qardum ‘valiant, heroic, coraggioso, prode, eroico’ + nēru (a bird). Quindi qardu-nēru ‘uccello valoroso’ fu il primo nome del cardellino in Sardegna. Sussiste anche il cat. cadarnera, cadernera, di cui Wagner (DES 299) non ha saputo dare alcuna spiegazione, negandone addirittura l’esistenza.
Ducu (Ghilarza) ‘frana’ (Spano). Wagner, non avendo conseguito conferme etimologiche, la considera “voce dubbia”, come dire che la dichiara spuria. Invece, a quanto pare, la base etimologica è il sum. du ‘to build, heap up, accumulate’ + kud ‘to cut, break off; tagliare, rompere a pezzi’. Il composto duk-kud in origine significò ‘rottura del cumulo’.
Lareḍḍa camp. ‘piattola’, voce registrata solo dallo Spano. Wagner, dopo adeguata discussione, dubita molto della correttezza di questa voce, ed attribuisce allo Spano un errore, che con ciò s’assomma ai molti errori che lo Spano avrebbe fatto nell’interpretare il dialetto campidanese. Ma la questione non sta nei termini delineati dal Wagner, e va detto che Spano, specie per le parole da nessun altro registrate, è invece molto preciso. A mio avviso, lareḍḍa ha base etimologica nel sum. la ‘to hang, agganciarsi’ + rig ‘to eat, mangiare’ + dab ‘to seize, overhelm; afferrare, sopraffare’. Il composto la-rig-dab in origine volle significare il tipo di attività delle piattole, le quali succhiano il sangue attaccandosi tenacemente alla parte puberale.
Pádriu log. ‘chiaro, articolato’; ispadriare ‘parlare chiaro, articolare bene i suoni’. Wagner ne ignora l’etimo, pur dichiarando pádriu, per principio, “non indigeno” (spudoratezza di chi, non riuscendo a trovare un etimo, dichiara spurio il vocabolo la cui fonte gli è ignota). Egli cita anche l’interpretazione del Salvioni (lat. pātrius ‘paterno’) e del Rolla (lat. practicus). Come al solito, i miei predecessori scavano soltanto nel latino, anche se poi, come spesso, e come in questo caso, la loro riuscita è fuorviante. Invero, base etimologica di pádriu è il sum. padr ‘rompere, fare a pezzi’. Pádriu è un evidente aggettivale in -iu dall’originario padr, e si riferisce alla capacità del parlante di spezzare bene la catena parlata evidenziando i singoli vocaboli e facendoli intendere pianamente all’ascoltatore.
Pádulu camp. rust. (Sarrabus: corra bádua ‘corna divaricate’): questa citazione è del Wagner (DES II 204). Ma osservo che pádulu è voce inventata al posto di ádulu, bádulu. La b- di bádulu è concresciuta come spesso accade nell’intera Sardegna davanti a vocale (peraltro in Sardegna accade anche l’opposto: es. berbèke > erbéke). Base etimologica di ádulu, bádulu è il sum. ad ‘crippled, zoppo’ + ul (pronome dimostrativo: ‘quello’). Il composto ad-ul in origine significò ‘lo zoppo’ (per l’andamento poco armonioso); evidentemente col tempo s’inventò la metafora anche per le corna scomposte, altrimenti dette in Sardegna corressas (vedi).
Voci tradotte alla carlona. Abbiamo quindi che Wagner talora inventa anche voci inesistenti. Altre volte, inopinatamente, le traduce alla carlona. Faccio un solo esempio tra tanti, per non tediare.
Irrancare log. ‘arrivare, giungere’. Questa è traduzione del Wagner, il quale non solo non mostra alcun etimo, ma prende, come suol dirsi, “fischi per fiaschi”. In realtà le frasi dove si trova questa voce sono le seguenti: irrancare a pisciare ‘pisciare con ostentazione’; irrancu, irrancada ‘pisciata’; unu irrancu e pίsciu ‘un grande arco d’urina, un ponte di urina’ (Casu). Base etimologica è l’akk. reḫû ‘versare, inondare’.
Voci trattate da Wagner sotto un solo lemma. Infine annoto che Wagner praticò il particolare metodo d’intruppare molte parole sotto lo stesso lemma (onde io parlo di “lemmi a grappolo”) per il solo fatto di trovarle molto simiglianti nella fonetica (di ciò ho scritto qua e là nei precedenti paragrafi). Ma il lettore avrà capito che le simiglianze fonetiche tra parole (omofonie) non possono di per sé autorizzare quest’operazione. Tantomeno possono portare a un etimo. Affinché questo possa accettarsi, serve che le parole messe a confronto abbiano in comune un’arcaica antenata che ne comprovi la parentela fono-semantica. L’operazione, insomma, deve disegnare una sorta di triangolo, mettendo ai vertici di base le due voci a confronto, e ponendo al terzo vertice un’altra voce (quella più antica) che riesca ad unirsi semanticamente con gli angoli di base.
Per dare almeno un esempio, elenco quattro voci trattate dal Wagner sotto il lemma soru, dove purtroppo egli ha prodotto un pasticcio. Si noterà invece che le quattro voci sono legate a coppia da due diversi etimi.
Sóru ‘siero’ (del formaggio, della ricotta); (Urzulei) suru ‘ciò che resta dopo la produzione del formaggio’. Wagner ovviamente non dà l’etimo. Il lemma ha base nel sum. sur ‘premere, pressare’ e pure ‘gocciolare, piovere’ (metonimia dove s’indica l’effetto al posto del processo di caseificazione).
Assorare1 log. ‘ingrassare il maiale con siero’. Per l’etimo vedi soru.
Assorare2 (Bitti) ‘essere puzzolente’: ovos assoratos; (Talana) όu assuráu; insuríri camp. ‘idem’: pisci insuríu ‘pesce guasto’. Wagner, con nonchalance, lo apparenta a soru ‘siero (del latte)’, ignorando che il siero non si guasta mai e semplicemente si trasforma. La base etimologica è il sum. šurum ‘litter, dung; immondezza, merda, letame’.
Insuríri camp. ‘guastarsi’: pisci insuríu. Wagner lo apparenta parimenti a soru, mentre la base etimologica è la stessa di assorare2.
La dittatura dell’incompetenza. Il porkeḍḍìno. La Questione della lingua osservata dal basso (ossia, osservata a mente libera da un qualsiasi parlante capace di mettere a fuoco il pensiero dei persuasori che dall’Accademia inventano le regole), viene spesso vista come una dittatura. Nel dire ciò non intendo “politicizzare” il fenomeno linguistico, anche se altri ci hanno tentato e ci stanno tentando, come quei dotti che vorrebbero imporre una Limba de Mesanìa intesa ad unificare i vari dialetti della Sardegna.
Leggendo i primi tre paragrafi, specialmente il terzo (“È possibile sopraffare una lingua?”), il lettore avrà capito com’è difficile sopraffare una lingua. Ciò vale anche per i dialetti (o lingue regionali, o sub-regionali) che la lingua-corifea (o dialetto-corifeo) vorrebbe omologare …o sopprimere. Nel considerare la Questione della lingua, non è affatto secondario il problema dei maestri di cappella. Quanti di loro hanno esperienza e nozioni adeguate ad esercitare il mestiere? A mio avviso, quelli sinora succedutisi non erano buoni emuli di Bach ma orecchianti, gente spaesata che per caso si è ritrovata sul podio a far cantare il coro.
I vari paragrafi di questa premessa metodologica hanno evocato gran parte degli errori di metodo prodotti, a mio avviso, dai miei predecessori in rapporto alla lingua sarda, in rapporto a quella italiana ed in rapporto alle lingue mediterranee. Per far capire meglio che cosa significhi dittatura dell’incompetenza, propongo di analizzare ancora altri due lemmi.
Abbàcchio it. ‘agnello di uno, massimo due anni’; anche ‘agnello arrosto’. La voce entra nei migliori dizionari italiani per il suo prestigio, maturato dall’essere usata in Roma e dintorni; la si introduce nel novero italiano col previo marchio di “romanesca”; per ciò stesso, nell’ambito della lingua italiana essa è individuata quale “civis minoris juris”, perché non è propriamente “italiana”. Adesso assumiamo come ipotesi di lavoro che tale parola fosse soltanto sarda, parlata da 1,6 milione di persone; ebbene, essa non sarebbe nemmeno entrata nel dizionario italiano, neppure se barattata come “civis minoris juris”. Due pesi e due misure.
Questo esempio bipartito basterebbe a far risaltare l’inadeguatezza di un dizionario che vuol essere “nazionale”, che accetta il romanesco e non accetta il sardo. Quale tipo di “nazione” vagheggia quel dizionario? Ed è giustificata l’apartheid riservata ad abbàcchio classificato come “romanesco”? Quale tipo di “scavo archeologico” è stato fatto per accettare infine (sia pure con riserva) abbàcchio tra le voci “italiane”, mentre poi, paradossalmente, lo si è relegato tra quelle “romanesche”? Quanto all’etimo, il DELI acquisisce la proposta che abbàcchio derivi dal lat. ăd băculum ‘presso il bastone’, «dato che, come ci informa Varrone, De re rustica II, 2, 15-18, gli agnellini, dieci giorni dopo la nascita, vengono legati a un palo di modo che, saltando qua e là tutto il giorno, non si facciano male tra loro, e così sono allevati fino al quarto mese, allorché sono svezzati e sono immessi nel gregge». Quindi essa sarebbe voce prettamente latina. In realtà abbàcchio, a parte quell’interpretazione peregrina che qualunque persona sensata rifiuterebbe, è parola mediterranea, italiana, romana, persino sarda, ed ha base nell’akk. bakkā’um ‘belante, lamentoso’. Questa radice si ritrova nella voce greca Baccanti, e pure nel personale sd. Bakis, come altrove ho già specificato nelle mie etimologie. E non serve fantasia ad intuire un certo legame tra l’abbacchio e le Baccanti le quali usavano sbranare ritualmente i giovani animali vivi.
Ancora più eclatante è il seguente esempio relativo a una voce dalla fonetica simile.
Abbauca’, abbacca’ sass. ‘stordire, sbalordire, intontire’: è tuttu abbaucaḍḍu da li midizíni ‘è intontito dalle medicine’; una tzanda abbauccada ‘un papavero appassito’. In log. e camp. abbaccáre, abbaccái ‘rallentare, calmare, calmarsi (es. del vento, del dolore)’; su bentu abbacat. In sass. anche abbraca’ ‘diminuire, scemare’. Cfr. sic. abbacari ‘calmare, cessare, abbonacciare’; calabr. abbacare ‘stare in ozio, avere tempo libero’; così anche a Molfetta, in Abruzzo, nei dialetti italici settentrionali, es. lomb. balcà; in provenzale moderno c’è (a)baucà; cat. (a)balcar. Tutte le citazioni sono di Wagner, il quale respinge l’origine catalana soltanto perché in Alta Italia i Catalani non dominarono. Bontà sua: stando alla sua interpretazione, se i Catalani ci avessero messo il piedino per qualche anno, avrebbero potuto confermare il proprio marchio in tutta Italia, oltreché sulla Sardegna. Modo miope di studiare una etimologia, quello del Wagner. Invero, la parola è mediterranea, con base etimologica nell’akk. baḫû ‘to be thin, be scarce’, anche ‘to make emaciated’. Vedi it. abbacchiato, bacchiato ‘depresso fisicamente o moralmente’.
La vicenda di abbàcchio e di abbacchiare (abbaucca’) lascia comprendere quanto l’Italia sia zeppa di parole recanti la dignità che dovrebbe autorizzare ad usarle nel Vocabolario Italiano senza discriminazioni, senza le ascientifiche distinzioni tra “italiana” e “rurale”, tra “italiana” e “sarda” o “sicula” o “piemontese”.
La lingua italiana ha disperato bisogno di gente che ne comprenda l’esaltante, immensa, folgorante ricchezza perché, oltre a essere italiana, tale lingua è stata primamente mediterranea, e nei tempi arcaici il Mediterraneo era anche, se non principalmente, un mare sardo. Le parole che i Sardi hanno contribuito a forgiare in tanti millenni, sono ancora vive nella lingua sarda, e moltissime sono vive anche nella lingua italiana, sia pure con lievi modifiche di forma o significato. Spesso furono gli stessi Sardi ad introdurle in Italia, ma ciò è ben lungi dall’essere riconosciuto.
È metodicamente deplorevole che la lingua sarda (una lingua con 100.000 voci) sia da troppi considerata minore, mentre quando i Romani presero a forza l’isola essa era ancora in grado di collaborare attivamente al vocabolario mediterraneo. La sua vitalità è stata tale, da riuscire a mantenersi viva sino ad oggi, nonostante cinque colonizzazioni. I radicali comuni a tutto il Mediterraneo ed alla Sardegna lo testimoniano. I Romani hanno continuato per millenni ad usare le parole sarde. Nel mentre arrivò il Medioevo, superato il quale, l’Italia (+ la Sardegna) si scoprì zeppa di lingue (che ora gli studiosi, per disfarsene, chiamano dialetti). Nessuno più è in grado di capire che l’Italia era ed è composta da 32 lingue + la variegata lingua sarda + quella siciliana. Occorrerebbe gestire queste lingue in una visione unitaria ed inclusiva, se è vero che si pretende l’unità politica degli Italiani. E che fanno invece i dizionari italiani? Continuano a distinguere senza criterio, e persino ad escludere senza criterio, senza nemmeno sapere quanta vita in comune abbiano avuto le parole distinte od escluse. I dizionaristi operano alla cieca. Quando si dice dittatura dell’incompetenza…
È tale e tanta la dittatura dell’incompetenza, che l’imposizione e la conta delle parole accettate e di quelle rifiutate è una moda alla quale si applicano le migliori accademie, a cominciare dall’Accademia della Crusca. Alla quale – per quanto nata agli inizi del ‘600 per tutelare esclusivamente la lingua toscana – nessuno si sognerebbe di negare autorità e meriti. Nessuno oggi si sogna di obiettare alcunché a tale Accademia, anche perché il suo lavoro è diventato sempre più inclusivo sino alla quinta edizione ed oltre.
Ma che significa oggi includere, quando l’inclusione riguarda soltanto l’uso scrittorio anziché badare all’uso parlato delle numerose lingue italiche nell’ambito di un’unica nazione?
È tale il disastro fatto dalle Accademie, che troppi Sardi avvertono disagio nel parlare l’italiano, nell’usarlo senza remore. Avvertono di essere dominati da processi porkeḍḍìni, maccheronici. Nessuno si rende conto che un tempo tali processi erano non solo ammessi ma favoriti, essendo spesso gli unici processi che appianavano l’incontro tra portatori di idiomi diversi nell’ambito di una sola Koiné.
Porkeḍḍínu log. e camp.; puχeḍḍínu log. e sass., agg. ‘bastardo, maccheronico’ (riferito al modo di parlare, al discorso); itariánu puχeḍḍínu ‘italiano maccheronico’, fabiḍḍa’ puχeḍḍínu (avverbio) ‘parlare in maccheronico’. Il termine non è registrato nei dizionari, anche perché risulta ostico ai linguisti questo termine paronomastico riferito stranamente ai ‘maialetti’ (porkeḍḍus).
La base etimologica è invece l’akk. puḫḫu(m) ‘scambiare, sostituire’ < pūḫu ‘scambio, sostituzione’ + (w)ēdu(m) ‘singolo, solitario; hapax’: stato costrutto pūḫ-ēdu, col significato di ‘singola sostituzione (di vocabolo)’; vedi pure akk. pūḫizzaru ‘scambio equivalente’. Quindi il sass. itariánu puχeḍḍínu significa ‘italiano sostitutivo’ ossia parlato sostituendovi una o alcune parole della lingua sarda.
Ebbene, il rifiuto e la demonizzazione del porkeḍḍìno devono cessare immantinente! Il porkeḍḍìno deve essere ammesso!, anche dalle Accademie!, come procedura strutturale nella comunicazione verbale. Nessun sardo deve sentirsi discriminato. Anche perché, focalizzando l’uso che si fa dell’italiano non in Sardegna ma nella Penisola, notiamo che tutti i Continentali (sos Terramannésos) si esprimono reciprocamente tra di loro senza alcuna remora, nonostante che si percepisca molto spesso il loro ancoraggio indefettibile alla lingua del proprio territorio. Nessuno di essi se ne vergogna, e nessuno dei “puristi” s’adonta nell’ascoltarli. Anche loro, tra Italiani, parlano porkeḍḍìno.
Nell’osservare e mettere a confronto il fenomeno dell’incompetenza e dall’altra quello del porkeḍḍìno, percepiamo soltanto i cachinni degli idioti, i quali credono d’essere aquile mentre sono ridicoli polli. Gli idioti sono facilmente identificabili tra certi giornalisti o certi attori i quali, avendo ricevuto un’educazione stringente e rigorosa all’uso di quella che gli è stata additata come “lingua italiana”, mettono sempre alla berlina la gente più in vista (parlamentari, ministri, uomini e donne di successo) per la loro “alienità”, per la distanza tra la loro parlata e la cosiddetta “lingua italiana”.
Io chiamo ciò dittatura dell’incompetenza, poiché questi giornalisti ed attori sono stati assoggettati alla dittatura del buon dizionario, della buona vocalità, alla dittatura di una grammatica e di una sintassi ritagliate su misura. Con tale formazione, quei saputoni non si rendono conto che l’avverbio KE usato al Sud Italia al posto del SE toscano ha lo stesso valore, ed è identico al KI campidanese (segno di una Koiné mediterranea plurimillenaria). Parimenti, quei giornalisti sono lungi dall’avvertire d’essere immersi nel brago dell’ignoranza allorché criticano la gente del Sud Italia per il fatto che “maneggiano male” la sintassi italiana. E non sanno che la sintassi “italiana” ricalca la falsariga della sintassi latina (la sintassi del latino ciceroniano), mentre gli Italiani del Sud, eredi della lingua greca, non subirono mai una sintassi così rigorosa e limitante, visto che l’antica lingua greca preferì la massima libertà d’espressione, la quale spessissimo si risolveva, persino nei massimi scrittori antichi, con forme sintattiche molto simili a quelle dell’attuale inglese, saltando a pie’ pari le forme congiuntive e condizionali. Imporre a quelli del Sud una grammatica e una sintassi ancorate al latino, è una violenza.
La purezza della lingua. Il campidanese rustico. I due paragrafi precedenti sono legati in certo qual modo alla “purezza della lingua”, la quale a sua volta non può scindersi da tutte le considerazioni sin qui fatte in questa premessa metodologica. Stiamo imparando che i dotti che pretendono padroneggiare la questione della purezza sono molti ma alquanto impreparati.
Paradossalmente, Wagner fu il più grande scopritore della “purezza” sarda. Dico paradossalmente, perché anche lui fu legato alla moda prevalente di chi vuole abbandonare le lingue minori alla libera invasione da parte delle lingue dominanti, senza alcuna cura di proteggere il patrimonio storicamente costruito nei millenni. Oggi migliaia di parole inglesi s’introducono nella lingua sarda, nella lingua italiana, nelle lingue non più egemoni nelle faccende internazionali. L’inglese è fenomeno che tarla da 60 anni. Ma l’italiano tarla il sardo da 3 secoli. Certamente le accademie (ad esempio la Crusca) hanno fatto del loro meglio per scacciare il tarlo dalla propria lingua. Ma sono voces clamantis in deserto, nel bene e nel male. Epperò è una fortuna che l’Italia abbia una accademia. Mentre la lingua sarda non ha alcuna protezione accademica (mi rifiuto di chiamara “accademici” gli attuali linguisti delle due Università sarde). La Sardegna non è Israele, che difende la propria lingua ed i propri vocaboli con tutti i mezzi possibili: fare buona politica significa anche questo. Ma occorre attenzione e distinzione, poiché Israele fonda la propria accademia con degli scopi peculiari. Noi in Sardegna, se vogliamo puntare a una nostra “Crusca”, dovremo farla operare solo ed esclusivamente nel vasto e fruttuoso ambito che ho tracciato in tutti i paragrafi precedenti. Altrimenti quell’accademia produrrà soltanto… crusca.
Il mio compito di etimologo non può affatto prescindere dalla difesa del patrimonio linguistico consolidato dai Sardi. Nel far ciò, mi sono chiesto quale sia il patrimonio da difendere e quali vocaboli spuri da “rispedire al mittente”. Anch’io ho dovuto fare una scelta, cominciando ad espellere dal Dizionario del Wagner 690 voci, che ho messo a disposizione, per il controllo da parte del lettore, nell’Appendice a questa premessa (v. infra).
Di questo “taglio” (pari al 10% dei lemmi trattati dal Wagner) mi assumo piena responsabilità. E dichiaro, addossandomi anche qui la responsabilità, che lo smalto della lingua sarda con tale operazione non è stato del tutto rilucidato. Rimangono ancora delle opacità. In quest’ottica, mi sono assunto la responsabilità di dichiarare come accatti almeno il 15% tra i vocaboli da me risparmiati entro il corpus del Wagner e trasferiti entro il mio Dizionario. E così siamo al 25% dei lemmi che furono accolti dal Wagner e da me rifiutati (o accettati col marchio). Insomma, io dichiaro accettabili nel patrimonio consolidato della lingua sarda soltanto i ¾ dei lemmi proposti dal Wagner, oltre a qualche migliaio di voci sinora indagate per mio conto.
A giustificazione dell’operazione da me condotta, dichiaro di ritenere assurdo l’introdurre in un vocabolario le voci spurie, appartenenti più propriamente a un altro vocabolario. So perché Wagner le introdusse nella lingua sarda: egli le considerava acquisite dall’uso sardo. Ma è proprio a questo punto che s’erigono le barricate e si scatenano i conflitti. Un conflitto che non si placa barattando la percentuale degli accatti (mille in più, mille in meno, come dire che Wagner avrebbe sbagliato per eccesso o per difetto): non siamo al mercato delle vacche. Io dichiaro che Wagner eccedette per una ragione ben precisa: la sua conoscenza diretta della lingua sarda parlata dalle genti paesane e montagnine era poco profonda. Voglio dire che Wagner peccò d’ignoranza (nonostante la sua grande erudizione), non avendo indagato a sufficienza la lingua sarda, ed avendo tralasciato l’indagine diretta in numerosissimi villaggi. Ciò si evince anche dal DES, dove egli cita come fonti dirette meno di 40 villaggi, quelli un tempo serviti da strade percorribili con mezzi a motore. Ne rimane fuori il 90%.
Per intenderci, Wagner svolse la seguente operazione: prima dell’indagine diretta trasferì nel DES tutti i vocaboli acquisiti (e tradotti) dai suoi predecessori nelle loro indagini, in qualsiasi forma condotte. Per il campidanese egli acquisì, oltre ai lemmi delle Carte Volgari, tutto il Dizionario del Porru, senza tener conto che Porru, cent’anni prima, aveva già infarcito per suo conto il proprio Dizionario con una gran massa di vocaboli italianeggianti. Questo fu il primo errore del Wagner, poiché il Porru non aveva infarcito il Dizionariu con gli accatti liberamente adottati dagli indigeni. No, non lo aveva fatto. Porru aveva infarcito la sua opera di voci italiane scelte da lui (non dal popolo) con l’intento ideologico di spurgare la parlata campidanese dai vocaboli che considerava troppo rustici o popolani. Porru fece un gigantesco errore metodologico, una “pulizia etno-linguistica” che io ho già denunciato al cap. 1.1 della mia Grammatica Storica; a sua volta Wagner trasferì nel DES quel macroscopico errore, nonostante che ne fosse avvertito, poiché il Porru aveva dichiarato esplicitamente il proprio intento nella prefazione al Dizionariu.
Potrei continuare indicando le altre fonti del Wagner, anch’esse nutrite d’inserimenti spuri ed ideologici, sia pure non dichiarati con sicumera secondo lo stile del Porru. Davanti a tale sfacelo metodologico, mi è stato forza intervenire sul Wagner con tagli o esplicite avvertenze.
Oltre agli italianismi, Wagner introdusse nel DES anche numerosissimi catalanismi e spagnolismi. Molti di questi sono accatti (valutabili al 15% dei lemmi del DES). Ma qui è più arduo stabilire se l’accatto sia stato operato dal parlante sardo, oppure sia stato Wagner ad aver forzato la situazione, inserendolo nel DES con atteggiamento ideologico, replicando il comportamento ideologico del Porru. Infatti sappiamo con quanta protervia Wagner sostenne che la lingua sarda fosse stata iberizzata fino al midollo. Il suo “derivazionismo” filo-iberico non è accettabile, e l’ho già dimostrato e discusso in alcuni dei paragrafi pregressi, specialmente in quello intitolato “La pregiudiziale iberica”.
Al riguardo, l’unico grimaldello in grado di evidenziare, schiavare e mettere “con le spalle al muro” i troppi accatti del Wagner è la considerazione che l’indagine fatta dal Wagner sulla lingua sarda partì sempre dalle città, specialmente da Cagliari quale “capofila” del Campidano meridionale; Oristano quale “capofila” del Campidano centrale; ed anche Nuoro come “capofila” della parlata nuorese. Una cartina di tornasole privilegiata, per lui, fu sempre Alghero per la testimonianza della pervasione catalana sulla lingua sarda. Operazione scorretta, quella di Alghero. Ma furono scorrette anche le altre “basi” di partenza, che invece per lui costituivano dei veri capisaldi culturali, le fonti da cui la lingua sarda s’irradiava contaminando il contado, il mondo dei villaggi, il mondo delle montagne. Un’operazione, la sua, che fu esattamente contraria a quanto una indagine scientifica sulla lingua sarda avrebbe dovuto fare. Questo è almeno il mio parere.
Infatti, tenuto conto che la lingua sarda esiste viva e vegeta da almeno 40.000 anni grazie al diuturno uso dei montagnini, dei pastori, degli agricoltori, pretendere di considerare le città (specie quelle costiere) quale base d’irraggiamento della lingua sarda verso l’interno significa dimenticare che le città furono prese e ripopolate ab imō dapprima dai Romani, poi da Pisani e Genovesi, poi dai Catalani, poi dagli Spagnoli, poi dai Torinesi e dagli Italiani. Wagner non tiene conto che furono invece le città a ricevere volta per volta la genuina linfa dell’autoctonia da is biḍḍáius, dai biḍḍíncuri che via via le ripopolarono di elementi genuinamente sardi, scacciando gradatamente, se non tutti, almeno parte degli elementi coloniali.
Oggi non è più tanto facile, se non in pochi casi, distinguere tra accatto operato dai Sardi e accatto operato dal Wagner. Però nel mio Dizionario ho tentato – molto prudentemente – di farlo. C’è peraltro un macro-elemento che aiuta la mia cernita ed àncora la mia indagine alla procedura scientifica: è l’elemento del “campidanese rustico”, patrimonio prezioso che spesso è testimone dell’antichità (e sardità) del vocabolo. Wagner distingue spesso tra “campidanese” e “campidanese rustico”. Fa questa distinzione nella presunzione che il prototipo sia sempre quello “campidanese” (la parlata del Campidano di Cagliari), al quale affianca con pari dignità il “cagliaritano” parlato in città. Insomma, la parlata del Sud viene da lui tripartita, e da tale operazione si apprende che il “campidanese rustico” per Wagner rimane sempre un sotto-tipo, un elemento corrotto, una dimensione retrograda vissuta da gente poco capace di fare la storia di una lingua.
Io, come si è visto, la penso al contrario del Wagner, anche se nel presente Dizionario ho preferito spesso intruppare sotto l’unica qualifica “campidanese” i lemmi marcati dal Wagner come “campidanese rustico”. Tenuto conto che il cosiddetto “rustico” ha inflessioni particolari, difficili da rendere graficamente (specie per San Vito), ho evitato di scrivere gli strani caratteri usati dal Wagner, poco utili alla percezione da parte del lettore. Ho preferito invece scrivere quei vocaboli come ho scritto i consimili del Campidano di Cagliari, senza contrazioni né “colpi di naso” (operazione che ho replicato anche quando ho dovuto evitare i “colpi di glottide” del nord-Barbagia). Il fatto che la maggior parte dei vocaboli sarrabesi e gerreini siano condivisi anche dal Campidano di Cagliari (poiché condividono le stesse radici), può considerarsi quasi sempre una reciproca garanzia di autenticità. Nei rari casi in cui il vocabolo appaia solamente come “campidanese rustico”, a maggior ragione l’ho registrato per la sua preziosità. Tutto ciò è bastante per un etimologo.
Tutto quanto precede, però, sarebbe stato incongruo dirlo per la difesa della lingua italiana; tanto più incongruo lo sarebbe per la difesa della lingua inglese, oggi dominante nel mondo. Le lingue, purtroppo, non convivono tutte paritariamente. Non è vergogna ammettere che tra di esse c’è una scala, e la lingua dominante tende inesorabilmente a comprimere, erodere, annebbiare, sminuire, infine abolire la lingua minoritaria contigua. È un po’ lo stesso fenomeno della foresta. Le piante nobili sono tali perché crescono sotto la protezione del sottobosco. Ma poi s’evolvono, superano in altezza il sottobosco, ricoprendolo infine con una vasta chioma. È quindi il sottobosco ad essere dominato e “tenuto a bada”, quando non impoverito per l’assenza della luce catturata dalla chioma dominante.
Fuor di metafora, va detto che una lingua minoritaria non ha bisogno di una vaga “liberta”, impossibile da gestire al confronto con le lingue egemoni; ha bisogno invece di protezione (da non configurare come una campana di vetro!). Pertanto sono da condannare sotto ogni punto di vista le assurde “libertà” cui le sottopongono certi dottori in Lettere, i quali hanno della lingua (di qualunque lingua) una nozione gracile e bettolesca, priva di rigore scientifico. A maggior ragione le lingue minoritarie sono nemiche di ogni tipo di slang, poiché l’invenzione dello slang da parte di buontemponi incapaci di mettere a valore il proprio tempo libero, è perniciosa, deleteria. Infatti lo slang viene orecchiato e imposto proprio dai parlanti meno motivati all’uso e alla salvezza del “thesaurum”.
Il “thesaurum” della lingua sarda c’è, è cospicuo, è saldamente ancorato a radici plurimillenarie che ancora oggi si lasciano esattamente comprendere. Andare a inventare di sana pianta forme “sradicate” (lo slang, appunto) è operazione demenziale che porterebbe prestissimo alla sparizione della Lingua. Lo slang medesimo è di per sé una miserrima operazione anti-culturale prodotta da chi non ha alcun amore né rispetto per la cultura, da chi, per intenderci, ha già resecato il cordone ombelicale con la lingua-madre e di essa si fa sarcasticamente beffe con segni di dispregio e di commiato definitivo.
L’ortografia sarda e sa Limba Sarda Comuna. Nella lingua inglese esistono circa 40 suoni fondamentali, ma le forme ortografiche per rappresentarli sono oltre 500; non è un caso che i bambini inglesi siano molto più soggetti di quelli italiani alla dislessia: un disturbo neurologico non da poco. La complessità del sistema di scrittura anglosassone rende incapaci molti residenti di leggere e comprendere un intero scritto pur comprendendo ogni singola parola. In Italia la situazione è notevolmente migliore perché la differenza tra pronuncia ed espressioni ortografiche è meno astrusa, e semmai capovolge il rapporto numerico.
La Sardegna, dopo 1000 anni di anarchia ortografica, si pone soltanto oggi il problema del rapporto tra espressione fonica e corrispondenza ortografica, e con le regole della LSC (Limba Sarda Comuna) vorrebbe mirare a semplificare ulteriormente, rispetto all’italiano, il rapporto suoni/ortografia. Senza però riuscirvi appieno. Infatti il sistema LSC incorpora parte del sistema italiano (e parte del sistema spagnolo), lasciando nel caos – per fare un esempio – la grafia delle velari e delle palatali. In questo Dizionario il mio sistema tenta di sanare almeno in parte quelle discrasie normative della LSC.
A scanso di equivoci, avverto il lettore che i singoli lemmi del mio Dizionario non vengono scritti utilizzando i caratteri fonetici internazionali (i quali sommano a circa 300), anche perché essi mancano sulla tastiera del computer e comunque genererebbero nel lettore più confusione che rilassatezza. In omaggio a Wagner, concedo eccezionalmente alle dentali sonore sarde l’espressione grafica -ḍḍ-. I miei lemmi sono di regola scritti con i pochi caratteri storicamente attestati nel Mediterraneo centro-occidentale, al fine di agevolare il lettore a capire istantaneamente la parola espressa, evitandogli d’impelagarsi in un sistema tecnico inventato dai fonetisti, del quale è destino che siano gli stessi fonetisti a rimanerne fruitori unici. Ho inoltre scelto, stavolta in omaggio al sistema della LSC, di non scandire i lemmi col sistema accentuativo internazionale (quindi non in-kendere ma inkèndere; non inkime-rare ma inkimerare).
Il sistema grafico da me adottato, disancorato dalla pletora delle grafie internazionali (e con l’occhio indulgente alla ridotta disponibilità della tastiera), si trascina pur sempre delle imprecisioni residue. Ma questa maledizione perseguita anche i grammatici di buona volontà, non essendo tecnicamente possibile ridurre a tre decine i 300 caratteri fonetici, senza che ciò comporti delle “sbavature” grafiche rispetto alla pletora dei suoni idiomatici, che in Sardegna superano largamente i 30. Ma spero di avere proposto, rispetto alla LSC, un numero di caratteri che, per quanto pari a quelli della LSC, giungano a un climax più equo, tale da permettere all’utente di comprendere meglio il testo sardo, senza alcun disturbo percettivo.
Termino le avvertenze sulla grafia con un cenno alle consonanti rafforzate (le doppie). La LSC tende a renderle tutte scempie, salvo eccezioni che rendono ondivaga la scelta, dal momento che prende a modello le forme latine ed al contempo se ne libera a piacere, senza criterio. Notiamo che la LSC giustifica la sua originale “aspirazione alla semplificazione” con (non meglio chiarite) “esigenze etimologiche”. Esprimo sconcerto dinanzi a quelle affermazioni, dal momento che la fonte etimologica della LSC rimane saldamente ed unicamente il latino, il quale peraltro nel proprio sistema contiene sia le scempie sia le doppie.
Al riguardo ho ampiamente fatto osservare in questa premessa metodologica che delle etimologie, in Italia e in Sardegna, è stato fatto un autentico vituperio. Anche sulla vicenda delle scempie/doppie sarebbe ora di stendere un velo pietoso.
Tocca a me, a questo punto, dichiarare responsabilmente la mia scelta al riguardo. Ebbene, al contrario della LSC, dichiaro di utilizzare le doppie, ma limitatamente ai momenti in cui ciò serve veramente. In tal guisa, spero che la mia scelta non presenti alcun carattere ondivago, avendo legato le eventuali doppie al vero etimo della voce. Per l’occasione ho tenuto conto di un fatto a un tempo storico e tecnico, ossia che le doppie, almeno nella tradizione italiana, sono spessissimo il risultato dell’incontro di due consonanti differenti appartenenti a sillabe differenti (es. -c-t-, -p-t-, -d-c-). Tale ragione storico-tecnica m’induce a non sottovalutare la tradizione scrittoria dell’italiano, dalla quale attingo fintanto ch’essa non debordi dal quadro di coerenza appena citato.
Peraltro nessuno ha mai criticato l’uso di scempie e doppie fatto dal Wagner (un uso anch’esso trascurato, quindi ondivago). Come unico esempio indicherei fittianu, che in base alla vera pronuncia ed in base alla vera etimologia deve essere scritto fitianu.
Presento di seguito l’elenco dei 30 segni grafici da me adottati. Parecchi di questi meritano delle precisazioni per i problemi che pongono alla lettura dei testi in lingua sarda.
Elenco: A, B, C, D, E, F, G, GH, GL, GN, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, SC, T, U, V, X, Θ, Z, TZ.
Precisazioni
1) Il segno B non si presta a molte varianti, tranne che nel logudorese settentrionale e specialmente nel sassarese, dove esprime non soltanto la /b/ vera e propria ma anche molte voci dove la /b/ s’avvicina alla /v/ e spesso sosta in una terra di mezzo, svanendo in una spirante bilabiale appena soffiata (quasi come fanno i cubani per pronunciare La Habana).
2) Il segno C
Wagner usa questo segno, espresso però con /č/, soltanto per indicare la consonante palatale o comunque per esprimere la consonante seguita da vocali palatali. Esempi: dίccia (che Wagner scrive dίčča), dispacciare (Wagner: dispaččare), ciorixeḍḍa (Wagner: čorižèḍḍa), círcuri (Wagner: čírkuri).
Io, come si noterà, seguo l’esempio italiano, usando c-, -c- sia per le velari sia per le palatali nei vari casi che ora vado ad esplicare:
- anzitutto con c-, -c- marco la palatalità sia della consonante sia della sonante successiva (es. cibíu);
- con c-, -c- esprimo anche le velari nei casi in cui la sonante seguente non sia palatale: es. casu, cosa. Escludo l’uso della c-, -c- per le velari seguite da -u- + sonante (per questo gruppo uso qu-: vai al punto 11).
La mia scelta semplificante ha una ragione storica importante ed unificante, cioè che C è grafema latino di estrema antichità, avente lo stesso valore (ed essendo la semplificazione grafica) del gr. K. Non solo, C è lo stesso segno della velare ebraica kaph (scritta a rovescio: Ͻ). Quindi la tradizione dell’uso di questo segno è plurimillenaria e mediterranea. Che poi dall’Alto medioevo la C sia usata anche per le palatali, è segno che la cultura latina non sentì mai il bisogno di sdoppiare questo grafema.
3) Il segno D
Tutte le volte che una parola sarda esprime un’alveo-dentale rafforzata, Wagner scrive /ḍḍ/, come in biḍḍa. In ciò ho seguito fedelmente Wagner. In certe sub-regioni o in certi villaggi c’è qualche leggera variazione nella pronuncia della consonante /d/. Wagner lo fa osservare, e pertanto scrive moltissimi vocaboli in -đ- (es. biđale ‘ditale’; io scrivo bidale).
4) Il segno G
È scritto dal Wagner con ğ quando esprime l’affricata prepalatale sonora, come nell’it. gente. Es. gáğğu (Dedola: gággiu). Altre volte è scritto col suono velare sonoro fricativo: es. fóiǥa (Dedola: fóiga).
5) Il segno GH
Viene espresso dal Wagner col segno occlusivo velare sonoro davanti ad e, i: ĝiníperu ‘ginepro’ (Dedola: ghiníperu). Altre volte è scritto col segno velare sonoro fricativo: diǥitale (Dedola: dighitale).
6) Il segno GL
Wagner lo scrive col carattere l’ (palatale, come in it. figlio). Io preferisco l’uso italiano gl.
7) Il segno GN
Wagner scrive /ñ/: es. diñu (Dedola: dignu), diéñu ‘zimbello’ (Dedola: diégnu). Altre volte Wagner scrive n’ (da leggere come in it. vigna). Io preferisco sempre -gn-, perché la -ñ- manca nella tastiera del computer, e perché n’ non appartiene alle tradizioni mediterranee.
8) Il segno J
Questo segno è da me preferito rispetto ad -y- che invece è usato a piene mani dal Wagner. La ragione è semplice: i vocaboli del Wagner in -y- sono soggetti a frequenti metafonesi che li fanno pronunciare con -j- (come j francese o inglese). Di qui la mia preferenza. Es. yáyu ‘nonno’ (Dedola: jáju, poiché la prima semiconsonante in sardo è pronunciata spessissimo -g- come in it. gente).
9) Il segno K
È da me usato per le velari precedenti le palatali /e/, /i/, e soltanto per queste. Ciò per non sottostare al doppio carattere italiano ch- -ch- preferito invece dalla LSC. La mia preferenza è in linea con l’identica pratica dei condaghes e di altre carte antiche della Sardegna. Peraltro questa scelta rispetta la natura velare del carattere, nonché l’identico uso presso gli anglosassoni.
A sua volta Wagner, nell’esigenza di evidenziare qualsiasi tipo di velare, usa largamente la /k/ davanti ad ogni vocale; quindi kaduffu (Dedola: cadduffu), kasu (Dedola: casu), kena (= Dedola), kida (= Dedola), kokka (Dedola: cocca), kras (Dedola: cras), kunnu (Dedola: cunnu), kuḍḍu (Dedola: cuḍḍu).
10) Il segno L
Oltre agli usi normali della grafia italiana, questo segno è da me proposto talora nell’uso sassarese con grafia Ł, ł, ogni qualvolta io intenda esprimere la /L/ fricativa laterale, quella che precede -t-, -d- esplodenti dopo il “fregamento” laterale della lingua (v. fałta, fałdetta). Gli stessi grafemi sono da me utilizzati, sempre per il sassarese, per esprimere l’incontro di -r-t- o -r-d-; es. lardu log. e camp. ‘lardo’, sass. lałdu.
11) Il segno Q
Intendo fermamente proseguire nell’uso di Q, nonostante che le norme della Limba Sarda Comuna (ed. 2013, p. 17) lo vietino favorendo al suo posto lo spagnolesco C (es. cuadru, cuatru, ácua). La velare Q si trova primamente nell’uso delle lingue semitiche (accadico etc.: le quali addirittura hanno quattro segni per distinguere quattro velari: q, k, ḫ, ḥ); poi la stessa Q si ritrova nell’uso latino, e passa nell’uso grafico italiano. Ciò basta ed avanza per rifiutare l’imposizione della LSC, che va nella direzione di nobilitare acriticamente la moda spagnolesca inaugurata partigianamente dal Wagner.
12) il segno S
L’orecchio del Wagner era indubbiamente addestrato a percepire le minime differenze fonetiche. In tal guisa, il vocabolo da me scritto sderroccái da lui è scritto śderroccái (ś alveolare); il vocabolo da me scritto dismajare è scritto da lui diśmayare. (Per meglio comprendere la y del Wagner vai a j).
13) Il segno SC
Wagner scrive sempre š. Io ho preferito la complicata sc, sci (all’italiana). Quindi: Wagner šorroccái (fricativa dentale), Dedola sciorroccái; Wagner šorái, Dedola sciorái. Peraltro š non esiste sulle mormali tastiere del computer.
14) Il segno X (= gr. χ)
Giusto l’ampio uso fàttone dal Wagner, c’è bisogno d’introdurre questo grafema al fine di rendere meglio i suoni del dialetto sassarese, che del grafema hanno bisogno per esprimere il log. o sd. -rc-, -sc-. Quindi: log. barca → sass. baχa; log. áscamu → sass. áχamu.
15) Il segno X (= fr. j)
Wagner lo rende con ž-, -ž- (es. čorižèḍḍa, ážina), mentre io preferisco la -x- (es. čorixèḍḍa, áxina). La mia preferenza è dovuta al fatto che da parecchi secoli in Campidano si usa la grafia -x-, ed inoltre quest’uso è identico a quello degli Etruschi; storicamente è tramandato anche dai Catalani. Quindi nel Mediterraneo questo carattere non fu affatto sconosciuto, e non c’è bisogno di sostituirlo con una innovativa ž, peraltro inesistente sulla tastiera del computer.
16) Il segno T
Anche questa esplosiva interdentale, che sembra pulita e inconfondibile, in Sardegna presenta qua e là qualche variante fonica che la riconduce agli usi da me raggruppati sotto il segno θ. Vedi le alternanze rilevabili per uno stesso omo-semantema, quale sd. tanda/tzanda ‘papavero’; sd. tumu/gr. θύμος ‘timo; sd. tura < sum. zur ‘nerezza’.
17) Il segno Θ
Segno greco introdotto da Wagner per distinguere certi fonemi appartenenti ad unica radice, da lui espressi variamente per le varie sub-regioni coi simboli tz, z, zz, th, tt. Esempio: aθθéθθu (Bitti, Nuoro, Dorgali), θénθu (Baunei), distinti da atténtu, attéttu log., atzentzu (S.Lussùrgiu), séntzu camp. ‘assenzio’ (Arthemisia absintium). Wagner con la lettera θ volle indicare l’esplosiva dentale simile alla th inglese. Ho accettato di scrivere la θ quasi le stesse volte del Wagner, pur non condividendo la sua rigorosa esigenza distintiva; esigenza peraltro non necessaria, bastando volta per volta l’uso di una o dell’altra consonante da me qui riprodotte per esprimere la reale pronuncia espressa nelle singole sub-regioni.
18) Il segno Z
Indica esclusivamente la z-, -z- sonora come in ziru ‘orcio, giarra’, eventualmente rafforzata (-zz-) come in azzu ‘aglio’. Wagner la esprime con dz-, -dz-, rafforzata in ddz-, -ddz-.
19) Il segno TZ
Indica esclusivamente la tz-, -tz- sorda (in italiano: z- -zz-) come in tzaccare ‘fendere, spaccare’, o atzárgiu ‘ferro, acciaio’.
La tz (esplosiva dentale sorda) è stata espressa nella lingua sarda in vari modi, anche con i caratteri ts: vedi log. ant. dirittsadores (Stat. Castels.: diriçadores). Sembra che Wagner prediliga proprio la forma ts, tts, con la quale egli ha scritto moltissimi vocaboli da me espressi invece con la tz.
APPENDICE: Elenco lemmi del D.E.S. esclusi dal No.F.E.L.Sa.
Abate, abbáttiri, applikare, appoggiai, apporkai, apostadamente, appraniare, appresare, appretziare, appuntare ‘cucire leggermente’, aranguitzu, arantzu, arkette, arkibusu, arcione, ardidu, arengu, arghentu, arghidda, arguire, argudzinu, arma, armigoddu, arrabbiare, arrancare2, arrapillai ‘ripigliare’, arrappiare ‘rapire’, arrecabai ‘ricavare’, arrefa, arregordai, arrembumbare, arremusulla, arrèndirisi, arrenomenai ‘nominare’, arrepentire, arrivare, arritzare, arruffare, arrughire, arrustire, arte1, ascultare, ásinu, asma, asperges, aspersorio, aspettare, aspu (e naspu), assaltare, assazzare, assembrare, ássidu ‘acido’, assistere, assuntu, asta, astile, ástiu, astutu, asurru ‘azzurro’, ascendere, ascensione, asciugare, asciuttu, asuttu, attaccare, attediare, attenticare, atterrire, attilladu, attuffare, atturdire ‘stordire’, ausente ‘assente’, autu ‘atto’, avarìa, avaru, avemaria, avidu, avvalirisì, avvértere, atzéndere, azzuttare ‘aiutare’. Totale 81
Baccánu, bagamundu, baia, baiu, balaustru, baldanza, baleriana, balire ‘barile’, balordu, baluardu, banchina, baraunda, barbaridadi, barbéri, barbugliai, bardadura, bardottu, barella, bártziga (gioco di carte), basìlica, bassottus, basta, bastarda, bastardu, bastimentu, bastinu, battazzu, báttere, battéu, beccàccia, beffa, belare, belladonna, benignu, benzìna, berrùga ‘verruca’, bessare ‘versare’, béstia, beta ‘bietola’, bicicletta, bidriólu ‘vetriolo’, bile, bìglias ‘biglie’, binistra ‘ginestra’, biscottu, bisquadru, bistorinu ‘bisturi’, bistrattare, bizzarru, blandu, blusa, bóccia, boda ‘botte’, boga (pesce), bomba, bonatza, bòo, borbottare, boscu, botta ‘colpo’, bottáju, bravata, bravu, brίcola1, briglia, brindare, brogliatzu ‘brogliaccio’, bróu, bruncu1, brunu, bruscu, bùccia, búcculu, bugliólu, bùiu, burdellu, burdone ‘contrabbasso’, buriàna, burίnu ‘bulino’, burò ‘canterano’, burrasca, burru ‘gioco di carte’, burtsu ‘polso’, buttìglia. Totale 80
Cabanna, caffè, calafattare, calamari ‘calamaio’, calamidade, calancà (sorta di tela), caldaròne, caldu ‘brodo’, calìgine, calma, calmúk, calòre, calùra, calvu, caltzare1, caltzettéri, caltzoláju, caltzones, camúsciu ‘camoscio’, canavácciu, cannétu, cannocciale, cantârida ‘cantaride’, caparra, capigliè, capitanu, capòccia, cáppara!, cappella, cappellanu, cappone, cappuccínu, carabinéri, caramella, cárdine, carésima, carestìa, caríssia ‘carezza’, carreyone ‘carnagione’, cartúccia, casacca, casána, cáspita, cassarola, càssula, castorru ‘cappello di castoro’, cáttara!, cautela, cavessa ‘cavezza’, céfalu, centáura (Centaurium), cérnia, cértu ‘certo’, cicculatta, cimitériu, cinematόgrafu, cipressu, ciuffu, ciurma, cognakki ‘cognac’, collana, còllera, colore, colostru, comunigare ‘comunicare’, congeniái ‘convenire’, coniurare, conkistare, conservare, contentu, contestura, controvérsia, coraḍḍu ‘corallo’, corággiu, coroḍḍa ‘corolla’, corrèggere, corrugái, coscίnu ‘cuscino’, crésima, crespu ‘tela di seta’, criantza, cricca2, cricca3, crίmene, crine, crista, cristallu, cristèle ‘clistere’, cristianu, Cristu, crosta, cuaglia, cuartu, cubare ‘covare’, cullega, culpa, cumbattàre, cumbáttere, cumpagnu, cumparare, cumprèndere, cundennare, cunduttu. Totale 110
Damascu, dantsare, debusciau, deféndere, déntike ‘dentice’, determinare, devastare, dilúviu, din ‘danaro’, discípulu, discretu, dispéndiu, dispettu, donzella, dossu ‘dorso’, dottrina, duana ‘dogana’, dulcamara. Totale 18
Ecclisse, èdera, érpice, escluíri, esécuias, esigíre, esímere, espressare ‘esprimere’, estínghere, estremuntsiòne, evangéliu. Totale 11
Faccenda, fagottu, falcone, fangu, fantasma, farina, fellone, feluga ‘feluca’, fiancu, fiera, fiducia, filone ‘astuto’, flanella, flemma ‘spurgo del catarro’, fléttere, fluíre, fluttu, folada ‘folata’, fonte, forgiái ‘foggiare’, forma, formica, frana, frángia, frotta, fundare, furtu, furúnculu, fuscu. Totale 29
Gábbia, gabella, gabellottu, gaḍḍína, galibardìna (varietà di gallina), gagliardu, garitta, gasetta ‘gazzetta’, gelosu, gentziana, ghiácciu, ghirlanda, giallu, giarrettéra, giassintu ‘giacinto’, gilè (relativo a un gioco di carte), girándula, giubiléu, glòria, gobba, golfu, gonfalone, graduare, graffiare, gressinu ‘grissino’, grida, gríglia, grillu, grúccia, grúe (uccello), grumma, grumu, grunda, gualdrappa, guante ‘guanto’, guarnire, guastare, guérciu, gúmena. Totale 39
Imbastire, imbáttere, imbidai ‘invitare’, imbraga ‘imbraca’, impedire, impiastru ‘cataplasma’, impicciare, importunare, imposta ‘tassa’, impostore, impostura, improverare ‘rimproverare’, imputare, incabigliare ‘accapigliarsi’, incarnadu ‘incarnato’, incastrare, inclinare, inclúiri, increadu, incuadernare, incensu, ìndigu ‘indaco’, indìvia, infermedadi ‘malattia’, insalada, intantu, intempèrie, intermesu, intimare, inzegnéri, isbáttere, isbirru, iscansìa, iscartafógliu, iscartare, iscassu ‘scarso’, iscátula, isciallu, isfarzu ‘sfarzo’, iskeda, iskiera, iskiffu, iskitzare, ismarrire, isopu ‘santoreggia’, ispásimu, ispilórciu, ispinatzu ‘spinacio, spinaci’, ispinette ‘spinetta’ (strumento musicale), ispitale ‘ospedale’, isprolokkiare, ispuntare ‘spuntare’, istabilire, istincu, istίtigu, istivare, istoccu ‘stocco’, istrapatzare, istrappare, istrapuntu ‘strapunta’, istraviare ‘togliere dalla via’, istringa, istufare, ίsula, isvalorire, iumentu, iustu. Totale 80
Kidru ‘cedro’, kimera, kìmighe ‘cimice’, kina ‘chinino’, kìnghere ‘cingere’, kintàna ‘quintana’, kitáde ‘città’. Totale 7
Labare ‘lavare’, lambiccare, lanterna, lapida ‘lapide’, lastra, latrina, latta, lavamanu, lavandinu, legùmene ‘legume’, leίtimu, letanìas, lìnia ‘linea’, lίttera, lizzadru ‘leggiadro’, lordu, lucru, lupu, lusingare, lustrare, luttare, luttu, luttsu ‘luccio di mare’. Totale 23
Magestade ‘maestà’, malandrinu, mandίbula, mangerίa, mániga, manovra, manzu, marcurella ‘mercorella’, maretta, margherita, mariólu, marionetta, marmotta, marramáu, martsapane, massacru, masserίtzia, masticare, mattone, mattutίnu, mélica ‘medica (erba)’, melissa, mendicare, mendίgu, mentirosu ‘bugiardo’, merenda, mermelada ‘cotognata’, méru ‘puro’, mèsse, méstruu, minestra, moda, molare (dente), mòrdere, morίa, muččačča, muffa, mustarda. Totale 38
Natzione, negare, negru-de-fumu ‘nerofumo’, nervόsu, néspula. Totale 5
Oca, occiales, odore, offèndere, olfátu, onta, όnus ‘peso, carico’, opprίmere, ordίre, orίna, òrma, òro, osare, òstia, ostinare, ottanta, ottòbri. Totale 17
Pa ‘bacio’, pacotίglia, paccioccòne, padiglione, paèse, palitsada, páncia, paòne ‘pavone’, pappagallu, parággiu, paralίticu, paramánu ‘nettatoio dei muratori’, parente, parláta, parrocchiánu, passatiémpu, patata, pattúglia, paúra, pérgula, Perú, piastra, picocuán(n)a ‘ipecacuana’ (radice di pianta americana), picciòne, pidemìa ‘epidemia’, pioppu, pipίta de sant’Ignátsiu (albero), pistòla, pitanza ‘pietanza’, placca, placare ‘intarsiare’, impiallacciare’, porru (Allium porrum), porta, portante ‘ambio’, portare, posare, postitzu ‘posticcio’, precettare, prelatu, prevaléssiri ‘prevalere’, primavèra, prim(m)èra ‘primiera’ (gioco di carte), priváda ‘cesso’, prostrare, provulòne, prúa, prudíre ‘aver prurito’, puéstu ‘posto’, pugnale, pula, pulcinella, puntale, puntéḍḍu ‘puntello’, puttsolána ‘pozzolana’. Totale 56
Rampa, rapίna, rappare ‘tosare’, rastréllu, reale ‘schietto’, rebárbaru ‘rabarbaro’, recúsa ‘ricusa, rifiuto’, rédina, redingottu ‘cappotto’, refittulèra ‘che lavora nel refettorio’, repente, rettsètta ‘ricetta’, risu (cereale), ròdere, ròre ‘rugiada’. Totale 17
Sabadίglia (erba esotica), sábia, salámu ‘salame’, saldare, salsa, sandália ‘sandalo’, sangrare ‘salassare’, satanassu, sciábica, sciacca-méndula, sceša (lettera x), scumbru, sériu, siática ‘sciatica’, sigillu, silίssiu ‘cilicio’, sòttanu. Totale 17
Tabaccu, taccágnu, taccòne, tafanáriu ‘sedere, deretano’, taffettánu ‘taffettà’, taitái, talèa, taléntu, talίsu, tan, tángheru, tassa ‘imposizione’, tassellu, tassu (Taxus baccata), tatà ‘bussa, percossa’, tèndine, tentazione, terna, terraplénu, tertzu, tesòru, tèssera, testa, tikki (tic), timbru, timòne, tinca, tipu, toppa, torbadu (torbato), tòrcia, tortu ‘torto’, tòtanu ‘totano’, tramuntana, trankillu ‘tranquillo’, trapassare, trementina, trikkitracca, trot(t)a, truffare, truppa, tulipani, turba, turbare, turrione ‘torrione’. Totale 40
Úlcera, últimu, úmidu, úmile, usùra. Totale 5
Vakketta, vagare, variare, vassallu, vata (voce sospetta), vendicare, ventágliu, viola, visu2 ‘faccia’, visúra ‘visura (di atti)’, vittu, volante (lakkè), vueccelléntzia ‘vostra eccellenza’. Totale 14
Zambayòne, tsipolla ‘nodo del legno che è a spicchi come la cipolla’. Totale 2
Totale generale: 690